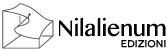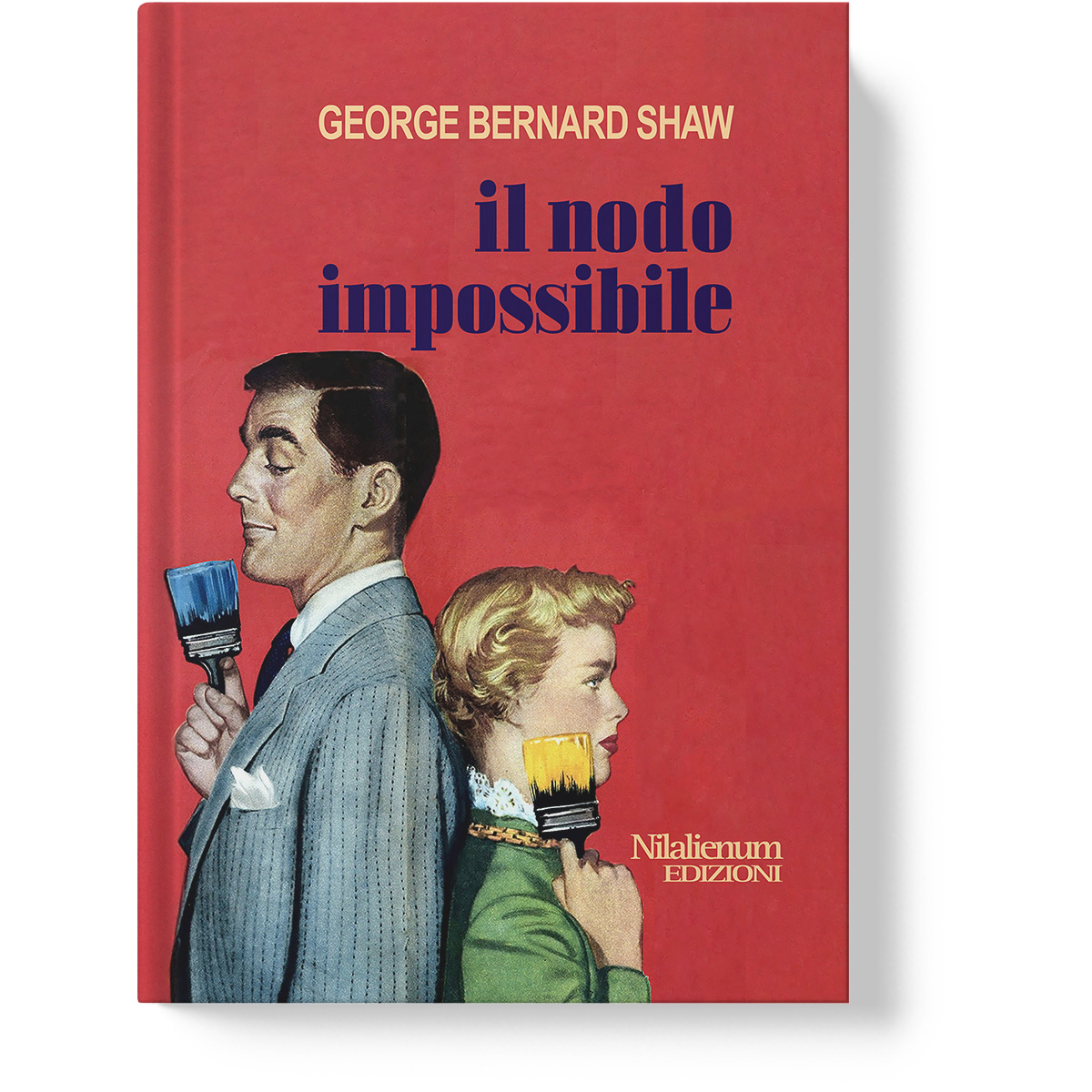L'Autore
George Bernard Shaw arrivò a Londra da Dublino nel 1876 con poche sterline in tasca e una fiducia smisurata nelle proprie capacità. Aveva vent’anni, era povero, sconosciuto, e dotato di un’ironia così feroce da renderlo spesso insopportabile anche agli amici.
Possedeva però un talento raro: la capacità di trasformare ogni sconfitta in uno spettacolo, ogni fallimento in un aneddoto brillante. Quest’uomo dalla barba rossa e dal bastone da dandy sarebbe diventato il primo al mondo ad aver vinto sia il Premio Nobel per la Letteratura che l’Oscar. Un primato che rivela la sua straordinaria capacità di reinventarsi continuamente, trasformando la provocazione in una vera e propria forma d’arte.
Shaw comprese presto che nella società vittoriana, dove l’ipocrisia regnava sovrana dietro una facciata di rispettabilità, il modo migliore per farsi ascoltare era imporsi all’attenzione con la forza della provocazione. Era un genio letterario che dipendeva fortemente dalla pubblicità e dalla fama. Questa apparente contraddizione, inaccettabile per i canoni vittoriani che esigevano dagli artisti un nobile distacco dal successo, era in realtà la sua forza: utilizzava la celebrità come un’arma per veicolare idee rivoluzionarie. Era socialista in un’epoca in cui il socialismo era sinonimo di sovversione, femminista quando le donne non avevano diritto di voto, vegetariano quando la carne era simbolo di forza e agiatezza.
Scrisse “Il nodo impossibile” (“The Irrational Knot”) nel 1880, quando aveva appena ventiquattro anni. Come il primo, anche questo romanzo fu respinto da tutti gli editori londinesi e americani. Shaw ammise in seguito, con la sua consueta ironia, di non sapere se gli editori lo avessero respinto per i suoi difetti o proprio per le sue qualità.
Il titolo originale “The Irrational Knot” rivela tutta la genialità di Shaw nel trasformare una metafora comune in una tagliente critica sociale. Gli inglesi si riferiscono al matrimonio con l’espressione “to tie the knot” (stringere il nodo), ma Shaw ribaltò questa immagine tradizionalmente positiva definendola “irrazionale”. La sua critica colpì nel segno: l’istituzione matrimoniale vittoriana non si fondava sull’amore o sulla compatibilità, ma su convenzioni sociali tanto rigide quanto assurde.
Nel romanzo, questo “nodo irrazionale” si manifesta concretamente nel fallimento dell’unione tra Marian ed Edward. Il loro matrimonio entra in crisi non per incompatibilità caratteriali, ma perché Marian rimane prigioniera dei preconcetti della sua classe sociale, incapace di condividere gli interessi e la visione del mondo del marito. Il “nodo” matrimoniale diventa così simbolo di un sistema più ampio: quello delle divisioni di classe che rendono impossibile ogni autentico rapporto umano. Il “nodo impossibile” non è solo il matrimonio di Marian e Edward: è il nodo di tutte le contraddizioni sociali che Shaw avrebbe passato una vita a denunciare. Un nodo che, forse, non può essere sciolto ma solo compreso nella sua assurdità fondamentale.
Shaw denuncia l’irrazionalità di una società che impedisce l’unione tra persone potenzialmente compatibili basandosi su distinzioni artificiali di nascita e status sociale. Il matrimonio, che dovrebbe essere l’espressione più libera dei sentimenti, si trasforma invece in una prigione di convenzioni, un nodo che più si cerca di sciogliere, più si stringe.
La storia della pubblicazione del romanzo è essa stessa un piccolo capolavoro di ironia shawiana. Dopo anni di rifiuti, il manoscritto trovò una casa editrice grazie ad Annie Besant, attivista e teosofa, che lo pubblicò a puntate nella sua piccola rivista propagandistica. Shaw raccontò questo episodio con il suo tipico autocompiacimento: il romanzo “sfuggì a ogni possibilità di controllo” e lui non poté più “frapporsi tra lui e il pubblico americano”.
Shaw aveva un talento particolare per trasformare le contraddizioni in verità illuminanti. Era un pacifista che sosteneva la necessità della forza, un aristocratico dello spirito che predicava l’uguaglianza sociale, un razionalista che credeva nella forza vitale dell’istinto. La sua casa ad Ayot St Lawrence, una contea dell’Hertfordshire, divenne un salotto intellettuale dove si discuteva di tutto: dalla riforma dell’alfabeto inglese (Shaw propose un alfabeto di 40 lettere per rendere la scrittura più logica) alle teorie di Darwin, che influenzarono profondamente il suo pensiero evolutivo.
Prima di diventare drammaturgo, Shaw fece il critico musicale dal 1888 al 1894, scrivendo per le riviste sotto lo pseudonimo ironico di “Corno di Bassetto” (uno strumento a fiato dal suono così cupo che Shaw stesso disse: “Nemmeno il diavolo in persona riuscirebbe a farlo brillare”). Anche in questo campo riuscì a essere un iconoclasta: adorava Wagner quando era considerato troppo moderno e rivoluzionario, detestava l’opera italiana tradizionale quando era di moda. Con la sola eccezione di Verdi che, secondo lui, era riuscito con il Rigoletto a fondere inscindibilmente il personaggio con la musica stessa. Shaw riconobbe che il compositore italiano aveva superato i confini dell’opera convenzionale per creare qualcosa di artisticamente superiore.
Nel 1938 vinse l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per “Pigmalione”. Shaw non si presentò alla cerimonia di consegna a Hollywood – del resto aveva 82 anni e viveva in Inghilterra. Accettò il premio ma con riserve ironiche, dichiarando di essere “abbastanza vecchio da aver imparato che i premi vengono dati per ragioni che spesso non hanno nulla a che fare con il merito”. Non rifiutò formalmente l’Oscar, ma lo trattò con il suo caratteristico distacco verso i riconoscimenti ufficiali. La statuetta gli fu spedita per posta in Inghilterra, dove la tenne sulla scrivania non come trofeo ma come curioso soprammobile. Dopo la sua morte, quando la casa divenne un museo, l’Oscar era talmente annerito che il curatore, non riconoscendone il valore, lo usò addirittura come fermaporta – un destino che Shaw stesso avrebbe probabilmente trovato deliziosamente ironico, simbolo perfetto del suo rapporto ambivalente con il successo hollywoodiano.
Shaw morì nel 1950 a 94 anni, cadendo da una scala mentre potava gli alberi nel suo giardino. Anche la sua morte fu coerente con il personaggio: attivo, indipendente, piuttosto spericolato fino all’ultimo.
La sua figura rimane quella di un iconoclasta che trasformò la provocazione in arte. Per decenni aveva sistematicamente demolito tutto ciò che la società vittoriana ed edoardiana considerava sacro: il matrimonio tradizionale, le divisioni di classe, i ruoli di genere, le convenzioni morali. Le sue idee scandalizzavano i benpensanti ma entusiasmavano chi cercava aria nuova nella società borghese dell’epoca.
Shaw aveva capito che per cambiare il mondo bisognava prima farlo ridere delle proprie contraddizioni. Il suo bastone da dandy non era solo un accessorio di moda: era lo strumento di un illusionista che trasformava la critica sociale in spettacolo e l’irrazionalità del mondo in una commedia tanto amara quanto illuminante, rendendo digeribili verità altrimenti inaccettabili.