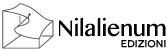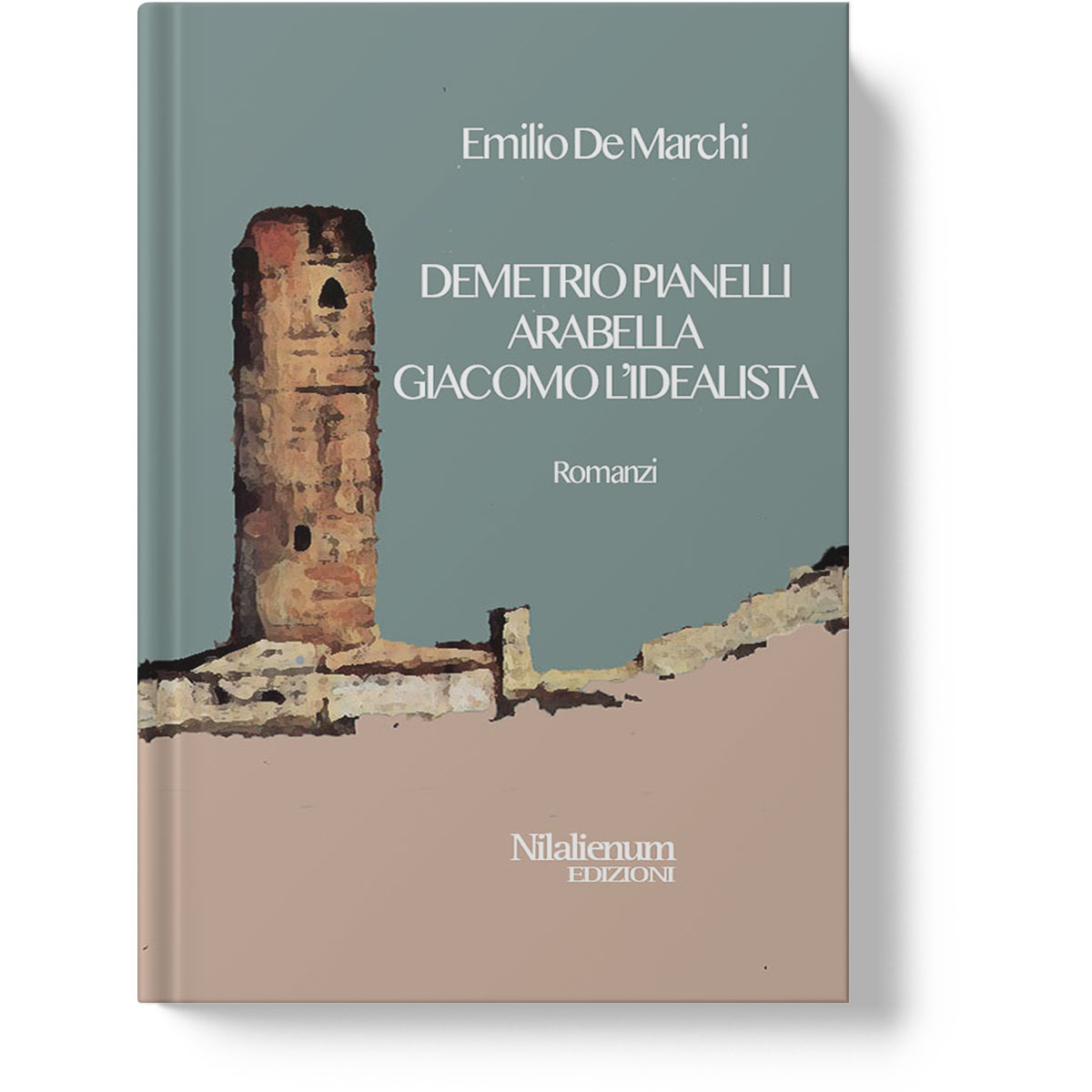L'Autore
Emilio De Marchi (Milano 1851-1901) è stato uno scrittore italiano. Rimasto orfano del padre a nove anni, fu educato ai grandi ideali civili, morali e religiosi dalla madre Caterina, un’eroina delle «cinque giornate» milanesi. Si laureò in lettere all’Accademia Scientifico-letteraria, dove fu poi segretario e professore di stilistica; sposò nel 1880 Lina Martelli, da cui ebbe due figli.
Dopo aver assistito e partecipato agli ultimi bagliori della scapigliatura e collaborato al «Convegno» (1874), fondò nel 1877, con G. Borghi e A. Bazzero, la «Vita Nuova»: un periodico letterario fra romanticismo «rientrato», culto manzoniano e vaghe aspirazioni sociali. Ma alla morte della rivista (1878), già nel primo romanzo, in qualche modo pirandelliano, Due anime in un corpo (1878), la vocazione di De Marchi appare chiaramente identificata: un realismo pensoso rivolto a cogliere i rapporti eterni fra Dio e l’uomo sotto le più logore apparenze della vita, un cristianesimo angosciato e problematico di fronte ai più pesanti interrogativi del vivere di ogni giorno. È una vocazione che determina un’attenzione vigile al mondo degli umiliati e degli infelici, una predilezione per i personaggi sempre in bilico sugli indefiniti confini del bene e del male, una dolente sensibilità per gli oscuri e inconfessati grovigli sentimentali.
Novelliere vario e facile (Storie d’ogni colore, 1885; Nuove storie d’ogni colore, 1895; Vecchie storie, postumo, 1926), affrontò nel Cappello del prete (1888) il tema dostoevskiano del fatale precipitare verso il delitto e poi del rimorso che conduce alla pazzia (un tema ripreso da L. Capuana nel Marchese di Roccaverdina); ma trovò il suo tono più schietto e resistente quando rivolse quella sua visione di realista intimista alla rappresentazione della società piccolo-borghese della Milano di fine Ottocento.
Con Demetrio Pianelli (1890) De Marchi scrisse il suo capolavoro. Riuscì, in questa elegia dei deserti dalla vita e dall’amore, a rappresentare insieme la fatica di vivere e la forza morale degli eroi delle soprammaniche; gli impiegatucci sempre chiusi fra una miseria decente e lo spettro della fame, sempre vittime di soprusi, ma che alle volte sanno superare la loro condizione di vinti con una dissimulata e disadorna generosità, con una straordinaria ricchezza interiore. Demetrio è per questo una delle creazioni letterarie più ricche del nostro Ottocento, uno dei tipi umani più rappresentativi dell’Italia umbertina; la società che lo circonda è ritratta con un realismo non privo di humor, con una luminosità vaporosa alla Cremona e alla Ranzoni.
Con Arabella (1893) De Marchi non continuò soltanto contenutisticamente il precedente romanzo, ma aprì la via alla più audace indagine psicologica, verso i regni della sensazione e del subcosciente, dell’essere e del non essere. Questi suggestivi sviluppi narrativi si approfondiscono, sia pur frammentariamente e con discontinuità, in Giacomo l’idealista (1897); ma appaiono invece dimenticati nel racconto d’appendice Redivivo ( 1894-96) e poi involuti in Col fuoco non si scherza (1901).
Vivamente amato per la sua bontà generosa, e ammirato come narratore da amici quali Ferrari, Verga, Fogazzaro, Giacosa, De Amicis, Mantegazza, Rovetta ecc., non riuscì a fermare l’attenzione del grande pubblico del suo tempo, ma ebbe sempre lettori affezionati e devoti: i «fedeli di Demetrio Pianelli», come li chiamò, annoverandosi fra essi, un fervido ammiratore e imitatore di De Marchi, A. Panzini.
In questo dopoguerra il suo spiccato carattere di «scrittore popolare», la sua larga e appassionata sensibilità sociale, i suoi generosi interessi per il mondo operaio, la sua predilezione per gli sdoppiamenti di coscienza e di persona quasi pirandelliani, il suo protendersi dalla scapigliatura al decadentismo hanno determinato un revival demarchiano che si è esteso fino alle trasposizioni cinematografiche e televisive dei suoi romanzi.