QUADERNO 1
(8 febbraio 1929)
Note e appunti
Argomenti principali:
1) Teoria della storia e della storiografia.
2) Sviluppo della borghesia italiana fino al 1870.
3) Formazione dei gruppi intellettuali italiani: svolgimento, atteggiamenti.
4) La letteratura popolare dei «romanzi d’appendice» e le ragioni della sua persistente fortuna.
5) Cavalcante Cavalcanti: la sua posizione nella struttura e
nell’arte della Divina Commedia.
6) Origini e svolgimento dell’Azione Cattolica in Italia e in Europa.
7) Il concetto di folklore.
8) Esperienze della vita in carcere.
9) La «quistione meridionale» e la quistione delle isole.
10) Osservazioni sulla popolazione italiana: sua composizione, funzione dell’emigrazione.
11) Americanismo e fordismo.
12) La quistione della lingua in Italia: Manzoni e G. I. Ascoli.
13) Il «senso comune» (cfr 7).
14) Riviste tipo: teorica, critico‑storica, di cultura generale (divulgazione).
15) Neo‑grammatici e neo‑linguisti («questa tavola rotonda è quadrata»).
16) I nipotini di padre Bresciani.
Q1 §1 Sulla povertà, il cattolicismo e il papato. Ricordare la
risposta data da un operaio cattolico francese all’autore di un
libretto su Ouvriers et
Patrons, memoria premiata nel 1906 dall’Accademia di
scienze morali e politiche di Parigi. La risposta rispondeva in
modo epigrammatico all’obbiezione mossagli che, secondo
l’affermazione di Gesù Cristo, ci devono essere sempre ricchi e
poveri: «vuol dire che lasceremo almeno due poveri, perché Gesù
Cristo non abbia ad aver torto». Questa quistione generale
dovrebbe essere esaminata in tutta la tradizione e la dottrina
della Chiesa Cattolica.
Affermazioni principali fatte nelle encicliche degli ultimi
papi, cioè di quelli più importanti da quando la quistione ha
assunto una importanza storica: 1° La proprietà privata,
specialmente quella «fondiaria», è un «diritto naturale», che
non si può violare neanche con forti imposte (da questa
affermazione sono derivati i programmi delle tendenze
«democratiche cristiane», per la distribuzione delle terre, con
indennità, ai contadini poveri e le loro dottrine finanziarie);
2° I poveri devono contentarsi della loro sorte, poiché le
distinzioni di classe e la distribuzione della ricchezza sono
disposizioni di dio, e sarebbe empio cercare di eliminarle; 3°
L’elemosina è un dovere cristiano e implica l’esistenza della
povertà; 4° La quistione sociale è anzitutto morale e religiosa,
non economica, e dev’essere risolta con la carità cristiana e
con i dettami della moralità e il giudizio della religione.
(Vedi Codice sociale e Sillabo).
Q1 §2 Faccia a faccia col nemico, di Luigi Galleani, stampato negli Stati Uniti (Boston?) verso il 1910 dalle «Cronache Sovversive». È uno zibaldone compilatorio sui processi degli individualisti (Ravachol, Henry ecc.), poco utile in generale. Qualche osservazione:
A Livorno nel suo discorso, Abbo ripeté l’introduzione della dichiarazione di principii di Etievant, riportata in appendice nel libro: la frase, che suscitò l’ilarità generale, sulla «linguistica», è presa letteralmente; Abbo conosceva a memoria la prima parte della dichiarazione, certamente. Può servire, questo rilievo, per far notare come si facevano la cultura questi uomini e come questa specie di letteratura sia diffusa e popolare.
In tutte le dichiarazioni degli imputati, risulta che uno dei motivi fondamentali delle loro azioni è il «diritto al benessere» che ritengono un diritto naturale (i francesi, s’intende, che occupano la maggior parte del libro). Da vari imputati è ripetuta la frase che «un’orgia dei signori consuma ciò che basterebbe a mille famiglie operaie». Non c’è neanche un accenno ai rapporti di produzione. La dichiarazione di Etievant, riportata integralmente in appendice, è tipica, perché cerca di costruire un sistema giustificativo degli individualisti d’azione; naturalmente, le stesse giustificazioni sono valide per tutti, per i giudici, per i giurati, per il carnefice: ogni elemento sociale è chiuso nella rete delle sue sensazioni, come un porco in una botte di ferro e non può evaderne; l’individualista lancia la «marmitta», il giudice condanna, il carnefice taglia la testa. Non c’è uscita. È un volontarismo che per giustificarsi moralmente nega se stesso in modo tragicomico. L’analisi di questa dichiarazione mostra come queste «azioni» individuali erano il portato di uno sconcerto morale della società francese che dal ’70 arriva fino al dreyfusismo, nel quale trova il suo sfogo collettivo.
A proposito dell’Henry c’è nel volume riportata la lettera di un certo Galtey (mi pare, ma bisognerebbe verificare) a proposito dell’amore represso di Henry per sua moglie. Questa donna, saputo che Henry era stato innamorato di lei (pare che non se ne fosse accorta) dichiara a un giornalista che se avesse saputo, si sarebbe data, forse. Il marito, nella lettera, dichiara di non trovar nulla da dire sulle dichiarazioni della moglie e spiega: se un uomo non è riuscito a incarnare il sogno romantico della sua donna sul cavaliere azzurro (o qualcosa di simile), peggio per lui; deve ammettere che un altro lo sostituisca. È tipico questo miscuglio di cavalieri azzurri e di razionalismo materialistico.
Nella sua dichiarazione al processo di Lione del 1894 (vedi) Kropotkin afferma con certezza che entro dieci anni ci sarà lo sconvolgimento finale: il tono di sicurezza è notevole.
Q1 §3 Rapporti tra Stato e Chiesa. Il «Vorwärts» del 14 giugno 1929 in un articolo a proposito del Concordato tra la Città del Vaticano e la Prussia scrive che «Roma ha ritenuto fosse decaduta (la legislazione precedente che già costituiva di fatto un concordato) in seguito ai cambiamenti politici intervenuti in Germania». Questo potrebbe essere un precedente molto importante e da ricordare.
Q1 §4 Diritto naturale e cattolicismo. Gli attuali polemisti contro il diritto naturale si guardano bene dal ricordare che esso è parte integrante del cattolicismo e della sua dottrina. Sarebbe interessante una ricerca che dimostrasse lo stretto rapporto tra la religione e gli «immortali principii». I cattolici stessi ammettono questi rapporti quando affermano che con la rivoluzione francese è cominciata una «eresia», riconoscono cioè che si tratta della scissione dottrinale di una stessa mentalità e concezione generale. Si potrebbe dire, pertanto, che non i principii della rivoluzione francese superano la religione, ma le dottrine che superano questi principii, cioè le dottrine della forza contrapposte al diritto naturale.
Q1 §5 Rapporti tra Stato e Chiesa. Nella «Vossische Zeitung» del 18 giugno 1929 Hoepker‑Aschoff, ministro democratico delle finanze di Prussia, poneva così la questione, rilevata più su dal «Vorwärts»: «Egualmente non è possibile disconoscere la fondatezza della tesi di Roma che, in presenza dei molti cambiamenti politici e territoriali avvenuti, richiedeva che gli accordi venissero adattati alle nuove circostanze». Nello stesso articolo l’Hoepker‑Aschoff ricorda che lo Stato prussiano «aveva sempre sostenuto che gli accordi del 1821 erano ancora in vigore». (E il periodo del Kulturkampf?).
Q1 §6 «Per lodare un libro non è affatto necessario di aprirlo; ma, se si è deciso di criticarlo, è sempre prudente leggerlo. Almeno sinché l’autore è vivo... ». Rivarol.
Q1 §7 Margherita Sarfatti e le «giostre». Nella recensione di Goffredo Bellonci del Palazzone di Margherita Sarfatti «Italia letteraria», 23 giugno 29 si legge: «verissima quella timidezza della vergine che si ferma pudica innanzi al letto matrimoniale mentre pur sente che “esso è benigno e accogliente per le future giostre”». Questo pudore che sente con le espressioni tecniche dei novellieri licenziosi è impagabile: avrà sentito anche le future «molte miglia» e il suo «pelliccione» ben scosso.
Q1 §8 Generazione vecchia e nuova. La vecchia generazione degli intellettuali ha fallito, ma ha avuto una giovinezza Papini, Prezzolini, Soffici ecc.). La generazione dei giovani attuali non ha neanche questa età delle brillanti promesse: asini brutti anche da piccoletti (Titta Rosa, Angioletti, Malaparte ecc.).
Q1 §9 Soffici. Un cafone senza ingenuità e spontaneità.
Q1 §10 Su Machiavelli. Si suole troppo considerare Machiavelli come il «politico in generale» buono per tutti i tempi: ecco già un errore di politica. Machiavelli legato al suo tempo: 1) lotte interne nella repubblica fiorentina; 2) lotte tra gli stati italiani per un equilibrio reciproco; 3) lotte degli stati italiani per equilibrio europeo.
Su Machiavelli opera l’esempio della Francia e della Spagna che hanno raggiunto una forte unità statale. Fa un «paragone ellittico» come direbbe il Croce e desume le regole per un forte stato in generale e italiano in particolare. Machiavelli è uomo tutto della sua epoca e la sua arte politica rappresenta la filosofia del tempo che tende alla monarchia nazionale assoluta, la forma che può permettere uno sviluppo e un’organizzazione borghese. In Machiavelli si trova in nuce la separazione dei poteri e il parlamentarismo; la sua «ferocia» è contro i residui del feudalismo, non contro le classi progressive; il principe deve porre fine all’anarchia feudale e ciò fa il Valentino in Romagna, appoggiandosi sulle classi produttive, contadini e mercanti. Dato il carattere militare del capo dello stato, come si richiede in un periodo di lotta per la formazione e il consolidamento del potere, l’indicazione di classe contenuta nell’Arte della guerra si deve intendere per la struttura generale statale: se i borghesi della città vogliono porre fine al disordine interno e all’anarchia esterna, devono appoggiarsi sui contadini come massa, costituendo una forza armata sicura e fedele.
Si può dire che questa concezione essenzialmente politica è così dominante nel Machiavelli che gli fa commettere gli errori di carattere militare: egli pensa specialmente alla fanteria, le cui masse possono essere arruolate con un’azione politica, e perciò misconosce il valore dell’artiglieria. Insomma deve essere considerato come un politico che deve occuparsi di arte militare in quanto ciò è necessario per la sua costruzione politica, ma lo fa in modo unilaterale, perché non lì è il centro del suo pensiero.
Q1 §11 Dell’originalità nella scienza. Einaudi: «Una teoria non va attribuita a chi la intuì, o per incidente la enunciò o espose un principio da cui poteva essere dedotta o raccontò slegatamente le diverse nozioni, le quali aspiravano ad essere ricomposte in unità». Manca la parte positiva accennata in seguito nella frase: «in quale altro libro fu assunto come oggetto “voluto” di “particolare” trattato la seguente proposizione, ecc.?» Il Croce: «Altro è metter fuori un’osservazione incidentale, che si lascia poi cadere senza svolgerla, ed altro stabilire un principio di cui si sono scorte le feconde conseguenze; altro enunciare un pensiero generico ed astratto ed altro pensarlo realmente e in concreto; altro, finalmente, inventare, ed altro ripetere di seconda o di terza mano». L’enunziazione dell’Einaudi è molto difettosa e piena di curiose improprietà linguistiche, ma è derivata dal Croce (Einaudi, «Riforma Sociale», 1929, p. 277; Croce, Mat. storicoIV, p. 26).
Q1 §12 Giovanni Papini. Il «pio autore» della «Civiltà Cattolica».
Q1 §13 Alfredo Panzini. Scrive F. Palazzi nell’«Italia che scrive» (Giugno 1929) a proposito di I giorni del sole e del grano: «soprattutto si occupa e si preoccupa della vita campestre come può occuparsene un padrone che vuol essere tranquillo sulle doti lavorative delle bestie da lavoro che possiede, sia di quelle quadrupedi, sia di quelle bipedi e che a veder un campo coltivato, pensa subito se il raccolto sarà quale spera». Panzini negriero, insomma.
Q1 §14 Fortunato Rizzi ossia dell’italiano meschino. Louis Reynaud, che deve essere un discepolo di Maurras, ha scritto un libro: Le Romantisme (Les origines anglo‑germaniques. Influences étrangères et traditions nationales. Le réveil du génie français), Paris, Colin, per esporre diffusamente e dimostrare una tesi propria del nazionalismo integrale: che il romanticismo è contrario al genio francese ed è un’importazione straniera, germanica e anglo‑tedesca. In questa proposizione, per Maurras e indubbiamente anche per il Reynaud, l’Italia è e deve essere con la Francia, e anzi in generale le nazioni cattoliche, il cattolicismo, sono solidali contro le nazioni protestanti, il latinismo contro il germanesimo. Il romanticismo è una infezione d’origine germanica, infezione per la latinità, per la Francia, che ne è stata la grande vittima: nei suoi paesi originari, Inghilterra e Germania, il romanticismo sarà o è stato senza conseguenze, ma in Francia esso è diventato lo spirito delle rivoluzioni successive dal 1789 in poi, ha distrutto o devastato la tradizione ecc. ecc.
Ora ecco come il prof. Fortunato Rizzi, autore di un libro a quanto pare mediocrissimo (non fa maraviglia, a giudicare dal modo come egli tratta le correnti di pensiero e di sentimenti) sul 500, vede il libro del Reynaud in un articolo (Il Romanticismo francese e l’Italia) pubblicato nei «Libri del giorno» del giugno 1929. Il Rizzi ignora l’«antefatto», ignora che il libro del Reynaud è più politico che letterario, ignora le proposizioni del nazionalismo integrale di Maurras nel campo della cultura e va a cercare con la sua lucernina di meschino italiano le traccie dell’Italia nel libro. Perbacco! l’Italia non c’è, l’Italia dunque è negletta, è misconosciuta! «È veramente singolare il silenzio quasi assoluto per quanto si riferisce all’Italia. Si direbbe che per lui (il Reynaud) l’Italia non esista né sia mai esistita: eppure se la deve esser trovata innanzi agli occhi ogni momento». Il Reynaud ricorda che il 600 nella civiltà europea è francese. E il Rizzi: «Ci voleva proprio uno sforzo eroico a notare, almeno di passaggio, di quanto la Francia del 600 sia debitrice all’Italia del 500? Ma l’Italia non esiste per i nostri buoni fratelli d’oltralpe». Che malinconia!
Il Reynaud scrive: «les anglais, puis les allemands, nous communiquent leur superstition de l’antique». E il Rizzi: «Oh guarda donde viene alla Francia l’adorazione degli antichi! Dall’Inghilterra e dalla Germania! E il Rinascimento italiano con la sua maravigliosa potenza di diffusione in Europa e, sì proprio, anche in Francia? Cancellato dalla storia... ». Altri esempi sono altrettanto divertenti. «stentata o inconscia indifferenza o ignoranza nei riguardi dell’Italia» che, secondo il Rizzi, non aggiunge valore all’opera ma anzi «per certi rispetti la attenua grandemente e sminuisce». Conclusione: «ma noi che siamo i figli primogeniti o, meglio (secondo il pensiero del Balbo) unigeniti di Roma, noi siamo dei signori di razza e non facciamo le piccole vendette ecc. ecc.» e quindi riconosce che l’opera del Reynaud è ordinata, acuta, dotta, lucidissima ecc. ecc.
Ridere o piangere. Ricordo questo episodio: parlando di un Tizio, un articolista ricordava che un antenato dell’eroe era ricordato da Dante nella Divina Commedia, «questo libro d’oro della nobiltà italiana». Era ricordato infatti, ma in una bolgia dell’Inferno: non importa per l’italiano meschino, che non si accorge, per la sua mania di grandezza da nobiluomo decaduto che il Reynaud, non parlando dell’Italia nel suo libro, le ha voluto fare il più grande omaggio, dal suo punto di vista. Ma al Rizzi importa che il Manzoni sia stato solo ricordato in una rella a piè di pagina!
Q1 §15 Delle università italiane. Perché non esercitano nel paese quell’influsso di regolatrici della vita culturale che esercitano in altri paesi?
Uno dei motivi deve ricercarsi in ciò che nelle università il contatto tra insegnanti e studenti non è organizzato. Il professore insegna dalla cattedra alla massa degli ascoltatori, cioè svolge la sua lezione, e se ne va. Solo nel periodo della laurea avviene che lo studente si avvicini al professore, gli chieda un tema e consigli specifici sul metodo della ricerca scientifica. Per la massa degli studenti i corsi non sono altro che una serie di conferenze, ascoltate con maggiore o minore attenzione, tutte o solo una parte: lo studente si affida alle dispense, all’opera che il docente stesso ha scritto sull’argomento o alla bibliografia che ha indicato.
Un maggiore contatto esiste tra i singoli insegnanti e singoli studenti che vogliono specializzarsi su una determinata disciplina: questo contatto si forma, per lo più, casualmente ed ha una importanza enorme per la continuità accademica e per la fortuna delle varie discipline. Si forma, per esempio, per cause religiose, politiche, di amicizia famigliare.
Uno studente diventa assiduo di un professore, che lo incontra in biblioteca, lo invita a casa, gli consiglia libri da leggere e ricerche da tentare. Ogni insegnante tende a formare una sua «scuola», ha suoi determinati punti di vista (chiamati «teorie») su determinate parti della sua scienza, che vorrebbe veder sostenuti da «suoi seguaci o discepoli». Ogni professore vuole che dalla sua università, in concorrenza con le altre, escano giovani «distinti» che portino contributi «seri» alla sua scienza. Perciò nella stessa facoltà c’è concorrenza tra professori di materie affini per contendersi certi giovani che si siano già distinti con una recensione o un articoletto o in discussioni scolastiche (dove se ne fanno). Il professore allora guida veramente il suo allievo; gli indica un tema, lo consiglia nello svolgimento, gli facilita le ricerche, con le sue conversazioni assidue accelera la sua formazione scientifica, gli fa pubblicare i primi saggi nelle riviste specializzate, lo mette in rapporto con altri specialisti e lo accaparra definitivamente.
Questo costume, salvo casi sporadici di camorra, è benefico, perché integra la funzione delle università. Dovrebbe, da fatto personale, di iniziativa personale, diventare funzione organica: non so fino a che punto, ma mi pare che i seminari di tipo tedesco, rappresentino questa funzione o cerchino di svolgerla. Intorno a certi professori c’è ressa di procaccianti, che sperano raggiungere più facilmente una cattedra universitaria. Molti giovani invece, che vengono dai licei di provincia specialmente, sono spaesati e nell’ambiente sociale universitario e nell’ambiente di studio. I primi sei mesi del corso servono per orientarsi sul carattere specifico degli studi universitari e la timidezza nei rapporti personali è immancabile tra docente e discepolo. Nei seminari ciò non si verificherebbe o almeno non nella stessa misura.
In ogni modo, questa struttura generale della vita universitaria non crea, già all’università, alcuna gerarchia intellettuale permanente tra professori e massa di studenti; dopo l’università anche quei pochi legami si sciolgono e nel paese manca ogni struttura culturale che si impernii sull’università. Ciò ha costituito uno degli elementi della fortuna della diade Croce‑Gentile, prima della guerra, nel costituire un gran centro di vita intellettuale nazionale; tra l’altro essi lottavano anche contro l’insufficienza della vita universitaria e la mediocrità scientifica e pedagogica (talvolta anche morale) degli insegnanti ufficiali.
Q1 §16 Ignobile pigiama. Bruno Barilli in un articolo della «Nuova Antologia» (16 giugno 1929) chiama l’uniforme del bagno penale «quella specie di ignobile pijama». Ma forse già molti modi di vedere e di pensare a proposito delle cose carcerarie sono andati mutando. Quando ero nel carcere di Milano ho letto nella «Domenica del Corriere» una «Cartolina del pubblico» che press’a poco diceva: «In treno due si incontrano e uno dice che è stato 20 anni in carcere. – “Certo per ragioni politiche” dice l’altro». Ma la punta epigrammatica non è in questa risposta, come potrebbe apparire nel riferimento. Dalla «cartolina» appare che l’essere stato in carcere non desta più repulsione, perché si può esservi stati per ragioni politiche. E le «cartoline del pubblico» sono uno dei documenti più tipici del senso comune popolare italiano. E Barilli è perfino al di sotto (di) questo senso comune: filisteo per i filistei classici della «Domenica del Corriere».
Q1 §17 Riccardo Balsamo-Crivelli. A proposito di «Cartoline del Pubblico» della «Domenica del Corriere» è da notare questo inciso del signor Domenico Claps («L’Italia che scrive», giugno 1929) in un articolo su Riccardo Balsamo‑Crivelli (che nel titolo e nel sommario è confuso con Gustavo!): «chi gliel’avrebbe detto che questo libro (Cammina... cammina...) si sarebbe adottato come testo di lingua all’Università di Francoforte?», Ahilui! una volta che prima della guerra all’Università di Strasburgo adoperavano come testo di lingua le «Cartoline del Pubblico»! Naturalmente per Università bisogna intendere solo il seminario di filologia romanza, chi sceglie non è il professore ma solo il lettore d’italiano che può essere un semplice studente universitario italiano e per «testo di lingua» bisogna intendere il testo che dia agli studenti tedeschi un modello della lingua parlata dalla media degli italiani e non della lingua letteraria o artistica. La scelta delle «Cartoline del Pubblico» è pertanto molto assennata e il signor Domenico Claps è anch’egli un «italiano meschino» al quale il Balsamo‑Crivelli dovrebbe mandare i padrini.
Q1 §18 L’errore di Maurras. sul partito monarchico francese. Il partito monarchico in regime repubblicano, come il partito repubblicano in regime monarchico e il partito nazionalista in regime di soggezione nazionale, non può non essere un partito sui generis: deve essere, cioè, se vuole ottenere un successo relativamente rapido, la centrale di una federazione di partiti, più che un partito caratterizzato in tutti i punti particolari del suo programma di governo. Il partito di un sistema generale di governo e non di un governo particolare. (Un posto a parte in questa stessa serie, però, spetta ai partiti confessionali, come il Centro tedesco e i diversi partiti popolari ‑ cristiano‑sociali). Ogni partito si fonda su una classe e il partito monarchico si fonda in Francia su i residui della vecchia nobiltà terriera e su una piccola parte di intellettuali.
Su che sperano i monarchici per diventare capaci di prendere il potere e restaurare la monarchia? Sperano sul collasso del regime parlamentare‑borghese e sulla incapacità di qualsiasi altra forza organizzata esistente ad essere il nucleo politico di una dittatura militare prevedibile o da loro stessi preordinata. Le loro forze sociali di classe in nessun modo potrebbero altrimenti giungere al potere. In attesa, il centro dirigente svolge questa attività: 1) azione organizzatrice politico‑militare (militare nel senso di partito), per raggruppare nel modo più efficace possibile la angusta base sociale su cui storicamente s’appoggia il movimento. Essendo questa base costituita di elementi in generale più scelti per intelligenza, cultura ricchezza, pratica di amministrazione ecc. che in qualsiasi altro, è possibile avere un partito‑movimento notevole, imponente persino, ma che si esaurisce in se stesso, che non ha cioè, riserve da buttare nella lotta in una crisi risolutiva. È notevole dunque solo nei periodi normali, quando gli elementi attivi si contano solo a decine di migliaia, ma diventerà insignificante (numericamente) nei momenti di crisi, quando gli attivi si potranno contare a centinaia di migliaia e forse a milioni (Continua).
Q1 §19 Notizie sui rapporti tra ebrei e cristiani nel Risorgimento. Nel 1921 l’editore Bocca ha raccolto in tre volumi, con prefazione di un D. Parodi, una serie di Confessioni e professioni di fede di Letterati, Filosofi, Uomini politici, ecc., apparse precedentemente nel «Coenobium» di Bignami, come risposta a un quistionario sul sentimento religioso e i suoi diversi rapporti. La raccolta può essere interessante per chi voglia studiare le correnti di opinione verso la fine del secolo scorso e il principio dell’attuale, sebbene difettosa per molti aspetti. Raffaele Ottolenghi, invece di attenersi al quistionario, fa, secondo il suo carattere, una scorribanda lirico‑sentimentale nei suoi ricordi di «ebreo» piemontese. Estraggo dal suo scritto qualche notizia sulla situazione degli ebrei nel periodo del Risorgimento.
Un ebreo, veterano di Napoleone, ritornò al suo paese con una donna francese: il vescovo, saputo che la donna era cristiana, contro la sua volontà, la fece portar via dai gendarmi. Il vescovo si impadroniva dei fanciulli ebrei che avessero minacciato di farsi cristiani durante qualche lite coi genitori. (Il Brofferio registrò questi fatti nella sua storia).
Dopo il 15 gli ebrei cacciati dalle Università e quindi dalle professioni liberali.
Nel 1799 durante l’invasione austro‑russa, pogrom di ebrei; ad Acqui solo l’intervento del vescovo riesce a salvare il bisavolo dell’Ottolenghi dai fucili della folla. Ricorda un pogrom a Siena, dove ebrei furono mandati al rogo e il vescovo rifiutò di intervenire.
Nel 1848 il padre dell’Ottolenghi tornò ad Acqui da Torino, vestito da Guardia Nazionale; irritazione dei reazionari; fu sparsa la voce del sacrifizio rituale di un bambino da parte dell’Ottolenghi padre; campane a stormo; venuta dei villani dalla campagna per saccheggiare il Ghetto. Il vescovo si rifiutò di intervenire; l’Ottolenghi fu salvato dal sindaco, con un arresto simulato fino all’arrivo delle truppe. I reazionari e i clericali volevano fare apparire le innovazioni liberali del 48 come una «invenzione» degli ebrei. (La storia del fanciullo Mortara).
Q1 §20 Salvator Gotta. Oremus sugli altari e flatulenze in sacrestia.
Q1 §21 Nel 1° volume delle Confessioni e professioni di fede già citate sono contenute le risposte dei seguenti letterati ecc. italiani: Angiolo Silvio Novaro, prof. Alfredo Poggi, prof. Enrico Catellani, Raffaele Ottolenghi, prof. Bernardino Varisco, Augusto Agabiti, prof. A. Renda, Vittore Marchi, direttore del giornale «Dio e Popolo», Ugo Janni, pastore valdese, A. Paolo Nunzio, Pietro Ridolfi Bolognesi, Nicola Toscano Stanziale, direttore della «Rassegna Critica», Dott. Giuseppe Gasco, Luigi Di Mattia, Ugo Perucci, maestro elementare, prof. Casimiro Tosini, direttore di Scuola Normale, Adolfo Artioli, prof. Giuseppe Morando, direttore della «Rivista Rosminiana», preside del Liceo Ginnasio di Voghera, prof. Alberto Friscia, Vittorio Nardi, Luigi Marrocco, pubblicista, G. B. Penne, Guido Piccardi, Renato Bruni, prof. Giuseppe Rensi.
Q1 §22 Nel 2° volume delle Confessioni e professioni di fede sono contenute le risposte dei seguenti italiani: Del Greco Francesco, prof., direttore di Manicomio, Alessandro Bonucci, prof. Università, Francesco Cosentini, prof. Università, Luigi Pera, medico, Filippo Abignente, direttore del «Carattere», Giampiero Turati, Bruno Franchi, redattore‑capo della «Scuola Positiva di Diritto Criminale», Manfredi Siotto‑Pintor, prof. Università, Enrico Caporali, prof., Giovanni Lanzalone, direttore della rivista «Arte e Morale», Leonardo Gatto Roissard, tenente degli Alpini, Pietro Raveggi, pubblicista, Widar Cesarini‑Sforza, Leopoldo De Angelis, prof. Giovanni Predieri, Orazio Bacci, Giuseppe Benetti, pubblicista, prof. G. Capra‑Cordova, Costanza Palazzo, Pietro Romano, Giulio Carvaglio, Leone Luzzatto, Adolfo Faggi, prof. Università, Ercole Quadrelli, Carlo‑Francesco Gabba, senatore, prof. Università, Dott. Ernesto Lattes, pubblicista, Settimio Corti, prof. di filosofia, B. Villanova D’Ardenghi, pubblicista (Bruno Brunelli), Paolo Calvino, pastore evangelico, Giuseppe Lipparini, prof., Prof. Oreste Ferrini, Luigi Rossi Casè, prof., Prof. Antioco Zucca, Vittoria Fabrizi de’ Biani, Guido Falorsi, prof., Prof. Benedetto De Luca, pubblicista, Giacomo Levi Minzi (bibliofilo marciano), prof. Alessandro Arrò, Bice Sacchi, prof. Ferdinando Belloni‑Filippi, Nella Doria Cambon, prof. Romeo Manzoni.
Q1 §23 Nel volume 3° delle Confessioni e professioni di fede: Romolo Murri, Giovanni Vidari, prof. Università, Luigi Ambrosi, prof. Università, Salvatore Farina, Angelo Flavio Guidi, pubblicista, Conte Alessandro D’Aquino, Baldassarre Labanca, prof. di Storia del Cristianesimo all’Università, Giannino Antona‑Traversi, autore drammatico, Mario Pilo, prof., Alessandro Sacchi, prof. Università, Angelo De Gubernatis, Giuseppe Sergi, prof. Università, Adolfo Zerboglio, prof. Università, Vittorio Benini, prof., Paolo Arcari, Andrea Lo Forte Randi, Arnaldo Cervesato, Giuseppe Cimbali, prof. Università, Alfredo Melani, architetto, Giovanni Preziosi, Silvio Adrasto Barbi, prof., Massimo Bontempelli, Achille Monti, prof. Università, Velleda Benetti, studentessa, Achille Loria, Francesco Pietropaolo, prof., Amilcare Lauria, prof., Eugenio Bermani, scrittore, Ugo Fortini Del Giglio, Luigi Puccio, avv., Maria Nono Villari, scrittrice, Gian Pietro Lucini, Angelo Valdarnini, prof. Università, Teresina Bontempi, ispettrice degli asili d’infanzia nel Canton Ticino, Luigi Antonio Villari, Guido Podrecca, Alfredo Panzini, Amedeo Massari, avv., Giuseppe Barone, prof., Giulio Caprin, Gabriele Morelli, avv., Riccardo Gradassi‑Luzi, Torquato Zucchelli, tenente colonnello onorario (sic), Ricciotto Canudo, Felice Momigliano, prof., Attilio Begey, Antonino Anile, prof. Università, Enrico Morselli, prof. Università, Francesco Di Gennaro, Ezio Maria Gray, Roberto Ardigò, Arturo Graf, Pio Viazzi. Innocenzo Cappa, duca Colonna di Cesarò, P. Villari, Antonio Cippico, Alessandro Groppali, prof. Università, Angelo Marzorati, Italo Pizzi, Angelo Crespi, E. A. Marescotti, F. Belloni‑Filippi, prof. Università, Francesco Porro, astronomo, Fortunato Rizzi, prof.
Q1 §24 I nipotini del padre Bresciani. Esame di una parte cospicua della letteratura narrativa italiana, specialmente di questo ultimo decennio. La preistoria del Brescianesimo moderno: 1°) Antonio Beltramelli, con Gli Uomini Rossi, Il Cavalier Mostardo ecc.; 2°) Polifilo (Luca Beltrami), con le diverse storie su Casale Olona; 3°) la letteratura abbastanza vasta, più tecnicamente di «sagrestia», in generale poco conosciuta e studiata, nella quale il carattere propagandistico è apertamente confessato.
A mezza strada tra la letteratura di sagrestia e il Brescianesimo laico sono i romanzi di Giuseppe Molteni, dei quali conosco solo l’Ateo. L’aberrazione morale di questo libro è tipica: in esso si riflette lo scandalo Don Riva ‑ suor Fumagalli. L’autore giunge fino ad affermare che appunto data la sua qualità di prete, legato al voto di castità, bisogna compatire Don Riva (che ha violentato e contagiato una trentina di bambine) e crede che a questo massacro possa essere contrapposto, come moralmente equivalente, il volgare adulterio di un socialista ateo. Il Molteni è un uomo molto noto nel mondo clericale: è stato critico letterario e articolista di tutta una serie di quotidiani e di periodici cattolici.
Il Brescianesimo laico assume una certa importanza nel dopoguerra e va sempre più diventando la «scuola» letteraria preminente e ufficiale.
Ugo Ojetti, Mio figlio ferroviere. Caratteristiche generali della letteratura di Ojetti. Suoi diversi atteggiamenti ideologici. Scritti su Ojetti di Giovanni Ansaldo nelle riviste dove l’Ansaldo collaborava. Ma la manifestazione più tipica di Ugo Ojetti è la sua lettera aperta al padre Rosa, pubblicata nel «Pègaso» e riprodotta nella «Civiltà Cattolica» col commento del padre Rosa. L’Ojetti dopo l’annunzio della avvenuta conciliazione tra Stato e Chiesa non solo era persuaso che ormai tutte le manifestazioni intellettuali italiane sarebbero state controllate secondo uno stretto conformismo cattolico e clericale, ma si era già adattato a questa idea, e si rivolgeva al padre Rosa con uno stile untuosamente adulatorio delle benemerenze culturali della Compagnia di Gesù per impetrare una «giusta» libertà artistica. Non si può dire, alla luce degli avvenimenti posteriori (discorsi del capo del governo) se sia più abbietta la prostrazione dell’Ojetti o più comica la sicura baldanza del padre Rosa, che in ogni caso dava una lezione di carattere all’Ojetti, al modo dei gesuiti, già si intende. Il caso Ojetti è stato tipico da più punti di vista: ma la codardia intellettuale dell’uomo eccelle su tutto.
Alfredo Panzini – già nella preistoria con qualche brano della Lanterna di Diogene (l’episodio del livido acciaro per esempio)–, Il padrone sono me, Il mondo è rotondo e quasi tutti i libri dell’ultimo decennio. Sul recente I giorni dei sole e del grano vedi giudizio di F. Palazzi già annotato. Nella Vita di Cavour un accenno al padre Bresciani veramente strabiliante. Tutta la letteratura pseudo‑storica del Panzini è da riesaminare dal punto di vista del Brescianesimo laico. Episodio Croce‑Panzini, riferito recentemente nella «Critica», è un caso di gesuitismo personale, oltre che letterario.
Salvator Gotta nel suo «Ciclo dei Vela» deve ricadere specificamente nel Brescianesimo, oltre che genericamente in tutta la sua produzione.
Margherita Sarfatti e il Palazzone. Cfr nota precedente sulle sue «giostre». Su questo punto ci sarebbe da spassarsi assai: ricordare l’episodio leggendario di Dante e la prostituta di Rimini (?) riportato nella raccolta Papini (Carabba) di leggende e aneddoti su Dante; per dire che di «giostre» può parlar l’uomo, non la donna; ricordare l’espressione di Chesterton nella Nuova Gerusalemme sulla chiave e la serratura a proposito della lotta dei sessi: per dire che il «punto di vista» della chiave non può essere quello della serratura. Ricordare che G. Bellonci, il «fine» intenditore di cose artistiche e che civetta volentieri con l’erudizione preziosa (a buon mercato) per fare spicco tra il giornalistume, trova naturale che la vergine Fiorella pensi alle giostre.
Mario Sobrero, Pietro e Paolo, può rientrare nel quadro generale per il chiaroscuro.
Francesco Perri, Gli emigranti. Questo Perri non è poi il Paolo Albatrelli dei Conquistatori? Tener conto in ogni modo anche dei Conquistatori. Gli Emigranti: la caratteristica più appariscente è la rozzezza, ma una rozzezza non da principiante ingenuo, che in tal caso potrebbe essere il grezzo non elaborato che però lo può diventare, ma una rozzezza opaca, materiale, non da primitivo ma da decadente. Romanzo verista (vedi articolo del Perri nella «Fiera Letteraria»); ma può esistere «verismo» non storicista? Il verismo stesso è una continuazione del vecchio romanzo storico nell’ambiente dello storicismo moderno (del secolo XIX). Negli Emigranti non c’è accenno alcuno cronologico. È questa una cosa casuale? Non pare. Due riferimenti generici: il fenomeno dell’emigrazione meridionale che ha avuto un decorso storico e un tentativo di invasione delle terre signorili usurpate che anch’esso può essere fatto rientrare in un’epoca determinata.
Storicamente il fenomeno emigratorio ha creato un’ideologia (il mito dell’America), come ad una ideologia è legato il fenomeno dei tentativi sporadici ma endemici di invasioni di terre prima della guerra (tutt’altro è il movimento del ’19‑’20, che è generalizzato, e che ha una organizzazione implicita nel combattentismo meridionale). Negli Emigranti l’uno e l’altro fenomeno si riflettono in modo rozzo, brutale, senza preparazione né generica né specifica, in modo meccanico. È evidente che il Perri conosce l’ambiente popolare contadino: calabrese non immediatamente, per esperienza sentimentale e psicologica diretta, ma per il tramite dei vecchi clichés regionalistici (se egli è l’Albatrelli occorre tener conto delle sue origini politiche). Il fatto dell’occupazione delle terre a Pandure nasce da intellettuali, su una base giuridica, e si termina nel nulla, come se non avesse sfiorato neppure le abitudini di un villaggio patriarcale. Puro meccanismo. Così l’emigrazione. Questo villaggio di Pandure, con la famiglia di Rocco Blefasi, è (per dirla con una frase di Leonida Rèpaci)) un parafulmine di tutti i guai.
Insistenza su errori di parole, è tipica nel brescianismo. Le «macchiette» (il Galeoto, ecc.) pietose. La mancanza di storicità è «ricercata» per poter mettere in un sacco alla rinfusa tutti i motivi folkloristici generici, che in realtà sono molto ben distinti nel tempo, oltre che nello spazio.
Leonida Rèpaci), L’ultimo Cireneo. Si può vedere come la ficelle è stata intrecciata.
Umberto Fracchia. Non ho letto nulla: mi pare che in
ci sono elementi che rientrano in questo quadro. Nella
intelaiatura generale occupano il primo piano
Ojetti‑Beltramelli‑Panzini. Il carattere gesuitesco è in essi
più appariscente e più importante è il posto che essi occupano
nella valutazione più corrente (oltre che per un certo
riconoscimento ufficiale: Beltramelli e Panzini nell’Accademia).
Vedere libri di divulgazione critica (tipico deve essere il
recente libro di Camillo Pellizzi). (Continua).
Q1 §25 Achille Loria. A proposito di Achille Loria bisogna ricordare i principali documenti in cui si trovano le principali «stranezze»:
1° Sull’influenza sociale dell’aeroplano, nella «Rassegna Contemporanea» diretta dal Colonna di Cesarò e da (Vincenzo) Picardi del 1912: in questo articolo si incontra la teoria sull’emancipazione operaia dalla coercizione della fabbrica per mezzo degli svolazzamenti sugli aeroplani unti di vischio. Tutto l’articolo è un monumento mostruoso di insulsaggini e stoltezze: la caduta del credito fiduciario, lo sfrenarsi delle birbonate sessuali (adulteri, seduzioni), l’ammazzamento sistematico dei portinai per le cadute dei cannocchiali, la teoria del grado di moralità secondo l’altezza al livello del mare, con la proposta pratica di rigenerare i delinquenti costruendo le prigioni sui monti o addirittura su immensi aeroplani che stiano sempre ad alta quota ecc.
2° La conferenza tenuta a Torino durante la guerra e pubblicata nella Nuova Antologia (del 1916 o 1917) dove l’unico «documento concreto» sul Dolore universale (deve essere anche questo il titolo della conferenza) riportato era la nota di ciò che costa la «claque» agli attori di teatro (da una statistica fissata dal Reina) e dove si trova questo ragionamento: «la natura provvida ha creato l’antidoto contro questo avvelenamento universale del dolore, dando ai poverelli che sono costretti a pernottare all’aria aperta una pelle più spessa».
3° L’articolo pubblicato nel «Palvese» di Trieste verso il 1910 o 1911 riguardante la scienza del linguaggio e intitolato press’a poco: Perché i bergamaschi triplicano e i veneziani scempiano. Questo articolo era stato inviato dal Loria al Comitato organizzato a Trieste per le onoranze ad Attilio Hortis in occasione del cinquantenario della sua attività letteraria e che doveva mettere insieme una Miscellanea in onore del festeggiato (uscita infatti in quel torno di tempo). Il Comitato non poteva pubblicare l’articolo per la sua insulsaggine, ma non voleva neppure mancare di riguardi al Loria che era un esponente illustre della scienza italiana: se la cavò, scrivendo al Loria che la Miscellanea era ormai completa e che il suo articolo era stato passato al (settimanale) letterario il «Palvese». L’articolo espone un aspetto (quello linguistico) della teoria loriana sull’influenza dell’altimetria sulla civiltà: i montanari, moralmente più puri, sono fisicamente più robusti e «triplicano» le consonanti, la gente di pianura (guai poi se sta al livello del mare come i veneziani) invece, oltre che moralmente depravata, è anche fisicamente degenerata e «scempia» le consonanti.
4° La prefazione alla 1ª edizione del Corso di Economia Politica importante anche perché vi si trova la istoria del suo «ritrovamento» del materialismo storico: vi si espone la teoria della connessione tra «misticismo» e «sifilide».
5° Lo scritto nella Riforma Sociale del Settembre‑Ottobre 1929: Documenti ulteriori a suffragio dell’economismo storico. Questi cinque documenti sono i più vistosi che io ricordo, ma la quistione è interessante appunto perché nel Loria non si tratta di qualche caso di obnubilamento dell’intelligenza occasionale, sia pure con ricadute. Si tratta di un filone, di una continuità sistematica, che accompagna tutta la sua carriera letteraria. Non si può neanche negare che il Loria sia uomo d’un certo ingegno e che abbia del giudizio. In tutta una serie di articoli le «stranezze» appaiono qua e là, e anche di un certo tipo, legate cioè a determinati modi di pensiero. Per esempio si è vista la «teoria» altimetrica apparire nella quistione dell’aeroplano e in quella «linguistica». Così in un articoletto pubblicato nella «Proda» (o «Prora», usciva a Torino durante la guerra, diretto da un certo Cipri‑Romanò, un giornalettucolo un po’ losco, certamente di bassissima speculazione ai margini della guerra e dell’antidisfattismo) si dividevano i protagonisti della guerra in mistici (gl’imperi centrali) e positivisti (Clemenceau e Lloyd George): ricchi di elementi sono la poesia Al mio bastone pubblicata nella Nuova Antologia (durante la guerra) e l’articolo sull’epistolario di Marx (pure nella «Nuova Antologia»).
La «leziosità letteraria» notata dal Croce in Loria è un elemento secondario del suo squilibrio, ma che ha una certa importanza in quanto si manifesta continuamente. Un altro elemento è la pretesa all’«originalità» intellettuale a tutti i costi. Un certo opportunismo di bassa estrazione non manca spesso: ricordo due articoli pubblicati a distanza breve, uno nella «Gazzetta del Popolo» (ultra reazionaria), l’altro nel «Tempo» di Pippo Naldi (nittiano), sullo stesso argomento (la Russia) e con un’immagine del Macaulay che nell’uno era usata in un senso e nell’altro nel senso opposto.
A proposito dell’osservazione di Croce sui «servi a spasso» e sulla loro importanza nella sociologia loriana, ricordare un capocronaca della «Gazzetta del Popolo» del ’19 o ’20 in cui si parla degli intellettuali come di quelli che tengono dritta la «scala d’oro» sulla quale sale il popolo, con avvertimenti al popolo di tenersi buoni questi intellettuali ecc.
Loria non è un caso teratologico individuale: è l’esemplare più compiuto e finito di una serie di rappresentanti di un certo strato intellettuale di un certo periodo; in generale degli intellettuali positivisti che si occupano della quistione operaia e che più o meno credono di approfondire, o correggere, o superare il Marxismo. Enrico Ferri – Arturo Labriola – lo stesso Turati potrebbero dare una messe di osservazioni e di aneddoti.
In Luzzatti, in un altro campo sarebbe da mietere.
Ma non bisogna dimenticare Guglielmo Ferrero e Corrado Barbagallo. Nel Barbagallo forse la manifestazione è più occasionale che negli altri: pure il suo scritto sul capitalismo antico pubblicato nella «Nuova Rivista Storica» del 1929 è estremamente sintomatico (con la postilla un po’ comica che segue al successivo articolo del Sanna). In generale dunque il Lorismo è un carattere di certa produzione letteraria e scientifica del nostro paese (molti documenti di esso si trovano nella «Critica» di Croce, nella «Voce» di Prezzolini, nell’«Unità» di Salvemini) connesso alla scarsa organizzazione della cultura e quindi alla mancanza di controllo e di critica.
Q1 §26 L’ossicino di Cuvier. Osservazione legata alla nota precedente. Il caso Lumbroso. Da un ossicino di topo si ricostruiva talvolta un serpente di mare.
Q1 §27 Postumi del basso romanticismo? La tendenza della sociologia di sinistra in Italia a occuparsi della criminalità. Legata al fatto che a tale corrente avevano aderito Lombroso e altri che parevano allora la suprema espressione della scienza? O un postumo del basso romanticismo del 48 (Sue ecc.)? O legato al fatto che in Italia impressionava questi uomini la grande quantità di reati di sangue ed essi credevano di non poter procedere oltre senza aver spiegato «scientificamente» questo fenomeno?
Q1 §28 Diritto naturale. Vedi le due noticine precedenti a p. 2 e a p. 3 bis. Nella polemica presente contro il diritto naturale non bisogna cercare una intenzione scientifica qualunque. Si tratta di esercitazioni giornalistiche non molto brillanti, che si propongono lo scopo propagandistico di distruggere certi stati d’animo molto diffusi e che sono ritenuti pericolosi.
A questo proposito vedere l’opuscolo del Tilgher su «Storia e Antistoria», dal quale apparirebbe che mai come oggi la mentalità illuministica da cui è nata la teoria del diritto naturale è diffusa. L’opuscolo del Tilgher, a suo modo, è una riprova di tale diffusione, perché il Tilgher cerca con esso di farsi un posticino al nuovo sole. Mi pare che chi studi con una certa profondità (se si astrae dal linguaggio sforzato) le contraddizioni psicologiche che nascono sul terreno dello storicismo, come concezione generale della vita e dell’azione, sia Filippo Burzio. Per lo meno la sua affermazione: «essere sopra alle passioni e ai sentimenti pur provandoli» mi pare ricca di molte conseguenze. Infatti questo è il nodo della quistione dello «storicismo» che il Tilgher non sfiora neppure: «come si possa essere critici e uomini d’azione nello stesso tempo, in modo non solo che l’uno aspetto non indebolisca l’altro, ma anzi lo convalidi». Il Tilgher scinde molto meccanicamente i due aspetti di ogni personalità umana (dato che non esiste e non è mai esistito un uomo tutto critico e uno tutto passionale) invece di cercare di determinare come in diversi periodi storici i due aspetti si combinino in modo che nel mondo della cultura prevalga una corrente o l’altra. (L’opuscolo del Tilgher lo dovrò ancora rivedere).
Q1 §29 Il sarcasmo come espressione di transizione negli storicisti. In un articolo di Bonaventura Tecchi Il Demiurgo di Burzio («Italia letteraria», 20 ottobre 1929) da cui è preso lo spunto succitato del Burzio, si accenna spesso all’elemento «ironia» come caratteristico di questa posizione. «Ironia» è giusto per la letteratura, per indicare il distacco dell’artista dal contenuto sentimentale della sua creazione: ma nel caso dell’azione storica, l’elemento «ironia» sarebbe appunto troppo letterario (basterebbe dire semplicemente «letterario») e indicherebbe una forma di distacco connessa piuttosto allo scetticismo più o meno dilettantesco (dovuto a disillusione, a stanchezza o anche a «superominismo»). Invece in questo caso (cioè dell’azione storica) l’elemento caratteristico è il «sarcasmo» e in una sua certa forma, cioè «appassionato». In Marx troviamo l’espressione più alta anche esteticamente, del «sarcasmo appassionato». Da distinguere da altre forme, in cui il contenuto è opposto a quello di Marx. Di fronte alle «illusioni» popolari (credenza nella giustizia, nell’uguaglianza, nella fraternità, cioè negli elementi della «religione dell’umanità») Marx si esprime con «sarcasmo» appassionatamente «positivo», cioè si capisce che egli non vuol dileggiare il sentimento più intimo di quelle «illusioni» ma la loro forma contingente legata a un determinato mondo «perituro», il loro puzzo di cadavere, per così dire, che trapela dal belletto. C’è invece il sarcasmo di «destra», che raramente è appassionato, ma è sempre «negativo», puramente distruttivo, non solo della «forma» contingente, ma del contenuto «umano» di quei sentimenti. (A proposito di questo «umano» vedi in Marx stesso quale significato occorre dargli, specialmente la Sacra Famiglia). Marx cerca di dare a certe aspirazioni una forma nuova (quindi cerca di rinnovare anche queste aspirazioni) non di distruggerle: il sarcasmo di destra cerca di distruggere invece proprio il contenuto di queste aspirazioni, e in fondo l’attacco alla loro forma non è che un espediente «didattico».
Questa nota sul «sarcasmo» dovrebbe poi analizzare alcune manifestazioni di esso: c’è stata una manifestazione «meccanica», pappagallesca (o che è diventata tale per l’«abuso») che ha dato luogo anche a una specie di cifra o gergo e che potrebbe dar luogo a osservazioni piccanti (per es. quando le parole «civiltà» o «civile» sono sempre accompagnate dall’aggettivo «sedicente» può nascere il dubbio che si creda nell’esistenza di una «civiltà» astratta, esemplare, o almeno ci si comporta come se si credesse, cioè si ottiene proprio il risultato opposto a quello che probabilmente si voleva ottenere); e c’è da analizzare la sua significazione in Marx, di una espressione transitoria, che cerca di porre il distacco dalle vecchie concezioni in attesa che le nuove concezioni, con la loro saldezza acquistata attraverso lo sviluppo storico, dominino fino ad acquistare la forza delle «convinzioni popolari». Queste nuove concezioni esistono già in chi adopera il «sarcasmo», ma nella fase ancora «polemica»; se fossero espresse «senza sarcasmo» sarebbero una «utopia» perché solo individuali o di piccoli gruppi. D’altronde lo stesso «storicismo» non può concepirle come esprimibili in questa forma apodittica o predicatoria; lo «storicismo» crea un «gusto» nuovo e un linguaggio nuovo. Il «sarcasmo» diventa il componente di tutte queste esigenze, che possono apparire come contradittorie. Ma il suo elemento essenziale è sempre la «passionalità».
Da questo punto di vista occorre esaminare le ultime affermazioni del Croce nella sua prefazione del 1917 al Materialismo Storico a proposito della «maga Alcina».
Ricordare l’articolo di L. Einaudi nella «Riforma Sociale», su questa prefazione del Croce, per discutere l’importanza culturale del Marx nella rinascita della storiografia economica.
Q1 §30 Orano e Loria. Nella precedente nota su Loria ho dimenticato di ricordare le «stranezze» di Paolo Orano. Ne ricordo ora due: l’articolo «Ad metalla» nel volume Altorilievi (ed. Puccini, Milano), tipicamente «loriano», e il suo volumetto sulla Sardegna (credo sia uno dei primi libri dell’Orano) dove parla del «liquido ambiente». Nei medaglioni ci deve essere, se ben ricordo, da spulciare parecchio e così in tutte le altre pubblicazioni.
Q1 §31 Lettere del Sorel al Croce. Nelle lettere del Sorel al Croce si può spigolare più di un elemento sul «lorismo» o «lorianismo». Per esempio, il fatto che nella tesi di laurea di Arturo Labriola si scrive come se si credesse che il Capitale di Marx è stato elaborato sull’esperienza economica francese e non su quella inglese.
Q1 §32 Loria e Lumbroso. Alberto Lumbroso è da collocare nella serie loriana ma da un altro punto di vista e in un altro campo. Si potrebbe fare una introduzione generale che servirebbe appunto a dimostrare come Loria non sia una eccezione unica, ma si tratti in gran parte di un fatto generale di cultura, che poi si è «tumefatto» nel campo della «sociologia». In questa parte appunto possono dare elementi la «Critica», la «Voce» e l’«Unità». (Ricordare per esempio «la casa dei parti» di Tomaso Sillani, la «gomma di Vallombrosa» di Filippo Carli, del quale è anche notevole l’articolo della «Perseveranza» sul prossimo ritorno trionfale della navigazione a vela; la letteratura economica dei protezionisti vecchia covata è piena di molte preziosità del genere, di cui un ricordo può rintracciarsi negli scritti del Belluzzo sulle possibili ricchezze nascoste nelle montagne italiane). Tutti questi elementi piuttosto generici del «lorianismo» potrebbero servire per «agrémenter» l’esposizione. Così si potrebbe ricordare come limite «assurdo», perché sconfina nel caso clinico (tecnicamente clinico), la candidatura del Lenzi al IV collegio di Torino, con l’«aereo cigno» e con la proposta di radere le montagne italiane, ingombranti, per trasportarne il materiale in Libia e fertilizzare così il deserto di sabbia.
Il caso del Lumbroso è molto interessante, perché suo padre era un erudito di gran marca (Giacomo Lumbroso: ma la metodologia dell’erudizione non si trasmette per generazione e neppure per il contatto intellettuale anche il più assiduo, a quanto pare.
C’è da domandarsi, nel caso Lumbroso, come i suoi due ponderosi volumi sulle Origini Diplomatiche e politiche della guerra abbiano potuto essere accolti nella Collezione Gatti. Qui la responsabilità del sistema è evidente. Così per Loria e la «Riforma Sociale» e per Luzzatti e il «Corriere della Sera» (a proposito di Luzzatti ricordare il caso del «fioretto» di S. Francesco pubblicato come inedito dal «Corriere della Sera» del 1913 — mi pare —, con un commento economico spassosissimo, proprio dal Luzzatti che aveva poco prima pubblicato un’edizione dei Fioretti nella Collezione Notari; il così detto «inedito» era una variante inviata al Luzzatti dal Sabatier. Del Luzzatti famose le frasi, tra le quali «Lo sa il tonno» in un articoletto del «Corriere» che poi ha dato lo spunto al libro del Bacchelli).
Q1 §33 Freud. La diffusione della psicologia freudiana pare che dia come risultato la nascita di una letteratura tipo 700; al «selvaggio», in una forma moderna, si sostituisce il tipo freudiano. La lotta contro l’ordine giuridico viene fatta attraverso l’analisi psicologica freudiana. Questo è un aspetto della quistione, a quanto pare. Non ho potuto studiare le teorie di Freud e non conosco l’altro tipo di letteratura così detta «freudiana» Proust‑Svevo‑Joyce.
Q1 §34 Il Pragmatismo americano. Si potrebbe dire del pragmatismo americano (James), ciò che Engels ha detto dell’agnosticismo inglese? (Mi pare nella prefazione inglese al Passaggio dall’Utopia alla Scienza).
Q1 §35 Riviste tipo. Teorica: «storiografia» specialmente. Molto unitaria, quindi pochi collaboratori «principali», cioè che scrivano il corpo principale di ogni fascicolo. Il tipo più corrente non può essere che quello medio, di una rivista legata all’attualità e i cui articoli siano di tipo divulgativo, espositivo. L’esperienza ha insegnato che anche in questo tipo occorre una certa omogeneità, o per lo meno una forte organizzazione interna redazionale che fissi molto chiaramente (e per iscritto) il terreno comune di lavoro.
Il primo tipo può essere dato dalla «Critica» di B. Croce + la «Politica» di Coppola.
Il secondo tipo dalla «Voce» di Prezzolini prima e seconda maniera + «Unità» di Salvemini.
Un terzo tipo molto interessante si può ricavare dai numeri meglio riusciti del «Leonardo» di L. Russo + «L’Italia che scrive» del Formiggini.
Un’organizzazione unitaria di cultura che organizzasse i tre tipi con una casa editrice di collezioni «librarie» connesse alle riviste, darebbe soddisfazione alle esigenze di quella massa di pubblico che è più attiva intellettualmente e che più importa far pensare e trasformare.
Q1 §36 Lorianismo. Ricordare il libro del prof. Alberto Magnaghi sui geografi spropositanti: questo libro è un modello del genere.
Non ricordo il titolo esatto né il nome dell’editore. Credo che non fosse stato Messo in commercio.
Ricordare il primo volume (ediz. Lumachi o Ferr. Gonnelli) sulla Cultura Italiana di Papini e Prezzolini.
Q1 §37 Turati e il lorianismo. Il discorso sulle «salariate dell’amore» mi pare da connettere al lorianismo. Di Turati si possono raccogliere alcuni tratti di «cattivo gusto» sul genere di «lecca, popol sovrano, lecca ma ascolta».
Q1 §38 Riviste tipo. Terzo tipo. Critico‑ storico‑bibliografico.
Esami analitici di libri, per lettori che non possono, in generale, leggere i libri stessi.
Uno studioso che esamina un fenomeno storico per costruire un lavoro sintetico, deve compiere tutta una serie di operazioni preliminari, che solo in piccola parte, in ultima analisi, risultano utilizzabili. Questo lavoro è utilizzabile invece per questo tipo di rivista, dedicata a un tipo determinato di lettore, al quale occorre, oltre all’opera sintetica, presentare l’attività analitica prelirninare nel suo complesso. Il lettore comune non ha e non può avere un abito «scientifico» che solo viene dato dal lavoro specializzato: occorre perciò aiutarlo con una attività letteraria opportuna. Non basta dargli dei «concetti» storici; la loro concretezza gli sfugge: occorre dargli serie intiere di fatti specifici, molto individualizzati. Un movimento storico complesso si scompone nel tempo e nello spazio da una parte e in piani diversi (problemi speciali) dall’altro, anch’essi scomponibili nel tempo e nello spazio. Un esempio: l’Azione Cattolica.
Essa ha avuto sempre una direttiva centrale e centralizzata, ma anche una grande varietà di atteggiamenti regionali nei diversi tempi. L’Azione Cattolica nata specificatamente dopo il ’48 era molto diversa da quella attuale riorganizzata da Pio XI. La posizione dell’A. C. subito dopo il ’48 può essere caratterizzata con la stessa osservazione che uno storico ha fatto a proposito di Luigi XVIII: Luigi XVIII non riusciva a persuadersi che nella Francia dopo il 1815 la monarchia dovesse avere un partito politico specifico per sostenersi. Tutti i ragionamenti fatti dagli storici cattolici per spiegare la nascita dell’A. C. e i tentativi per riallacciare questa nuova formazione a movimenti e attività precedenti, sono fallacissimi.
Dopo il ’48 in tutta Europa (in Italia la crisi finale assume la forma specifica di fallimento del neoguelfismo) è superata vittoriosamente per il liberalismo (inteso come concezione della vita oltre che come azione politica positiva) la lotta con la concezione «religiosa» della vita. Prima si formavano dei partiti contro la religione, più o meno effimeri; ora la religione «deve» avere un partito suo, non può più parlare (altro che ufficialmente, perché non confesserà mai questo stato di cose) come se sentisse ancora di essere la premessa necessaria, universale di ogni modo di pensare e di agire. Molti oggi non riescono più neanche a persuadersi che così potesse essere una volta.
Per dare un’idea di questo fatto si potrebbe dare questo modello: — oggi nessuno pensa sul serio a fondare un partito contro il suicidio (è possibile che esista in qualche parte qualche associazione contro il suicidio, ma è un’altra cosa), perché non esiste un partito che cerchi persuadere gli uomini che bisogna suicidarsi in massa (sebbene siano apparsi singoli individui e anche piccoli gruppi che hanno sostenuto forme simili di nichilismo radicale, pare in Ispagna); la «vita» è la premessa necessaria di ogni manifestazione di vita evidentemente.
La religione ha avuto una funzione simile e se ne trovano abbondanti tracce nel linguaggio e nei modi di pensare dei contadini: cristiano e uomo significa la stessa cosa («Non sono cristiano» «E allora cosa sei, un animale? »): i coatti dicono: «cristiani e coatti» (in principio ad Ustica mi maravigliavo perché all’arrivo del vaporetto qualche coatto diceva: «sono tutti cristiani, non ci sono che cristiani, non c’è neanche un cristiano»: in carcere invece si dice più comunemente «borghesi e detenuti» o scherzosamente «borghesi e soldati» sebbene i meridionali dicano anche «cristiani e detenuti»), sarebbe interessante studiare tutta la serie di passaggi semantici per cui nel francese da «cristiano» si è venuti a «crétin» (donde il «cretino» italiano) e addirittura a «grédin»; il fenomeno deve essere simile a quello per cui «villano» da «uomo di campagna» ha finito col significare «screanzato» e addirittura «mascalzone», cioè il nome «cristiano» usato dai contadini per indicare se stessi come «uomini» si è, nella forma più popolare, staccato da «cristiano» in senso religioso e ha avuto la stessa sorte di «manant». Forse anche il russo «krestianin», «contadino» ha la stessa origine mentre «cristiano» religioso, forma più colta, ha mantenuto l’aspirazione del χ greco.
Forse a questa concezione è legato anche il fatto (bisogna poi vedere se è vero) che molti contadini russi, che non conoscevano personalmente gli ebrei, credevano che gli ebrei avessero la coda o altro attributo animalesco.
L’esame storico del movimento dell’A. C. può dar luogo, analiticamente, a diverse serie di ricerche e di studi.
I Congressi Nazionali. Come sono preparati dalla stampa centrale e locale. Il materiale ufficiale preparatorio: relazioni ufficiali e d’opposizione.
L’Azione Cattolica è stata sempre un organismo complesso, anche prima della costituzione della Confederazione bianca del Lavoro e del Partito Popolare, il quale non può non essere considerato parte politicamente integrante dell’A. C. anche se ufficialmente ne era separato. La stessa complessità si verificava e si verifica anche nel campo internazionale: l’A. C. ufficialmente si accentra nella persona del Papa, che è centro internazionale per eccellenza, ma di fatto esiste più di un ufficio che funziona da centro internazionale più esplicitamente politico, come l’Ufficio di Malines che ha compilato il Codice Sociale o come un ufficio di Friburgo per l’azione sindacale (verificare).
Svolgimento dei Congressi. — Ciò che viene messo all’ordine del giorno e ciò che viene omesso per evitare dissensi radicali. — L’ordine del giorno dovrebbe risultare dai problemi concreti che nello spazio tra un Congresso e l’altro si sono imposti alla soluzione, oltre che dai punti generali dottrinari intorno ai quali si formano le correnti e le frazioni. Su quale base vengono scelte o rinnovate in parte le direzioni? Sulla base di una tendenza generica alla quale si dà una fiducia generica, oppure dopo che il Congresso stesso ha fissato un indirizzo concreto e preciso di attività? La democrazia interna di un movimento (il grado più o meno grande di democrazia interna, cioè di partecipazione della base del P. alle decisioni e alla fissazione del programma) si può misurare e giudicare anche e forse specialmente a questa stregua. — Altro elemento importante è la composizione sociale dei Congressi, degli oratori e della direzione eletta, in rapporto alla composizione sociale del P. — I giovani e i loro rapporti con gli adulti. I Congressi si occupano del movimento giovanile che dovrebbe essere la fonte maggiore per il reclutamento e la migliore scuola per il P. stesso? — Che influenza hanno sui congressi di P. le organizzazioni subordinate al P. (o che dovrebbero essere subordinate): il gruppo parlamentare o gli organizzatori sindacali ecc.? Viene fatta organicamente. una posizione speciale nei congressi ai deputati e agli organizzatori sindacali?
Q1 §39 Répaci. I nipotini del padre Bresciani. Nella sua novella (autobiografica) Crepuscolo («Fiera Letteraria» 3 marzo 1929) scrive: «A quell’epoca io già schieravo dentro di me, fortificandole ogni giorno sulle ime radici dell’istinto, quelle belle qualità che più tardi, negli anni a venire, avrebbero fatto di me una centrale di guai: l’amore dei vinti, degli offesi, degli umili, lo sprezzo del pericolo per la giusta causa, l’indipendenza del carattere che palesa la rettitudine, l’orgoglio matto che braveggia persino sulle rovine, ecc. ecc. ».
Q1 §40 La «formula» di Léon Blum. Le pouvoir est tentant. Mais seule l’opposition est confortable.
Q1 §41 Lorianismo.— Luzzatti. Ricordare l’episodio alla Camera dei Deputati o al Senato nel 1911 o 12, quando fu proposta una cattedra speciale all’Università di Roma di «filosofia della storia» per Guglielmo Ferrero. Il ministro Credaro, mi pare in risposta al Croce (quindi al Senato) che aveva parlato contro la cattedra, fra l’altro giustificò la «filosofia della storia» con l’importanza che i filosofi avevano avuto nello svolgimento della storia (sic), esempio... Cicerone. Luzzatti assentì gravemente: «È vero, è vero!»
Q1 §42 I nipotini di padre Bresciani. — Curzio Malaparte ‑ Kurt Erich Suckert. Lo sfoggio del nome straniero nel periodo del dopoguerra. — Sua appartenenza all’organizzazione italiana di Guglielmo Lucidi che arieggiava alla «Clarté» francese e al «Controllo democratico» inglese e pubblicava la «Rivista (o Rassegna) Internazionale»; nella collezione di questa rivista pubblica La rivolta dei santi maledetti poi «brescianescamente» corretta nella edizione successiva e, credo, ritirata dal commercio in un terzo periodo.
A proposito dell’«esibizione» del nome straniero notare una corrente generale degli «intellettuali» italiani «moralizzatori» che era portata a ritenere che all’«estero» la gente era più «onesta» che in Italia, oltre che più «capace», più «intelligente» ecc. Questa «esteromania» assumeva forme noiose e talvolta rivoltanti, come in Graziadei, ma era abbastanza generalizzata e dava luogo a una «posa» snobistica: ricordate il breve colloquio con Prezzolini a Roma nel 24 e la sua affermazione sconsolata: «Avrei dovuto procurare a tempo ai miei figli la nazionalità inglese» o qualcosa di simile. Questo stato di animo non è stato caratteristico solo di alcuni ceti intellettuali italiani: è stato abbastanza diffuso, in certe epoche, anche in Russia, per esempio. Si confonde tutto il popolo con certi strati corrotti della piccola borghesia, molto numerosi specialmente nei paesi agricoli poco sviluppati, che possono essere paragonati, al lumpen‑proletariat delle città industriali (nella maffia siciliana e nella camorra meridionale abbondano questi tipi): si cade nel pessimismo perché le «prediche» moralizzatrici lasciano il tempo che trovano e si arriva a una conclusione implicita di «inferiorità» di un intero popolo, per cui non c’è niente da fare.
Q1 §43 Riviste tipo. Terzo tipo — critico‑storico‑bibliografico —. Nell’esame dei partiti: — fissare lo svolgimento che hanno avuto nel tempo e nello spazio i problemi concreti più importanti — Quistione sindacale — Rapporti tra il partito e i sindacati — Quistione agraria — ecc. ecc. Ogni quistione due aspetti: come è stata trattata teoricamente e come è stata affrontata praticamente.
Un’altra rubrica è quella della stampa, nei suoi diversi aspetti: stampa quotidiana, stampa periodica, opuscoli.
Il gruppo parlamentare. Trattando di una determinata attività parlamentare bisogna tener presenti alcuni criteri di ricerca e di giudizio: quando un deputato di un partito di massa parla in parlamento, ci possono essere tre versioni del suo discorso: 1° la versione degli atti parlamentari, che di solito è riveduta e corretta e spesso edulcorata post festum; 2° la versione dell’organo ufficiale del partito al quale il deputato appartiene: essa è combinata dal deputato d’accordo col corrispondente del giornale in modo da non urtare certe suscettibilità della maggioranza ufficiale del partito e non creare ostacoli prematuri a determinate combinazioni in corso; 3° la versione dei giornali di altri partiti o dei così detti organi della pubblica opinione (giornali a grande diffusione), che è fatta dal deputato d’accordo coi rispettivi corrispondenti in modo da favorire determinate combinazioni in corso: questi giornali mutano da periodo a periodo e secondo i mutamenti delle rispettive direzioni politiche.
Lo stesso criterio può essere esteso al campo sindacale, a proposito dell’interpretazione da dare a determinati movimenti concreti e anche all’indirizzo generale dell’organizzazione sindacale data. Esempi promemoria: la «Stampa», il «Resto del Carlino», il «Tempo» (di Naldi) hanno servito da casse di risonanza e da strumento di combinazioni politiche tanto ai socialisti che ai popolari. Un discorso parlamentare socialista o popolare era presentato sotto un certo aspetto da uno di questi giornali per il suo pubblico, mentre era presentato sotto un altro aspetto dagli organi socialisti o popolari. I giornali popolari tacevano addirittura per il loro pubblico certe affermazioni dei loro deputati che tendevano a rendere possibile un avvicinamento ai socialisti, ecc. ecc. — Da questo punto di vista è indispensabile tener conto delle interviste date dai deputati ad altri giornali e degli articoli pubblicati in altri giornali. — L’omogeneità politica di un partito può essere saggiata anche con questo criterio: quali indirizzi sono favoriti dai membri di questi partiti nella loro collaborazione a giornali di altri partiti o di «opinione pubblica» così detti: il dissidio interno si manifesta talvolta solo così, i dissidenti scrivono articoli in altri giornali, firmati e non firmati, dànno interviste, suggeriscono motivi polemici, non smentiscono le opinioni loro attribuite, ecc. ecc.
Nelle riviste di questo tipo sono indispensabili alcune rubriche: — un dizionario enciclopedico politico‑scientifico‑filosofico. In questo senso: in ogni numero sono pubblicate una o più piccole monografie di carattere enciclopedico su concetti politici, filosofici, scientifici che ricorrono spesso nei giornali e nelle riviste e che la media dei lettori difficilmente afferra o addirittura travisa. In realtà ogni movimento politico crea un suo linguaggio, cioè partecipa allo sviluppo generale di una determinata lingua, introducendo termini nuovi, arricchendo di nuovo contenuto termini già in uso, creando metafore, servendosi di nomi storici per facilitare la comprensione e il giudizio su determinate situazioni politiche attuali, ecc. ecc. Le trattazioni devono essere veramente pratiche, cioè devono riallacciarsi a bisogni realmente sentiti ed essere, per la forma d’esposizione, adeguate alla media dei lettori. Possibilmente i compilatori devono essere informati degli errori più diffusi risalendo alle fonti stesse degli errori, cioè alla pubblicazione di paccotiglia scientifica tipo «Biblioteca popolare Sonzogno» o dizionari (Melzi, Premoli ecc.) o enciclopedie popolari più diffuse. Queste trattazioni non devono presentarsi già in forma organica (per es. ordine alfabetico o di materia) né secondo un’economia prefissata di spazio come se già una pubblicazione complessiva fosse in vista, ma invece devono essere messe in rapporto con altre pubblicazioni di quella o di altre riviste collegate che hanno trattato questo o quell’argomento: l’ampiezza della trattazione deve essere determinata volta per volta non dall’importanza intrinseca dell’argomento, ma dall’interesse immediato (ciò sia detto solo in generale): insomma non deve presentarsi come un libro pubblicato a puntate, ma come una rubrica interessante di per sé, volta per volta, dalla quale magari potrà scaturire un libro.
Legata alla precedente è la rubrica delle biografie, non in quanto il nome del biografato entra nel dizionario enciclopedico per un determinato concetto politico, ma in quanto tutta la vita di un uomo può interessare la cultura generale di un certo strato sociale. Per esempio, può darsi che nel dizionario enciclopedico si debba parlare di lord Carson per accennare alla crisi del regime parlamentare già prima della guerra mondiale e proprio in Inghilterra, nel paese dove il regime parlamentare era più efficiente; ciò non vorrà dire che si debba fare la biografia di lord Carson. A una persona di media cultura interessano due soli dati biografici: 1° lord Carson nel 1914 prese le armi nell’Ulster per opporsi all’applicazione della legge sull’Home Rule irlandese, approvata dal Parlamento che «può far tutto eccetto che un uomo diventi donna»; 2° lord Carson non solo non fu punito ma divenne ministro poco dopo, allo scoppio della guerra. — Invece di un altro interessa tutta la biografia, quindi rubrica separata.
Un’altra rubrica può essere quella delle autobiografie politiche‑intellettuali. Se fatte bene esse possono essere del massimo interesse giornalistico e di grande efficacia formativa. Sincerità, semplicità. Come uno supera il suo ambiente, attraverso quali impulsi esterni e quali crisi di pensiero e di sentimento. (Poche, ma buone). Un’altra rubrica, fondamentale questa: l’esame storico‑bibliografico delle situazioni regionali. Molti vorrebbero studiare le situazioni locali, che interessano molto, ma non sanno come fare, da dove incominciare: non conoscono il materiale bibliografico, non sanno fare ricerche nelle biblioteche, ecc. Si tratta dunque di dare l’ordito generale di un problema concreto o di un tema scientifico, indicando i libri che l’hanno trattato, gli articoli delle riviste specializzate ecc., in forma di rassegne bibliografico‑critiche, con speciale diffusione per le pubblicazioni poco comuni o in lingue straniere. Ciò può essere fatto per le regioni, da diversi punti di vista, per problemi generali di cultura ecc. ecc.
Uno spoglio sistematico di giornali e riviste per la parte che interessa le rubriche principali (fondamentali) — Sola citazione di autori, titoli, dati con brevi cenni di tendenza (ogni numero) — Recensioni dei libri. Due tipi di recensione. Informativo‑critico: si suppone che il lettore non possa leggere il libro, ma che sia interessante per lui conoscerne il contenuto generale. — Teorico‑critico: si suppone che il lettore debba leggere il libro e allora non si riassume, ma si trattano criticamente le obbiezioni che gli si devono muovere o si svolge qualche parte che vi è sacrificata ecc. Questo secondo tipo di recensione è più adatto per l’altro tipo di rivista («Critica» ‑ «Politica»).
Uno spoglio critico‑bibliografico della produzione letteraria degli autori fondamentali per la teoria generale. Uno spoglio simile per gli autori italiani, o per le traduzioni italiane di autori stranieri; questo spoglio deve essere molto minuto e circostanziato, perché occorre tener presente che attraverso questo lavoro e questa elaborazione si può solo raggiungere la fonte autentica di tutta una serie di concezioni erronee che circolano incontrollate. Occorre tener presente che in ogni regione, specialmente in Italia, data la ricchissima varietà di tradizioni locali, esistono gruppi e gruppetti caratterizzati da motivi ideologici e psicologici propri; «ogni paese ha o ha avuto il suo santo locale, quindi il suo culto e la sua cappella». La elaborazione unitaria di una coscienza collettiva domanda condizioni e iniziative molteplici. La diffusione da un centro omogeneo di un modo di pensare e di operare omogeneo è la condizione principale, ma non deve essere e non può essere la sola. Un errore molto diffuso consiste nel pensare che ogni strato sociale elabori la sua coscienza e la sua cultura allo stesso modo, con gli stessi metodi, cioè i metodi degli intellettuali di professione.
Anche l’intellettuale è un «professionista» che ha le sue «macchine» specializzate e il suo «tirocinio», che ha un suo sistema Taylor. È illusorio attribuire a tutti questa capacità «acquisita» e non innata. È illusorio pensare che una «idea chiara» opportunamente diffusa si inserisca nelle diverse coscienze con gli stessi effetti «organizzatori» di chiarezza diffusa. È un errore «illuministico». La capacità dell’intellettuale di professione di combinare abilmente l’induzione e la deduzione, di generalizzare, di dedurre, di trasportare da una sfera a un’altra un criterio di discriminazione, adattandolo alle nuove condizioni, ecc. è una «specialità», non è un dato del «senso comune». Ecco dunque che non basta la premessa della «diffusione organica da un centro omogeneo di un modo di pensare e di operare omogeneo». Lo stesso raggio luminoso passa per prismi diversi e dà rifrazioni di luce diverse: se si vuole la stessa rifrazione occorre tutta una serie di rettificazioni dei singoli prismi. La «ripetizione» paziente e sistematica è il principio metodico fondamentale. Ma la ripetizione non meccanica, materiale: l’adattamento di ogni principio alle diverse peculiarità, il presentarlo e ripresentarlo in tutti i suoi aspetti positivi e nelle sue negazioni tradizionali, organizzando sempre ogni aspetto parziale nella totalità. Trovare la reale identità sotto l’apparente differenziazione e contraddizione e trovare la sostanziale diversità sotto l’apparente identità, ecco la più essenziale qualità del critico delle idee e dello storico dello sviluppo sociale. Il lavoro educativo‑formativo che un centro omogeneo di cultura svolge, l’elaborazione di una coscienza critica che esso promuove e favorisce su una determinata base storica che contenga le premesse materiali a questa elaborazione, non può limitarsi alla semplice enunciazione teorica di principi «chiari» di metodo; questa sarebbe pura azione «illuministica». Il lavoro necessario è complesso e deve essere articolato e graduato: ci deve essere la deduzione e l’induzione combinate, l’identificazione e la distinzione, la dimostrazione positiva e la distruzione del vecchio. Ma non in astratto, in concreto: sulla base del reale. Ma come sapere quali sono gli errori radicati o più generalmente diffusi? Evidentemente è impossibile una «statistica» dei modi di pensare e delle singole opinioni individuali, che dia un quadro organico e sistematico: non rimane che la revisione della letteratura più diffusa e più popolare combinata con lo studio e la critica delle correnti ideologiche precedenti, ognuna delle quali «può» aver lasciato un sedimento, variamente combinatosi con quelli precedenti e susseguenti.
In questo stesso ordine di osservazioni si inserisce un criterio più generale: i mutamenti nei modi di pensare, nelle credenze, nelle opinioni, non avvengono per «esplosioni» rapide e generalizzate, avvengono per lo più per «combinazioni successive» secondo «formule» disparatissime. L’illusione «esplosiva» nasce da assenza di spirito critico. Come non si è passati, nei metodi di trazione, dalla diligenza a trazione animale, agli espressi moderni elettrici, ma si è passati attraverso una serie di «combinazioni intermedie» che in parte ancora sussistono (come la trazione animale su rotaie ecc. ecc.) e come avviene che il materiale ferroviario invecchiato negli Stati Uniti viene ancora utilizzato per molti anni in Cina e vi rappresenta un progresso tecnico — così nella sfera della cultura i diversi strati ideologici si combinano variamente e ciò che è diventato «ferravecchio» nella città è ancora «utensile» in provincia. Nella sfera della coltura anzi, le esplosioni» sono ancora meno frequenti e meno intense che nella sfera della tecnica.
Si confonde l’esplosione «di passioni» politiche accumulate in un periodo di trasformazioni tecniche alle quali non corrispondono adeguate nuove forme di organizzazione giuridica con le sostituzioni di nuove forme di cultura alle vecchie.
L’accenno al fatto che talvolta ciò che è diventato «ferravecchio» in città è ancora «utensile» in provincia può essere utilmente svolto. I rapporti tra popolazione urbana e popolazione rurale non sono sempre gli stessi. Bisogna determinare i «tipi» di urbano e di rurale. Si verifica il paradosso che il tipo rurale sia più progressivo del tipo urbano. Una città «industriale» è sempre più progressiva della campagna che ne dipende. Ma in Italia non tutte le città sono «industriali» e sono meno ancora le città «tipicamente» industriali. Le «cento» città italiane. In Italia l’urbanesimo non è solo e nemmeno «specialmente» un fenomeno industriale. La più grande città italiana, Napoli, non è una città industriale. Tuttavia anche in queste città esistono nuclei di popolazione tipicamente urbana. Ma qual è la loro posizione relativa? Essi sono sommersi, premuti, schiacciati dall’altra parte che è rurale, di tipo rurale, ed è la grandissima maggioranza. Le città del «silenzio». In questo tipo di città esiste una unità «urbana» ideologica contro la campagna: c’è ancora l’odio e il disprezzo contro il «villano»: per reciproca c’è un’avversione «generica» della campagna contro la città. Questo fenomeno generale, che poi è molto complesso e si presenta in forme talvolta apparentemente contraddittorie, sarebbe da studiare nel corso del Risorgimento. Esempio tipico di apparenti contraddizioni è l’episodio della Repubblica partenopea del 1799: la campagna ha schiacciato la città con le orde del cardinal Ruffo, perché la città aveva completamente trascurato la campagna. Nel Risorgimento si verifica già embrionalmente il rapporto storico tra Nord e Sud come un rapporto simile a quello di una grande città a una grande campagna: essendo questo rapporto non gia quello organico normale di provincia e capitale industriale, ma assumendo l’aspetto di un vasto territorio, si accentuano le colorazioni di contrasto nazionale. Ciò che nel Risorgimento è specialmente notevole è il fatto che nelle crisi politiche il Sud ha l’iniziativa: 1799 Napoli — 20‑21 Palermo — 47 Messina, 47‑48 Napoli e Sicilia.
Altro fatto notevole è l’aspetto particolare che assume il movimento nell’Italia centrale, come una via di mezzo tra Nord e Sud: il periodo delle iniziative popolari (relativamente) va dal 1815 al 48 e culmina nella Repubblica Romana (le Romagne e la Lunigiana bisogna sempre congiungerle al Centro). Queste peculiarità hanno un riscontro anche in seguito: i fatti del giugno 1914 hanno avuto una forma particolare nel Centro (Romagna e Marche). La crisi del 94 in Sicilia e Lunigiana, col contraccolpo a Milano nel 98; 1919 nel Mezzogiorno e 1920 nel Settentrione. Questo relativo sincronismo mostra l’esistenza di una struttura economico‑politica omogenea (relativamente) da una parte e mostra come nei periodi di crisi, sia la parte più debole, periferica, a reagire per la prima.
La relazione di città e campagna tra Nord e Sud può essere studiata nelle diverse forme di cultura. Benedetto Croce e Giustino Fortunato sono a capo, nell’inizio di questo secolo, di un movimento culturale che si contrappone al movimento culturale del Nord (futurismo). È notevole il fatto che la Sicilia si stacca dal Mezzogiorno per molti rispetti: Crispi è l’uomo dell’industria settentrionale; Pirandello nelle linee generali è più vicino al futurismo; Gentile ed il suo idealismo attuale sono anch’essi più vicini al movimento futurista, inteso in senso largo, come opposizione al classicismo tradizionale, come forma di un «romanticismo» contemporaneo. Diversa struttura elle classi intellettuali: — nel mezzogiorno domina ancora il tipo del «curiale» o del paglietta, che pone a contatto la massa contadina con quella dei proprietari fondiari e con l’apparato statale; — nel Nord domina il tipo del «tecnico» d’officina che serve di collegamento tra la massa operaia e la classe capitalistica; il collegamento tra massa operaia e Stato era dato dagli organizzatori sindacali e dai partiti politici, cioè da un ceto intellettuale completamente nuovo (l’attuale corporativismo, con la sua conseguenza della diffusione su scala nazionale di questo tipo sociale, in modo più sistematico e conseguente che non avesse potuto fare il vecchio sindacalismo, e in un certo senso uno strumento di unità morale e politica.
Questo rapporto città‑campagna è visibile nei programmi politici effettuati prima del fascismo: il programma Giolitti o dei liberali democratici è questo: — creare nel Nord un blocco «urbano» (capitalisti‑operai) che dia la base allo stato protezionista per rafforzare l’industria settentrionale, cui il Mezzogiorno è mercato di vendita semicoloniale; il Mezzogiorno è «curato» con due sistemi di misure: 1) sistema poliziesco (repressione implacabile di ogni movimento di massa, stragi periodiche di contadini); nella commemorazione di Giolitti «Spectator» della Nuova Antologia si maraviglia che Giolitti si sia sempre strenuamente opposto ad ogni diffusione del socialismo nel Mezzogiorno, mentre la cosa è naturale e ovvia, poiché un protezionismo operaio (riformismo, cooperative, lavori pubblici) è solo possibile se parziale, cioè perché ogni privilegio presuppone dei sacrificati; 2) misure politiche: favori personali al ceto dei paglietta o pennaioli (impieghi pubblici, permesso di saccheggio delle pubbliche amministrazioni, legislazione ecclesiastica meno rigida che nel Nord ecc. ecc.), cioè incorporamento a «titolo personale» degli elementi più attivi meridionali nelle classi dirigenti, con particolari privilegi «giudiziari», impiegatizi ecc., in modo che lo strato che avrebbe potuto organizzare il malcontento meridionale diventava uno strumento della politica settentrionale, un suo accessorio «poliziesco»; il malcontento non poteva così assumere aspetto politico e le sue manifestazioni esprimendosi solo in modo caotico e tumultuario diventavano «sfera» della «polizia». A questo fenomeno di corruzione aderivano sia pure passivamente e indirettamente anche uomini egregi come il Croce e il Fortunato per il feticismo dell’«Unità» (episodio Fortunato‑Salvemini a proposito dell’«Unità» raccontato da Prezzolini nella prima edizione della Cultura italiana)4.
Non bisogna dimenticare questo fattore politico‑morale della campagna di intimidazione che si faceva contro ogni anche obbiettivissima constatazione di motivi di contrasto tra Nord e Sud. Ricordare: conclusione dell’inchiesta Pais‑Serra sulla Sardegna dopo la crisi 94‑98, l’accusa fatta da Crispi ai fasci siciliani di essere venduti agli Inglesi (trattato di Bisacquino) ecc.; specialmente tra gli intellettuali siciliani esiste questa forma di esasperazione unitaria (conseguenza della popolarità regionale di Crispi) che anche recentemente si è manifestata in attacco Natoli contro Croce per gli accenni nella Storia d’Italia (cfr risposta di Croce nella «Critica»).
Il programma Giolitti fu «turbato» da due «fattori»: l’affermarsi degli intransigenti nel partito socialista con Mussolini e il loro civettare coi meridionalisti (libero scambio, elezioni di Molfetta ecc.), che distruggeva il blocco «urbano» e l’introduzione del suffragio universale che allargava in modo impressionante la base parlamentare nel Mezzogiorno e rendeva difficile la corruzione individuale (troppi da corrompere!). Giolitti muta «partenaire»: al blocco «urbano» sostituisce il patto Gentiloni o meglio lo rafforza per impedirne il completo crollo, cioè, in definitiva un blocco tra gli industriali settentrionali e i rurali della campagna «organica e normale» (forze elettorali cattoliche specialmente nel Nord e nel Centro), con estensione degli effetti anche nel Sud nella misura immediatamente sufficiente per «rettificare» utilmente gli effetti dell’allargamento della massa elettorale.
L’altro programma è quello che si può chiamare del «Corriere della Sera» o di Albertini e può essere fatto coincidere con una alleanza degli industriali settentrionali (con a capo i tessili, cotonieri, setaioli libero scambisti) coi rurali meridionali (blocco rurale): il «Corriere» ha sostenuto Salvemini a Molfetta (campagna Ojetti), ha sostenuto il ministero Salandra, ha sostenuto il ministero Nitti, cioè i primi due ministeri formati da meridionali (i siciliani sono da considerarsi a parte).
Il suffragio universale già nel 1913 aveva suscitato i primi accenni di quel fenomeno che avrà la massima espressione nel 19‑20‑21 in conseguenza dell’esperienza politica‑organizzativa acquistata dalle masse contadine durante la guerra, cioè la rottura relativa del blocco rurale meridionale e il distacco dei contadini guidati da una parte degli intellettuali (ufficiali in guerra) dai grandi proprietari: si ha il sardismo, il partito riformista siciliano (gruppo Bonomi con 22 deputati siciliani) e il «rinnovamento» nell’Italia meridionale con tentativi di partiti regionali d’azione (rivista «Volontà» col Torraca, «Popolo romano» ecc.). In questi movimenti l’importanza della massa contadina è graduata dalla Sardegna, al Mezzogiorno, alla Sicilia a seconda della forza organizzata e della pressione esercitata ideologicamente dai grandi proprietari, che hanno in Sicilia un massimo di organizzazione e hanno invece una importanza relativamente piccola in Sardegna. Altrettanto graduata è l’indipendenza relativa dei rispettivi intellettuali.
Per intellettuali occorre intendere non solo quei ceti comunemente intesi con questa denominazione, ma in generale tutta la massa sociale che esercita funzioni organizzative in senso lato, sia nel campo della produzione, sia nel campo della cultura, sia nel campo amministrativo‑politico: corrispondono ai sott’ufficiali e agli ufficiali subalterni nell’esercito (e anche a una parte degli ufficiali superiori con esclusione degli stati maggiori nel senso più ristretto della parola).
Per analizzare le funzioni sociali degli intellettuali occorre ricercare ed esaminare il loro atteggiamento psicologico verso le grandi classi che essi mettono a contatto nei diversi campi: hanno atteggiamento «paternalistico» verso le classi strumentali? o «credono» di esserne una espressione organica? hanno «servile» verso le classi dirigenti o si credono essi stessi dirigenti, parte integrante delle classi dirigenti?
Nella storia del Risorgimento il così detto Partito d'Azione aveva un atteggiamento «paternalistico», perciò non è riuscito che in misura minima a mettere le grandi masse a contatto con lo stato. Il così detto «trasformismo» è legato a questo fatto: il Partito d'Azione viene incorporato molecolarmente dai moderati e le masse vengono decapitate, non assorbite nell’ambito del nuovo stato.
Dal rapporto «città‑campagna» deve muovere l’esame delle forze motrici fondamentali della storia italiana e dei punti programmatici da cui occorre studiare l’indirizzo del Partito d’Azione nel Risorgimento: 1° la forza urbana settentrionale; 2° la forza rurale meridionale; 3° la forza rurale settentrionale‑centrale; 4°-5° la forza rurale della Sicilia e della Sardegna.
Restando ferma la posizione di «locomotiva» della prima forza, occorre studiare le diverse combinazioni «più utili» per formare un «treno» che progredisca il più speditamente nella storia. La prima forza incomincia con l’avere i problemi «propri», di organizzazione, di articolazione per omogeneità, di direzione politica e militare; ma rimane fissato che, già «meccanicamente», se questa forza ha raggiunto un certo grado di unità e di combattività, essa esercita una funzione direttiva «indiretta».
Nei diversi periodi del Risorgimento appare che il porsi di questa forza in posizione di intransigenza e di lotta contro il dominio straniero determina un’esaltazione delle forze progressive meridionali; da ciò il sincronismo relativo, ma non la simultaneità nei movimenti del 20‑21, del 31, del 48; si realizza nel 59‑60 un sincronismo in senso inverso, cioè il Nord inizia, il Centro aderisce pacificamente o quasi e nel Sud lo Stato borbonico crolla per la spinta dei garibaldini, relativamente debole: questo avviene perché il P. d’A. (Garibaldi) interviene, dopo che i moderati (Cavour) avevano organizzato il Nord e il Centro; non è cioè la stessa direzione politica e militare (moderati ‑ Stato sardo o P. d’A.) che organizza la simultaneità relativa ma la collaborazione (meccanica) delle due direzioni che si integrano felicemente.
La prima forza si deve poi porre il problema di organizzare intorno a sé le forze urbane delle altre sezioni nazionali. Questo problema è il più difficile: esso si presenta irto di contraddizioni e di motivi che scatenano ondate di passioni. Ma la sua soluzione, appunto per questo, era il punto cruciale. Le forze urbane sono socialmente omogenee, quindi devono trovarsi in una posizione di perfetta eguaglianza. Teoricamente questo è vero, ma storicamente la quistione si pone altrimenti: le forze urbane del Nord sono nettamente alla testa della loro sezione nazionale, mentre per le forze urbane del Sud questo non si verifica perlomeno in egual misura. Le forze urbane del Nord dovevano quindi far capire a quelle del Sud che la loro funzione direttiva non poteva non consistere che nell’assicurare la direzione del Nord verso il Sud nel rapporto generale di città‑campagna, cioè la funzione direttiva delle forze urbane del Sud non poteva esser altro che una «funzione» della più vasta funzione direttiva del Nord. La contraddizione più dolorosa nasceva da questo ordine di fatti: la forza urbana del Sud non poteva essere considerata come qualcosa a sé, indipendente da quelle del Nord; porre la quistione così avrebbe significato affermare pregiudizialmente un insanabile dissidio «nazionale», dissidio tanto grave che neanche la soluzione federalistica avrebbe potuto comporre; si sarebbe trattato di nazioni diverse, tra le quali poteva realizzarsi solo un’alleanza diplomatico‑militare contro il comune nemico, l’Austria (l’unica «comunità» e solidarietà, insomma, sarebbe consistita solo nell’avere un «comune» nemico).
Ora, in realtà, esistevano solo alcuni aspetti della quistione nazionale, ma non «tutti» gli aspetti e neanche quelli più essenziali. L’aspetto più grave era la debole posizione delle forze urbane meridionali in rapporto alle forze rurali, rapporto sfavorevole che si manifestava talvolta in una vera e propria soggezione della città alla campagna. Il collegamento tra forze urbane del Nord e del Sud, doveva aiutare queste a rendersi autonome, ad acquistare coscienza della loro funzione storica dirigente in modo «concreto» e non puramente teorico e astratto, suggerendo loro le soluzioni da dare ai vasti problemi regionali. Era naturale che si trovassero opposizioni nel Sud; il compito più grave spettava però alle forze urbane del Nord che non solo dovevano convincere i loro «fratelli» del Sud, ma dovevano incominciare col convincere se stesse di questa complessità di sistema politico: praticamente cioè la quistione consisteva nell’esistenza di un forte centro di direzione politica, al quale necessariamente avrebbero dovuto collaborare forti e popolari individualità meridionali e delle isole. Il problema, dunque, di creare una unità Nord‑Sud è strettamente legato e in gran parte assorbito nel problema di creare una coesione tra tutte le forze urbane nazionali. (Il ragionamento su esposto vale infatti per le tre sezioni meridionali, Napoletano, Sicilia, Sardegna). La forza rurale settentrionale‑centrale pone una serie di problemi che la forza urbana del Nord deve porsi per il rapporto regionale città‑campagna. Bisognava distinguere in essa due sezioni: quella laica e quella clericale. La forza clericale aveva il suo peso massimo nel Lombardo‑Veneto, quella laica nel Piemonte, «peso massimo», con interferenze marginali più o meno vaste non solo tra Piemonte e Lombardo‑Veneto, ma tra queste due regioni‑tipo e le altre settentrionali e centrali e in minore misura anche meridionali e insulari. Risolvendo bene questi rapporti immediati le forze urbane settentrionali avrebbero dato un ritmo a tutte le quistioni simili su scala nazionale.
Su questo problema il Partito d'Azione fallì completamente. Non si può dire fallisse il partito moderato perché esso voleva soldati nell’esercito piemontese e non eserciti garibaldini troppo grandi. Perché il Partito d’Azione non pose in tutta la sua vastità il problema agrario? Che non lo ponessero i moderati era naturale: l’impostazione data dai moderati al problema nazionale domandava un blocco di tutte le forze di destra, comprese le classi dei grandi proprietari terrieri. La minaccia fatta dall’Austria di risolvere la quistione agraria a favore dei contadini, minaccia seguita dai fatti in Galizia contro i latifondisti polacchi, non solo gettò lo scompiglio tra gli interessati, determinando tutte le oscillazioni dell’aristocrazia, per esempio (fatti di Milano del febbraio 53 e atto di omaggio delle più illustri famiglie milanesi a Francesco Giuseppe proprio alla vigilia delle impiccagioni di Belfiore) ma paralizzò il Partito d’Azione. Mazzini, dopo il febbraio 53, pur con qualche accenno, non seppe poi decidersi (vedi Epistolario di quel periodo). Condotta dei garibaldini in Sicilia nel 60: schiacciamento implacabile dei movimenti dei contadini insorti contro i baroni mano a mano che Garibaldi avanzava — opera repressiva di Nino Bixio —. Nelle relle di uno dei mille di G. C. Abba elementi per dimostrare che la quistione agraria era la molla per far entrare in moto le grandi masse — ricordare discorsi dell’Abba col frate che va incontro ai garibaldini subito dopo lo sbarco a Marsala — In alcune novelle di G. Verga elementi pittoreschi di queste sommosse i contadine — formazione della Guardia Nazionale per soffocare questi moti col terrore e le fucilazioni in massa (questo lato della spedizione dei Mille non è stato ancora studiato).
La non impostazione della quistione agraria portava alla quasi impossibilità di risolvere la quistione del clericalismo e dell’atteggiamento del Papa. Sotto questo riguardo i moderati furono molto più arditi del Partito d'Azione: è vero che essi non distribuirono i beni ecclesiastici fra i contadini, ma se ne servirono per creare un ceto nuovo di grandi e medi proprietari legato alla nuova situazione politica, ma almeno non esitarono a mettere le mani sulle congregazioni. Il P. d’A. era invece paralizzato dalle velleità mazziniane di una riforma religiosa che non solo non toccava le grandi masse, ma le rendeva passibili di una sobillazione contro i nuovi eretici. L’esempio della Francia era lì a dimostrare che i giacobini, che erano riusciti a schiantare i girondini sulla quistione agraria e non solo a impedire la coalizione rurale contro Parigi ma a moltiplicare nelle provincie i loro aderenti, furono invece danneggiati dai tentativi di Robespierre di instaurare una riforma religiosa.
Bisognerebbe studiare minutamente la politica agraria della Repubblica Romana e il vero carattere della missione repressiva data da Mazzini a Felice Orsini nelle Romagne e nelle Marche: in questo periodo e fino al 70 sotto il nome di brigantaggio si intendeva per lo più il movimento dei contadini per impadronirsi delle terre. (Cercare specialmente nella Corrispondenza e negli articoli di giornali i giudizi di Marx e di Engels sulla quistione agraria in Italia dal 48 al 60).
Q1 §44 Direzione politica di classe prima e dopo l’andata al governo. Tutto il problema delle varie correnti politiche del Risorgimento, dei loro rapporti reciproci e dei loro rapporti con le forze omogenee o subordinate delle varie sezioni (o settori) storiche del territorio nazionale si riduce a questo fondamentale: che i moderati rappresentavano una classe relativamente omogenea, per cui la direzione subì oscillazioni relativamente limitate, mentre il Partito d'Azione non si appoggiava specificamente a nessuna classe storica e le oscillazioni che subivano i suoi organi dirigenti in ultima analisi si componevano secondo gli interessi dei moderati: cioè storicamente il Partito d'Azione fu guidato dai moderati (l’affermazione di Vittorio Emanuele II di «avere in tasca», o qualcosa di simile, il Partito d'Azione è esatta, e non solo per i suoi contatti personali con Garibaldi; il Partito d’Azione storicamente fu guidato da Cavour e da Vittorio Emanuele II).
Il criterio storico‑politico su cui bisogna fondare le proprie ricerche è questo: che una classe è dominante in due modi, è cioè «dirigente» e «dominante». È dirigente delle classi alleate, è dominante delle classi avversarie. Perciò una classe già prima di andare al potere può essere «dirigente» (e deve esserlo): quando è al potere diventa dominante ma continua ad essere anche «dirigente». I moderati continuarono a dirigere il Partito d'Azione anche dopo il 70 e il «trasformismo» è l’espressione politica di questa azione di direzione; tutta la politica italiana dal 70 ad oggi è caratterizzata dal «trasformismo», cioè dall’elaborazione di una classe dirigente nei quadri fissati dai moderati dopo il 48, con l’assorbimento degli elementi attivi sorti dalle classi alleate e anche da quelle nemiche. La direzione politica diventa un aspetto del dominio, in quanto l’assorbimento delle élites delle classi nemiche porta alla decapitazione di queste e alla loro impotenza. Ci può e ci deve essere una «egemonia politica» anche prima della andata al Governo e non bisogna contare solo sul potere e sulla forza materiale che esso dà per esercitare la direzione o egemonia politica.
Dalla politica dei moderati appare chiara questa verità ed è la soluzione di questo problema che ha reso possibile il Risorgimento nelle forme e nei limiti in cui esso si è effettuato di rivoluzione senza rivoluzione o di rivoluzione passiva secondo l’espressione di V. Cuoco. In quali forme i moderati riuscirono a stabilire l’apparato della loro direzione politica? In forme che si possono chiamare «liberali» cioè attraverso l’iniziativa individuale, «privata» (non per un programma «ufficiale» di partito, secondo un piano elaborato e costituito precedentemente all’azione pratica e organizzativa). Ciò era «normale», data la struttura e la funzione delle clagsi rappresentate dai moderati, delle quali i moderati erano il ceto dirigente, gli «intellettuali» in senso organico. Per il Partito d'Azione il problema si poneva in altro modo e diversi sistemi avrebbero dovuto essere applicati. I moderati erano «intellettuali», «condensati» già naturalmente dall’organicità dei loro rapporti con le classi di cui erano l’espressione (per tutta una serie di essi si realizzava l’identità di rappresentato e rappresentante, di espresso e di espressivo, cioè gli intellettuali moderati erano una avanguardia reale, organica delle classi alte perché essi stessi appartenevano economicamente alle classi alte: erano intellettuali e organizzatori politici e insieme capi di azienda, grandi proprietari‑amministratori terrieri, imprenditori commerciali e industriali, ecc.). Data questa «condensazione» o concentrazione organica, i moderati esercitavano una potente attrazione, in modo «spontaneo», su tutta la massa d’intellettuali esistenti nel paese allo stato «diffuso», «molecolare», per le necessità, sia pure elementarmente soddisfatte, della istruzione pubblica e dell’amministrazione. Si rivela qui la verità di un criterio di ricerca storico‑politico: non esiste una classe indipendente di intellettuali, ma ogni classe ha i suoi intellettuali; però gli intellettuali della classe storicamente progressiva esercitano un tale potere di attrazione, che finiscono, in ultima analisi, col subordinarsi gli intellettuali delle altre classi e col creare l’ambiente di una solidarietà di tutti gli intellettuali con legami di carattere psicologico (vanità ecc.) e spesso di casta (tecnico‑giuridici, corporativi).
Questo fenomeno si verifica «spontaneamente» nei periodi in cui quella determinata classe è realmente progressiva, cioè fa avanzare l’intera società, soddisfacendo alle sue esigenze esistenziali non solo, ma ampliando continuamente i suoi quadri per una continua presa di possesso di nuove sfere di attività industriale‑produttiva. Quando la classe dominante ha esaurito la sua funzione, il blocco ideologico tende a sgretolarsi e allora alla «spontaneità» succede la «costrizione» in forme sempre meno larvate e indirette, fino alle misure vere e proprie di polizia e ai colpi di Stato.
Il Partito d'Azione non poteva avere questo potere di attrazione ed anzi egli stesso era attratto, sia per l’atmosfera di intimidazione che lo rendeva esitante ad accogliere nel suo programma determinate rivendicazioni popolari, sia perché alcuni dei suoi uomini maggiori (Garibaldi, per es.) erano, sia pure saltuariamente («oscillazioni») in rapporto personale di subordinazione coi capi dei moderati. Perché il P. d’A. diventasse una forza autonoma e, in ultima analisi, per lo meno riuscisse a imprimere al moto del Risorgimento un carattere più marcatamente popolare e democratico (più in là non poteva andare date le premesse fondamentali del moto stesso) avrebbe dovuto contrapporre all’azione «empirica» dei moderati (che era empirica solo per modo di dire) un programma organico di governo che abbracciasse le rivendicazioni essenziali delle masse popolari, in primo luogo dei contadini. All’attrazione «spontanea» esercitata dai moderati, doveva cioè contrapporre un’attrazione «organizzata», secondo un piano.
Come esempio tipico di attrazione spontanea dei moderati bisogna ricordare il fatto della nascita del movimento «cattolico‑liberale», che tanto impressionò il papato e in parte riuscì a paralizzarlo e a demoralizzarlo, cacciandolo in una posizione più destra di quella che avrebbe potuto occupare e quindi parzialmente isolandolo; il papato ha appreso la lezione e ha saputo perciò manovrare magnificamente nei tempi più recenti. Il modernismo prima e il popolarismo poi sono fenomeni simili a quello dei «cattolico‑liberali» del Risorgimento: essi sono in gran parte dovuti al potere di attrazione «spontanea» esercitata dal movimento operaio moderno. Il papato (sotto Pio X) ha colpito il modernismo come tendenza riformatrice della religione, ma ha sviluppato il popolarismo, cioè la base economica del modernismo, e oggi, con Pio XI, fa di ciò il fulcro della sua politica mondiale.
Intanto il Partito d'Azione avrebbe dovuto avere un programma di governo, ciò che sempre gli mancò. Esso in sostanza fu sempre, più di tutto, un movimento di agitazione e propaganda dei moderati. I dissidi e i conflitti interni del Partito d'Azione, gli odi tremendi che Mazzini suscitò contro di sé da parte dei più cospicui uomini d’azione (Garibaldi stesso, Felice Orsini ecc.) sono dovuti a questa mancanza di direzione politica. Le polemiche interne sono in gran parte altrettanto astratte della predicazione di Mazzini, ma da esse si possono trarre utili indicazioni storiche (valgano per tutti gli scritti del Pisacane, che d’altronde commise errori militari gravissimi, come l’opposizione alla dittatura militare di Garibaldi nella Repubblica Romana). Il Partito d'Azione segue la tradizione «retorica» della letteratura italiana. Confonde l’unità culturale con l’unità politica e territoriale. Confronto tra giacobini e Partito d’Azione: i giacobini lottarono strenuamente per assicurare il legame tra città e campagna; furono sconfitti perché dovettero soffocare le velleità di classe degli operai; il loro continuatore è Napoleone e sono oggi i radico‑socialisti francesi.
Nella letteratura politica francese questa necessità del legame tra città e campagna era vivissima: ricordare i Misteri del Popolo di Eugenio Sue, diffusissimi anche in Italia intorno al 1850 (il Fogazzaro nel Piccolo Mondo Antico ricorda che F. Maironi riceveva clandestinamente dalla Svizzera i Misteri del Popolo che a Vienna furono bruciati dal carnefice, credo) e che insistono con particolare costanza sulla necessità di legare i contadini alla città; il Sue è il romanziere della tradizione giacobina e un antenato di Herriot e di Daladier da tanti punti di vista (leggenda napoleonica in Ebreo Errante, anticlericalismo in tutti i libri ma specialmente nell’Ebreo Errante, riformismo piccolo‑borghese nei Misteri di Parigi ecc. ecc.).
Il Partito d'Azione era implicitamente antifrancese per l’ideologia mazziniana (cfr in «Critica» l’articolo dell’Omodeo Primato francese e iniziativa italiana, anno 1929, p. 223); ma aveva nella storia italiana la tradizione a cui collegarsi. La storia dei Comuni è ricca di esperienza in proposito: la borghesia nascente cerca alleati nei contadini contro l’Impero e contro il proprio feudalismo locale (è vero che la quistione è resa più complessa dalla lotta tra borghesia e nobiltà terriera per contendersi la mano d’opera: i borghesi hanno bisogno di mano d’opera ed essa può esser data solo dalle classi rurali; ma i nobili vogliono legati al suolo i contadini; fuga dei contadini in città, dove i nobili non possono catturarli. In ogni modo, anche in diversa situazione, appare nell’epoca dei Comuni la funzione direttiva della città che approfondisce la lotta interna delle campagne e se ne serve come strumento politico‑militare per abbattere il feudalismo). Ma il più classico maestro di politica per le classi dirigenti italiane, il Machiavelli, aveva anch’esso posto il problema, naturalmente nei termini e con le preoccupazioni del tempo: nelle scritture militari del Machiavelli è vista abbastanza bene la necessità di legarsi i contadini per avere una milizia nazionale che elimini le compagnie di ventura.
Pisacane, credo, deve proprio essere legato a questa corrente del Machiavelli; anche per Pisacane il problema delle soddisfazioni da dare alle rivendicazioni popolari è visto prevalentemente dal punto di vista militare. A proposito di Pisacane deve essere analizzata la contraddizione della sua concezione militare: il Pisacane, principe napoletano, era riuscito a impossessarsi di alcune concezioni militari derivate dall’esperienza della rivoluzione francese e delle campagne di Napoleone, e che a Napoli furono trapiantate durante i regni di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, ma specialmente per l’esperienza viva degli ufficiali napoletani che avevano militato con Napoleone (vedi in Nuova Antologia nella commemorazione di Cadorna l’importanza che ha avuto questa esperienza militare napoletana, attraverso il Pianell, nell’organizzazione del nuovo esercito italiano): egli cioè comprese che senza una politica democratica non si possono avere eserciti nazionali a coscrizione obbligatoria; ma è inspiegabile la sua avversione contro la strategia di Garibaldi e la sua diffidenza di Garibaldi; egli ha verso Garibaldi la stessa attitudine sprezzante che avevano i vecchi stati maggiori contro Napoleone.
L’individualità che più occorre studiare per questi problemi del Risorgimento è Giuseppe Ferrari, non tanto nelle sue opere così dette maggiori, veri zibaldoni farraginosi e confusi, quanto nei suoi opuscoli d’occasione e nelle sue lettere. Però il Ferrari era in gran parte fuori della realtà concreta italiana; egli si era troppo francesizzato. Certe volte sembra più acuto di quanto realmente fosse, solo perché adattava all’Italia gli schemi francesi, i quali rappresentavano una situazione ben più avanzata di quella italiana. Il Ferrari, si può dire, si trovava, nei rapporti con l’Italia, nella posizione di un «postero»: era, in un certo senso, il suo, un «senno del poi». Il politico invece deve essere un realizzatore «effettuale e attuale»; egli non riusciva a costruire l’anello tra la situazione italiana e quella francese più avanzata, ma era proprio quest’anello che importava saldare per passare a quello successivo. Il Ferrari non seppe tradurre il «francese» in «italiano», perciò la sua acutezza stessa diventava un inciampo, creava nuove sette e scolette, ma non incideva nel movimento reale.
Per molti aspetti appare che la differenza tra molti uomini del Partito d'Azione e i moderati era più di «temperamento» che politica. La parola «giacobini» ha finito con l’assumere due significati: uno è il significato proprio, storicamente caratterizzato: un deterininato partito della Rivoluzione francese, che concepiva la rivoluzione in un determinato modo, con un determinato programma, sulla base di determinate forze sociali e che esplicò la sua azione di partito e di governo con una determinata azione metodica caratterizzata da una estrema energia e risolutezza dipendenti dalla credenza fanatica nella bontà e di quel programma e di quel metodo. Nel linguaggio politico i due aspetti del giacobinismo furono scissi e si chiamò giacobino l’uomo politico energico e risoluto perché fanaticamente persuaso delle virtù taumaturgiche delle sue idee. Crispi è «giacobino» solo in questo senso. Per il suo programma egli è un moderato puro e semplice. La sua «ossessione» giacobina è l’unità politico‑territoriale del paese. Questo principio è sempre la sua bussola d’orientamento, non solo nel periodo del Risorgimento ma anche nel periodo successivo del suo governo. Uomo fortemente passionale, egli odia i moderati come persone; egli vede nei moderati uomini dell’ultima ora, eroi della sesta giornata, gente che avrebbe fatto la pace coi vecchi regimi se questi fossero diventati costituzionali, gente, come i moderati toscani, che si erano aggrappati alla giacca del granduca per non farlo scappare: egli si fidava poco di una unità fatta da non unitari. Perciò si lega alla monarchia che egli sente sarà assolutamente unitaria per interessi dinastici e abbraccia il principio‑fatto dell’egemonia piemontese con una energia e una foga che non avevano gli stessi politici piemontesi.
Cavour aveva avvertito di non trattare il Mezzogiorno con gli stati d’assedio, e Crispi invece subito stabilisce lo stato d’assedio in Sicilia per il movimento dei Fasci: accusa i dirigenti dei Fasci di tramare con l’Inghilterra per il distacco della Sicilia (trattato di Bisacquino). Si lega strettamente coi latifondisti siciliani perché la classe più unitaria per paura delle rivendicazioni contadine, nello stesso tempo in cui la sua politica generale tende a rafforzare l’industrialismo settentrionale con la guerra di tariffe contro la Francia e col protezionismo doganale. Egli non esita a gettare tutto il Mezzogiorno in una crisi commerciale paurosa pur di rafforzare l’industria che può dare al paese una vera indipendenza e allargare la classe dominante: è la politica di fabbricare il fabbricante. Il governo dei moderati dal 61 al 76 aveva solo e timidamente creato le condizioni esterne di uno sviluppo economico — sistemazione dell’apparato statale, strade, ferrovie, telegrafi — e sanato le finanze oberate dai debiti del Risorgimento; il governo della Sinistra cercò di rimediare all’odio suscitato nel popolo dal fiscalismo della Destra, ma non riuscì ad altro che a questo, ad essere una valvola di sicurezza; era la politica della destra con uomini e frasi di sinistra. Crispi invece dette un reale colpo in avanti alla società italiana, fu il vero uomo della nuova borghesia. La sua figura è diminuita dalla sproporzione tra i fatti e le parole, tra le repressioni e l’oggetto da reprimere, tra lo strumento e il colpo vibrato: maneggiava una colubrina arrugginita come fosse un moderno pezzo d’artiglieria. Anche la sua politica d’espansione coloniale è legata alla sua ossessione unitaria. In questo seppe comprendere l’innocenza politica del Mezzogiorno; il contadino meridionale voleva la terra; Crispi non gliela voleva dare in Italia stessa, non voleva fare del «giacobinismo economico»; gli prospettò il miraggio delle terre coloniali da sfruttare. L’imperialismo di Crispi è un imperialismo rettorico passionale, senza base economico‑finanziaria. L’Europa capitalistica, ricca di capitali, li esportava negli imperi coloniali che andò allora creando. Ma l’Italia non solo non aveva capitali da esportare, ma doveva ricorrere al capitale straniero per i suoi stessi strettissimi bisogni. Mancava una base reale all’imperialismo italiano, e alla base reale fu sostituita la «passionalità»: imperialismo‑castello in aria, avversato dagli stessi capitalisti che avrebbero più volentieri visto impiegate in Italia le somme ingenti spese in Africa. Ma nel Mezzogiorno Crispi fu popolare per il miraggio della terra.
Crispi ha dato una forte impronta agli intellettuali siciliani, specialmente, ha creato quel fanatismo «unitario» che ha determinato una permanente atmosfera di sospetto contro tutto ciò che può arieggiare a separatismo. Ciò naturalmente non ha impedito che nel 1920 i latifondisti siciliani si riunissero a Palermo e pronunziassero un vero ultimatum contro il governo minacciando la separazione, come non impedisce che parecchi di questi latifondisti continuino a mantenere la cittadinanza spagnola e facciano intervenire il governo spagnolo (caso del duca di Bivona) per tutelare i loro interessi compromessi dall’agitazione dei contadini. L’atteggiamento delle classi meridionali dal 19 al 26 serve a mettere in luce alcune debolezze della politica «ossessionatamente» unitaria di Crispi e a mettere in rilievo alcune correzioni (poche in realtà, perché da questo punto di vista Giolitti si mantenne nel solco di Crispi) apportatevi da Giolitti.
L’episodio dei latifondisti siciliani del 1920 non è isolato e di esso potrebbe darsi altra interpretazione, per i precedenti delle alte classi lombarde che in qualche occasione minacciarono di «far da sé» (trovare i riscontri e i documenti) se non trovasse una interpretazione autentica nelle campagne, fatte dal «Mattino» dal 19 al 26 (fino alla espulsione dei fratelli Scarfoglio), che sarebbe semplicistico ritenere completamente campate in aria, cioè non legate in qualche modo a correnti di opinione pubblica e a stati d’animo rimasti sotterranei, latenti, potenziali per l’atmosfera d’intimidazione formata dall’«unitarismo ossessionato». Il «Mattino» a due riprese sostenne questa tesi: «che il Mezzogiorno è entrato a far parte dello Stato unitario su una base contrattuale, lo Statuto Albertino, ma che (implicitamente) continua a conservare la sua personalità e che ha il diritto di uscire dall’unità se la base contrattuale viene, in qualsiasi modo, meno, se cioè la costituzione è mutata». Questa tesi fu sostenuta nel 19‑20 contro un mutamento costituzionale di sinistra, nel 24‑25‑26 contro un mutamento costituzionale di destra. Bisogna tener presente il carattere del «Mattino» che fu organo crispino con Edoardo Scarfoglio (amicizia di Scarfoglio con Carducci), africanista ecc. e che mantenne sempre un atteggiamento espansionista e colonialista, dando il tono all’ideologia meridionale creata dalla fame di terra e dall’emigrazione verso la colonizzazione imperialista. Del «Mattino» occorre ricordare anche la violentissima campagna contro il Nord a proposito della manomissione da parte dei tessili lombardi delle industrie cotoniere meridionali e dei tentativi di trasportarne le macchine in Lombardia sotto veste di ferro vecchio. In questa campagna (del 1923) il «Mattino» giunse fino a fare una esaltazione dei Borboni e della loro politica economica. Ricordare inoltre la commemorazione fatta dal «Mattino» di Maria Sofia nel 1925 che destò molto scandalo.
È certo che in questo atteggiamento del «Mattino» occorre apportare alcune correzioni metodiche: il carattere «avventuroso» dei fratelli Scarfoglio, la loro venalità (ricordare che Maria Sofia cercava sempre d’intervenire nella politica interna italiana per spirito di vendetta se non con la speranza di restaurare il regno di Napoli: ricordare il trafiletto di Salvemini nell’«Unità» del 14 o 15 contro Malatesta per i fatti del giugno 1914 che si insinuava potessero essere stati patrocinati dallo Stato Maggiore austriaco per il tramite di Zita di Borbone e l’episodio ricordato da Benedetto Croce in Uomini e cose della vecchia Italia sui legami tra Malatesta e Maria Sofia per far evadere un anarchico che aveva fatto un attentato e sul passo diplomatico fatto dal governo italiano presso il governo francese per queste attività di Maria Sofia: — ricordare gli aneddoti della signora [...] che nel 1919 frequentò Maria Sofia per farle il <ritratto> [Nel ms alcune parole cancellate, non leggibili; l’integrazione redazionale è ripresa dal testo C.]), il loro dilettantismo politico e ideologico, ma occorre pur ricordare che il «Mattino» era il giornale più diffuso del Mezzogiorno e che i fratelli Scarfoglio erano dei giornalisti nati, cioè possedevano quell’intuizione rapida e «simpatica» delle correnti passionali popolari che rende possibile la diffusione della stampa gialla.
Un altro elemento per saggiare la portata reale della politica «unitaria ossessionata» di Crispi è il complesso di sentimenti creatosi nel settentrione per riguardo al mezzogiorno. La «miseria» del Mezzogiorno era inspiegabile «storicamente» per le masse popolari del Nord: queste non capivano che l’unità non era stata creata su una base di eguaglianza, ma come egemonia del Nord sul Sud nel rapporto territoriale città‑campagna, cioè che il Nord era una «piovra» che si arricchiva alle spese del Sud, che l’incremento industriale era dipendente dall’impoverimento dell’agricoltura meridionale. Esse invece pensavano che se il Mezzogiorno non progrediva dopo essere stato liberato dagli impacci che allo sviluppo moderno opponeva il borbonismo, ciò significava che le cause della miseria non erano esterne ma interne; poiché d’altronde era radicata la persuasione della grande ricchezza naturale del terreno, non rimaneva che una spiegazione, l’incapacità organica degli uomini, la loro barbarie, la loro inferiorità biologica.
Queste opinioni già diffuse (il lazzaronismo napoletano era una leggenda di vecchia data) furono consolidate e teorizzate addirittura dai sociologhi del positivismo (Niceforo, Ferri, Orano ecc.) assumendo la forza delle «verità scientifiche» in un tempo di superstizione della scienza. Si ebbe così una polemica Nord‑Sud sulle razze e sulle superiorità e inferiorità del Settentrione e del Mezzogiorno (libri di Colajanni in difesa del Mezzogiorno e collezione della «Rivista Popolare»). Intanto rimase nel Nord la credenza della «palla di piombo» che il Mezzogiorno rappresenterebbe per l’Italia, la persuasione dei più grandi progressi che la civiltà moderna industriale del Nord avrebbe fatto senza questa «palla di pionibo» ecc. ecc. Nei principi del secolo c’è una forte reazione meridionale anche su questo terreno. Congresso Sardo del 1911 sotto la presidenza del generale Rugiu, nel quale si calcola quanti milioni sono stati estorti alla Sardegna nei primi 50 anni di unità a favore del continente. Campagne di Salvemini culminate nella fondazione dell’«Unità», ma condotte già nella «Voce» (numero unico della «Voce» sulla «Quistione meridionale» pubblicato anche in opuscolo).
In questo secolo si realizza un certo blocco «intellettuale» che ha a capo B. Croce e Giustino Fortunato e che si dirama in tutta Italia; in ogni rivistina di giovani, che abbiano tendenze liberali‑democratiche e in generale si propongano di svecchiare la cultura italiana, in tutti i campi, dell’arte, della letteratura, della politica, appare non solo l’influenza del Croce e del Fortunato, ma la loro collaborazione: esempio tipico la «Voce» e l’«Unità», ma si vede anche nella «Patria» di Bologna, nell’«Azione Liberale» di Milano, nei «borelliani» ecc.. Appare anche nel «Corriere della Sera» e finisce nel dopoguerra, date le nuove situazioni, con l’apparire nella «Stampa» (attraverso Cosmo, Salvatorelli, Ambrosini) e nel giolittismo, con l’assunzione di Croce nell’ultimo governo Giolitti.
Di questo movimento, oggi, vien data una interpretazione tendenziosa anche da G. Prezzolini che ne fu una tipica incarnazione; ma rimane la prima edizione della Cultura italiana di Prezzolini, del 1923, con le sue «omissioni», come documento autentico. Questo movimento giunge fino al Gobetti e alle sue iniziative di cultura e trova in lui il suo punto di risoluzione. Gobetti rappresenta il punto d’approdo di questo movimento e la fine del blocco, cioè l’origine della sua dissoluzione. La polemica di Giovanni Ansaldo contro Guido Dorso è il documento più espressivo di questa dissoluzione, anche per una certa comicità di atteggiamenti gladiatori di intimidazione dell’«unitarismo ossessionato». Da questo complesso di avvenimenti e di spunti polemici deriva un criterio per ricercare la diversa «saggezza» delle diverse correnti che si contesero la direzione politica e ideologica del Partito d’Azione: il collegamento delle diverse classi rurali che si realizza in un blocco attraverso i diversi ceti intellettuali può essere dissolto per addivenire a una nuova formazione (passaggio dal borbonesimo al regime liberale nazionale nell’Italia meridionale) solo se si fa forza in due direzioni: sui contadini di base accettandone le rivendicazioni e facendo di esse parte integrante del nuovo programma di governo e sugli intellettuali insistendo sui motivi che più li possono interessare. Il rapporto tra queste due azioni è dialettico: se i contadini si muovono, gli intellettuali incominciano a oscillare e reciprocamente se un gruppo di intellettuali si pone sulla nuova base, essi finiscono col trasportare con sé frazioni di massa sempre più importanti.
Si può dire, data la dispersione e l’isolamento della popolazione rurale e la difficoltà quindi di concentrarli in forti organizzazioni, che conviene iniziare il lavoro politico dagli intellettuali, ma in generale è il rapporto dialettico tra le due azioni che occorre tener presente. Si può dire anche che partiti contadini nel senso proprio della parola è quasi impossibile crearne: il partito nei contadini si realizza in generale come forte corrente di opinioni, non in forme schematiche; ma l’esistenza anche di uno scheletro di partito è di immensa utilità, sia per una certa selezione di uomini, sia per controllare gli intellettuali e impedire che gli «interessi di casta» li trasportino impercettibilmente in altro terreno.
Questo criterio deve essere tenuto presente nello studio di Giuseppe Ferrari che fu lo specialista inascoltato in questioni agrarie del Partito d'Azione. In Giuseppe Ferrari bisogna anche studiare bene il suo atteggiamento verso il bracciantato agricolo, cioè i contadini senza terra, sui quali egli fonda una parte cospicua delle sue ideologie per cui egli è ancora ricercato e studiato da determinate correnti moderne (opere del Ferrari ristampate dal Monanni con prefazione di Luigi Fabbri). Occorre riconoscere che il problema del bracciantato è difficilissimo e rende arduo anche oggi il trovarne una soluzione. In generale occorre tener presenti questi criteri: i braccianti sono anche oggi ed erano tanto più nel periodo del Risorgimento, dei semplici contadini senza terra, non degli operai di una industria agricola sviluppata con capitale concentrato. La loro psicologia perciò è, salvo eccezioni, la stessa del colono e del piccolo proprietario. (Bisognerebbe rivedere la polemica tra i senatori Bassini e Tanari nel «Resto del Carlino» e nella «Perseveranza» della fine del 17 o del 18 a proposito della realizzazione della formula «la terra ai contadini» lanciata durante la guerra: il Tanari era pro, il Bassini contro sulla base della sua esperienza di grande industriale agricolo, di proprietario di aziende agricole in cui la divisione del lavoro era già talmente progredita da rendere indivisibile la terra per la sparizione del contadino‑artigiano e l’emergere dell’operaio). In una forma acuta la quistione si poneva non tanto nel Mezzogiorno, dove il carattere artigianesco del lavoro contadino è troppo evidente, ma nella valle padana dove esso è più velato.
Anche in tempi recenti però l’esistenza del bracciantato padano era dovuta in parte a cause extraeconomiche: 1° sovrappopolazione che non trovava lo sbocco nell’emigrazione come nel Sud ed era artificialmente mantenuta con la politica dei lavori pubblici; 2° volontà dei proprietari che non volevano consolidare in un’unica classe né di braccianti né di mezzadri la popolazione rurale e quindi alternavano alla mezzadria la conduzione a economia, servendosi di questa alternanza anche per selezionare un gruppo di mezzadri privilegiati che fossero i loro alleati politici (in ogni congresso di agrari della regione padana si discute sempre se convenga meglio la mezzadria o la conduzione diretta, e traspare la motivazione politica della scelta che vien fatta). Il problema del bracciantato padano appariva nel Risorgimento sotto la forma di fenomeno pauroso di pauperismo. Così è visto da Tullio Martello nella sua Storia dell’Internazionale del 1871‑72, lavoro che occorre tener presente perché riflette ancora le passioni politiche e le preoccupazioni sociali del periodo precedente.
La posizione del Ferrari poi è indebolita dal suo «federalismo», che specialmente in lui, vivente in Francia, appariva ancor più come il riflesso degli interessi nazionali e statali francesi. Ricordare Proudhon e i suoi pamphlets contro l’unità italiana, combattuta dal punto di vista confessato dell’interesse statale francese e della democrazia: tutte le correnti principali della politica francese erano contro l’unità italiana. Ancora oggi i monarchici (Bainville, ecc.) fanno la lotta contro il principio nazionalitario dei due Napoleoni che avrebbe portato all’unificazione della Germania e dell’Italia, abbassando così la statura relativa della Francia.
È proprio sulle parole d’ordine di «unità e indipendenza» senza tener conto del concreto contenuto politico che i moderati formarono il blocco nazionale sotto la loro egemonia. Come fossero riusciti nell’intento lo dimostra anche questa espressione di Guerrazzi in una lettera a uno studente siciliano (pubblicata nell’«Archivio Storico Siciliano» da Eugenio de Carlo — carteggio di F. D. Guerrazzi col notaio Francesco Paolo Sardofontana di Riella, riassunto nel «Marzocco» del 24 novembre 1929): «Sia che vuolsi — o dispotismo, o repubblica o che altro, — non cerchiamo di dividerci; con questo cardine, caschi il mondo, ritroveremo la via»; ma di questi esempi se ne potrebbero citare a migliaia e tutta l’operosità di Mazzini è stata concretamente riassunta nella propaganda per l’unità. (Naturalmente i moderati dopo il 48, quando furono riorganizzati da Cavour intorno al Piemonte).
A proposito del giacobinismo e del Partito d'Azione un elemento da ricordare è che i giacobini conquistarono con la lotta la loro funzione di partito dirigente: essi si imposero alla borghesia francese, conducendola su una posizione molto più avanzata di quella che la borghesia avrebbe voluto «spontaneamente» e anche molto più avanzata di quella che le premesse storiche dovevano consentire, e perciò i colpi di ritorno e la funzione di Napoleone. Questo tratto, caratteristico del giacobinismo e quindi di tutta la Rivoluzione Francese, del forzare la situazione (apparentemente) e del creare fatti compiuti irreparabili, cacciando avanti la classe borghese a calci nel sedere, da parte di un gruppo di uomini estremamente energici e risoluti può essere «schematizzato» così: il terzo stato era il meno omogeneo degli stati; la borghesia ne costituiva la parte più avanzata culturalmente ed economicamente; lo sviluppo degli avvenimenti francesi mostra lo sviluppo politico di questa parte, che inizialmente pone le questioni che solo interessano i suoi componenti fisici attuali, i suoi interessi «corporativi» immediati (corporativi in un senso speciale, di immediati ed egoistici di un determinato gruppo ristretto sociale); i precursori della rivoluzione sono dei riformisti moderati, che fanno la voce grossa ma in realtà domandano ben poco. Questa parte avanzata perde a mano a mano i suoi caratteri «corporativi» e diventa classe egemone per l’azione di due fattori: la resistenza delle vecchie classi e l’attività politica dei giacobini.
Le vecchie classi non vogliono cedere nulla e se cedono qualche cosa lo fanno con l’intenzione di guadagnare tempo e preparare la controffensiva; la borghesia sarebbe caduta in questi «tranelli» successivi senza l’azione energica dei giacobini, che si oppongono ad ogni arresto intermedio e mandano alla ghigliottina non solo i rappresentanti delle vecchie classi, ma anche i rivoluzionari di ieri oggi diventati reazionari. I giacobini dunque rappresentano il solo partito della rivoluzione, in quanto essi non solo vedono gli interessi immediati delle persone fisiche attuali che costituiscono la borghesia francese, ma vedono gli interessi anche di domani e non di quelle sole determinate persone fisiche, ma degli altri strati sociali del terzo stato che domani diventeranno borghesi, perché essi sono persuasi dell’égalité e della fraternité. Bisogna ricordare che i giacobini non erano astrattisti, anche se il loro linguaggio «oggi» in una nuova situazione e dopo più di un secolo di elaborazione storica, sembra «astrattista». Il linguaggio dei giacobini, la loro ideologia, rifletteva perfettamente i bisogni dell’epoca, secondo le tradizioni e la cultura francese (cfr nella Sacra Famiglia l’analisi di Marx da cui risulta che la fraseologia giacobina corrispondeva perfettamente ai formulari della filosofia classica tedesca, alla quale oggi si riconosce maggiore concretezza e che ha dato origine allo storicismo moderno): 1° bisogno: annientare la classe avversaria o almeno ridurla all’impotenza; creare l’impossibilità di una controrivoluzione; 2° allargare gli interessi di classe della borghesia, trovando gli interessi comuni tra essa e gli altri strati del terzo stato, mettere in moto questi strati, condurli alla lotta, ottenendo due risultati: 1° di opporre un bersaglio più largo ai colpi della classe avversa, cioè di creare un rapporto militare favorevole alla rivoluzione; 2° di togliere alla classe avversa ogni zona di passività in cui essa avrebbe certamente creato eserciti vandeani (senza la politica agraria dei giacobini Parigi sarebbe stata circondata dalla Vandea fino alle sue porte: la resistenza della Vandea propriamente detta è legata alla quistione nazionale determinata tra i Brettoni dalla formula della «repubblica una e indivisibile», alla quale i giacobini non potevano rinunziare pena il suicidio: i girondini cercarono di far leva sul federalismo per schiacciare i giacobini, ma le truppe provinciali condotte a Parigi passarono ai giacobini: eccetto la Brettagna e altre piccole zone periferiche, la quistione agraria si presentava scissa dalla quistione nazionale, come si vede in questo e altri episodi militari: la provincia accettava l’egemonia di Parigi, cioè i rurali comprendevano che i loro interessi erano legati a quelli della borghesia). I giacobini dunque forzarono la mano, ma sempre nel senso dello sviluppo storico reale, perché essi fondarono non solo lo Stato borghese, fecero della borghesia la classe «dominante», ma fecero di più (in un certo senso), fecero della borghesia la classe dirigente, egemone, cioè dettero allo Stato una base permanente.
Che i giacobini siano sempre rimasti sul terreno di classe, è dimostrato dagli avvenimenti che segnarono la loro fine e la morte di Robespierre: essi non vollero riconoscere agli operai il diritto di coalizione (legge Chapelier e [sue conseguenze nella legge del «maximum»]) e così spezzarono il blocco urbano di Parigi; le loro forze d’assalto, che si riunivano nel Comune, si dispersero, deluse, e il Termidoro ebbe il sopravvento: la rivoluzione aveva trovato i suoi limiti di classe: la politica degli «alleati» aveva fatto sviluppare quistioni nuove che allora non potevano essere risolte.
Nel Partito d'Azione non troviamo questo spirito giacobino, questa volontà di diventare «partito dirigente». Occorre tener conto delle differenze: in Italia la lotta si presentava come lotta contro i vecchi trattati e contro la Potenza straniera, l’Austria, che li rappresentava e li sosteneva in Italia con le armi, occupando il Lombardo‑Veneto ed esercitando un controllo sul resto del territorio. Anche in Francia il problema si presentò, almeno in un certo senso, perché ad un certo punto la lotta interna divenne lotta nazionale combattuta alla frontiera, ma i giacobini seppero trarne elementi di maggior energia: essi compresero bene che per vincere il nemico esterno dovevano schiacciare all’interno i suoi alleati e non esitarono a compiere le stragi di settembre. In Italia questo legame che pur esisteva, esplicito ed implicito, tra l’Austria e una parte almeno delle alte classi nobiliari e terriere, non fu denunziato dal Partito d’Azione o almeno non fu denunziato con la dovuta energia: in ogni modo non divenne elemento politico attivo. Si trasformò, curiosamente, in una quistione di maggiore o minore dignità patriottica e dette poi luogo a uno strascico di polemiche acrimoniose, ma sterili fino al 98 (cfr articoli di «Rerum Scriptor» nella «Critica Sociale» e il libro di Bonfadini Cinquant’anni di patriottismo).
Ricordare a questo proposito la quistione dei «costituti» di Federico Confalonieri; il Bonfadini nel suo libro su citato afferma che i «costituti» si trovano nell’Archivio di Stato di Milano; mi pare accenni a 80 fascicoli; altri hanno sempre negato che i «costituti» esistessero in Italia e così spiegavano la non pubblicazione; in un articolo sul «Corriere della Sera» del senatore Salata, incaricato dal Governo di far ricerche negli Archivi di Vienna sulla storia italiana, si diceva, verso il 24 o 25, che i «costituti» erano stati da lui trovati. Ricordare il fatto che in un certo periodo la «Civiltà Cattolica» sfidò i liberali a pubblicarli, affermando che essi, conosciuti, avrebbero nientedimeno fatto saltare in aria la unità italiana. Il fatto notevole nella quistione Confalonieri consiste in questo: che a differenza di altri patriotti graziati dall’Austria, il Confalonieri, che pure era un rimarchevole uomo di Stato, si ritirò dalla vita politica attiva e mantenne, dopo la sua liberazione, un contegno molto riservato. Tutta la quistione del Confalonieri è da esaminare, insieme con l’atteggiamento tenuto al processo da lui e dai suoi compagni, anche su un esame più approfondito delle memorie scritte dai singoli, quando le scrissero: per le polemiche che suscitò, interessanti le memorie del francese Alessandro Andryane in parte piccolissima pubblicate da Rosolino Guastalla in una edizione Barbera, che, mi pare, se attaccò il Pallavicino per la sua debolezza, tributa invece molto rispetto al Confalonieri.
A proposito delle difese fatte anche recentemente dell’atteggiamento tenuto dall’aristocrazia lombarda verso l’Austria, specialmente dopo l’insurrezione del febbraio 53 e durante il viceregno di Massimiliano, ricordare che Alessandro Luzio, la cui opera storica è completamente tendenziosa, giunge fino a legittimare i fedeli servizi pretati all’Austria dal Salvotti e C.; altro che spirito giacobino!.
La punta comica nella quistione è data da Alfredo Panzini che, nella Vita di Cavour, fa tutta una variazione altrettanto leziosa quanto stucchevole e gesuitica sulla «pelle di tigre» esposta da una finestra aristocratica durante una visita a Milano di Francesco Giuseppe!!.
Da tutti questi punti di vista devono essere considerate le concezioni di Missiroli, Gobetti, Dorso, ecc. sul Risorgimento italiano come «conquista regia».
Se in Italia non sorse un partito giacobino, ci devono essere le ragioni da ricercare nel campo economico, cioè nella relativa debolezza della borghesia italiana, e nella temperatura storica diversa dell’Europa. Il limite trovato dai giacobini, nella loro politica di forzato risveglio delle energie popolari francesi da alleare alla borghesia, con la legge Chapelier e la legge sul «maximum»Aggiunto a margine in epoca posteriore., si presentava nel 48 come uno «spettro» già minaccioso, sapientemente agitato dall’Austria e dai vecchi governi, ma anche da Cavour (oltre che dal Papa). La borghesia non poteva più estendere la sua egemonia su i vasti strati che poté abbracciare in Francia, è vero, ma l’azione sui contadini era sempre possibile. Differenza tra Francia, Germania e Italia nel processo di presa del potere della borghesia (e Inghilterra). In Francia abbiamo il fenomeno completo, la maggior ricchezza di elementi politici. In Germania il fenomeno rassomiglia per alcuni aspetti a quello italiano, per altri a quello inglese. In Germania il 48 fallisce per la poca concentrazione borghese (la parola d’ordine di tipo giacobino fu data nel 48 tedesco da Marx: «rivoluzione in permanenza») e perché la quistione è intrecciata con quella nazionale; le guerre del 64, del 66 e del 70 risolvono la quistione nazionale e la quistione di classe in un tipo intermedio: la borghesia ottiene il governo economico‑industriale, ma le vecchie classi feudali rimangono come ceto governativo con ampi privilegi di casta nell’esercito, nell’amministrazione statale e sulla terra; ma almeno in Germania queste vecchie classi, se conservano tanta importanza e mantengono tanti privilegi, esercitano una funzione, sono gli «intellettuali» della borghesia, con un determinato temperamento dato dall’origine di classe e dalla tradizione. In Inghilterra, dove la Rivoluzione borghese si è svolta prima che in Francia, abbiamo lo stesso fenomeno che in Germania di fusione tra il vecchio e il nuovo, nonostante l’estrema energia dei «giacobini» inglesi, cioè le «teste rotonde» di Cronwell: la vecchia aristocrazia rimane come ceto governativo, con certi privilegi, diventa anch’essa il ceto intellettuale della borghesia inglese (vedi in proposito le osservazioni di Engels nella prefazione inglese, mi pare, a Utopia e Scienza, che occorre ricordare per questa ricerca sugli intellettuali e le loro funzioni storiche di classe).
La spiegazione data da Antonio Labriola sulla permanenza al potere in Germania degli Junker e del kaiserismo nonostante il grande sviluppo capitalistico adombra la giusta spiegazione: il rapporto di classe creatosi per lo sviluppo industriale col raggiungimento del limite dell’egemonia borghese e col rovesciamento delle situazioni di classi progressive, induce la borghesia a non lottare a fondo contro il vecchio mondo, ma a lasciarne sussistere quella parte di facciata che serva a velare il suo dominio.
Questo diverso manifestarsi dello stesso fenomeno nei diversi paesi è da legare ai diversi rapporti non solo interni, ma anche internazionali (i fattori internazionali di solito sono sottovalutati in queste ricerche). Lo spirito giacobino, audace, temerario, è certamente legato all’egemonia esercitata dalla Francia per tanto tempo. Le guerre di Napoleone, invece, con l’enorme distruzione di uomini, tra i più forti e avventurosi, indeboliscono non solo le energie francesi, ma anche quelle delle altre nazioni, sebbene diano anche formidabili lezioni di energia nuova.
I fattori internazionali sono stati certo fortissimi nel determinare la linea del Risorgimento. Essi poi sono stati ancora più esagerati dal partito moderato (Cavour) a scopo di partito: è notevole il fatto, a questo proposito, di Cavour che teme come il fuoco l’iniziativa garibaldina prima della spedizione di Quarto per le complicazioni internazionali che può creare e poi è spinto egli stesso dall’entusiasmo creato dai mille nell’opinione pubblica europea fino a vedere come fattibile una nuova guerra all’Austria. Esisteva dunque in Cavour una certa deformazione professionale del diplomatico, che lo portava a vedere «troppe» difficoltà e lo induceva a una esagerazione cospirativa e a prodigi, che sono in gran parte funamboleschi, di sottigliezza e di intrigo. In ogni caso egli fece bene la sua parte di uomo di partito; che poi questo partito rappresentasse la nazione, anche solo nel senso della più vasta estensione della comunità di interessi della borghesia con altre classi, è un’altra quistione.
A proposito della parola d’ordine «giacobina» lanciata da Marx alla Germania del 48‑49 è da osservare la sua complicata fortuna. Ripresa, sistematizzata, elaborata, intellettualizzata dal gruppo Parvus-Bronstein [Trotzky ndc], si manifestò inerte e inefficace nel 1905 e in seguito: era una cosa astratta, da gabinetto scientifico. La corrente che la avversò in questa sua manifestazione intellettualizzata, invece, senza usarla «di proposito» la impiegò di fatto nella sua forma storica, concreta, vivente, adatta al tempo e al luogo, come scaturiente da tutti i pori della società che occorreva trasformare, di alleanza tra due classi con l’egemonia della classe urbana.
Nell’un caso, temperamento giacobino senza il contenuto politico adeguato, tipo Crispi; nel secondo caso temperamento e contenuto giacobino secondo i nuovi rapporti storici, e non secondo un’etichetta intellettualistica.
Q1 §45 Intellettuali siciliani. Rivalità fra Palermo e Catania per contendersi il primato intellettuale dell’isola. — Catania chiamata l’Atene siciliana, anzi la «sicula Atene». —
Celebrità di Catania: Domenico Tempio, poeta licenzioso, la cui attività viene dopo il terremoto del 1693 che distrusse Catania (Antonio Prestinenza collega il tono licenzioso del poeta al fatto del terremoto: morte — vita — distruzione — fecondità). — Vincenzo Bellini, contrapposto al Tempio per la sua melanconia romantica.
Mario Rapisardi è la gloria moderna di Catania. Garibaldi gli scrive: «All’avanguardia del progresso noi vi seguiremo» e Victor Hugo: «Vous êtes un précurseur». — Rapisardi‑Garibaldi‑Victor Hugo. — Polemica Carducci‑Rapisardi. — Rapisardi‑De Felice (il primo maggio De Felice conduceva il corteo sotto il portone di Rapisardi). — Popolarismo socialista mescolato col culto superstizioso di Sant’Agata: quando Rapisardi in punto di morte si volle che rientrasse nella Chiesa: «Tal visse Argante e tal morì qual visse» disse Rapisardi. — Accanto al Rapisardi: Verga, Capuana, De Roberto, che però non considerati «sicilianissimi», anche perché legati alle correnti continentali e amici del Carducci. — Catania e l’Abruzzo nella letteratura italiana dell’ottocento.
Q1 §46 Moderati e gli intellettuali. I moderati dovevano avere il sopravvento tra gli intellettuali. Mazzini e Gioberti. Gioberti offriva agli intellettuali una filosofia che sembrava nazionale e originale, tale da porre l’Italia allo stesso livello delle nazioni più progredite e dare nuova dignità al «pensiero» italiano; Mazzini dava solo degli aforismi e degli accenni filosofici che a molti intellettuali, specialmente meridionali, dovevano sembrare vuote chiacchiere (il Galiani aveva «sfottuto» quel modo di pensare e di scrivere). Quistione della scuola. Attività dei moderati per introdurre il principio pedagogico dell’«insegnamento reciproco» (Confalonieri, Capponi ecc.); movimento di Ferrante Aporti e degli asili, legato anche al pauperismo. Era il solo movimento concreto contro la scuola «gesuitica» e non poteva non avere efficacia non solo fra i laici, ai quali dava una personalità propria, ma anche nel clero liberaleggiante e antigesuitico (ostilità contro Ferrante Aporti ecc.; il ricovero e l’educazione dell’infanzia abbandonata era un monopolio del clericalismo e queste iniziative spezzavano il monopolio).
Queste attività scolastiche del Risorgimento di carattere liberale o liberaleggiante hanno una grande importanza per afferrare il meccanismo dell’egemonia dei moderati sugli intellettuali. L’attività scolastica, in tutti i suoi gradi, ha un’importanza enorme, anche economica, per gli intellettuali di tutti i gradi; l’aveva allora anche maggiore, data la ristrettezza dei quadri sociali e le scarse strade aperte all’iniziativa degli intellettuali (oggi: giornalismo, movimento di partiti ecc. hanno allargato moltissimo i quadri intellettuali).
L’egemonia di un centro direttivo sugli intellettuali ha queste due linee strategiche: «una concezione generale della vita», una filosofia (Gioberti), che dia agli aderenti una «dignità» da contrapporre alle ideologie dominanti come principio di lotta; un programma scolastico che interessi e dia una attività propria nel loro campo tecnico a quella frazione degli intellettuali che è la più omogenea e la più numerosa (insegnanti, dai maestri ai professori d’Università).
I Congressi degli scienziati che si ripeterono nel Risorgimento ebbero una doppia efficacia: 1° riunire gli intellettuali del grado più elevato, moltiplicando così la loro influenza; 2° ottenere una più rapida concentrazione degli intellettuali dei gradi più bassi, che sono portati normalmente a seguire gli universitari, i grandi scienziati per spirito di casta.
Lo studio delle Riviste enciclopediche e specializzate dà un altro aspetto di questa egemonia. Un partito come quello moderato offriva alla massa degli intellettuali tutte le soddisfazioni per le esigenze generali che possono essere offerte da un governo (da un partito al governo) attraverso i servizi statali (per questa funzione di partito «di governo» servì ottimamente dopo il 48 lo Stato piemontese che accolse gli intellettuali esuli e mostrò in modello ciò che sarebbe stato il futuro Stato unitario).
Q1 §47 Hegel e l’associazionismo. La dottrina di Hegel sui partiti e le associazioni come trama «privata» dello Stato. Essa derivò storicamente dalle esperienze politiche della Rivoluzione francese e doveva servire a dare una maggiore concretezza al costituzionalismo. Governo col consenso dei governati, ma col consenso organizzato, non generico e vago quale si afferma nell’istante delle elezioni: lo Stato ha e domanda il consenso, ma anche «educa» questo consenso con le associazioni politiche e sindacali, che però sono organismi privati, lasciati all’iniziativa privata della classe dirigente. Hegel, in un certo senso supera già, così, il puro costituzionalismo e teorizza lo Stato parlamentare col suo regime dei partiti. La sua concezione dell’associazione non può essere che ancora vaga e primitiva, tra il politico e l’economico, secondo l’esperienza storica del tempo, che era molto ristretta e dava un solo esempio compiuto di organizzazione, quello «corporativo» (politica innestata nell’economia).
Marx non poteva avere esperienze storiche superiori a quelle di Hegel (almeno molto superiori), ma aveva il senso delle masse, per la sua attività giornalistica e agitatoria. Il concetto di Marx dell’organizzazione rimane ancora impigliato tra questi elementi: organizzazione di mestiere, clubs giacobini, cospirazioni segrete di piccoli gruppi, organizzazione giornalistica. La Rivoluzione francese offre due tipi prevalenti: i clubs, che sono organizzazioni non rigide, tipo «comizio popolare», centralizzate da singole individualità politiche, ognuna delle quali ha il suo giornale, con cui tiene desta l’attenzione e l’interesse di una determinata clientela sfumata ai margini, che poi sostiene le tesi del giornale nelle riunioni del club. È certo che in mezzo agli assidui dei clubs dovevano esistere aggruppamenti ristretti e selezionati di gente che si conosceva reciprocamente, che si riuniva a parte e preparava l’atmosfera delle riunioni per sostenere l’una o l’altra corrente secondo i momenti e anche secondo gli interessi concreti in gioco. Le cospirazioni segrete, che poi ebbero tanta diffusione in Italia prima del 48, dovettero svilupparsi dopo il Termidoro in Francia, tra i seguaci di seconda linea del giacobinismo, con molte difficoltà nel periodo napoleonico per l’occhiuto controllo della polizia, con più facilità dal 15 al 30 sotto la Restaurazione, che fu abbastanza liberale alla base e non aveva certe preoccupazioni. In questo periodo dal 15 al 30 dovette avvenire la differenziazione del campo politico popolare, che appare già notevole nelle «gloriose giornate» del 1830, in cui affiorano le formazioni venutesi costituendo nel quindicennio precedente. Dopo il 30 e fino al 48 questo processo di differenziazione si perfeziona e dà dei tipi abbastanza compiuti con Blanqui e con Filippo Buonarroti.
È difficile che Hegel potesse conoscere da vicino queste esperienze storiche, che invece erano più vivaci in Marx (su questa serie di fatti vedere come primo materiale le pubblicazioni di Paul Louis e il Dizionario politico di Maurice Block; per la Rivoluzione francese specialmente Aulard; vedere anche le dell’Andler al Manifesto; per l’Italia il libro del Luzio sulla Massoneria e il Risorgimento, molto tendenzioso).
Q1 §48 Il giacobismo a rovescio di Carlo Maurras (seguito al Q1 § di p. 8 bis). Lo sviluppo del giacobinismo (di contenuto) ha trovato la sua perfezione formale nel regime parlamentare, che realizza nel periodo più ricco di energie «private» nella società l’egemonia della classe urbana su tutta la popolazione, nella forma hegeliana di governo col consenso permanentemente organizzato (coll’organizzazione lasciata all’iniziativa privata, quindi di carattere morale o etico, perché consenso «volontario», in un modo o nell’altro). Il «limite» trovato dai giacobini con la legge Chapelier o il maximum viene superato e allargato attraverso un processo complesso, teorico‑pratico (giuridico‑politico = economico), per cui si riottiene il consenso politico (si mantiene l’egemonia) allargando e approfondendo la base economica con lo sviluppo industriale e commerciale fino alla epoca dell’imperialismo e alla guerra mondiale. In questo processo si alternano insurrezioni e repressioni, allargamenti e restrizioni del suffragio politico, libertà di associazione e restrizione o annullamento di questa libertà, libertà nel campo sindacale ma non nel campo politico, forme diverse del suffragio, di lista o per piccola circoscrizione, proporzionale o individuale, con le varie combinazioni che ne risultano, il sistema di una camera o delle due camere, coi vari modi di scelta per ognuna (camera vitalizia ed ereditaria, o solamente vitalizia, elettiva anch’essa, ma non come la camera bassa, ecc.), col vario equilibrio dei poteri, per cui la magistratura è un potere o un ordine, indipendente o controllato e diretto dal governo, con le diverse attribuzioni del capo dello Stato, col diverso equilibrio interno degli organismi territoriali (centralismo o decentramento, minori o maggiori poteri dei prefetti, dei Consigli provinciali, dei comuni); con un diverso equilibrio tra forze armate di leva e corpi armati professionali (polizia, gendarmeria); con la dipendenza di questi corpi professionali dall’uno o dall’altro potere statale (dalla magistratura, dal ministro dell’interno o da quello della guerra); con la maggiore o minore parte lasciata alla consuetudine o alla legge scritta, per cui si sviluppano delle forme consuetudinarie che possono essere abolite in virtù della legge scritta; con il distacco reale più o meno grande tra i regolamenti e le leggi fondamentali, con l’uso più o meno grande di decreti legge che si sovrappongono alla legislazione ordinaria e la modificano in certe occasioni, forzando la «pazienza» del parlamento. A questo processo contribuiscono i teorici‑filosofi, i pubblicisti, i partiti politici ecc. per la parte formale e i movimenti di massa per la parte sostanziale, con azioni e reazioni reciproche, con iniziative «preventive» prima che un fenomeno si manifesti pericolosamente e con repressioni quando le prevenzioni sono mancate o sono state tardive o inefficaci. L’esercizio «normale» dell’egemonia nel terreno divenuto classico del regime parlamentare, è caratterizzato da una combinazione della forza e del consenso che si equilibrano, senza che la forza soverchi di troppo il consenso, anzi appaia appoggiata dal consenso della maggioranza espresso dai così detti organi dell’opinione pubblica (i quali perciò, in certe situazioni, vengono moltiplicati artificiosamente). Tra il consenso e la forza sta la corruzione‑frode (che è caratteristica di certe situazioni di difficile esercizio della funzione egemonica presentando l’impiego della forza troppi pericoli), cioè lo snervamento e la paralisi procurati all’antagonista o agli antagonisti con l’accaparrarne i dirigenti, copertamente in via normale, apertamente in caso di pericolo prospettato per gettare lo scompiglio e il disordine nelle file antagoniste.
Nel periodo del dopoguerra, l’apparato egemonico si screpola e l’esercizio dell’egemonia diventa sempre più difficile. Il fenomeno viene presentato e trattato con vari nomi e sotto vari aspetti. I più comuni sono: «crisi del principio di autorità» — «dissoluzione del regime parlamentare». Naturalmente del fenomeno si descrivono solo le manifestazioni centrali, nel terreno parlamentare e governativo, e si spiegano col fallimento del «principio» parlamentare, del «principio» democratico ecc., non però del «principio» d’autorità (questo fallimento viene proclamato da altri). Praticamente questa crisi si manifesta nella sempre crescente difficoltà di formare dei governi e nella sempre crescente instabilità dei governi stessi ed ha la sua origine immediata nella moltiplicazione dei partiti parlamentari e nelle crisi interne permanenti di ognuno di questi partiti (cioè si verifica nell’interno di ogni partito ciò che si verifica nell’intero parlamento: difficoltà di governo). Le forme di questo fenomeno sono anche, in una certa misura, di corruzione e dissoluzione morale: ogni gruppetto interno di partito crede di avere la ricetta per arrestare l’indebolimento dell’intero partito e ricorre a ogni mezzo per averne la direzione o almeno per partecipare alla direzione così come nel parlamento il partito crede di essere il solo a dover formare il governo per salvare il paese o almeno, per dare l’appoggio al governo, di doverci partecipare il più largamente possibile; quindi contrattazioni cavillose e minuziose che non possono non essere personalistiche in modo da apparire scandalose. Forse nella realtà, la corruzione è minore di quanto si creda. Che gli interessati a che la crisi si risolva dal loro punto di vista, fingano di credere che si tratti della «corruzione» e «dissoluzione» di un «principio», potrebbe anche essere giustificato: ognuno può essere il giudice migliore nella scelta delle armi ideologiche che sono più appropriate ai fini che vuol raggiungere e la demagogia può essere ritenuta arma eccellente. Ma la cosa diventa comica quando il demagogo non sa di esserlo, quando cioè si opera praticamente come se si creda realmente che l’abito è il monaco, che il berretto è il cervello. Machiavelli e Stenterello. La crisi in Francia. Sua grande lentezza. I partiti francesi. Essi erano molto numerosi anche prima del 14. La loro molteplicità formale dipende dalla ricchezza di avvenimenti politici in Francia dal 1789 all’Affare Dreyfus. Ognuno di questi avvenimenti ha lasciato sedimenti e strascichi che si sono consolidati in partiti; ma le differenze essendo molto meno importanti delle coincidenze, in realtà ha regnato in parlamento il regime dei due partiti: liberali‑democratici (varie gamme del radicalesimo) e conservatori. La molteplicità dei partiti è stata utile nel passato: ha permesso una vasta opera di selezione e ha creato un gran numero di uomini di governo. Così ogni movimento dell’opinione pubblica trovava un immediato riflesso e una composizione. L’egemonia borghese è molto forte e ha molte riserve. Gli intellettuali sono molto concentrati (Accademia, Università, grandi giornali e riviste di Parigi) e quantunque numerosissimi, molto disciplinati ai centri di cultura. La burocrazia militare e civile ha una grande tradizione e ha raggiunto una grande omogeneità. La debolezza interna più pericolosa nell’apparato statale (militare e civile) era data dal clericalismo alleato ai monarchici. Ma la massa popolare, se pure cattolica, non era clericale. Nell’affare Dreyfus è culminata la lotta per paralizzare l’influenza clericale‑monarchica nell’apparato statale e per dare all’elemento laico la netta prevalenza. La guerra non ha indebolito, ma rafforzato l’egemonia; non si è avuto tempo di pensare: il paese è entrato in guerra e quasi subito il suo territorio è stato invaso. Il passaggio dalla vecchia disciplina alla nuova non ha domandato una crisi troppo grande: i vecchi quadri militari erano vasti abbastanza e abbastanza elastici: gli ufficiali subalterni e i sottufficiali erano forse i più scelti del mondo, i meglio allenati.
Confronto con altri paesi. La quistione degli arditi. La crisi dei quadri, il gran numero degli ufficiali di complemento. Gli arditi in altri paesi hanno rappresentato un nuovo esercito di volontari, una selezione militare, che ebbe una funzione tattica primordiale. Il contatto col nemico fu ricercato solo attraverso gli arditi, che formarono come un velo tra il nemico e l’esercito di leva (come le stecche di un busto). La fanteria francese formata in maggioranza di coltivatori diretti, cioè di uomini con una certa riserva muscolare e nervosa che rese più difficile il collasso fisico procurato dalla vita di trincea (il consumo medio di un francese è di circa 1 500 000 calorie all’anno, mentre quello italiano è di meno che un milione); in Francia il bracciantato è minimo (il contadino senza terra è servo di fattoria, cioè vive la stessa vita dei padroni e non conosce l’inedia della disoccupazione neanche stagionale, il vero bracciantato non arriva a un milione di persone); inoltre il vitto in trincea era migliore che in altri paesi e il passato democratico, ricco di lotte, aveva creato il cittadino, nel doppio senso, che l’uomo del popolo si sentiva qualche cosa, non solo, ma era ritenuto qualche cosa dai superiori, cioè non era sfottuto e bistrattato per bazzecole. Non si formarono così quei sedimenti di rabbia avvelenata e sorniona che si formarono altrove. Le lotte interne dopo l’armistizio mancarono perciò di grande asprezza e, specialmente, non si verificò l’inaudita oscillazione delle classi rurali. La crisi parlamentare francese indica che c’è un malessere diffuso nel paese, ma questo malessere non ha avuto sinora un carattere radicale, non ha posto in gioco quistioni «intangibili». C’è stato un allargamento della base industriale, e quindi un accresciuto urbanesimo. Masse di rurali si sono riversate in città, ma non perché ci fosse in campagna disoccupazione o fame insoddisfatta di terra; perché in città si sta meglio, ci sono più soddisfazioni (il prezzo della terra è basso e molte terre buone sono abbandonate agli italiani). La crisi parlamentare riflette (finora) piuttosto uno spostamento di masse normale (non dovuto a crisi economica), con una ricerca di nuovi equilibri di partito e un malessere vago, premonitore di una grande crisi. La stessa sensibilità dell’organismo politico porta a esagerare i sintomi del malessere. Si tratta per ora di una lotta per la divisione dei carichi statali e dei benefici statali, più che altro. Perciò crisi dei partiti medi e del partito radicale in primo luogo, che rappresenta le città medie e piccole e i contadini più avanzati. Le forze politiche si preparano alle grandi lotte future e cercano un miglior assestamento. Le forze extrastatali fanno sentire più sensibilmente il loro peso e impongono i loro uomini in modo più brutale.
Maurras grida già allo sfacelo e si prepara alla presa del potere. Maurras passa per un grande uomo di stato e per un grandissimo realista. In realtà egli è solo un giacobino alla rovescia. I giacobini usavano un certo linguaggio, seguivano una certa ideologia; nel loro tempo quel linguaggio e quella ideologia erano ultra‑realistici perché ottennero di far marciare le forze necessarie per ottenere i fini della rivoluzione e dettero alla classe rivoluzionaria il potere. Furono poi staccati dal tempo e dal luogo e ridotti in formule: erano una cosa diversa, uno spettro, delle parole vane e inerti. Il comico è che Maurras a quelle formule ne contrappose delle altre, in un sistema logico‑letterario formalmente impeccabile, ma del più puro illuminismo. Maurras rappresenta il più puro campione dello «stupido secolo XIX» la concentrazione di tutte le banalità massoniche rovesciate meccanicamente: la sua relativa popolarità viene appunto da questo, che il suo metodo piace perché è proprio quello della ragione ragionante da cui è sorto l’enciclopedismo, l’illuminismo e tutta la cultura massonica francese. Gli illuministi avevano creato il mito del selvaggio o che so io, Maurras crea il mito del passato monarchico francese; solo che questo mito è stato «storia» e le deformazioni intellettualistiche di esso possono essere troppo facilmente corrette.
La formula fondamentale di Maurras è «politique d’abord», ma egli è il primo a non osservarla. Prima della politica per lui c’è sempre l’«astrazione politica», l’accoglimento integrale di un programma «ideologico» minuziosissimo, che prevede tutti i particolari, come nelle utopie, che domanda una determinata concezione non della storia, ma della storia di Francia e d’Europa, cioè una determinata ermeneutica.
Léon Daudet ha scritto che la grande forza dell’Action Française è stata la incrollabile omogeneità e unità del suo gruppo dirigente. Sempre d’accordo, sempre solidali politicamente e ideologicamente.
Certo questa è una forza. Ma di carattere settario e massonico, non di grande partito di governo. Il linguaggio politico è diventato un gergo, si è formata un’atmosfera da conventicola: a forza di ripetere sempre le stesse formule, di maneggiare gli stessi schemi mentali irrigiditi, si finisce, è vero, col pensare allo stesso modo, perché si finisce col non pensar più. Maurras a Parigi e Daudet a Bruxelles pronunziano la stessa frase, senza accordo, sullo stesso avvenimento, ma l’accordo c’era già prima: erano già due macchinette di frasi montate da 20 anni per dire le stesse frasi nello stesso momento.
Il gruppo di Maurras si è formato per «cooptazione»: in principio c’era Maurras col suo verbo, poi si unì Vaugeois, poi Daudet, poi Pujo, ecc. ecc. Quando si staccò Valois fu una catastrofe di polemiche e di accuse. Dal punto di vista di tipo d’organizzazione l’Action Française è molto interessante. La sua forza è costituita di questi elementi: che i suoi elementi di base sono tipi sociali selezionati intellettualmente, nobili, intellettuali, ex‑ufficiali, studenti, gente cioè che è portata a ripetere pappagallescamente le formule di Maurras e anzi a trarne profitto «snobistico»; in una repubblica può essere segno di distinzione l’essere monarchici, in una democrazia parlamentare l’essere reazionar conseguenti; che sono ricchi, così che possono dare tanti fondi da permettere molteplici iniziative che danno l’apparenza di una certa vitalità e attività; la ricchezza di mezzi e la posizione sociale degli aderenti palesi ed occulti permette al giornale e al centro politico di avere una massa di informazioni e di documenti riservati che danno al giornale il mezzo delle polemiche personali: nel passato, ma in parte anche ora, il Vaticano doveva essere una fonte di primo ordine (il Vaticano, come centro, la Segreteria di Stato e l’alto clero francese; molte campagne devono essere a chiave o a mezza chiave: una parte di vero che fa capire che si sa tutto o allusioni furbesche comprensibili dagli interessati). A queste campagne il giornale dà un doppio significato: galvanizzare i propri aderenti sfoggiando conoscenza delle più segrete cose, ciò che dà l’impressione di gran forza d’organizzazione e di capacità, e paralizzare gli avversari, con la minaccia di disonorarli, per fare di alcuni dei fautori segreti.
La concezione pratica che si può ricavare da tutta l’attività dell’Action Française è questa: il regime parlamentare repubblicano si dissolverà ineluttabilmente perché esso è un «monstrum» storico che non corrisponde alle leggi «naturali» della società francese fissate da Maurras. I nazionalisti integrali devono: 1° appartarsi dalla vita reale della politica francese, non riconoscendone la legalità (astensionismo, ecc.), combattendola in blocco; 2° creare un antigoverno, sempre pronto a insediarsi «nei palazzi tradizionali», per un colpo di mano; questo antigoverno si presenta già oggi con tutti gli uffici embrionali, che corrispondono alle grandi attività nazionali. Furono fatti molti strappi a questo rigore: nel 19 furono presentate delle candidature; nelle altre elezioni l’Action Française appoggiò i candidati di destra che accettavano alcuni suoi principii marginali (significa che tra Maurras e gli altri l’accordo non era perfetto). Per uscire dall’isolamento fu progettata la pubblicazione di un grande giornale d’informazione, ma finora non pare che se ne sia fatto nulla (esiste solo la «Revue Universelle» che compie questo ufficio nel campo delle riviste). La recente polemica col Vaticano ha rotto il solo legame che l’Action Frariffise avesse con larghe masse, legame anch’esso piuttosto aleatorio. Il suffragio universale introdotto dalla Repubblica ha portato già da tempo in Francia al fatto che le masse cattoliche politicamente aderiscono ai partiti del centro e di sinistra, sebbene questi partiti siano anticlericali. La formula che la religione è una «quistione privata» si è radicata come forma popolare della separazione della Chiesa dallo Stato. Di più il complesso di associazioni che costituiscono l’Azione Cattolica francese è in mano alla aristocrazia terriera (il generale Castelnau), senza che il basso clero eserciti quella funzione di guida spirituale‑sociale che esercitava in Italia (settentrionale specialmente). Il contadino francese rassomiglia piuttosto al nostro contadino meridionale, che volentieri dice: «il prete è prete sull’altare, ma fuori è un uomo come tutti gli altri» (se non peggio). L’Action Française attraverso lo strato dirigente cattolico pensava di dominare tutto l’apparecchio di massa del cattolicismo francese. Certo c’era molta illusione in ciò, ma tuttavia doveva esserci una parte di verità, perché il legame religioso, rilassato in tempi normali, diventa più vigoroso e assorbente in epoche di grande crisi politico‑morale, quando l’avvenire appare pieno di nubi tempestose. In realtà anche questa riserva possibile è svanita per Maurras. La politica del Vaticano non vuole più «astenersi» dagli affari interni francesi; ma il Vaticano è più realista di Maurras e concepisce meglio il motto «politique d’abord». Finché il contadino cattolico dovrà scegliere tra Herriot e un hobereau, sceglierà Herriot: bisogna creare il tipo politico del «radicale cattolico», cioè del «popolare», bisogna accettare la Repubblica e la democrazia e su questo terreno organizzare le masse facendo sparire (superando) il dissidio tra religione e politica, facendo del prete non solo la guida spirituale (nel campo individuale‑privato) ma anche la guida sociale nel campo politico‑economico.
La sconfitta di Maurras è certa: è la sua concezione che è falsa per troppa perfezione logica. Del resto la sconfitta era sentita da Maurras proprio all’inizio della crisi col Vaticano, che coincise con la crisi parlamentare francese del 25. Quando i ministeri si succedevano a rotazione, l’Action Française pubblicò di essere pronta a prendere il potere. Fu pubblicato un articolo in cui si giunge fino ad invitare Caillaux a collaborare, Caillaux per il quale si annunziava sempre il plotone di esecuzione. L’episodio è classico: la politica irrigidita e razionalistica tipo Maurras, dell’astensionismo aprioristico, delle leggi naturali siderali che reggono la società è condannata al marasma, al crollo, all’abdicazione al momento risolutivo. Allora si vede che le grandi masse di energia non si riversano nei serbatoi creati artificialmente, ma seguono le vie della storia, si spostano secondo i partiti che sono stati sempre attivi. A parte la stoltezza di credere che nel 25 potesse avvenire il crollo della Repubblica per la crisi parlamentare (l’intellettualismo porta a queste allucinazioni monomaniache), ci fu un crollo morale, se non di Maurras, che sarà anche rimasto nel suo stato di illuminazione apocalittica, del suo gruppo, che si senti isolato e fece appello a Caillaux.
Q1 §49 Il «centralismo organico» e le dottrine di Maurras. Il «centralismo organico» ha come principio la «cooptazione» intorno a un «possessore della verità», a un «illuminato dalla ragione» che ha trovato le leggi «naturali» ecc. (Le leggi della meccanica e della matematica funzionano da motore intellettuale; la metafora sta invece del pensiero storico). Collegato col Maurrasismo.
Q1 §50 Un documento dell’Amma per la quistione Nord-Sud. Pubblicato dai giornali torinesi del settembre 1920. È una circolare dell’Amma credo del 1916 in cui si ordina alle industrie dipendenti di non assumere operai che siano nati sotto Firenze.
Cfr con la politica seguita da Agnelli‑Gualino specialmente nel 1925‑26 di far venire a Torino circa 25 000 siciliani da immettere nell’industria (case‑caserme, disciplina interna ecc.). Fallimento dell’emigrazione e moltiplicazione dei reati commessi nelle campagne vicine da questi siciliani che fuggivano le fabbriche: cronache vistose nei giornali che non allentarono certo la credenza che i siciliani sono briganti.
La quistione speciale Piemonte‑Sicilia è legata all’intervento delle truppe piemontesi in Sicilia contro il così detto brigantaggio dal 60 al 70. I soldati piemontesi riportarono la convinzione nei loro paesi della barbarie siciliana e, viceversa, i siciliani si persuasero della ferocia piemontese. La letteratura amena (ma anche quella militare) contribuì a rafforzare questi stati d’animo (cfr la novella di De Amicis sul soldato a cui viene mozzata la lingua dai briganti): nella letteratura siciliana si è più equanimi, perché si descrive anche la ferocia siciliana (una novella di Pirandello: i briganti che giocano alle bocce coi teschi). Ricordare il libro, mi pare di un certo D’Adamo (cfr «Unità» al tempo della guerra libica) nel quale si dice che siciliani e piemontesi devono far la pace, poiché la ferocia degli uni compensa quella degli altri.
A proposito della letteratura amena su Nord‑Sud ricordare Caccia grossa di Giulio Bechi: caccia grossa vuol dire «caccia agli uomini». Giulio Bechi ebbe qualche mese di fortezza; ma non per aver operato in Sardegna come in terra di conquista, ma per essersi messo in una situazione per cui dei signori sardi l’avevano sfidato a duello; la sfida dei sardi, poi, fu fatta non perché il Bechi aveva fatto della Sardegna una jungla, ma perché aveva scritto che le donne sarde non sono belle.
Ricordare un libriccino di ricordi di un ufficiale ligure (stampato in una cittadina ligure, Oneglia o Porto Maurizio) che fu in Sardegna nei fatti del 1906, dove i sardi sono detti «scimmie» o qualcosa di simile e si parla del «genio della specie» che agita l’autore alla vista delle donne.
Q1 §51 Clero come intellettuali. Ricerca sui diversi atteggiamenti del clero nel Risorgimento, in dipendenza delle nuove correnti religiose‑ecclesiastiche. Giobertismo, rosminianismo. Episodio più caratteristico del giansenismo. A proposito della dottrina della grazia e della sua conversione in motivo di energia industriale, e dell’obbiezione che lo Jemolo fa alla tesi giusta dell’Anzilotti (da dove l’Anzilotti l’aveva presa?) cfr in Kurt Kaser, Riforma e Controriforma, a proposito della dottrina della grazia nel calvinismo, e il libro del Philip dove sono citati documenti attuali di questa conversione. In questi fatti è contenuta la documentazione del processo dissolutivo della religiosità americana: il calvinismo diventa una religione laica, quella del Rotary Club, così come il teismo degli illuministi era la religione della massoneria europea, ma senza l’apparato simbolico e comico della massoneria e con questa differenza, che la religione del Rotary non può diventare universale: essa è propria di un’aristocrazia eletta (popolo eletto, classe eletta) che ha avuto e continua ad avere successi; un principio di selezione, non di generalizzazione, di un misticismo ingenuo e primitivo proprio di chi non pensa ma opera come gli industriali americani, che può avere in sé i germi di una dissoluzione anche molto rapida (la storia della dottrina della grazia può essere interessante per vedere il diverso accomodarsi del cattolicesimo e del cristianesimo alle diverse epoche storiche e ai diversi paesi).
Fatti americani riportati dal Philip da cui risulta che il clero di tutte le chiese, in certe occasioni, ha funzionato da pubblica opinione in assenza di un partito medio e di una stampa di tale partito.
Q1 §52 Origine sociale del clero. L’origine sociale del clero ha importanza per giudicare della sua influenza politica: nel Nord il clero è di origine popolare (artigiani e contadini), nel Sud è più legato ai «galantuomini» e alla classe alta. Nel Sud e nelle isole il clero o individualmente o come rappresentante della chiesa, ha voli proprietà terriere e si presta all’usura. Appare al contadino spesso, oltre che come guida spirituale, come proprietario che pesa sugli affitti («gli interessi della chiesa») e come usuraio che ha a sua disposizione le armi spirituali oltre che le temporali. Perciò i contadini meridionali vogliono preti del paese (perché conosciuti, meno aspri, e perché la loro famiglia, offrendo un certo bersaglio, entra come elemento di conciliazione) e qualche volta rivendicano i diritti elettorali dei parrocchiani. Episodi in Sardegna di tali rivendicazioni. (Ricordare articolo di Gennaro Avolio nel numero unico della «Voce» su clero meridionale, dove si accenna al fatto che i preti meridionali fanno apertamente vita coniugale con una donna e hanno rivendicato il diritto di prender moglie). La distribuzione territoriale del Partito Popolare mostra la maggiore o minore influenza del clero, e la sua attività sociale. Nel Mezzogiorno In epoca posteriore queste parole erano collocate tra parentesi e lo stesso G. annotava in interlinea: «no». (occorre tener presente oltre a ciò, il peso delle diverse frazioni: nel Sud Napoli, ecc.) prevaleva la destra, cioè il vecchio clericalismo. conservatore. Ricordare episodio delle elezioni ad Oristano nel 1913.
Q1 §53 Maurrasianesimo e sindacalismo. Nella concezione di Maurras ci sono molti tratti simili a certe teorie catastrofiche formali di certo sindacalismo o economismo. È avvenuta parecchie volte questa trasposizione nel campo politico e parlamentare di concezioni nate sul terreno economico e sindacale. Ogni astensionismo politico si basa su questa concezione (astensionismo politico in generale, non solo parlamentare). Meccanicamente avverrà il crollo dell’avversario se, con metodo intransigente, lo si boicotterà nel campo governativo (sciopero economico, sciopero o inattività politica). L’esempio classico italiano è quello dei clericali dopo il 70. In realtà poi, dopo il 90 il non expedit fu temperato fino al patto Gentiloni. La fondazione del P. P. segnò il rigetto totale di questo meccanicismo catastrofico. Il suffragio universale rovesciò questo piano: esso infatti già diede i sintomi di nuove formazioni legate all’interesse dei contadini di entrare attivamente nella vita dello Stato.
Q1 §54 La battaglia dello Jütland. La trattazione di questa battaglia fatta da Winston Churchill nelle sue memorie di guerra. È notevole come il piano e la direzione strategica della battaglia da parte del comando inglese e di quello tedesco siano in contrasto colla raffigurazione tradizionale dei due popoli. Il comando inglese aveva centralizzato «organicamente» il piano nella nave ammiraglia: le altre unità dovevano «attendere ordini» volta per volta. L’ammiraglio tedesco invece aveva spiegato a tutti i comandi subalterni il piano strategico generale, e aveva lasciato alle unità quella certa libertà di manovra che le circostanze potevano richiedere. La flotta tedesca manovrò molto bene. La flotta inglese corse molti rischi, nonostante la sua superiorità, e non poté conseguire fini strategici positivi, perché a un certo punto, l’ammiraglio perdette le comunicazioni con le unità combattenti e queste commisero errori su errori. Rivedere il libro di Churchill.
Q1 §55 Riviste tipo. Una rivista tipo è l’«Osservatore» del Gozzi, cioè il tipo di rivista moralisteggiante del settecento (tipo perfetto in Inghilterra con l’Addison): essa ebbe una certa importanza per diffondere una nuova concezione della vita, servendo di anello di passaggio per la piccola gente, tra la religione e la civiltà moderna. Oggi il tipo si conserva specialmente nel campo ecclesiastico. (Ma anche l’«Asino» e il «Seme» rientravano in questo tipo).
Q1 §56 Apologo del ceppo e delle frasche secche. Le frasche secche sono indispensabili per far bruciare il ceppo, non in sé e per sé. Solo il ceppo, bruciando, modifica l’ambiente freddo in caldo. Arditi — artiglieria e fanteria. Queste rimangono sempre le regine.
Q1 §57 Reazioni del Nord alle pregiudiziali antimeridionali. 1° Episodio del 1914 a Torino: proposta a Salvemini di candidatura: la città del Nord elegge il deputato per la campagna del Sud. Rifiuto, ma partecipazione di Salvemini alla elezione come oratore. 2° Episodio Giovane Sardegna del 19 con annessi e connessi. 3° Brigata Sassari nel 17 e nel 19. 4° Cooperativa Agnelli nel 20 (suo significato «morale» dopo il settembre; motivazione del rifiuto). 5° Episodio del 21 a Reggio Emilia (di questo Zibordi si guarda bene dal parlarne nel suo opuscolo su Prampolini).
Sono questi fatti che colpirono Gobetti e quindi provocarono atmosfera del libro di Dorso. (B. S.: agnelli e conigli. Miniere‑Ferrovie).
Q1 §58 Emigrazione e movimenti intellettuali. Funzione dell’emigrazione nel provocare nuove correnti e nuovi raggruppamenti intellettuali. Emigrazione e Libia. Discorso di Ferri alla Camera nel 1911 dopo il suo ritorno dall’America (la lotta di classe non spiega l’emigrazione). Passaggio di un gruppo di sindacalisti al partito nazionalista. Concetto di nazione proletaria in Enrico Corradini. Discorso di Pascoli La grande proletaria si è mossa. Sindacalisti-nazionalisti di origine meridionale: Forges Davanzati ‑ Maraviglia. In generale molti sindacalisti intellettuali d’origine meridionale. Loro passaggio episodico nelle città industriali (il ciclonismo): loro più stabile fortuna nelle regioni agricole, dal Novarese alla valle padana e alle Puglie. Movimenti agrari del decennio 1900-10. La statistica dà in quel periodo un aumento del 50% dei braccianti, a scapito specialmente della categoria degli obbligati‑schiavandari (statistica del 1911: cfr prospetto dato dalla «Riforma sociale»). Nella valle del Po ai sindacalisti succedono i riformisti più piatti, eccetto che a Parma e in vari altri centri dove il sindacalismo si unisce al movimento repubblicano formando l’Unione del Lavoro dopo scissione del 14‑15. Il passaggio di tanti contadini al bracciantato è legato al movimento della cosidetta «Democrazia cristiana» («l’Azione» di Cacciaguerra usciva a Cesena) e al modernismo: simpatie di questi movimenti per il sindacalismo.
Bologna è il centro intellettuale di questi movimenti ideologici legati alla popolazione rurale: il tipo originale di giornale che è stato sempre il «Resto del Carlino» non si potrebbe altrimenti spiegare (Missiroli‑Sorel ecc.).
Oriani e le classi della Romagna: il Romagnolo come tipo originale italiano (molti tipi originali: Giulietti ecc.) di passaggio tra Nord e Sud.
Q1 §59 Ugo Ojetti. Ricercare il giudizio datone dal Carducci.
Q1 §60 Papini, Cristo, Giulio Cesare. Papini nel 1912‑13 scrisse in «Lacerba» l’articolo Gesù peccatore, sofistica raccolta di aneddoti e di sforzate ipotesi tratte dagli Evangeli apocrifi; per questo articolo pareva dovesse subire un’azione giudiziaria con grande suo spavento (sostenne come plausibile e probabile l’ipotesi di rapporti tra Gesù e Giovanni). Nel suo articolo su Cristo romano (nel volume Gli operai della vigna) sostiene, con gli stessi procedimenti critici e la stessa «vigoria» intellettuale, che Cesare è un precursore del Cristo, fatto nascere a Roma dalla Provvidenza. Se farà ancora un passo in avanti, usando dei procedimenti loriani, giungerà alla conclusione di rapporti necessari tra il cristianesimo e l’inversione.
Q1 §61 Americanismo. L’americanismo può essere una fase intermedia dell’attuale crisi storica? La concentrazione plutocratica può determinare una nuova fase dell’industrialismo europeo sul modello dell’industria americana? Il tentativo probabilmente sarà fatto (razionalizzazione, sistema Bedaux, taylorismo ecc.). Ma può riuscire? L’Europa reagisce, contrapponendo alla «vergine» America le sue tradizioni di cultura. Questa reazione è interessante non perché una così detta tradizione di cultura possa impedire una rivoluzione nell’organizzazione industriale, ma perché essa è la reazione della «situazione» europea alla «situazione» americana. In realtà, l’americanismo, nella sua forma più compiuta, domanda una condizione preliminare: «la razionalizzazione della popolazione», cioè che non esistano classi numerose senza una funzione nel mondo della produzione, cioè classi assolutamente parassitarie. La «tradizione» europea è proprio invece caratterizzata dall’esistenza di queste classi, create da questi elementi sociali: l’amministrazione statale, il clero e gli intellettuali, la proprietà terriera, il commercio. Questi elementi, quanto più vecchia è la storia di un paese, tanto più hanno lasciato durante i secoli delle sedimentazioni di gente fannullona, che vive della «pensione» lasciata dagli «avi». Una statistica di questi elementi sociali è difficilissima, perché molto difficile è trovare la «voce» che li possa abbracciare. L’esistenza di determinate forme di vita dà degli indizi.
Il numero rilevante di grandi e medi agglomerati urbani senza industria è uno di questi indizi, forse il più importante. Il così detto «mistero di Napoli». Ricordare le osservazioni fatte da Goethe su Napoli e le «consolanti» conclusioni di Giustino Fortunato (opuscolo pubblicato recentemente dalla «Biblioteca editrice» di Rieti nella collana «Quaderni Critici» di Domenico Petrini; recensione di Einaudi nella «Riforma Sociale» dello scritto del Fortunato quando uscì la prima volta, forse nel 1912). Goethe aveva ragione nel rigettare la leggenda del «lazzaronismo» organico dei napoletani e nel notare che essi invece sono molto attivi e industriosi. La quistione consiste però nel vedere quale risultato effettivo abbia questa industriosità: essa non è produttiva, e non è rivolta a soddisfare le esigenze di classi produttive. Napoli è una città dove i proprietari terrieri del Mezzogiorno spendono la rendita agraria: intorno a decine di migliaia di queste famiglie di proprietari, di più o meno importanza economica, con la loro corte di servi e di lacché immediati, si costituisce una buona parte della città, con le sue industrie artigianesche, i suoi mestieri ambulanti, lo sminuzzamento incredibile dell’offerta immediata di merci o servizi agli sfaccendati che circolano nelle strade. Un’altra parte importante è costituita dal commercio all’ingrosso e dal transito. L’industria «produttiva» è una parte relativamente piccola. Questa struttura di Napoli (sarebbe molto utile avere dei dati precisi) spiega molta parte della storia di Napoli città.
Il fatto di Napoli si ripete per Palermo e per tutta una serie di città medie e anche piccole, non solo del Mezzogiorno e delle isole, ma anche dell’Italia centrale (Toscana, Umbria, Roma) e persino di quella settentrionale (Bologna, in parte, Parma, Ferrara ecc.). (Quando un cavallo caca, cento passeri fanno il pasto).
Media e piccola proprietà terriera in mano non a contadini coltivatori, ma a borghesi della cittaduzza o del borgo che la danno a mezzadria primitiva (cioè affitto in natura) o in enfiteusi. Questo volume enorme di piccola o media borghesia di «pensionati» e «redditieri» ha creato nella letteratura economica italiana la figura mostruosa del «produttore di risparmio» così detto, cioè di una classe numerosa di «usurai» che dal lavoro primitivo di un numero determinato di contadini trae non solo il proprio sostentamento, ma ancora riesce a risparmiare.
Le pensioni di Stato: uomini relativamente giovani e ben portanti che dopo 25 anni di impiego statale (qualche volta a 45 anni e con buonissima salute) non fanno più nulla, ma vivacchiano con le 500-600‑700 lire di pensione. In una famiglia si fa un prete che diventa canonico: il lavoro manuale diventa «vergognoso». Tutt’al più il commercio. La composizione della popolazione italiana è stata già resa «malsana» dall’emigrazione e dalla scarsa occupazione delle donne nei lavori produttivi. Il rapporto tra popolazione «potenzialmente» attiva e quella passiva è uno dei più sfavorevoli (vedere studio del Mortara nelle Prospettive Economiche del 1922 e forse ricerche successive): esso è ancora più sfavorevole se si tiene conto: 1) delle malattie endemiche (malaria ecc.) che diminuiscono la forza produttiva; 2) della denutrizione cronica di molti strati inferiori contadineschi (come risulta dalle ricerche di Mario Camis nella «Riforma Sociale» del 1926 — primo o secondo fascicolo —, le cui medie nazionali dovrebbero essere scomposte per medie di classi; ma la media nazionale raggiunge appena lo standard fissato dalla scienza e quindi è ovvia la conclusione di una denutrizione cronica di certi strati. Nella discussione al Senato del bilancio preventivo per le finanze del 1929‑30 l’on. Mussolini riconobbe che in alcune regioni la popolazione vive intere stagioni di sole erbe: vedere); 3) della disoccupazione endemica di alcune regioni agrarie che non risulta dai censimenti; 4) di questa massa di popolazione assolutamente parassitaria (volissima), che per i suoi servizi domanda l’occupazione di altra ingente popolazione; e di quella semiparassitaria, che cioè moltiplica in modo anormale (dato un certo tipo di società) determinate attività, come il commercio.
Questa situazione non si presenta solo in Italia; in misura notevole si presenta in tutta Europa, più in quella meridionale, sempre meno verso il Nord. (In India e in Cina deve essere ancor più anormale che in Italia e ciò spiega il ristagno della storia).
L’America senza «tradizione», ma anche senza questa cappa di piombo: questa una delle ragioni della formidabile accumulazione di capitali, nonostante i salari relativamente migliori di quelli europei. La non esistenza di queste sedimentazioni vischiose delle fasi storiche passate ha permesso una base sana all’industria e specialmente al commercio e permette sempre più la riduzione dei trasporti e del commercio a una reale attività subalterna della produzione, coll’assorbimento di questa attività da parte dell’industria stessa (vedi Ford e quali «risparmi» abbia fatto sui trasporti e sul commercio assorbendoli). Questa «razionalizzazione» preliminare delle condizioni generali della produzione, già esistente o facilitata dalla storia, ha permesso di razionalizzare la produzione, combinando la forza (— distruzione del sindacalismo —) con la persuasione (— salari e altri benefizi —); per collocare tutta la vita del paese sulla base dell’industria. L’egemonia nasce dalla fabbrica e non ha bisogno di tanti intermediari politici e ideologici. Le «masse» di Romier sono l’espressione di questo nuovo tipo di società, in cui la «struttura» domina più immediatamente le soprastrutture e queste sono razionalizzate (semplificate e diminuite di numero). Rotary Club e Massoneria (il Rotary è una massoneria senza i piccoli borghesi). Rotary — America = Massoneria — Europa. YMCA — America = gesuiti — Europa.
Tentativi dell’YMCA in Italia: episodio Agnelli — tentativi di Agnelli verso l’«Ordine Nuovo» che sosteneva un suo «americanismo». In America c’è l’elaborazione forzata di un nuovo tipo umano: ma la fase è solo iniziale e perciò (apparentemente) idillica. È ancora la fase dell’adattamento psico‑fisico alla nuova struttura industriale, non si è verificata ancora (se non sporadicamente, forse) alcuna fioritura «superstrutturale», quindi non è ancora stata posta la quistione fondamentale dell’egemonia: la lotta avviene con armi prese dall’arsenale europeo e ancora imbastardito, quindi appaiono e sono «reazionarie».
La lotta che c’è stata in America (descritta dal Philip) è ancora per la proprietà del mestiere, contro la «libertà industriale», cioè come quella che si è avuta in Europa nel secolo XVIII, sebbene in altre condizioni. L’assenza della fase europea segnata come tipo dalla Rivoluzione francese, in America, ha lasciato gli operai ancora grezzi.
In Italia abbiamo avuto un inizio di fanfara fordistica (esaltazione della grande città — la grande Milano ecc. — il capitalismo è ancora ai suoi inizi ecc., con messa in programma di piani urbanistici grandiosi: vedi «Riforma Sociale» — articoli di Schiavi).
Conversione al ruralismo e all’illuministica depressione delle città: esaltazione dell’artigianato e del patriarcalismo, accenni di «proprietà del mestiere» e di lotta contro la «libertà industriale» (vedi accenno fatto criticamente da U. Ricci in lettera ai «Nuovi Studi»): in ogni caso non «mentalità» americanistica.
Il libro del De Man è legato a questa quistione. È una reazione alle due forze storiche maggiori del mondo.
Q1 §62 Quistione sessuale. Ossessione della quistione sessuale. «Pericoli» di questa ossessione. Tutti i «progettisti» risolvono la quistione sessuale. Notare come nelle «utopie» la quistione sessuale abbia larghissima parte, spesso prevalente (l’osservazione di Croce che le soluzioni del Campanella nella Città del Sole non possono spiegarsi coi bisogni sessuali dei contadini calabresi). Gli istinti sessuali sono quelli che hanno subito la maggiore «repressione» da parte della società in sviluppo. Il loro «regolamento» sembra il più «innaturale», quindi più frequenti in questo campo i richiami alla «natura». La letteratura «freudistica» ha creato un nuovo tipo di «selvaggio» settecentesco sulla base «sessuale» (inclusi i rapporti tra padri e figli).
Distacco tra città e campagna. In campagna avvengono i reati sessuali più mostruosi e più numerosi. Nell’inchiesta parlamentare sul Mezzogiorno si dice che in Abruzzo e Basilicata (maggiore patriarcalismo e maggiore fanatismo religioso) si ha l’incesto nel 30% delle famiglie. In campagna molto diffuso il bestialismo.
La sessualità come funzione riproduttiva e come «sport»: ideale estetico femminile da riproduttrice a ninnolo; ma non è solo in città che la sessualità è diventata uno «sport»; i proverbi popolari — l’uomo è cacciatore, la donna è tentatrice; chi non ha di meglio, va a letto con la moglie — mostrano la diffusione dello «sport». La funzione «economica» della riproduzione non è solo legata al mondo economico produttivo, è anche interna; «il bastone della vecchiaia» mostra la coscienza istintiva del bisogno «economico» che ci sia un certo rapporto tra giovani e vecchi, tra lavoratori attivi e parte passiva della popolazione; lo spettacolo di come sono bistrattati nei villaggi i vecchi e le vecchie senza figliolanza spinge le coppie a desiderare figli; i vecchi senza figli sono trattati come i «bastardi».
I progressi dell’igiene pubblica che hanno elevato le medie della vita umana pongono sempre più la quistione sessuale come una «quistione economica» a sé stante, che pone dei problemi coordinati del tipo di superstruttura. L’aumento della media della vita in Francia, con la scarsa natalità, e con la ricchezza naturale del paese, pone già un aspetto di problema nazionale: le generazioni vecchie vanno mettendosi in un rapporto anormale con le generazioni giovani della stessa stirpe, e le generazioni lavoratrici si impinguano di masse straniere immigrate che modificano la base: si verifica, già come in America, una certa divisione del lavoro (mestieri qualificati per gli indigeni, oltre alle funzioni direttive e organizzative, e mestieri non qualificati per gli immigrati). Lo stesso rapporto si pone in ogni paese tra la città, a bassa natalità, e la campagna prolifica, ponendo un problema economico abbastanza grave: la vita industriale domanda un apprendissaggio in generale, un adattamento psico‑fisico a condizioni di lavoro, di nutrizione, di abitazione ecc. che non sono «naturali»: i caratteri urbani acquisiti si tramandano per ereditarietà. La bassa natalità domanda una continua spesa di apprendissaggio e porta con sé un continuo mutarsi della composizione sociale‑politica delle città, ponendo quindi anche un problema di egemonia.
La quistione più importante è la salvaguardia della personalità femminile: finché la donna non abbia veramente raggiunto una indipendenza di fronte all’uomo, la quistione sessuale sarà ricca di caratteri morbosi e bisognerà esser cauti nel trattarla e nel trarre conclusioni legislative. L’abolizione della prostituzione legale porterà con sé già molte difficoltà: oltre allo sfrenamento che succede a ogni crisi di compressione.
Lavoro e sessualità. È interessante come gli industriali americani si interessino delle relazioni sessuali dei loro dipendenti: la mentalità puritana vela però una necessità evidente: non può esserci lavoro intenso produttivo senza una regolamentazione dell’istinto sessuale.
Q1 §63 Lorianismo e Graziadei. Vedi in Croce (Materialismo storico ecc.) nota su Graziadei e il Paese di Cuccagna. Vedi nel libro di Graziadei Sindacati e salari del 1929 la alquanto comica risposta al Croce dopo quasi trent’anni. Questa risposta al Croce, alquanto gesuitica oltre che alquanto comica, è stata determinata indubbiamente dall’articolo pubblicato nel 1926 nell’«Unter dem Banner des Marxismus» su Prezzo e sovraprezzo, articolo che cominciava proprio con la citazione della nota crociana. Sarebbe interessante ricercare nelle produzioni di Graziadei i possibili accenni al Croce: non ha veramente mai risposto, neppure indirettamente? Eppure la pizzicata era forte! In ogni modo, l’«ossequio» all’autorità scientifica del Croce espresso con tanta unzione, dopo trent’anni, è veramente comico. Il motivo del Paese di Cuccagna rintracciato dal Croce in Graziadei è inoltre interessante perché colpisce una sotterranea corrente di romanticismo popolare creata dal «culto della scienza» dalla «religione del progresso» e dall’ottimismo generale del secolo XIX. In questo senso è da vedere se non sia legittima la reazione del Marx che con la «legge tendenziale della caduta del saggio del profitto» e col «catastrofismo» gettava molta acqua sul fuoco: è da vedere anche quanto queste correnti ottimistiche abbiano impedito una analisi più accurata delle proposizioni di Marx.
Queste osservazioni riconducono alla quistione della «utilità» o meno di tutte le sul lorianismo. A parte il fatto di un «giudizio» spassionato sull’opera complessiva di Loria e della «ingiustizia» di mettere solo in rilievo le manifestazioni strampalate del suo ingegno, che può essere discusso a sé, rimane per giustificare queste notazioni una serie di ragioni. Gli autodidatti sono specialmente portati, per l’assenza in loro di un abito scientifico e crltico, a fantasticare di paesi di Cuccagna e di facili soluzioni di ogni problema. Come reagire? La soluzione migliore sarebbe la scuola, ma è una soluzione di lunga attesa, specialmente per grandi masse di uomini. Bisogna dunque colpire, per intanto, la «fantasia» con dei tipi di ilotismo intellettuale, che creino l’avversione per il disordine intellettuale (e il senso del ridicolo). Questa avversione è ancora poco, ma è già qualcosa per instaurare un ordine intellettuale indispensabile. Come mezzo pedagogico è molto importante.
Ricordare episodi tipici: l’Interplanetaria del 16‑17 di Rab.; episodio del «moto perpetuo» nel 25, mi pare; tipi del 19‑20: quistione degli affitti (Pozzoni di Como ecc.). La mancanza di sobrietà e di ordine intellettuale porta anche al disordine morale. La quistione sessuale porta, con le sue fantasticherie, molti disordini: poca partecipazione delle donne alla vita collettiva, attrazione di farfalloni postribolari verso iniziative serie ecc. (Ricordare episodio narrato da Cecilia De Tourmay: potrebbe essere vero, perché è verosimile: ho sentito dire che a Napoli, quando c’erano riunioni femminili, si precipitavano subito i liberoamoristi coi loro opuscoli neomaltusiani ecc.). Tutti i più ridicoli fantasticatori si precipitano sui movimenti nuovi, per spacciare le loro fanfaluche di geni finallora incompresi, gettando lo scredito. Ogni collasso porta con sé disordine intellettuale e morale. Bisogna creare gente sobria, paziente, che non disperi dinanzi ai peggiori orrori e non si esalti a ogni sciocchezza. Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà.
Q1 §64 Lorianismo e G. Ferrero. Ricordare gli spropositi contenuti nella prima edizione delle sue storie: la misura lineare itineraria persiana confusa con una regina di cui si fa la biografia ecc.
Q1 §65 Riviste tipo: «Osservatore» del Gozzi. A questo tipo appartengono anche, nelle forme moderne, le riviste umoristiche, che, a loro modo, vorrebbero essere di critica del costume. Le pubblicazioni tipo «Cri de Paris», «Fantasio», «Charivari». Per alcuni aspetti rientrano in questo tipo i così detti «elzeviri» o «corsivi» dei giornali quotidiani.
La «Frusta letteraria» del Baretti fu una forma intermedia: bibliografia universale, critica del contenuto, con tendenze moralizzatrici (critica dei costumi, dei modi di vedere, dei punti di vista). «Lacerba» di Papini, per la parte non «artistica», era anch’essa di questo tipo, a tendenze «satanistiche» (Gesù Peccatore, Viva il maiale, Contro la famiglia ecc. di Papini; Giornale di Bordo di Soffici; Elogio della prostituzione ecc. di Tavolato). Questo tipo generale appartiene alla sfera del «buon senso» o «senso comune»: cerca di modificare l’opinione media di una certa società, criticando, suggerendo, correggendo, svecchiando, introducendo nuovi «luoghi comuni». Se sono ben scritte, con «verve», con un certo distacco, ma tuttavia con interesse per l’opinione media, esse possono avere grande diffusione ed esercitare una funzione importantissima. Non devono avere nessuna «mutria», né scientifica, né moralisteggiante, non devono essere «filistee» e accademiche, insomma, né apparire fanatiche o soverchiamente partigiane: devono porsi nel campo stesso del «senso comune» distaccandosene quel tanto che permette il sorriso canzonatorio, ma non il disprezzo o la superiorità altezzosa.
«La Pietra», motto dantesco dalle rime della Pietra: «così nel mio parlar voglio esser aspro». «La Compagnia della Pietra». Ogni strato sociale ha il suo «senso comune» che è in fondo la concezione della vita e la motale più diffusa. Ogni corrente filosofica lascia una sedimentazione di «senso comune»: è questo il documento della sua effettualità storica. Il senso comune non è qualcosa di irrigidito e immobile, ma si trasforma continuamente, arricchendosi di nozioni scientifiche e opinioni filosofiche entrate nel costume. Il «senso comune» è il folklore della «filosofia» e sta di mezzo tra il «folklore» vero e proprio (cioè come è inteso) e la filosofia, la scienza, l’economia degli scienziati. Il «senso comune» crea il futuro folklore, cioè una fase più o meno irrigidita di un certo tempo e luogo. (Occorrerebbe fissare bene questi concetti, ripensandoli a fondo).
Q1 §66 Colonie italiane. Nel «Diritto Ecclesiastico» diretto, fra gli altri, dal prof. Cesare Badii dell’Università di Roma e da Amedeo Giannini, consigliere di Stato, del marzo‑aprile 1929, è pubblicato un articolo dell’avv. prof. Arnaldo Cicchitti: La S. Sede nelle Colonie italiane dopo il Concordato con il Regno, nel quale due volte, a p. 138 e a p. 139, si pone l’Albania fra le colonie italiane. L’autore rimanda (in materia, se sia applicabile alla religione cattolica apostolica romana il trattamento nelle Colonie concesso agli altri culti) a suoi studi pubblicati nella «Rivista di diritto pubblico» 1928 (pp. 126‑31) e 1929 (pp. 141‑57) e nella «Rivista delle Colonie Italiane» 1929: sarebbe interessante vedere se anche in questi l’Albania è considerata colonia.
Q1 §67 A proposito del matrimonio religioso con validità civile è interessante notare che da alcuni estratti della succitata rivista mi pare risulti che il Diritto Canonico e il Tribunale della Sacra Rota concedono lo scioglimento del matrimonio (se non ci sono figli) con abbastanza larghezza, purché si abbiano amici compiacenti che testimonino e i due coniugi siano concordi (oltre ai quattrini da spendere). Ne risulterà una situazione di favore per i cattolici.
Q1 §68 La quistione sessuale e la Chiesa cattolica. Elementi dottrinari. Il canone 1013 dice: «Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae». I giuristi discutono sull’«essenza» del matrimonio cattolico, distinguendo fra fine primario e oggetto (primario?): fine è la procreazione, oggetto la copula. Il matrimonio rende «morale» la copula attraverso il mutuo consenso dei coniugi; mutuo consenso espresso senza condizioni limitative. Il paragone con altri contratti (per es. di compravendita) non regge, perché il fine del matrimonio è nel matrimonio in se stesso: il paragone reggerebbe se il marito o la moglie acquistasse diritti di schiavitù sull’altro, cioè potesse disporne come di un bene (ciò che avviene, in parte, per la non riconosciuta uguaglianza giuridica dell’uomo e della donna; in ogni caso non per la persona fisica).
Il canone 1015 indica ciò che «consuma» il contratto matrimoniale: è l’atto «quo coniuges fiunt una caro»: «Matrimonium baptizatorum validum dicitur ratum, si nondum consummatione completum est; ratum et consummatum si inter coniuges locum habuerit coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et quo coniuges fiunt una caro». Il significato di «una caro» è assunto da una frase di Cristo, che la ripete dal Genesi: «Non legistis quia fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos et dixit: propterea dimittet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae et erunt duo in carne una? Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Qued ergo Deus coniunxit, homo non separet» (Matteo, XIX, 4‑7). Cioè essa è la copula, non il figlio (che non può essere disgiunto, perché materialmente uno). Il Genesi (II, 21-24) dice: «Dixitque Adam: haec vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est. Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem et adhaerebit uxori suae et erunt duo in carne una». (Sarebbe da vedere se questi elementi possono essere interpretati come giustificanti l’indissolubilità del matrimonio, per cui sono stati rivolti, come contributo della religione cristiana all’introduzione della monogamia, o non significassero in origine solo l’unione sessuale, cioè si contrapponessero alle tendenze «pessimistiche» della «purità» con l’astensione sessuale. Insomma si riferirebbero ai sessi in generale, che sono indissolubili e non a Pietro, Paolo, Giovanni uniti con Caterina, Maria, Serafina). Canone 1082 Q1 § 2° «Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem».
Il Q1 § 1° dello stesso dice: «Ut matrimonialis consensus haberi possit, necesse est ut contrabentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos» (dovrebbe giustificare e anzi imporre l’educazione sessuale, perché il presumere che si sappia praticamente significa solo che si è certi che l’ambiente compie questa educazione: è cioè una semplice ipocrisia e si finisce col preferire le nozioni saltuarie e «morbose» alle nozioni «metodiche» e educative). In qualche parte esiste esistevaVariante interlineare. la convivenza sessuale di prova e solo dopo la fecondazione avviene avvenivaa il matrimonio (per esempio in piccoli paesi come Zuri, Soddi, ecc. dell’ex circondario di Oristano): era un costume ritenuto moralissimo e che non sollevava obbiezioni, perché non aveva determinato abusi, né da parte delle famiglie né da parte del clero: in quei paesi anche matrimoni molto precoci; fatto legato al regime della proprietà sminuzzata, che domanda più di un lavoratore, ma non permette lavoro salariato. Can. 1013 Q1 § 2°: «essentiales matrimonii proprietates sunt untas ac indissolubilitas, quae in matrimonio christiano peculiarem obtinent firmitatem ratione sacramenti» ». Genesi (1, 27‑28):
«Masculum et feminam creavit eos, benedixitque illis Deus et ait: Crescite et multiplicamini et replete terram».
Q1 §69 Il premio Nobel. Filippo Crispolti ha raccontato in un numero del «Momento» del giugno 1928 (della prima quindicina) che quando nel 1906 si pensò in Svezia di conferire il premio Nobel a Giosuè Carducci, nacque il dubbio che un simile premio al cantore di Satana potesse suscitare scandalo tra i cattolici: chiesero informazioni al Crispolti che le dette per lettera e in un colloquio col ministro svedese a Roma, De Bildt. Le informazioni furono favorevoli. Così il premio Nobel al Carducci sarebbe stato dato da Filippo Crispolti.
Q1 §70 «Impressioni di prigionia» di Jacques Rivière, pubblicate nella «Nouvelle Revue Française» nel terzo anniversario della morte dell’autore (ne riporta alcuni estratti «La Fiera Letteraria» del 1° aprile 1928).
Dopo una perquisizione nella cella: gli hanno tolto fiammiferi, carta da scrivere e un libro: le conversazioni di Goethe con Eckermann, e delle provviste alimentari non permesse. «Penso a tutto ciò di cui mi hanno derubato: sono umiliato, pieno di vergogna, orribilmente spogliato. Conto i giorni che mi restano da «tirare» e, benché tutta la mia volontà sia tesa in questo senso, non sono più così sicuro di arrivare sino in fondo. Questa lenta miseria logora più che le grandi prove. ... Ho l’impressione che dai quattro punti cardinali si possa venirmi addosso, entrare in questa cella, entrare in me, in ogni momento, strapparmi ciò che ancora mi rimane e lasciarmi in un angolo, una volta di più, come una cosa che più non serve, depredato, violato. Non conosco nulla di più deprimente che questa attesa del male che si può ricevere, unita alla totale impotenza di sottrarsi ad esso. ... Con gradazioni e sfumature tutti conoscono questa stretta al cuore, questa profonda mancanza di sicurezza interiore, questo senso di essere incessantemente esposto senza difesa a tutti gli accidenti, dal piccolo fastidio di alcuni giorni di prigione alla morte inclusa. Non vi è rifugio: non scampo, non tregua soprattutto. Non rimane altro che offrire il dorso, che rimpicciolirsi quanto è possibile. ... Una vera timidità generale s’era impadronita di me, la mia immaginazione non mi presentava più il possibile con quella vivacità che gli conferisce in anticipo l’aspetto di realtà: in me era inaridita l’iniziativa. Credo che mi sarei trovato davanti alle più belle occasioni di fuga senza saperne approfittare; mi sarebbe mancato quel non so che, che aiuta a colmare l’intervallo fra ciò che si vede e ciò che si vuol fare, fra le circostanze e l’atto che ne rende padroni; non avrei più avuto fede nella mia buona sorte: la paura mi avrebbe fermato».
Il pianto in carcere: gli altri sentono se il pianto è «meccanico» o «angoscioso». Reazione diversa quando qualcuno grida: «Voglio morire». Collera e sdegno o semplice chiasso. Si sente che tutti sono angosciati quando il pianto è sincero. Pianto dei più giovani. L’idea della morte si presenta per la prima volta (si diventa vecchi d’un colpo).
Q1 §71 Il padre Gioacchino Ventura. Libro di Anna Cristofoli: Il pensiero religioso di Padre Gioacchino Ventura, Milano, Soc. Ed. «Vita e pensiero», 1927, in 8°, pp. 158. Recensione in «Fiera Letteraria» del 15 gennaio 1928 di Guido Zadei, molto severa. Il Ventura, frate siciliano, avrebbe subito l’influenza del Bonald, del Lamennais, del De Maistre. Lo Zadei cita un volume del Rastoul, Le Père Ventura, Parigi, 1906, in 16°, pp. 189. (Clero e intellettuali). (L’influenza del Lamennais).
Q1 §72 I nipotini di padre Bresciani. Arte cattolica. Lo scrittore Edoardo Fenu in un articolo Domande su un’arte cattolica pubblicato sull’«Avvenire d’Italia» e riassunto nella «Fiera Letteraria» del 15 gennaio 1928 rimprovera a «quasi tutti gli scrittori cattolici» il tono apologetico. «Ora la difesa (!) della fede deve scaturire dai fatti, dal processo critico (!) e naturale del racconto, deve cioè essere, manzonianamente il «sugo» dell’arte stessa. È evidente (!) che uno scrittore cattolico per davvero, non andrà mai a battere la fronte contro le pareti opache dell’eresia, morale o religiosa. Un cattolico per il solo fatto di essere tale, è già investito di quello spirito semplice e profondo che, trasfondendosi nelle pagine di un racconto o di una poesia, farà della sua (!) un’arte schietta, serena, nient’affatto pedante. È dunque (!) perfettamente inutile intrattenersi a ogni svolto di pagina a fare capire che lo scrittore ha una strada da farci percorrere, ha una luce per illuminarci. L’arte cattolica dovrà (!) mettersi in grado di essere essa medesima quella strada e quella luce, senza smarrirsi nella fungaia degli inutili predicozzi e degli oziosi avvertimenti». (In letteratura «... se ne togli pochi nomi, Papini, Giuliotti, e in certo senso anche Manacorda, il bilancio è pressoché fallimentare. Scuole?... ne verbum quidem. Scrittori? Sì; a voler essere di manica larga si potrebbe tirar fuori qualche nome, ma quanto fiato per trarlo cogli argani! A meno che non si voglia patentare per cattolico il Gotta, o dar la qualifica di romanziere al Gennari, o battere un applauso a quella caterva innumere di profumati e agghindati scrittori e scrittrici per «signorine» »).
Molte contraddizioni e improprietà: ma la conclusione è giusta: la religione è sterilità per l’arte, almeno nei religiosi. Cioè non esistono più «anime semplici e sincere» che siano artisti. Il fatto è già antico: risale al Concilio di Trento e alla Controriforma. «Scrivere» era pericoloso, specialmente di cose e sentimenti religiosi. La chiesa da quel tempo ha usato un doppio metro: essere «cattolici» è diventato cosa facilissima e difficilissima nello stesso tempo. È cosa facilissima per il popolo al quale non si domanda che di credere genericamente e di avere ossequio per la chiesa. Nessuna lotta reale contro le superstizioni pagane, contro le deviazioni ecc. In realtà tra un contadino cattolico, uno protestante e uno ortodosso non c’è differenza «religiosa», c’è solo differenza «ecclesiastica». È difficilissimo invece essere intellettuale attivo «cattolico» e artista «cattolico» (romanziere specialmente e anche poeta), perché si domanda un tale corredo di nozioni su encicliche, controencicliche, brevi, lettere apostoliche ecc. e le deviazioni storiche dall’indirizzo chiesastico sono state tante e così sottili che cadere nell’eresia o nella mezza eresia o in un quarto di eresia è facilissimo. Il sentimento religioso schietto è stato disseccato: occorre essere dottrinari per scrivere «ortodossamente». Perciò nell’arte la religione non è più un sentimento, è solo un motivo, uno spunto. E la letteratura cattolica può avere solo padri Bresciani, non più S. Franceschi o Passavanti o Tommaso da Kempis. Può essere «milizia», propaganda, agitazione, non più ingenua effusione di sentimenti. O non è cattolica: vedi la sorte di Fogazzaro.
Q1 §73 La letteratura italiana moderna del Crémieux. La«Fiera Letteraria» del 15 gennaio 1928 riassume un articolo di G. Bellonci, sul «Giornale d’Italia» abbastanza scemo e spropositante. Il Crémieux sostiene che in Italia manca una lingua moderna, ciò che è giusto in un senso molto preciso: 1°) che non esiste una classe colta italiana unitaria, che parli e scriva una lingua «viva» unitaria; 2°) che tra la classe colta e il popolo c’è una grande distanza: la lingua del popolo è ancora il dialetto, col sussidio di un gergo italianizzante che è in gran parte il dialetto tradotto meccanicamente. Esiste un forte influsso dei vari dialetti nella lingua scritta, perché anche la classe colta parla la lingua in certi momenti e il dialetto nella parlata famigliare, cioè in quella più viva e più aderente alla realtà immediata. Così la lingua è sempre un po’ fossilizzata e paludata e quando vuol essere famigliare, si frange in tanti riflessi dialettali. Oltre il tono del discorso (il cursus del periodo) che caratterizza le regioni, c’è anche il lessico, la morfologia e specialmente la sintassi. Il Manzoni «sciacquò» in Arno il suo tesoro lessicale, meno la morfologia, e quasi nulla la sintassi, che è più connaturata allo stile e quindi alla coltura personale artistica. Anche in Francia ciò si verifica tra Parigi e la Provenza, ma in misura minore; in un confronto tra A. Daudet e Zola è stato trovato che Daudet non conosce quasi più il passato remoto etimologico, sostituito dall’imperfetto, ciò che non si verifica in Zola che in misura minima.
Il Bellonci scrive: «Sino al cinquecento le forme linguistiche scendono dall’alto, dal seicento in poi salgono dal basso». Sproposito madornale, per superficialità. Proprio fino al 500 Firenze esercita l’egemonia culturale, perché esercita un’egemonia economica (papa Bonifacio VIII diceva che i fiorentini erano il quinto elemento della terra) e c’è uno sviluppo dal basso, dal popolo alle persone colte. Dopo la decadenza di Firenze, l’italiano è la lingua di una casta chiusa, senza contatto con una parlata storica. Non è questa forse la quistione posta dal Manzoni, di ritornare all’egemonia fiorentina e ribattuta dall’Ascoli che, storicista, non crede alle egemonie linguistiche per decreto legge, senza la struttura economico‑culturale?
La domanda del Bellonci: «Negherebbe forse, il Crémieux, che esista (che sia esistita, vorrà dire) una lingua greca perché vi hanno da essa varietà doriche, joniche, eoliche? » è veramente comica e mostra come egli non abbia capito il Crémieux.
Q1 §74 Stracittà e strapaese. Elementi presi dalla «Fiera Letteraria» del 15 gennaio 1928. Di Papini: «La città non crea, ma consuma. Com’è l’emporio dove affluiscono i beni strappati ai campi e alle miniere, così vi accorrono le anime più fresche delle province e le idee dei grandi solitari. La città è come un rogo che illumina perché brucia ciò che fu creato lontano da lei e talvolta contro di lei. Tutte le città sono sterili. Vi nascono in proporzione pochi figlioli e quasi mai di genio. Nelle città si gode, ma non si crea, si ama ma non si genera, si consuma ma non si produce». Tutto l’altro è ancor più settecentesco.
Nello stesso numero della «Fiera Letteraria» si trovano questi altri accenni: «Il nostro arrosto strapaesano si presenta con questi caratteri: avversione decisa a tutte quelle forme di civiltà che non si confacciano alla nostra o che guastino, non essendo digeribili, le doti classiche degli italiani; poi: tutela del senso universale del paese, che è, per dirla alla spiccia, il rapporto naturale e immanente fra l’individuo e la sua terra; infine, esaltazione delle caratteristiche nostrane, in ogni campo e attività della vita, e cioè: fondamento cattolico, senso religioso del mondo, semplicità e sobrietà fondamentali, aderenza alla realtà, dominio della fantasia, equilibrio fra spirito e materia»; e quest’altro di Francesco Meriano (pubblicato nell’«Assalto»): «Nel campo filosofico, io credo di trovare invece una vera e propria antitesi: che è l’antitesi, vecchia di oltre cento anni e sempre vestita di nuovi aspetti, tra il volontarismo il pragmatismo l’attivismo identificabile nella stracittà e l’illuminismo il razionalismo lo storicismo identificabile nello strapaese».
Q1 §75 Intellettuali siciliani. È interessante il gruppo del «Ciclope» di Palermo. Mignosi, Pignato, Sciortino ecc. Relazioni di questo gruppo con Piero Gobetti.
Q1 §76 La crisi dell’«Occidente». La «Fiera Letteraria» del 29 luglio 1928 riporta alcuni brani di un articolo di Filippo Burzio sulla «Stampa». Si parla oggi dell’Occidente come qualche secolo addietro si parlava della «Cristianità». È esistita una prima unità dell’Occidente, quella cristiano‑cattolica medioevale; un primo scisma, o crisi, la Riforma con le guerre di religione. Dopo la Riforma, dopo due secoli, o quasi, di guerre di religione, si realizzò di fatto, in Occidente, una seconda unità, di altra indole, permeando di sé profondamente tutta la vita europea e culminando nei secoli XVIII e XIX: né le resistenze che incontrò la infirmarono, più che le eresie medioevali non abbiano infirmata la prima. È questa nuova unità che è in crisi (il Burzio è in polemica implicita coi cattolici, i quali vorrebbero appropriarsi la «cura» della crisi, come se questa si verificasse nel loro terreno ed essi ne fossero gli antagonisti reali, mentre sono i rottami o i fossili di una unità storica già definitivamente superata). Essa poggia su tre piloni: lo spirito critico, lo spirito scientifico, lo spirito capitalistico (forse sarebbe meglio dire «industriale»). I due ultimi sono saldi (se «capitalismo» = «industrialismo» sì), il primo invece non lo è più, e perciò le élites spirituali di Occidente soffronono di squilibrio e di disarmonia fra la coscienza critica e l’azione (sarebbe sempre la crisi dello «storicismo» per l’opposizione tra «sentimento», «passione» e coscienza critica). Come sostegno al fare, come aiuto al vivere, l’imperativo filosofico è grigio e vuoto quanto il solidarismo scientifico. In questo vuoto l’anima boccheggia e ne sa qualche cosa l’ispirazione poetica, che si è andata facendo sempre più tetra o febbrile. Quasi nessun giorno interiore al nostro tempo è lieto (ma questa crisi non è piuttosto legata alla caduta del mito del progresso indefinito e all’ottimismo che ne dipendeva, cioè a una forma di religione, piuttosto che alla crisi dello storicismo e della coscienza critica? In realtà la «coscienza critica» era ristretta a una piccola cerchia, egemonica, sì, ma ristretta; l’«apparato di governo» spirituale si è spezzato, e c’è crisi, ma essa è anche di diffusione, ciò che porterà a una nuova «egemonia» più sicura e stabile). Dobbiamo salvare l’Occidente integrale; tutta la conoscenza, con tutta l’azione. L’uomo ha voluto navigare, e ha navigato; ha voluto volare, ed ha volato; da tanti secoli che pensa Dio, non dovrà servire a niente? Albeggia, emerge, dalla creatura la mentalità del creatore. Se non si può scegliere tra i vari modi di vita, perché specializzarsi vorrebbe dire mutilarsi, non rimane che fare tutto. Se l’antica religione sembri esausta, non rimane che ringiovanirla. Universalità, interiorità, magicità. Se Dio si cela, resta il demiurgo. Uomo dell’Occidente hic res tua agitur. (Notare come da poli opposti, B. Croce e F. Burzio resistono alla ondata della nuova «religiosità» antistoricistica).
Q1 §77 Clero e intellettuali. Numero commemorativo di «Vita e Pensiero» per il 25° anniversario della morte di Leone XIII. Utile l’articolo di padre Gemelli su «Leone XIII e il movimento intellettuale». Papa Leone è legato, nel campo intellettuale, alla rinnovazione della filosofia cristiana, all’indirizzo negli studi sociali, all’impulso dato agli studi biblici. Tomista, l’idea ispiratrice di Leone XIII fu questa: «ricondurre il mondo ad una dottrina fondamentale grazie alla quale l’intelligenza sia resa di nuovo capace di indicare all’uomo la verità che egli deve riconoscere e ciò non solo preparando la via alla fede, ma dando all’uomo il mezzo di orientarsi in modo sicuro su tutti i problemi della vita. Leone XIII presentava così al popolo cristiano una filosofia, la dottrina scolastica, non come un quadro del sapere, stretto, immobile ed esclusivo, ma come un organismo di pensiero vivo, suscettibile di arricchirsi del pensiero di tutti i dottori e di tutti i padri, capace di armonizzare la speculazione della teologia razionale con i dati della scienza positiva, condizione per stimolare e armonizzare la ragione e la fede; la scienza profana e la sacra; la filosofia e la teologia; il reale e l’ideale; il passato e le scoperte dell’avvenire, l’orazione e l’azione, la vita interiore e la vita sociale, i doveri dell’individuo e della società; i doveri verso Dio e verso l’uomo».
Leone XIII ha rinnovato completamente l’Azione Cattolica. Ricordare che l’enciclica Rerum Novarum è quasi simultanea al Congresso di Genova, cioè al passaggio del movimento operaio italiano dal primitivismo a una fase realistica e concreta, sebbene ancora confusa e indistinta. La neo scolastica ha permesso l’alleanza del cattolicesimo col positivismo (Comte, da cui Maurras). Nell’Azione Cattolica si è usciti dal puro astensionismo meccanico di dopo il 70 e si è iniziata una attività reale che portò allo scioglimento del 98.
Q1 §78 Bergson, il materialismo positivistico, il pragmatismo. Bergson legato al positivismo; si «ribella» contro il suo «ingenuo» dogmatismo. Il positivismo aveva avuto il merito di ridare alla cultura europea il senso della realtà esauritosi nelle antiche ideologie razionalistiche, ma poi aveva avuto il torto di chiudere la realtà nella sfera della natura morta e quindi anche di chiudere la ricerca filosofica in una specie di nuova teologia materialistica. La documentazione di questo «torto» è l’opera del Bergson. La critica del Bergson... si è addentrata, sconsacrando idoli dell’assoluto e risolvendoli in forme di contingenza fugace, per tutti i meandri del dogmatismo positivista, ha sottoposto ad un terribile esame l’intima struttura delle specie organiche e della personalità umana, ed ha infranto tutti gli schemi di quella meccanica staticità in cui il pensiero chiude il perenne fluire della vita e della coscienza.
Affermando il principio dell’eterno fluire e l’origine pratica di ogni sistema concettuale, anche le verità supreme (!) correvano rischio di dissolversi; e qui, in questa fatale tendenza è il limite (!) del Bergsonismo. (Estratti da un articolo di Balbino Giuliano riassunto dalla «Fiera Letteraria» del 25 novembre 1928).
Q1 §79 Italo Chittaro, La capacità di comando, Casa Ed. De Alberti, Rorna. Da una recensione di V. Varanini nella «Fiera Letteraria» del 4 novembre 1928, appare che in questo libro sono contenuti spunti molto interessanti. Necessità degli studi storici per la preparazione professionale degli ufficiali. Per comandare non basta il semplice buon senso: questo, se mai, è frutto di profondo sapere e di lungo esercizio. La capacità di comando è specialmente importante per la fanteria: se altrove si diventa specialisti di compiti particolari, nella fanteria si diventa specialisti nel comando, cioè del compito d’insieme: quindi necessità che tutti gli ufficiali destinati a gradi elevati abbiano tenuto comandi di fanteria. Infine considera la necessità della formazione di uno Stato Maggiore numeroso, valido, popolare alle truppe. — Libro da leggere.
Q1 §80 Il pubblico e la letteratura italiana. «Per una ragione o per l’altra si può dire che gli scrittori italiani non abbiano più pubblico. ... Un pubblico infatti vuol dire un insieme di persone, non soltanto che compra dei libri, ma soprattutto che ammira degli uomini. Una letteratura non può fiorire che in un clima d’ammirazione e l’ammirazione non è come si potrebbe credere, il compenso, ma lo stimolo del lavoro. ... Il pubblico che ammira, che ammira davvero, di cuore, con gioia, il pubblico che ha la felicità di ammirare (niente è più deleterio dell’ammirazione convenzionale) è il più grande animatore di una letteratura. Da molti segni si capisce ahimè che il pubblico sta abbandonando gli scrittori italiani». Leo Ferrero nel «Lavoro» («Fiera Letteraria» del 28 ottobre 1928).
L’ammirazione sarebbe la forma del contatto tra la nazione e i suoi scrittori. Oggi manca questo contatto, cioè la letteratura non è nazionale, perché non è popolare. Paradosso del tempo attuale. E non c’è gerarchia nella letteratura cioè manca ogni personalità eminente. Quistione del perché e di come una letteratura sia popolare. La «bellezza» non basta: ci vuole un contenuto «umano e morale» che sia l’espressione elaborata e compiuta delle aspirazioni del pubblico.
Cioè la letteratura deve essere insieme elemento attuale di cultura (civiltà) e opera d’arte (di bellezza). Altrimenti alla letteratura d’arte viene preferita la letteratura d’appendice, che, a modo suo, è un elemento di cultura, degradata se si vuole, ma attuale.
Q1 §81 Nino Daniele, D’Annunzio politico, San Paulo, 1928. Libro da leggere.
Q1 §82 I nipotini di padre Bresciani. Maddalena Santoro, L’amore ai forti. Romanzo. Bemporad, 1928.
Q1 §83 Piero Pieri, Il regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806, Napoli, Ricciardi, 1928, pp. 330, L. 25 (utile per comprendere meglio la Repubblica Partenopea attraverso la politica dei Borboni nel breve periodo della restaurazione) .
Q1 §84 Giovanni Maioli, Il fondatore della Società Nazionale, Soc. Naz. per la Storia del Risorgimento, Roma, 1928 (contiene 22 lettere di Giorgio Pallavicino e di Felice Foresti, sul periodo 1856‑58, quando il Pallavicino, presidente della Società Nazionale di cui era segretario il La Farina, lavorava a creare il blocco liberale sui due capisaldi «opinione italiana» — «esercito sardo». Una espressione del Pallavicino: «il rivoluzionario italiano, uomo fortissimo sul campo dell’azione, è troppo spesso un fanciullo in quello del pensiero»).
Notare che nell’attuale storiografia del Risorgimento, che è tendenziosissima a modo suo, si dà come «acuto realismo politico» tutto ciò che coincide col programma piemontese dei moderati: è un giudizio del senno di poi abbastanza ingenuo e poco acuto e corrisponde poi alla concezione dei «Gesta dei per Allobrogos» riverniciata e spolverata di concetti moderni.
Q1 §85 Giuseppe Solitro, Due famigerati gazzettieri dell’Austria (Luigi Mazzoldi, Pietro Perego), Padova, Draghi, 1927, L. 15. (Nella recensione pubblicata dalla «Fiera Letteraria» del 16 dicembre 1928, Guido Zadei scrive di possedere del materiale inedito e non sfruttato sul Mazzoldi e di una curiosa polemica in cui Filippo Ugoni accusa il Mazzoldi di propaganda comunista).
Q1 §86 Giovanni Crocioni, Problemi fondamentali del Folklore, Bologna, Zanichelli, 1928.
Q1 §87 Gentile e la filosofia della politica italiana. Articolo di Gentile pubblicato dallo «Spectator» del 3 novembre 1928 e ristampato su «Educazione fascista». «Filosofia che non si pensa, ma che si fa, e perciò si enuncia ed afferma non con le formule ma con l’azione». Ogni Stato ha «due» filosofie: quella che si enuncia per formule ed è una semplice arte di governo, e quella che si afferma con l’azione ed è la filosofia reale, cioè la storia. Il problema è di vedere in che misura queste due filosofie coincidono o divergono. La formula gentiliana in realtà non è che la camuffatura sofistica della «filosofia politica» più nota col nome di opportunismo ed empirismo. Se Bouvard e Pécuchet avessero conosciuto Gentile, avrebbero trovato nella sua filosofia la giusta interpretazione della loro attività rinnovatrice e rivoluzionaria (nel senso non corrotto della parola, come oggi si dice).
Q1 §88 Gioberti. Nella prefazione alle Letture del Risorgimento, il Carducci scrive: «Staccatosi dalla Giovane Italia nel 1834 tornò a quello che il Santarosa voleva e chiamava cospirazione letteraria ed egli la fece con certa sua filosofia battagliera, che molto alta portava la tradizione italiana, finché uscì nell’agone col Primato e predicando la lega dei principi riformatori, capo il pontefice, attrasse le anime timorose e gli ingegni timorosi, attrasse e rapi il giovane clero, che alla sua volta traevasi dietro il popolo credente anche della campagna». Altrove il Carducci scrive: «... l’abate italiano riformista e mezzo giacobino col Parini, soprannuotato col Cesarotti e col Barbieri alla Rivoluzione, che s’era fatto col Di Breme banditore di romanticismo e soffiatore nel carbonarismo del 21, che aveva intinto col Gioberti nelle cospirazioni e bandito il Primato d’ltalia e il Rinnovamento, che aveva col Rosmini additato le piaghe della Chiesa, che aveva coll’Andreoli e col Tazzoli salito il patibolo... ».
Q1 §89 Folklore. Il Giovanni Crocioni nel volume Problemi fondamentali del Folklore, Bologna, Zanichelli, 1928 critica come confusa e imprecisa la ripartizione del materiale folkloristico data dal Pitré nel 1897 nella premessa alla Bibliografia delle Tradizioni popolari e propone una ripartizione sua in quattro sezioni: arte, letteratura, scienza, morale del popolo. Anche questa divisione è criticata come imprecisa, mal definita e troppo lata. Il Ciampini (Raffaele) nella «Fiera Letteraria» del 30 dicembre 1928, domanda: «È essa scientifica? Come per es. farvi rientrare le superstizioni? E che vuol dire una morale del popolo? Come studiarla scientificamente? E perché, allora, non parlare anche di una religione di popolo?». Il folklore, mi pare, è stato finora studiato (in realtà finora è stato solo raccolto materiale grezzo) come elemento «pittoresco». Bisognerebbe studiarlo come «concezione del mondo» di determinati strati della società, che non sono toccati dalle correnti moderne di pensiero. Concezione del mondo non solo non elaborata e sistemizzata, perché il popolo per definizione non può far ciò, ma molteplice, nel senso che è una giustapposizione meccanica di parecchie concezioni del mondo, se addirittura non è un museo di frammenti di tutte le concezioni del mondo e della vita che si sono succedute nella storia. Anche il pensiero e la scienza moderna danno elementi al folklore, in quanto certe affermazioni scientifiche e certe opinioni, avulse dal loro complesso, cadono nel dominio popolare e sono «arrangiate» nel mosaico della tradizione (la Scoperta dell’America di Pascarella mostra come le nozioni diffuse dai manuali delle scuole elementari su Cristoforo Colombo e su altri personaggi siano assimilate bizzarramente). Il folklore può esser capito solo come riflesso delle condizioni di vita del popolo, sebbene spesso esso si prolunghi anche quando le condizioni siano modificate in combinazioni bizzarre.
Certo esiste una «religione di popolo» specialmente nei paesi cattolici e ortodossi (molto meno nei protestanti). La morale di popolo è il costume ed è strettamente legata, come la superstizione, alle sue credenze reali religiose: esistono degli imperativi, che sono molto più forti e tenaci che non quelli della morale kantiana.
Il Ciampini trova molto giusta la necessità sostenuta dal Crocioni che il folklore sia insegnato nelle scuole dove si preparavano i futuri insegnanti, ma poi nega che possa porsi la quistione della utilità del folklore (vorrà dire dello studio del folklore). Per lui il folklore (lo studio del folklore, cioè) è fine a se stesso o ha la sola utilità di offrire a un popolo gli elementi per una più profonda conoscenza di se stesso. Studiare le superstizioni per sradicarle, sarebbe per lui come se il folklore uccidesse se stesso, mentre la scienza non è che conoscenza disinteressata, fine a se stessa!!! Ma allora perché insegnate il folklore nelle scuole che preparano gli insegnanti? Per accrescere la cultura disinteressata dei maestri? Lo Stato ha una sua concezione della vita e cerca di diffonderla: è un suo compito e un suo dovere. Questa diffusione non avviene su una tabula rasa; entra in concorrenza e si urta per es. col folklore e «deve» superarlo. Conoscere il folklore significa per l’insegnante conoscere quali altre concezioni lavorano alla formazione intellettuale e morale delle generazioni giovani. Solo che bisognerebbe mutare lo spirito delle ricerche folkloristiche oltre che approfondirle: il folklore non deve essere concepito come una bizzarria, una stranezza, una cosa ridicola, una cosa tutt’al più pittoresca: ma deve essere concepito come una cosa molto seria e da prendere sul serio. Solo così l’insegnamento sarà più efficace e più formativo della cultura delle grandi masse popolari e sparirà il distacco tra cultura moderna e cultura popolare o folklore. Un lavoro di questo genere, in profondità, corrisponderebbe intellettualmente a ciò che è stata la Riforma nei paesi protestanti.
Q1 §90 La Voce e Prezzolini. L’articolo in cui Prezzolini difende la «Voce» e «rivendica di pieno diritto un posto per essa nella preparazione dell’Italia contemporanea» è citato nella «Fiera Letteraria» del 24 febbraio 1929 e quindi deve essere stato pubblicato nel «Lavoro fascista» di qualche giorno prima (nei dieci giorni tra il 14 e il 24 febbraio). L’articolo è stato provocato da una serie di articoletti della «Tribuna» contro Papini, nel quale, per il suo studio Su questa letteratura (pubblicato nel primo numero del «Pègaso») si scoprivano tracce del vecchio «protestantesimo» della «Voce». Lo scrittore della «Tribuna» ex nazionalista della prima «Idea Nazionale» non riusciva ancora a dimenticare i vecchi rancori contro la «Voce», mentre Prezzolini non ebbe il coraggio di sostenere la sua posizione d’allora. Su questo argomento Prezzolini pubblicò anche una lettera nel «Davide» che usciva irregolarmente a Torino nel 25‑26 diretto da Gorgerino. Bisogna poi ricordare il suo libro sulla Cultura Italiana del 23 e il suo volume sul «Fascismo» (in francese). Se Prezzolini avesse coraggio civile potrebbe ricordare che la sua «Voce» ha certamente molto influito su alcuni elementi socialisti ed è stata un elemento di revisionismo. Sua collaborazione e di Papini, nonché di molti vociani, al primo «Popolo d’Italia».
Q1 §91 Strapaese. Mino Maccari nella «Stampa» del 4 maggio 1929 scrive: «Quando Strapaese si oppone alle importazioni modernistiche, la sua opposizione vuol salvare il diritto di selezionarle al fine di impedire che i contatti nocivi, confondendosi con quelli che possono esser benefici, corrompano l’integrità della natura e del carattere proprii alla civiltà italiana, quintessenziata nei secoli, ed oggi anelante a una sintesi unificatrice».
Q1 §92 Sull’americanismo ha scritto un articolo Eugenio Giovannetti («Pègaso», maggio 1929, Federico Taylor e l’americanismo). Tra l’altro scrive (estratti dati dall’«Italia Letteraria» del 19 maggio): «L’energia letteraria, astratta, nutrita di retorica generalizzante, non è insomma oggi più in grado di capire l’energia tecnica, sempre più individuale ed acuta, tessuto originalissimo di volontà singolare e d’educazione specializzata. La letteratura energetica è ancora al suo Prometeo scatenato, immagine troppo comoda. L’eroe della civiltà tecnica non è uno scatenato: è un silenzioso che sa portare pei cieli la sua ferrea catena. Non è un ignorante che si goda l’aria: è uno studioso nel più bel senso classico, perché studium significava «punta viva». Mentre la civiltà tecnica o meccanistica, come volete chiamarla, elabora in silenzio questo suo tipo d’eroe incisivo, il culto letterario dell’energia non crea che un gaglioffo aereo, un acchiappanuvole scalmanato» .
È curioso che all’americanismo non si cerchi di applicare la formuletta di Gentile della «filosofia che non si enunzia in formule ma si afferma nell’azione»; è curioso e istruttivo, perché se la formula ha un valore è proprio l’americanismo che può rivendicarlo. Quando si parla dell’americanismo, invece, si trova che esso è meccanicistico, rozzo, brutale, cioè «pura azione» e gli si contrappone la tradizione ecc. Ma questa tradizione ecc. perché non viene assunta anche come base filosofica, come filosofia enunciata in formule per quei movimenti per i quali invece la «filosofia è affermata nell’azione»? Questa contraddizione può spiegare molte cose: differenza tra azione reale, che modifica essenzialmente la realtà esterna (e quindi anche la cultura reale) ed è l’americanismo, e gladiatorismo gaglioffo che si autoproclama azione e modifica solo il vocabolario non le cose, il gesto esterno non l’uomo interiore. La prima crea un avvenire che è intrinseco alla sua attività obbiettiva, e che spesso è ignorato. Il secondo crea dei fantocci perfezionati, secondo un figurino prefissato, che cadranno nel nulla appena tagliati i fili che danno loro l’apparenza del moto e della vita.
Q1 §93 I nipotini di padre Bresciani. Tommaso Gallarati Scotti, Storie dell’Amor Sacro e dell’Amor Profano. Ricordare la novella in cui si parla del falso corpo della santa portato dall’Oriente dai Crociati e le considerazioni sbalorditive dello Scotti. Dopo il frate Cipolla del Boccaccio... (Ricordare La reliquia di Eça de Queiroz tradotto dal L. Siciliani in una collezione di Rocco Carabba diretto dal Borgese: in essa è un riflesso della novella del Boccaccio). I bollandisti sono rispettabili, perché almeno hanno estirpato qualche radice di superstizione (sebbene le loro ricerche rimangano chiuse in un cerchio molto ristretto e servano più che altro per gli intellettuali, per far vedere agli intellettuali che il cattolicismo combatte le superstizioni) ma l’estetismo folkloristico dello Scotti è rivoltante. Ricordare il dialogo riportato da W. Steed tra un protestante e un Cardinale a proposito di san Gennaro e la nota di Croce su una sua conversazione con un prete napoletano su san Gennaro a proposito di una lettera di Sorel. La figura dello Scotti entra di scorcio fra i nipotini di padre Bresciani. Come appendice o complemento parallelo.
Q1 §94 Proudhon, Jahier e Raimondi. Nell’«Italia Letteraria» del 21 luglio 1929 Giuseppe Raimondi scrive: «... mi parla di Proudhon, della sua grandezza e della sua modestia, dell’influenza che le sue idee hanno esercitato nel mondo moderno, dell’importanza che queste idee hanno assunto in un mondo retto dal lavoro socialmente organizzato, in un mondo dove la coscienza degli uomini si va sempre più evolvendo e perfezionando in nome del lavoro e dei suoi interessi. Proudhon ha fatto un mito, umano e vivente, di questi poveri interessi. In me l’ammirazione per Proudhon è piuttosto sentimentale, d’istinto, come un affetto e un rispetto che io ho ereditato, che mi sono stati trasmessi nascendo. In Jahier è tutta d’intelletto, derivata dallo studio, perciò profondissima». Questo Raimondi è un discreto poseur con la sua «ammirazione ereditata». Più oltre rò un brano di un altro suo articolo, che fa spiccare ancor di più questa posa.
Q1 §95 Adriano Tilgher, Homo faber. Storia del concetto del lavoro nella civiltà occidentale, Roma, Libreria di Scienza e Lettere, 1929, L. 15.
Q1 §96 Adelchi Baratono ha scritto nel II fascicolo di «Glossa perenne» un articolo sul Novecentismo che deve essere ricchissimo di spunti «sfottendi». Tra l’altro: «L’arte e la letteratura di un tempo non può e non dev’essere (!) che quella corrispondente alla vita e al gusto del tempo, e tutte le deplorazioni, come non servirebbero a mutarne l’ispirazione e la forma, così sarebbero anche contrarie a ogni criterio storico e quindi giusto di giudicare». Ma la vita e il gusto di un tempo sono qualcosa di monolitico? E allora la «corrispondenza» come può verificarsi? Il Risorgimento era «corrisposto» dal Berchet o dal padre Bresciani? La deplorazione lamentosa e moralistica sarebbe certamente scema, ma si può fare la critica senza deplorare. De Sanctis era un partigiano deciso della rivoluzione nazionale, tuttavia seppe criticare il Guerrazzi e non solo il Bresciani. L’agnosticismo del Baratono non è altro che vigliaccheria morale e civile. (Egli riconosce impossibile, per difetto di obbiettività e universalità, il giudizio di merito sui contemporanei).
Q1 §97 Salvadori, Valli e il lorianismo. Valli e la sua interpretazione «cospiratoria» e massonica del Dolce Stil nuovo (col precedente di D. G. Rossetti e del Pascoli) e Giulio Salvadori che nei Promessi Sposi scopre il dramma di Enrichetta (Lucia) oppressa da Condorcet, Donna Giulia e il Manzoni stesso (Don Rodrigo, l’Innominato ecc.) appartengono a una branca del Lorianesimo. (Di Giulio Salvadori e della sua interpretazione vedi un articolo in «Arte e Vita» del giugno 1920 e il libro postumo Enrichetta Manzoni ‑ Blondel e il Natale del 33, Treves, 1929).
Q1 §98 Lello Gangemi, Il problema della durata del lavoro, Firenze, Vallecchi, 1929, L. 25. (Dalla breve recensione di Luigi Perla in «Italia Letteraria» del 18 agosto 1929 si ricava: il problema della durata del lavoro, passato in seconda linea dopo il miglioramento delle condizioni economiche seguito al periodo di depressione che ebbe inizio nel 1921, è ritornato ora in discussione per la crisi economica attuale. Esame della legislazione vigente in materia nei vari paesi, ponendo in luce la difficoltà di una regolamentazione uniforme. Il problema e la convenzione di Washington. Dal punto di vista dell’organizzazione scientifica del lavoro. Le pretenzioni teoriche e sociali, che hanno dominato il problema, si sono dimostrate inapplicabili nella pratica azione legislativa. Di contro alle ideologie che vorrebbero abolire le ingiustizie sociali e finiscono invece col moltiplicarle e renderle più gravi, la pratica ha confermato come la semplice riduzione delle ore lavorative non possa, da sola (!), raggiungere l’intento di una maggiore produttività e di maggiori vantaggi (!) per il lavoratore. Resta invece dimostrata la utilità di determinate un limite dello sforzo lavorativo; ma questo limite non deve essere imposto in base a ideologie astratte, ma deve risultare dalla razionale coordinazione di concetti (!) fisiologici, economici ed etici).
Q1 §99 Un famoso parabolano arruffone è Antonio Bruers, uno dei tanti tappi di sughero che salgono sulle creste melmose dei bassifondi agitati. Nel «Lavoro fascista» del 23 agosto 1929 egli dà per probabile l’affermarsi in Italia di una filosofia, «la quale, pur non rinunciando a nessuno dei valori concreti dell’idealismo, è in grado di comprendere, nella sua pienezza filosofica e sociale, l’esigenza religiosa. Questa filosofia è lo spiritualismo, dottrina sintetica (!), la quale non esclude l’immanenza, ma conferisce il primato logico (!) alla trascendenza, riconosce praticamente (!) il dualismo e quindi conferisce al determinismo, alla natura, un valore che si concilia con le esigenze dello sperimentalismo». Questa dottrina corrisponderebbe al «genio prevalente della stirpe italica» di cui il Bruers, nonostante il nome esotico, sarebbe naturalmente il coronamento storico, spirituale, immanente, trascendente, ideale, determinato, pratico e sperimentale nonché religioso.
Q1 §100 Goffredo Bellonci, Pagine e idee, Edizione Sapientia, Roma. Pare che sia una specie di storia della letteratura italiana originalmente sovvertita dal luogo comune. Questo Bellonci è proprio una macchietta del giornalismo letterario; un Bouvard delle idee e della politica, una vittima di Mario Missiroli che era già una vittima di Oriani e di Sorel.
Q1 §101 Piedigrotta. In un articolo sul «Lavoro» (8 settembre 1929) Adriano Tilgher scrive che la poesia dialettale napoletana e quindi in gran parte la fortuna delle canzoni di Piedigrotta è in fiera crisi. Se ne sarebbero essicate le due grandi fonti: realismo e sentimentalismo. «Il mutamento di sentimenti e di gusti è stato così rapido e sconvolgente, così vorticoso e subitaneo, ed è ancora così lontano dall’essersi cristallizzato in qualcosa di stabile e di duraturo che i poeti dialettali che si avventurano su quelle sabbie mobili per tentare di portarle alla durezza e alla chiarezza della forma sono condannati a sparirvi dentro senza rimedio».
La crisi di Piedigrotta è veramente un segno dei tempi. La teorizzazione di Strapaese ha ucciso strapaese (in realtà si voleva fissare un figurino tendenzioso di strapaese assai ammuffito e scimunito). E poi l’epoca moderna non è espansiva, è repressiva. Non si ride più di cuore: si sogghigna e si fa dell’arguzia meccanica tipo Campanile. La fonte di Piedigrotta non si è essicata, è stata essicata perché era diventata «ufficiale» e i canzonieri erano diventati funzionari (vedi Libero Bovio) (e cfr l’apologo francese del becco funzionario).
Q1 §102 «La Fiera letteraria» divenuta poi «L’Italia letteraria» è stata sempre, ma sta diventando sempre più un sacco di patate. Ha due direttori, ma è come se non ne avesse nessuno e un segretario esaminasse la posta in arrivo, tirando a sorte gli articoli da pubblicare. Il curioso è che i due direttori, Malaparte e Angioletti, non scrivono nel loro giornale ma preferiscono altre vetrine. Le colonne della redazione devono essere Titta Rosa ed Enrico Falqui, e dei due il più comico è quest’ultimo che compila la Rassegna della Stampa, saltabeccando a destra e a sinistra, senza bussola e senza idee. Titta Rosa è più ponteficale e si dà arie da grande pontefice disincantato anche quando scrive delle baggianate. L’Angioletti pare abbastanza ritrosetto a lanciarsi in alto mare: non ha l’improntitudine di Malaparte. È interessante notare come l’«Italia letteraria» non si arrischi a dare giudizi propri e aspetti che abbiano parlato prima i cani grossi. Così è avvenuto per gl’Indifferenti di Moravia, ma cosa più grave per il Malagigi di Nino Savarese, libro veramente saporoso, che fu recensito solo quando entrò in terna per il premio dei trenta, mentre non era stato notato nelle pagine della «Nuova Antologia». Le contraddizioni di questo gruppo di graffiacarte sono veramente spassose, ma non vale la pena di notarle. Ricordano i Bandar Log del Libro della Jungla: «noi faremo, noi creeremo», ecc. ecc.
Q1 §103 Confederazione Generale Fascista dell’Industria italiana, Lo sviluppo dell’Industria Italiana, Litografia del Genio Civile, Roma, 1929, L. 100 (78 tavole in policromia, che passano in rassegna l’industria italiana dal 1876 al 1928). Indispensabile.
Q1 §104 Jean Barois. Riceve i sacramenti della religione prima di morire. La moglie trova poi tra le sue carte il testamento, redatto negli anni della maturità intellettuale. Vi si trova: «per tema che la vecchiaia e le malattie mi indeboliscano a tal segno da farmi temere la morte e da indurmi a cercare le consolazioni della religione, redigo oggi nella pienezza delle mie facoltà e del mio equilibrio intellettuale, il mio testamento. Non credo all’anima sostanziale e immortale. So che la mia personalità è un agglomerato di atomi la cui disgregazione comporta la morte totale. Credo al determinismo universale... ». Il testamento è gettato nel fuoco. Ricercare.
Q1 §105 La filosofia americana. Studiare la posizione di Josiah Royce nel quadro della concezione americana della vita. Quale importanza e quale funzione ha avuto l’hegelismo in questa concezione? Può il pensiero moderno diffondersi in America, superando l’empirismo‑pragmatismo, senza una fase hegeliana?
Q1 §106 La concezione religiosa di Maurras. La «Rivista d’Italia» del 15 gennaio 1927 riassume un articolo di J. Vialatoux pubblicato nella «Chronique Sociale de France» di qualche settimana prima. Il Vialatoux respinge la tesi sostenuta da Jacques Maritain in Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques (Paris, Plon, 1926) che tra la filosofia e la morale pagane di Maurras da una parte e la sua politica dall’altra non vi sia che un rapporto contingente, di modo che se si prende la dottrina politica, astraendo dalla filosofia, si può andare incontro a qualche pericolo, come in ogni movimento umano, ma non v’ha nulla di condannabile. Per il Vialatoux, giustamente, la dottrina politica scaturisce (o per lo meno è inscindibilmente collegata — G.) dalla concezione pagana del mondo (su questo paganesimo bisognerebbe distinguere e chiarire, tra la veste letteraria, estrinseca, in cui consiste questo così detto paganesimo di Maurras e il nocciolo essenziale che è poi un positivismo naturalistico, preso da Comte e mediatamente dal sansimonismo, ciò che col paganesimo entra solo per la nomenclatura gergale della chiesa). La città è fine ultimo dell’uomo: realizza l’ordine umano con le sole forze della natura. Maurras è definibile per i suoi odii ancor più che per i suoi amori. Odia il cristianesimo primitivo (la concezione del mondo degli Evangeli, dei primi apologisti ecc., il cristianesimo fino all’editto di Milano, insomma, che credeva la venuta di Cristo annunziare la fine del mondo e determinava perciò la dissoluzione dell’ordine politico romano in una anarchia morale corrosiva di ogni valore civile e statale) che per lui è una concezione giudaica.
In questo senso Maurras vuole scristianizzare la società moderna. Per Maurras la chiesa cattolica è stata e sarà sempre più lo strumento di questa scristianizzazione. Egli distingue tra cristianesimo e cattolicismo ed esalta quest’ultimo come la reazione dell’ordine romano all’anarchia giudaica. Il culto cattolico, le sue devozioni superstiziose, le sue feste, le sue pompe, le sue solennità, la sua liturgia, le sue immagini, le sue formule, i suoi riti sacramentali, la sua gerarchia imponente, sono come un incantesimo salutare per domare l’anarchia cristiana, per immunizzare il veleno giudaico del cristianesimo autentico. Secondo il Vialatoux il nazionalismo dell’Action Française non è che un episodio della storia religiosa del nostro tempo. (Bisognerebbe aggiungere che l’odio di Maurras contro tutto ciò che sa di protestante ed è di origine anglotedesca ‑ romanticismo, Rivoluzione francese, capitalismo — non è che un aspetto di questo odio del cristianesimo primitivo; bisognerebbe inoltre cercare in Augusto Comte le origini della sua attitudine verso il cattolicismo, che non è indipendente dalla rinascita libresca del tomismo e dell’aristotelismo).
Q1 §107 Filippo Meda, Statisti cattolici, Alberto Morano, Napoli. Sono sei biografie: di Daniele ’O Connel, García Moreno, Luigi Windthorst, Augusto Bernaert, Giorgio Hertling, Antonio Maura. Esponenti del conservatorismo clericale (clerico‑moderati italiani), cioè della preistoria del moderno popolarismo cattolico. È indispensabile per ricostruire lo sviluppo storico dell’Azione Cattolica. La biografia di García Moreno (Venezuela, mi pare) è anche interessante per comprendere alcuni aspetti delle lotte ideologiche dell’ex‑America spagnola e portoghese, dove ancora si attraversa un periodo di Kulturkampf primitivo, dove cioè lo Stato moderno deve ancora lottare contro il passato clericale e feudale. È interessante notare questa contraddizione che esiste nell’America del Sud tra il mondo moderno delle grandi città commerciali della costa e il primitivismo dell’interno, contraddizione che si prolunga per l’esistenza di grandi masse di aborigeni da un lato e di immigrati europei dall’altro più difficilmente assimilabili che nell’America del Nord: il gesuitismo è un progresso in confronto dell’idolatria, ma è un inciampo per lo sviluppo della civiltà moderna rappresentata dalle grandi città costiere: esso serve come mezzo di governo per mantenere al potere le piccole oligarchie tradizionali, che perciò non fanno che una lotta blanda e molle. La massoneria e la Chiesa positivistica sono le ideologie e le religioni laiche della piccola borghesia urbana, alle quali aderisce in gran parte il così detto sindacalismo anarchico che dello scientifismo anticlericale fa il suo pascolo intellettuale. (Problema del risveglio alla vita politica e nazionale delle masse aborigene: nel Messico qualcosa di simile è avvenuto per impulso di Obregon e Calles?)
Q1 §108 Sul Risorgimento. Pubblicazioni di Augusto Sandonà, che dopo l’armistizio ha fatto ricerche negli archivi viennesi per studiare la documentazione austriaca ufficiale.
Q1 §109 Confidenti e agenti provocatori dell’Austria. I confidenti che agivano all’estero e che dipendevano dalla Cancelleria di Stato di Vienna, non dovevano fare gli agenti provocatori; ciò risulta dalle precise istruzioni del principe di Metternich che, in un dispaccio segreto dell’8 febbraio 1844 indirizzato al conte Apponyi ambasciatore d’Austria a Parigi, così si esprimeva in merito al servizio che prestava nella capitale francese il famigerato Attilio Partesotti: «Il grande fine che il Governo imperiale si propone non è di trovare dei colpevoli né di provocare delle imprese criminali... Partesotti deve di conseguenza considerarsi come un osservatore attento e fedele ed evitare con cura di essere agente provocatore» (Staatskanzlei). Così scrive Augusto Sandonà nello studio Il preludio delle cinque giornate di Milano ‑ Nuovi documenti, pubblicato nella «Rivista d’Italia» (ho letto solo la prima puntata nel numero del 15 gennaio 1927) a proposito dell’accusa lanciata dal dott. Carlo Casati (Nuove Rivelazioni sui fatti di Milano nel 1847‑48, Milano, Hoepli, 1885) e dall’«Archivio triennale delle cose d’Italia» (vol. I, Capolago, Tip. Elvetica, 1850) al barone Carlo Torresani, direttore generale della polizia di Milano dal 1822 al 48, di aver organizzato un servizio di agenti provocatori che inscenassero i tumulti. È da osservare però che, nonostante le disposizioni del Metternich, gli agenti provocatori potevano operare ugualmente per necessità delle polizie locali e anche per necessità personale degli «osservatori» stessi.
Q1 §110 Contraddizioni dei moderati prima del 48. La lega doganale, promossa da Cesare Balbo e stretta a Torino il 3 novembre 1847 dai tre rappresentanti del Piemonte, della Toscana e dello Stato romano, doveva preludere alla costituzione della Confederazione politica che poi fu disdetta dallo stesso Balbo, facendo così abortire anche la Lega doganale. La Confederazione era desiderata dagli Stati minori italiani: i piemontesi reazionari, tra cui Balbo, credendo assicurata l’espansione territoriale del Piemonte, non volevano pregiudicarla con legami che l’avrebbero ostacolata (il Balbo nelle Speranze d’Italia aveva sostenuto che la Confederazione era impossibile finché una parte d’Italia fosse stata in mano agli stranieri) e disdissero la Confederazione dicendo che le leghe si stringono prima o dopo la guerra (la Confederazione fu respinta nel 48 nei primi mesi — cercare). Gioberti con altri vedevano nella confederazione politica e doganale stretta anche durante la guerra la necessaria premessa per rendere possibile il motto «l’Italia farà da sé».
Questo episodio è della massima importanza, con quello dei volontari e della Costituente, per mostrare come il movimento del 48 fallì per gl’intrighi dei reazionari, che poi furono i moderati del periodo successivo. Essi non seppero dare né una direzione politica, né tanto meno una direzione militare alla rivoluzione prima del 48.
Q1 §111 Di Augusto Sandonà. 1°) Contributo alla storia dei processi del 21 e dello Spielberg, Torino, Bocca, 1911; 2°) L’idea unitaria ed i partiti politici alla vigilia del 1848, «Rivista d’Italia», giugno 1914; 3°) Il Regno lombardo‑veneto. La costituzione e l’amministrazione, Milano, Cogliati, 1912.
Q1 §112 Padre Facchinei. Nella «Rivista d’Italia» del 15 gennaio 1927 è pubblicato un articolo di Adolfo Zerboglio intitolato Il ritorno di padre Facchinei, autore di un libello contro Cesare Beccaria ed osservazioni sul libro intitolato «Dei delitti e delle pene» pubblicato verso il 1761. Dai brani riportati dallo Zerboglio (p. 27 della rivista) appare che il Facchinei conosceva già la parola «socialisti»: «Domando ai più pregiudicati socialisti: se un uomo trovandosi nella sua primitiva libertà, e prima di essere entrato in qualche società, domando, dico, se un uomo libero abbia diritto di uccidere un altr’uomo, che gli volesse in qualunque maniera levar la vita? Io sono sicuro che tutti i socialisti per questa volta mi risponderanno di sì». Ma cosa significava allora questa parola? Nel Dizionario politico di Maurizio Block la parola «socialisme» è assegnata a un’epoca molto più tarda, verso il 1830, se ben ricordo.
Q1 §113 Rivoluzione nel diritto penale e nella procedura penale e materialismo storico. La espressione di Marx nella prefazione alla Critica dell’Economia politica (del 1859) «così come non si giudica ciò che un individuo è da ciò che egli sembra a se stesso» può essere riallacciata al rivolgimento avvenuto nella procedura penale e alle discussioni teoriche in proposito, allora relativamente recenti. Infatti la vecchia procedura richiedeva la confessione dell’imputato (specialmente per i delitti capitali) per emettere la sentenza di condanna, donde la tortura. Nella nuova procedura l’interrogatorio dell’imputato è solo un elemento, talvolta trascurabile, del processo (non si domanda il giuramento, si riconosce che l’imputato può mentire o essere reticente) mentre il primo posto è preso dalle prove materiali e testimoniali. Ricercare se qualcuno ha rilevato questa coincidenza dei due fenomeni e ha studiato il movimento per la rinnovazione del diritto processuale e penale come un elemento suggestivo dell’innovazione portata da Marx nello studio della storia (Sorel potrebbe aver fatto l’osservazione, perché rientra nel suo stile).
Q1 §114 Risorgimento. Direzione Politica e militare. Nello studio della direzione politica e militare impressa al movimento nazionale prima e dopo il 48 occorre fare alcune preventive osservazioni di metodo e di nomenclatura. Per direzione militare non deve intendersi solo la direzione militare in senso stretto, tecnico, cioè come riferentesi alla strategia e alla tattica dell’esercito piemontese, o delle truppe garibaldine o delle varie milizie improvvisate nelle sollevazioni locali (5 giornate di Milano, difesa di Venezia, difesa della Repubblica Romana, insurrezione di Palermo nel 48 ecc.). Deve intendersi invece in senso molto più largo e più strettamente aderente alla direzione politica vera e propria. Il problema era di espellere dall’Italia una potenza straniera, che aveva uno dei più grandi eserciti dell’Europa d’allora e che aveva inoltre non pochi e deboli aderenti nell’Italia stessa, persino nel Piemonte. Il problema militare era pertanto questo: «come riuscire a mobilitare una forza che fosse in grado di espellere dall’Italia l’esercito austriaco e di impedire che potesse ritornare con una controffensiva, dato che l’espulsione violenta avrebbe messo in pericolo l’Impero e quindi ne avrebbe galvanizzato tutte le forze vitali per una rivincita».
Le soluzioni date teoricamente furono parecchie, tutte contraddittorie. «L’Italia farà da sé». Questa fu la parola d’ordine del 48. Ma volle dire la sconfitta. La politica ambigua, incerta, timida dei partiti di destra piemontesi fu la cagione principale della sconfitta: essi furono d’una astuzia meschina. Essi furono la causa del ritirarsi degli eserciti degli altri stati italiani, napoletani e romani, per aver troppo presto mostrato di volere l’espansione piemontese e non la confederazione italiana: essi non favorivano i volontari: essi, insomma, volevano che soli armati vittoriosi fossero i generali piemontesi. L’assenza di una politica popolare fu disastrosa: i contadini lombardi e veneti arruolati dall’Austria furono lo strumento per soffocare la rivoluzione di Vienna. Essi non vedevano nessun rapporto tra la rivoluzione di Vienna e quella dei loro paesi: il movimento lombardo‑veneto era una cosa dei signori e degli studenti come il movimento viennese. Mentre il partito nazionale italiano avrebbe dovuto, con la sua politica rivoluzionaria, portare o aiutare la disgregazione dell’Impero austriaco, con la sua inerzia ottenne che i reggimenti italiani fossero uno dei migliori puntelli della reazione austriaca. Eppure questo avrebbe dovuto essere il suo fine strategico: non distruggere il nemico e occuparne il territorio, che sarebbe stato fine irraggiungibile e utopistico, ma disgregarlo all’interno e aiutare i liberali austriaci ad andare al potere per mutare la struttura interna dell’impero in federalistica, o almeno per crearvi uno stato prolungato di lotte interne fra le varie nazionalità (lo stesso errore fu commesso da Sonnino durante la guerra mondiale, anche contro il parere di Cadorna: Sonnino non voleva la distruzione dell’Impero absburgico e si rifiutò a ogni politica di nazionalità; anche dopo Caporetto, questa politica fu fatta maltusianamente e non dette i rapidi risultati che avrebbe potuto dare).
Però dopo aver affermato «l’Italia farà da sé» si cercò dopo la sconfitta di avere l’aiuto francese, proprio quando al governo in Francia erano andati i reazionari, nemici di uno Stato italiano forte.
La direzione militare è dunque una quistione più vasta della direzione dell’esercito vero e proprio, della determinazione del piano strategico che questo esercito deve svolgere: essa riguarda la mobilitazione di forze popolari che insorgano alle spalle del nemico e ne intralcino il movimento, essa tende a creare masse ausiliarie e di riserva, da cui si possono trarre nuovi eserciti e che diano all’esercito «tecnico» l’atmosfera di entusiasmo e di ardore. La politica popolare non fu fatta neanche dopo il 48: si cercò l’aiuto della Francia e con l’alleanza francese si equilibrò la forza austriaca. La politica della destra piemontese ritardò l’unità d’Italia di 20 anni.
Q1 §115 A proposito della minaccia continua che il governo viennese faceva ai nobili del Lombardo‑Veneto di promulgare una legislazione agraria favorevole ai contadini (cosa che fu fatta nella Galizia contro i signori polacchi a favore dei contadini ruteni), sono interessanti alcuni particolari contenuti in un articolo della «Pologne littéraire» riassunto nel «Marzocco» del 1° dicembre 1929. Il giornale polacco, ricercando le cause storiche dello spirito militare dei polacchi, per cui si trovano volontari polacchi in tutte le guerre e le guerriglie, in tutte le insurrezioni e in tutte le rivoluzioni del secolo scorso, risale a questo fatto: il 13 luglio 1792 «una nazione che contava 9 milioni di abitanti, che aveva 70 000 soldati sotto le armi, fu conquistata senza essere stata vinta».
Il 3 maggio 1791 era stata proclamata una costituzione il cui spirito largamente democratico poteva divenire un pericolo per i vicini, il re di Prussia, l’imperatore d’Austria e lo zar di Russia, e che aveva parecchi punti di contatto con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino votata dalla Costituente francese nell’agosto del 1789. La Polonia fu conquistata colla piena connivenza dei nobili polacchi, i quali, più previdenti dei loro fratelli di Francia, non avevano atteso l’applicazione della carta costituzionale per provocare l’intervento straniero. Costoro preferirono vendere la nazione al nemico piuttosto che cedere la benché minima parte delle terre ai contadini. Preferirono cadere in servitù essi medesimi, anziché concedere la libertà al popolo. Secondo l’autore dell’articolo, Z. St. Klingsland, i 70 000 soldati presero la via dell’esilio e si diressero verso la Francia, ciò che è per lo meno esagerato. Ma il nocciolo degli avvenimenti è veramente istruttivo e spiega molta parte degli avvenimenti fino al 48 anche in Italia.
È interessante il fatto che un giornale polacco fatto per l’estero preferisca far risalire la spartizione polacca del 92 al tradimento dei nobili piuttosto che alla debolezza militare della Polonia, nonostante che la nobiltà abbia ancora in Polonia una funzione molto importante. Forse episodio della lotta di Pilsudsky contro Witos. Strano «punto d’onore» nazionale. Darwin, mi pare nel suo Viaggio intorno al mondo di un naturalista racconta qualcosa di simile per la Spagna: gli spagnoli sostenevano che una sconfitta della flotta alleata franco-spagnola era stata causata dalla loro slealtà, perché se avessero combattuto davvero, gli spagnoli non avrebbero potuto essere stati vinti. Meglio sleali e traditori che senza «spirito militare invincibile».
Q1 §116 Intellettuali italiani. Confronto tra la concentrazione culturale francese, che si riassume nell’«Istituto di Francia» e la non coordinazione italiana. Riviste di cultura francesi e italiane (tipo Nuova Antologia ‑ «Revue des deux mondes»). Giornali quotidiani italiani molto meglio fatti che i francesi: essi compiono due funzioni — quella di informazione e di direzione politica generale e la funzione di cultura politica, letteraria, artistica, scientifica che non ha un suo organo proprio diffuso (la piccola rivista per la media cultura). In Francia anzi anche la prima funzione si è distinta in due serie di quotidiani: quelli di informazione e quelli di opinione che a loro volta sono dipendenti da partiti direttamente, oppure hanno una apparenza di imparzialità («Action Française» ‑ «Temps» ‑ «Débats»).
In Italia, per l’assenza di partiti organizzati e centralizzati, non si può prescindere dai giornali: sono i giornali, raggruppati a serie, che costituiscono i veri partiti. Per esempio, nel dopoguerra, Giolitti aveva una serie di giornali che rappresentavano le varie correnti o frazioni del partito liberale democratico: la «Stampa» a Torino, che cercava d’influire sugli operai e aveva saltuariamente spiccate tendenze riformistiche (nella «Stampa» tutte le posizioni erano saltuarie, intermittenti, a seconda che Giolitti era o non era al potere ecc.); la «Tribuna» a Roma che era legata alla burocrazia e all’industria protezionista (mentre la «Stampa» era piuttosto liberista — quando Giolitti non era al potere con maggiore accentuazione); il «Mattino» a Napoli legato alle cricche meridionali giolittiane, con altri organi minori (la «Stampa» per certa collaborazione e servizi d’informazione era alla testa di un trust giornalistico di cui facevano parte specialmente il «Mattino», la «Nazione» e anche il «Resto del Carlino»).
Il «Corriere della Sera» formava una corrente a sé, che cercava di essere in Italia ciò che è il «Times» in Inghilterra, custode dei valori nazionali al di sopra delle singole correnti. Di fatto era legato all’industria lombarda d’esportazione tessile (e gomma), e perciò più permanentemente liberista: nel dopoguerra il «Corriere» era alla destra del Nittismo (dopo aver sostenuto Salandra). Il Nittismo aveva anch’esso una serie di giornali: il «Corriere» a destra, il «Carlino» al centro destra, il «Mondo» al centro sinistra, il «Paese» alla sinistra. Il Nittismo aveva due aspetti: plutocratico, legato all’industria protetta e di sinistra. Una posizione a parte occupava il «Giornale d’Italia», legato all’industria protetta e ai grandi proprietari terrieri dell’Emilia, del Centro e del Mezzogiorno. È interessante notare che i grandi giornali che rappresentavano la tradizione del Partito d'Azione — «Secolo» a Milano, «Gazzetta del Popolo» a Torino, «Messaggero» a Roma, «Roma» a Napoli — ebbero dal 21 al 25 un atteggiamento diverso dalla «Stampa», dal «Corriere», dal «Giornale d’Italia» ‑ «Tribuna», dal «Mattino» e anche dal «Resto del Carlino».
Il «Corriere» fu sempre antigiolittiano, come ho spiegato in una precedente nota. Anche al tempo della guerra libica, il «Corriere» si tenne neutrale fino a pochi giorni prima della dichiarazione di guerra, quando pubblicò l’articolo di Andrea Torre, rumoroso e pieno di strafalcioni.
Il Nittismo era ancora una formazione politica in fieri: ma Nitti mancava di alcune doti essenziali dell’uomo di Stato, era troppo pauroso fisicamente e troppo poco deciso: egli era però molto furbo, ma è questa una qualità subalterna. La creazione della Guardia Regia è il solo atto politico importante di Nitti: Nitti voleva creare un parlamentarismo di tipo francese (è da notare come Giolitti cercasse sempre le crisi extraparlamentari: Giolitti con questo «trucco» voleva mantenere formalmente intatto il diritto regio di nominare i ministri all’infuori o almeno a latere del Parlamento; in ogni caso impedire che il governo fosse troppo legato o esclusivamente legato al Parlamento), ma si poneva il problema delle forze armate e di un possibile colpo di Stato. Poiché i carabinieri dipendevano disciplinarmente e politicamente dal Ministero della Guerra, cioè dallo Stato Maggiore (anche se finanziariamente dal ministero degli interni), Nitti creò la Guardia Regia, come forza armata dipendente dal Parlamento, come contrappeso contro ogni velleità di colpo di Stato.
Per uno strano paradosso la Guardia Regia, che era un completo esercito professionale, cioè di tipo reazionario, doveva avere una funzione democratica, come forza armata della rappresentanza nazionale contro i possibili tentativi delle forze irresponsabili e reazionarie. È da notare la occulta lotta svoltasi nel 1922 tra nazionalisti e democratici intorno ai carabinieri e alla guardia regia. I liberali sotto la maschera di Facta volevano ridurre il corpo dei carabinieri o incorporarne una gran parte (il 50%) nella guardia regia. I nazionalisti reagiscono e al Senato il generale Giardino parla contro la Guardia Regia, e ne fa sciogliere la cavalleria (ricordare la comica e miserevole difesa che di questa cavalleria fece il «Paese»: il prestigio del cavallo, ecc. ecc.).
Le direttive di Nitti erano molto confuse: nel 1918, quand’era ministro del Tesoro, fece una campagna oratoria sostenendo la industrializzazione accelerata dell’Italia, e sballando grosse fanfaluche sulle ricchezze minerarie di ferro e carbone del paese (il ferro era quello di Cogne, il carbone era la lignite toscana: il Nitti giunse a sostenere che l’Italia poteva esportare questi minerali, dopo aver soddisfatto una sua industria decuplicata; cfr a questo proposito l’Italia in rissa di F. Ciccotti). Sostenne, prima dell’armistizio, la polizza ai combattenti, di 1000 lire, acquistando la simpatia dei contadini. Significato dell’amnistia ai disertori (italiani all’estero che non avrebbero più mandato rimesse, di cui la Banca di Sconto aveva il quasi monopolio). Discorso di Nitti sulla impossibilità tecnica della rivoluzione in Italia, che produsse un effetto folgorante nel partito socialista (cfr il discorso di Nitti con la lettera aperta di Serrati del novembre o dicembre 1920). La Guardia Regia era per il 90% di meridionali. Programma di Nitti dei bacini montani nell’Italia meridionale che produsse tanto entusiasmo.
La morte del generale Ameglio, suicidatosi dopo un pubblico alterco col generale Tettoni, incaricato di una ispezione amministrativa sulla gestione della Cirenaica (Ameglio era il generalissimo della Guardia Regia). La morte di Ameglio, per la sua tragicità, deve essere collegata al suicidio del generale Pollio nel 1914 (Pollio aveva, nel 19 12, al momento del rinnovo della Triplice, firmato la convenzione militare‑navale con la Germania che entrava in vigore il 6 agosto 1914: mi pare che proprio in base a questa convenzione l’Emden e il Göschen poterono rifugiarsi nel porto di Messina: cfr in proposito le pubblicazioni di Rerum Scriptor nella «Rivista delle Nazioni Latine» e nell’«Unità» del 17‑18, che io riassunsi nel «Grido del Popolo»). Nelle sue memorie Salandra accenna alla morte «repentina» di Pollio (non scrive che fu suicidio): il famoso «Memorandum» di Cadorna, che Salandra dichiara di non aver conosciuto, deve rispecchiare le vedute dello Stato Maggiore sotto la gestione Pollio e in dipendenza della Convenzione del 1912; la dichiarazione di Salandra di non averlo conosciuto è estremamente importante e piena di significati sulla politica italiana e sulla reale situazione dell’elemento parlamentare nelgoverno.
Nello studio dei giornali come funzionanti da partito politico occorre tener conto di singoli individui e della loro attività. Mario Missiroli è uno di questi. Ma i due tipi più interessanti sono Pippo Naldi e Francesco Ciccotti. Naldi ha cominciato come giovane liberale borelliano — collaboratore di piccole riviste liberali — direttore del «Resto del Carlino» e del «Tempo»: è stato un agente importantissimo di Giolitti e di Nitti; legato ai fratelli Perrone e certamente ad altri grossi affaristi; durante la guerra la sua attività è delle più misteriose. L’attività di Ciccotti è delle più complesse e difficili, sebbene il suo valore personale sia mediocre. Durante la guerra ebbe atteggiamenti disparati: fu sempre un agente di Nitti o per qualche tempo anche di Giolitti? A Torino nel 16‑17 era assolutamente disfattista; egli invitava all’azione immediata. Se si può parlare di responsabilità individuali per i fatti dell’agosto 17, Ciccotti avrebbe dovuto ritenersi il più responsabile: invece fu appena interrogato dal giudice istruttore e non si procedette contro di lui. Ricordo la sua conferenza del 16 o del 17, dopo la quale furono arrestati un centinaio di giovani e adulti accusati di aver gridato «Evviva l’Austria! ». Non credo che il grido sia stato emesso da nessuno, ma dopo la conferenza di Ciccotti non sarebbe stato strano che qualcuno avesse anche emesso questo grido.
Ciccotti cominciò la sua conferenza dicendo che i socialisti erano responsabili di una grave colpa: aver affermato che la guerra era capitalistica. Secondo Ciccotti questo significava nobilitare la guerra. Egli allora, con una sottigliezza rimarchevole nell’abilità di suscitare i sentimenti popolari elementari, sviluppò un romanzo d’appendice a forti tinte che cominciava su per giù così: — la sera tale si riunirono al caffè Faraglino Vincenzo Morello (Rastignac), il senatore Artom e un terzo che non ricordo ecc. ecc.; la guerra era dovuta alla congiura di questi tre e ai denari di Barrère. — Ricordo d’aver visto alcuni operai che conoscevo come gente calmissima e temperata coi capelli rizzati in testa, frenetici, uscire dalla sala, dopo la perorazione, in uno stato di eccitazione incredibile.
Il giorno dopo la «Stampa» pubblicava un articolo non firmato, scritto da Ciccotti, in cui si sosteneva la necessità del blocco tra Giolitti e gli operai in tempo prima che l’apparecchio statale cadesse completamente nelle mani dei pugliesi di Salandra. Qualche giorno dopo la «Giustizia» di Reggio Emilia pubblicava il resoconto di una conferenza di Ciccotti a Reggio, dove aveva esaltato il prampolinismo ecc. Ricordo che mostrai questo giornale ad alcuni «rigidi» i quali erano infatuati di Ciccotti e volevano si sostenesse (certo per istigazione del Ciccotti stesso) una campagna per dare l’«Avanti! » a Ciccotti.
Nessuno ha studiato ancora a fondo i fatti di Torino dell’agosto 17. È certissimo che i fatti furono spontanei e dovuti alla mancanza di pane prolungata, che negli ultimi dieci giorni prima dei fatti, aveva determinato la mancanza assoluta di ogni cibo popolare (riso, polenta, patate, legumi ecc.). Ma la quistione è appunto questa: come spiegare questa assoluta deficienza di vettovaglie? (Assoluta: nella casa dove abitavo io si erano saltati tre pasti di fila, dopo un mese in cui i pasti saltati erano andati crescendo, ed era una casa del centro). Il prefetto Verdinois nell’autodifesa pubblicata nel 1925, non dà ragguagli sufficienti; il ministro Orlando richiamò solo amministrativamente il Verdinois e nel discorso alla Camera se la cavò male anch’egli; intanto non fu fatta nessuna inchiesta. Il Verdinois accusa gli operai, ma la sua accusa è una cosa inetta: egli dice che i fatti non avevano come causa la mancanza di pane perché continuarono anche quando fu dato in vendita il pane fatto con la farina dei depositi militari. La «Gazzetta del Popolo» però, già da 20 giorni, prevedeva gravi fatti per la mancanza di pane e avvertiva quotidianamente di provvedere a tempo: naturalmente cambiò tono dopo e parlò solo di denaro straniero. Come fu lasciato mancare il pane a una città, la cui provincia è scarsamente coltivata a grano e che era diventata una grande officina di guerra, con una popolazione accresciuta di più di 100 000 lavoratori per le munizioni?
Io ho avuto la convinzione che la mancanza di pane non fu casuale, ma dovuta al sabotaggio della burocrazia giolittiana, e in parte all’inettitudine di Canepa, che né aveva la capacità per il suo ufficio, né era in grado di padroneggiare la burocrazia dipendente dal suo commissariato. I giolittiani erano di un fanatismo tedescofilo incredibile: essi sapevano che Giolitti non poteva andare ancora al potere, ma volevano creare un anello intermedio, Nitti o Orlando, e rovesciare Boselli; il meccanismo funzionò tardi, quando Orlando era già al potere, ma il fatto era stato preparato per far cadere il governo Boselli su una pozza di sangue torinese.
Perché fu scelta Torino? Perché era quasi tutta neutralista, perché Torino aveva scioperato nel 15, ma specialmente perché i fatti avevano importanza specialmente a Torino. Ciccotti fu il principale agente di questo affare; egli andava troppo spesso a Torino e non sempre per far conferenze agli operai, ma anche per parlare con quei della «Stampa». Non credo che i giolittiani fossero in collegamento con la Germania: ciò non era indispensabile. Il loro livore era tale per i fatti di Roma del 15 e perché pensavano che l’egemonia piemontese sarebbe stata fortemente scossa o addirittura spezzata, che essi erano capaci di tutto: il processo di Portogruaro contro Frassati e l’affare del colonnello Gamba mostrano solo che questa gente aveva perduto ogni controllo. Bisogna aver visto la soddisfazione con cui i redattori della «Stampa», dopo Caporetto, parlavano del panico che regnava a Milano nei dirigenti e della decisione del «Corriere» di trasportar via tutto il suo impianto, per comprendere di che potevano essere capaci: indubbiamente i giolittiani avevano avuto paura di una dittatura militare che li mettesse al muro; essi parlavano di una congiura Cadorna‑Albertini per fare un colpo di Stato: la loro smania di giungere a un accordo coi socialisti era incredibile.
Ciccotti durante la guerra servì di tramite per pubblicare nell’«Avanti! » articoli del Controllo Democratico inglese (gli articoli li riceveva la signora Chiaraviglio). Ricordo il racconto di Serrati del suo incontro a Londra con una signora che lo voleva ringraziare a nome del Comitato e la meraviglia del povero uomo, che fra questi intrighi non sapeva che decisioni prendere. Altro aneddoto raccontato da Serrati: l’articolo di Ciccotti contro la Commerciale lasciato passare, l’articolo contro la Sconto censurato; il commento di Ciccotti a un discorso di Nitti prima censurato, poi permesso dopo telefonata di Ciccotti che si richiamava a (una) promessa di Nitti e non pubblicato da Serrati ecc. Ma l’episodio più interessante è quello dei gesuiti che attraverso Ciccotti cercavano di far cessare la campagna per i SS. Martiri: — cosa avranno dato in cambio i gesuiti a Ciccotti? Ma nonostantetutto Ciccotti non venne espulso, perché bisognava dargli l’indennità giornalistica. Un altro di questi tipi è stato Carlo Bazzi.
Q1 §117 Direzione politica e militare nel Risorgimento. La incertezza politica, le continue oscillazioni tra dispotismo e costituzionalismo ebbero i loro effetti anche sull’esercito piemontese. Si può dire che quanto più un esercito è numeroso, cioè quanto più profonde masse della popolazione vi sono incorporate, tanto più cresce l’importanza della direzione politica su quella meramente tecnica‑militare. La combattività dell’esercito piemontese era altissima al principio della campagna del 48: i destri credettero che questa combattività fosse espressione di un puro «spirito militare» astratto e si dettero ad intrigare per restringere le libertà popolari. Il morale dell’esercito decadde. La polemica sulla «fatal Novara» è tutta qui. A Novara l’esercito non volle combattere, perciò fu sconfitto. I destri accusarono i sinistri d’aver portato la politica nell’esercito, d’averlo disgregato. Ma in realtà l’esercito si accorge di un mutamento di direzione politica, senza bisogno dei disgregatori, da una molteplicità di piccoli fatti, che uno per uno sembrano trascurabili ma nell’insieme formano una nuova atmosfera asfissiante: quindi la causa non è che di chi ha mutato la direzione politica, senza prevederne le conseguenze militari, cioè ha sostituito una cattiva politica a una precedente buona, conforme al fine. Il problema è legato al concetto di opportuno e di conforme al fine: se gli uomini fossero macchine, il concetto di conforme al fine sarebbe semplice. Ma gli uomini non sono uno strumento materiale che si può usare nei limiti della sua coesione meccanica e fisica: nel «conforme al fine» occorre perciò includere sempre la distinzione «secondo lo strumento dato». Se con una mazza di legno si batte un chiodo con la stessa energia con cui si batterebbe con un martello d’acciaio, è il chiodo che penetra nel legno invece di conficcarsi nel muro. Con un esercito di mercenari professionisti, la direzione politica è minima (sebbene esista anche in questo caso in qualche modo): con un esercito nazionale di leva il problema muta; nelle guerre di posizione fatte da grandi masse che solo con grandi riserve di forze morali possono resistere al grande logorio muscolare, nervoso, psichico, solo con un’abilissima direzione politica, che tenga conto delle aspirazioni più profonde delle masse, si impedisce la disgregazione e lo sfacelo.
La direzione militare deve essere sempre subordinata alla direzione politica, ossia i comandi dell’esercito devono essere l’espressione militare di una determinata politica. Naturalmente può darsi il caso che gli uomini politici non valgano nulla, mentre nell’esercito ci siano dei capi che alla capacità militare congiungono la capacità politica. Questo è il caso di Cesare e di Napoleone; ma in Napoleone s’è visto come il mutamento di politica, coordinato alla presunzione di avere uno strumento militare astrattamente militare, abbia portato alla sua rovina: cioè anche in questi esempi di direzione politica e militare unite in una stessa persona, la politica era superiore alla direzione militare. I libri di Cesare, ma specialmente il De bello civili, sono un classico esempio di esposizione di una sapiente combinazione di politica e arte militare: i soldati vedevano in Cesare non solo un grande capo militare, ma anche un grande capo politico.
Ricordare che Bismarck sosteneva la supremazia del politico sul militare, mentre Guglielmo II, secondo quanto riferisce Ludwig, annotò rabbiosamente un giornale in cui o l’opinione di Bismarck era riportata o si esprimeva un’opinione simile. Così i tedeschi vinsero brillantemente quasi tutte le battaglie, ma perdettero la guerra.
Q1 §118 Il problema dei volontari nel Risorgimento. C’è una tendenza a supervalutare l’apporto delle classi popolari al Risorgimento, insistendo specialmente sul fenomeno del volontariato (vedi articolo del Rota nella «Nuova Rivista Storica» per es.). A parte il fatto che da questi articoli appare che i volontari erano mal visti dalle autorità piemontesi, ciò che appunto conferma la cattiva direzione politico‑militare, è in ogni modo da osservare che c’è supervalutazione. Ma questo problema del volontariato pone più in luce la deficienza della direzione politico‑militare. Il governo piemontese poteva arruolare obbligatoriamente soldati nel suo territorio statale, in rapporto alla sua popolazione, come l’Austria poteva farlo nel suo territorio e in rapporto alla sua popolazione enormemente più grandi: una guerra a fondo in questi termini, sarebbe sempre stata disastrosa per il Piemonte dopo un certo tempo. Posto il principio che l’«Italia fa da sé» bisognava o accettare la Confederazione tra eguali con gli altri Stati italiani, o proporsi l’unità politica territoriale su una tale base politica popolare che le masse fossero insorte contro gli altri governi e avessero costituito eserciti volontari che fossero accorsi accanto ai piemontesi. Ma appunto qui è la quistione: che non si può pretendere entusiasmo, spirito di sacrifizio ecc. su un programma astratto e per fiducia generica in un governo lontano. Questo è stato il dramma del 48, ma non si può inveire contro il popolo: la responsabilità è dei moderati e forse più ancora del Partito d’Azione, cioè in fondo della scarsissima efficienza della classe dirigente.
Q1 §119 La demagogia. Le osservazioni fatte sulla deficienza di direzione politico‑militare nel Risorgimento potrebbero essere ribattute con un argomento molto comune e molto frusto: «quegli uomini non furono demagoghi, non fecero della demagogia». Bisogna intendersi sulla parola e sul concetto di demagogia. Quegli uomini effettivamente non seppero guidare il popolo, non seppero destarne l’entusiasmo e la passione, se si intende demagogia nel suo significato primordiale. Ma essi raggiunsero il fine che si proponevano? Bisogna vedere: essi si proponevano di creare lo Stato moderno in Italia e non ci riuscirono, si proponevano di creare una classe dirigente diffusa ed energica e non ci riuscirono, di avvicinare il popolo allo Stato e non ci riuscirono. La meschina vita politica dal 70 al 900, il ribellismo elementare ed endemico delle classi popolari, la creazione stentata e meschina di un ceto dirigente scettico e poltrone sono la conseguenza di quella deficienza. In realtà poi gli uomini del Risorgimento furono dei grandissimi demagoghi: essi fecero del popolo‑nazione uno strumento, degradandolo, e in ciò consiste la massima demagogia, nel senso peggiorativo che la parola ha assunto in bocca dei partiti di destra, in polemica coi partiti di sinistra, sebbene siano i partiti di destra ad aver sempre esercitato la peggiore demagogia.
Q1 § 120. «Credetemi, non abbiate paura né dei bricconi né dei malvagi. Abbiate paura dell’onesto uomo che s’inganna; egli è in buona fede verso se stesso, crede il bene e tutti si fidano di lui; ma, sfortunatamente, s’inganna circa i mezzi di procurare il bene agli uomini». Questo spunto dell’abate Galiani era rivolto contro i «filosofi» del 700, contro i giacobini futuri, ma si attaglia a tutti i cattivi politici così detti in buona fede.
Q1 §121 Novara 1849. Nel febbraio 1849 Silvio Spaventa visitò a Pisa il D’Azeglio e di questo colloquio fa ricordo in uno scritto politico composto nell’ergastolo nel 1856: «Un uomo di Stato piemontese dei più illustri diceva a me un mese innanzi: noi non possiamo vincere, ma combatteremo di nuovo: la nostra sconfitta sarà la sconfitta di quel partito che oggi ci risospinge alla guerra; e tra una sconfitta e una guerra civile noi scegliamo la prima: essa ci darà la pace interna e la libertà e l’indipendenza del Piemonte, che non può darci l’altra. Le previsioni di quel saggio (!) uomo si avverarono. La battaglia di Novara fu perduta per la causa dell’indipendenza e guadagnata per la libertà del Piemonte. E Carlo Alberto fece, secondo me, il sacrifizio della sua corona più a questa che a quella». (Cfr Silvio Spaventa, Dal 1848 al 1861. Lettere, scritti, documenti, pubblicati da B. Croce, 2a ed., p. 58 nota).
Q1 §122 Spunti e stimoli. Il Macaulay attribuisce la facilità di farsi abbagliare da sofismi quasi puerili propria dei Greci anche più colti alla gran predominanza del discorso vivo e parlato nell’educazione e vita greca. L’abitudine della conversazione genera una certa facoltà di trovare con gran prontezza argomenti di qualche apparenza che chiudono momentaneamente la bocca all’avversario. Questa osservazione si può farla anche per alcune classi della vita moderna, come constatazioni di una debolezza (operai) e di causa di diffidenza (contadini, i quali rimuginando ciò che hanno sentito declamare e che li ha colpiti momentaneamente per il luccicare e trovandone le deficienze e la superficialità, finiscono con l’essere diffidenti per sistema).
Riferisce il Macaulay una sentenza di Eugenio di Savoia, il quale diceva che più grandi generali erano riusciti quegli che erano stati messi d’un tratto alla testa dell’esercito e nella necessità del pensare alle manovre grandi e complessive (chi è troppo minuzioso per professione, si burocratizza: vede l’albero e non più la foresta, il regolamento e non più la strategia). A proposito della prima osservazione si può aggiungere: che il giornale si avvicina molto alla conversazione, gli articoli di giornale sono in generale affrettati, improvvisati, simili in grandissima parte, per la rapidità dell’ideazione, ai discorsi da riunione. Sono pochi i giornali che hanno redattori specializzati e anche l’attività di questi è in gran parte improvvisata: la specializzazione serve di solito per improvvisare meglio e più rapidamente. Mancano nei giornali italiani le rassegne periodiche più ponderate e studiate (teatro, per esempio, politica economica ecc.; i collaboratori suppliscono solo in parte e poi non sempre sono di uno stesso indirizzo). Perciò la solidità di cultura può essere misurata in tre gradi: 1°, lettori di soli giornali; 2°, lettori di riviste; 3°, lettori di libri; senza tener conto di una grande moltitudine che non legge neanche i giornali e si forma le convinzioni attraverso la pura conversazione sporadica con individui del suo stesso livello generale che però leggono i giornali, e di quella che si forma le convinzioni assistendo a riunioni periodiche e nei periodi elettorali tenute da oratori di livelli diversissimi. Questa svogliatezza mi ha colpito specialmente a Milano, dove in carcere era permesso il «Sole»; tuttavia un certo numero, anche di politici, leggeva piuttosto la «Gazzetta dello Sport»; tra 2500 inquisiti, si vendevano al massimo 80 copie del «Sole»; più letti la «Gazzetta dello Sport», la «Domenica del Corriere», il «Corriere dei Piccoli».
Q1 §123 Cercare l’origine storica esatta di alcuni principi della pedagogia moderna: la scuola attiva ossia la collaborazione amichevole tra maestro e alunno; la scuola all’aperto; la necessità di lasciar libero, sotto il vigile ma non appariscente controllo del maestro, lo sviluppo delle facoltà spontanee dello scolaro.
La Svizzera ha dato un grande contributo alla pedagogia moderna (Pestalozzi ecc.), per la tradizione ginevrina di Rousseau; in realtà questa pedagogia è una forma confusa di filosofia connessa a una serie di regole empiriche. Non si è tenuto conto che le idee di Rousseau sono una reazione violenta alla scuola e ai metodi pedagogici dei gesuiti e in quanto tale rappresentano un progresso: ma si è poi formata una specie di chiesa che ha paralizzato gli studi pedagogici e ha dato luogo a delle curiose involuzioni (nelle dottrine di Gentile e del Lombardo‑Radice). La «spontaneità» è una di queste involuzioni: si immagina quasi che nel bambino il cervello sia come un gomitolo che il maestro aiuta a sgomitolare. In realtà ogni generazione educa la nuova generazione, cioè la forma, e l’educazione è una lotta contro gli istinti legati alle funzioni biologiche elementari, una lotta contro la natura, per dominarla e creare l’uomo «attuale» alla sua epoca. Non si tiene conto che il bambino da quando incomincia a «vedere e a toccare», forse da pochi giorni dopo la nascita, accumula sensazioni e immagini, che si moltiplicano e diventano complesse con l’apprendimento del linguaggio. La «spontaneità» se analizzata diventa sempre più problematica. Inoltre la «scuola», cioè l’attività educativa diretta, è solo una frazione della vita dell’alunno, che entra in contatto sia con la società umana sia con la societas rerum e si forma criteri da queste fonti «extrascolastiche» molto più importanti di quanto comunemente si creda. La scuola unica, intellettuale e manuale, ha anche questo vantaggio, che pone contemporaneamente il bambino a contatto con la storia umana e con la storia delle «cose» sotto il controllo del maestro.
Q1 §124 I futuristi. Un gruppo di scolaretti che sono scappati da un collegio di gesuiti, hanno fatto un po’ di baccano nel bosco vicino e sono stati ricondotti sotto la ferula dalla guardia campestre.
Q1 §125 1919. Articoli della «Stampa» contro i tecnici d’officina e clamorose pubblicazioni degli stipendi più alti. Bisognerebbe vedere se a Genova, la stampa degli armatori, fece la stessa campagna contro gli stati maggiori quando essi entrarono in agitazione e furono aiutati dagli equipaggi.
Q1 §126 1922. Articoli del senatore Raffaele Garofalo, alto magistrato di Cassazione, sull’«Epoca» di Roma a proposito della dipendenza della magistratura dal potere esecutivo e della giustizia amministrata con le circolari. Ma è specialmente interessante l’ordine di ragioni con cui il Garofalo sosteneva la necessità immediata di rendere indipendente la magistratura.
Q1 §127 La quistione dei giovani. Esistono molte «quistioni» dei giovani. Due mi sembrano specialmente importanti: 1°) La generazione «anziana» compie sempre l’educazione dei «giovani»; ci sarà conflitto, discordia ecc. ma si tratta di fenomeni superficiali, inerenti a ogni opera educativa e di raffrenamento, almeno che non si tratti di interferenze di classe, cioè i «giovani» (o una parte cospicua di essi) della classe dirigente (intesa nel senso più largo, non solo economico, ma politico‑morale) si ribellano e passano alla classe progressiva che è diventata storicamente capace di prendere il potere: ma in questo caso si tratta di «giovani» che dalla direzione degli «anziani» di una classe passano alla direzione degli «anziani» di un’altra classe: in ogni caso rimane la subordinazione reale dei «giovani» agli «anziani» come generazione, pur con le differenze di temperamento e di vivacità su ricordate; 2°) Quando il fenomeno assume un carattere cosidetto «nazionale», cioè non appare apertamente l’interferenza di classe, allora la quistione si complica e diventa caotica. I «giovani» sono in istato di ribellione permanente, perché persistono le cause profonde di essa, senza che ne sia permessa l’analisi, la critica e il superamento (non concettuale e astratto, ma storico e reale); gli «anziani» dominano di fatto, ma... «après moi le déluge», non riescono a educare i giovani, a prepararli alla successione. Perché? Ciò significa che esistono tutte le condizioni perché gli «anziani» di un’altra classe debbano dirigere questi giovani, senza che possano farlo per ragioni estrinseche di compressione politico‑militare. La lotta, di cui si sono soffocate le espressioni esterne normali, si attacca come una cancrena dissolvente alla struttura della vecchia classe, debilitandola e imputridendola: assume forme morbose, di misticismo, di sensualismo, di indifferenza morale, di degenerazioni patologiche psichiche e fisiche ecc. La vecchia struttura non contiene e non riesce a dare soddisfazione alle esigenze nuove: la disoccupazione permanente o semipermanente dei così detti intellettuali è uno dei fenomeni tipici di questa insufficienza, che assume carattere aspro per i più giovani, in quanto non lascia «orizzonti aperti». D’altronde questa situazione porta ai «quadri chiusi» di carattere feudale‑militare, cioè inacerbisce essa stessa i problemi che non sa risolvere.
Q1 §128 Religione come principio e clero come classe-ordine feudale. Quando si esalta la funzione che la chiesa ha avuto nel medio evo a favore delle classi inferiori, si dimentica semplicemente una cosa: che tale funzione non era legata alla chiesa come esponente di un principio religioso-morale, ma alla chiesa come organizzazione di interessi economici molto concreti, che doveva lottare contro altri ordini che avrebbero voluto diminuire la sua importanza. Questa funzione fu dunque subordinata e incidentale: ma il contadino non era meno taglieggiato dalla chiesa che dai signori feudali. Si può forse dire questo: che la «chiesa» come comunità dei fedeli conservò e sviluppò determinati principi politico‑morali in opposizione alla chiesa come organizzazione clericale, fino alla Rivoluzione francese i cui principii sono propri della comunità dei fedeli contro il clero ordine feudale alleato al re e ai nobili: perciò molti cattolici considerano la Rivoluzione francese come uno scisma e un’eresia, cioè una rottura tra pastore e gregge, dello stesso tipo della Riforma, ma storicamente più matura, perché avvenuta sul terreno del laicismo: non preti contro preti, ma fedeli‑infedeli contro preti. Il vero punto di rottura tra democrazia e Chiesa è da porre però nella Controriforma, quando la Chiesa ebbe bisogno del braccio secolare (in grande stile) contro i luterani e abdicò alla sua funzione democraticaAggiunto in epoca posteriore..
Q1 §129 Il più diffuso luogo comune a proposito del Risorgimento è quello di ripetere in vari modi che tale rivolgimento storico si poté operare per merito delle sole classi colte. Dove sia il merito è difficile capire. Merito di una classe colta perché sua funzione storica è quella di dirigere le masse popolari: se la classe colta non è riuscita a compiere la sua funzione, non deve certo parlarsi di merito ma di demerito, cioè di immaturità e debolezza intima.
Q1 §130 Italia reale e Italia legale. La formula escogitata dai clericali dopo il 70 per indicare il disagio politico nazionale: contraddizione tra Italia legale e Italia reale. A Torino uscì fino a qualche anno avanti la guerra un quotidiano (poi settimanale) «L’Italia reale», diretto dall’avv. Scala e organo del più nero clericalismo. Come sorse la formula, da chi fu escogitata e quale giustificazione teorico‑politico‑morale ne fu data? Occorre farne la ricerca («Civiltà Cattolica», primi numeri della stessa «Italia reale» di Torino ecc.). Essa in generale è felice, perché esisteva un distacco netto tra lo Stato (legalità) e la società civile (realtà), ma questa società civile era tutta e solamente nel «clericalismo»? Intanto questa stessa società civile era qualcosa di informe e caotico e tale rimase per molti decenni; quindi fu possibile allo Stato dominarla, superando volta a volta le contraddizioni che si presentavano in forma sporadica, localistica, senza nesso nazionale. Il clericalismo non era dunque neanche esso l’espressione di questa società civile, perché non riuscì ad organizzarla nazionalmente, quantunque esso fosse una forte e compatta (formalmente) organizzazione nazionale. Intanto questa organizzazione non era politicamente omogenea ed aveva paura delle stesse masse che dominava in un certo senso. La formula del «non expedit» fu la espressione di questa paura ed incertezza; il boicottaggio parlamentare, che si presentava come un atteggiamento aspramente intransigente, era in realtà espressione del più piatto opportunismo. L’esperienza politica, specialmente francese, aveva dimostrato che il suffragio universale e il plebiscito a base larghissima poteva essere un apparato favorevolissimo alle tendenze reazionarie clericali (vedi a questo proposito le ingenue osservazioni di Jacques Bainville nella sua Storia della Francia che implicitamente rimprovera al legittimismo di non avere avuto fiducia nel suffragio universale, come invece aveva fatto Napoleone III); ma il clericalismo sentiva di non essere l’espressione reale della «società civile» italiana e che un successo sarebbe stato effimero e avrebbe determinato l’attacco frontale delle forze nuove evitato nel 1870. Esperienza del suffragio allargato nel 1882 e reazione crispina. Tuttavia l’atteggiamento clericale di mantenere statico il dissidio tra Stato e società civile era obbiettivamente «sovversivo» e una nuova organizzazione espressa dalle forze maturanti in questa società poteva giovarsene come campo di manovra per attaccare lo Stato; perciò la reazione statale nel 98 abbatté insieme e socialismo e clericalismo, giudicandoli giustamente ugualmente «sovversivi» e obbiettivamente alleati. Di ciò si accorse anche il Vaticano, e quindi da questo momento comincia la sua nuova politica, l’abbandono reale del «non expedit» anche nel campo parlamentare (il comune era tradizionalmente considerato società civile e non Stato). Ciò permette l’introduzione del suffragio universale, il patto Gentiloni e quindi la fondazione del Partito Popolare nel 1919. La quistione permane (di Italia reale e legale) ma su un piano più elevato politico e storico, e perciò episodi del 24‑26 fino a soppressione di tutti i partiti, con l’affermazione di una raggiunta identità tra reale e legale, perché la «società civile» in tutte le sue forme dominata da una sola organizzazione statale — di partito.
Q1 §131 Bainville e il suffragio universale in Francia. L’affermazione di Bainville sul suffragio universale che poteva (e potrebbe servire) anche al legittimismo come servì a Napoleone III, è ingenua, perché basata su un ingenuo e astrattamente scemo sociologismo. Il suffragio universale è considerato come uno schema sociologico, astratto dal tempo e dallo spazio. Nella realtà della storia francese ci sono stati diversi «suffragi universali» secondo che mutarono storicamente i rapporti economico‑politici. Le crisi del «suffragio universale» in Francia sono determinate dai rapporti tra Parigi e la provincia. Parigi vuole il suffragio universale nel 48, ma esso esprime un Parlamento reazionario‑clericale che permette a Napoleone III di fare la sua carriera. Nel 71 Parigi ha fatto un gran passo in avanti perché si ribella all’Assemblea nazionale formata dal suffragio universale, cioè implicitamente Parigi «capisce» che tra progresso e suffragio universale «può» esserci conflitto, ma questa esperienza storica, di valore inestimabile, è perduta immediatamente, perché i portatori di essa vengono fisicamente soppressi: non c’è sviluppo normale quindi. Il suffragio universale e la democrazia coincidono sempre più con l’affermarsi del partito radicale francese e la lotta anticlericale: Parigi perde la sua unità rivoluzionaria (il sindacalismo è l’espressione di questo stato di cose: l’astensionismo elettorale e l’economismo puro sono l’apparenza «intransigente» di questa abdicazione di Parigi al suo ruolo di testa rivoluzionaria della Francia, sono cioè anch’essi piatto opportunismo, il postumo del salasso del 1871) e la sua «democrazia» rivoluzionaria si scinde in classi: piccolo borghesi radicali e operai di fabbrica formalmente intransigenti, in realtà legati al radicalismo‑socialismo che unifica su un piano intermedio città e campagna. Dopo la guerra riprende lo sviluppo, ma esso è ancora incerto.
Q1 §132 L’idealismo attuale e il nesso ideologia‑filosofia. L’idealismo attuale fa coincidere ideologia e filosofia (ciò significa in ultima analisi l’unità da esso postulata fra reale e ideale, tra pratica e teoria ecc.), cioè è una degradazione della filosofia tradizionale rispetto all’altezza cui l’aveva portata il Croce con le sue «distinzioni». Questa degradazione è visibilissima negli sviluppi che l’idealismo attuale mostra nei discepoli del Gentile: i «Nuovi Studi» diretti da Ugo Spirito e A. Volpicelli sono il documento più vistoso che io conosca di questo fenomeno. L’unità di ideologia e filosofia, quando avviene in questo modo riporta a una nuova forma di sociologismo, né storia né filosofia cioè, ma un insieme di schemi astratti sorretti da una fraseologia tediosa e pappagallesca. La resistenza del Croce a questa tendenza è veramente «eroica»: il Croce, secondo me, ha viva la coscienza che tutti i movimenti di pensiero moderni portano a una rivalutazione trionfale del materialismo storico, cioè al capovolgimento della posizione tradizionale del problema filosofico e alla morte della filosofia intesa nel modo tradizionale. Egli resiste con tutte le sue forze a questa pressione della realtà storica, con una intelligenza eccezionale dei pericoli e dei mezzi dialettici di ovviarli. Perciò lo studio dei suoi scritti dal 19 ad oggi è del maggior valore: la preoccupazione del Croce nasce con la guerra mondiale e con la sua affermazione che essa è la «guerra del materialismo storico». La sua posizione «au dessus», in un certo senso, è già indice di tale preoccupazione ed è un allarme (nella guerra «ideologia e filosofia» entrarono in frenetico connubio). Anche certi suoi atteggiamenti recentissimi (verso il libro del De Man, libro Zibordi ecc.) non possono spiegarsi altrimenti perché molto in contraddizione con sue posizioni «ideologiche» (pratiche) di prima della guerra.
Q1 §133 Arte militare e arte politica. Ancora degli arditi. I rapporti che esistettero nel 17‑18 tra le formazioni di arditi e l’esercito nel suo complesso possono portare ed hanno portato già i dirigenti politici ad erronee impostazioni di piani di lotta. Si dimentica: 1°) che gli arditi sono semplici formazioni tattiche e presuppongono sì un esercito poco efficiente, ma non completamente inerte: perché se la disciplina e lo spirito militare si sono allentati fino a consigliare una nuova disposizione tattica, essi esistono ancora in una certa misura, cui appunto corrisponde la nuova formazione tattica; altrimenti ci sarebbe stata, senz’altro, la disfatta e la fuga; 2°) che non bisogna considerare l’arditismo come un segno della combattività generale della massa militare, ma viceversa, come un segno della sua passività e della sua relativa demoralizzazione.
Ciò sia detto mantenendo implicito il criterio generale che i paragoni tra l’arte militare e la politica sono sempre da stabilire cum grano salis, cioè solo come stimoli al pensiero e come termini semplificativi ad absurdum: infatti nella milizia politica manca la sanzione penale implacabile per chi sbaglia o non obbedisce esattamente, manca il giudizio marziale, oltre al fatto che lo schieramento politico non è neanche lontanamente paragonabile allo schieramento militare. Nella lotta politica oltre alla guerra di movimento e alla guerra d’assedio o di posizione, esistono altre forme. Il vero arditismo, cioè l’arditismo moderno, è proprio della guerra di posizione, così come si è rivelata nel 14‑18. Anche la guerra di movimento e la guerra d’assedio dei periodi precedenti avevano i loro arditi, in un certo senso: la cavalleria leggera e pesante, i bersaglieri ecc., le armi celeri in generale avevano in parte una funzione di arditi; così nell’arte di organizzare le pattuglie era contenuto il germe dell’arditismo moderno. Nella guerra d’assedio più che nella guerra di movimento era contenuto questo germe: servizio di pattuglie più estese e specialmente arte di organizzare sortite improvvise e improvvisi assalti con elementi scelti.
Un altro elemento da tener presente è questo: che nella lotta politica non bisogna scimiottare i metodi di lotta delle classi dominanti, senza cadere in facili imboscate. Nelle lotte attuali questo fenomeno si verifica spesso: una organizzazione statale indebolita è come un esercito infiacchito: entrano in campo gli arditi, cioè le organizzazioni armate private, che hanno due compiti: usare l’illegalità, mentre lo Stato sembra rimanere nella legalità, come mezzo di riorganizzare lo Stato stesso. Credere che alla attività privata illegale si possa contrapporre un’altra attività simile, cioè combattere l’arditismo con l’arditismo è una cosa sciocca; vuol dire credere che lo Stato rimanga eternamente inerte, ciò che non avviene mai, a parte le altre condizioni diverse. Il carattere di classe porta a una differenza fondamentale: una classe che deve lavorare ogni giorno a orario fisso non può avere organizzazioni d’assalto permanenti e specializzate, come una classe che ha ampie disponibilità finanziarie e non è legata, in tutti i suoi membri, a un lavoro fisso. In qualsiasi ora del giorno e della notte, queste organizzazioni, divenute professionali, possono vibrare colpi decisivi e cogliere alla sprovvista. La tattica degli arditi non può avere dunque per certe classi la stessa importanza che per altre; a certe classi è necessaria, perché propria, la guerra di movimento e di manovra, che nel caso della lotta politica, può combinare un utile e forse indispensabile uso della tattica da arditi. Ma fissarsi nel modello militare è da sciocchi: la politica deve, anche qui, essere superiore alla parte militare e solo la politica crea la possibilità della manovra e del movimento.
Da tutto ciò che si è detto risulta che nel fenomeno dell’arditismo militare, occorre distinguere tra funzione tecnica di arma speciale legata alla moderna guerra di posizione e funzione politico‑militare: come funzione di arma speciale l’arditismo si è avuto in tutti gli eserciti della guerra mondiale; come funzione politico‑militare si è avuta nei paesi politicamente non omogenei e indeboliti, quindi aventi come espressione un esercito nazionale poco combattivo e uno stato maggiore burocratizzato e fossilizzato nella carriera.
Q1 §134 Lotta politica e guerra militare. Nella guerra militare, raggiunto il fine strategico, distruzione dell’esercito nemico e occupazione del suo territorio, si ha la pace. È inoltre da osservare che perché la guerra finisca, basta che il fine strategico sia raggiunto solo potenzialmente: basta cioè che non ci sia dubbio che un esercito non può più combattere e che l’esercito vittorioso «può» occupare il territorio nemico. La lotta politica è enormemente più complessa: in un certo senso può essere paragonata alle guerre coloniali o alle vecchie guerre di conquista, quando cioè l’esercito vittorioso occupa o si propone di occupare stabilmente tutto o una parte del territorio conquistato. Allora l’esercito vinto viene disarmato e disperso, ma la lotta continua nel terreno politico e di «preparazione» » militare. Così la lotta politica dell’India contro gli Inglesi (e in una certa misura della Germania contro la Francia o dell’Ungheria contro la Piccola Intesa) conosce tre forme di guerre: di movimento, di posizione e sotterranea. La resistenza passiva di Gandhi è una guerra di posizione, che diventa guerra di movimento in certi momenti e in altri guerra sotterranea: il boicottaggio è guerra di posizione, gli scioperi sono guerra di movimento, la preparazione clandestina di armi e di elementi combattivi d’assalto è guerra sotterranea. C’è una forma di arditismo, ma essa è impiegata con molta ponderazione. Se gli Inglesi avessero la convinzione che si prepara un grande movimento insurrezionale destinato ad annientare l’attuale loro superiorità strategica (che consiste in un certo senso nella loro possibilità di manovrare per linee interne e di concentrare le loro forze nel punto «sporadicamente» più pericoloso) col soffocamento di massa, cioè costringendoli a diluire le forze in un teatro bellico divenuto simultaneamente generale, ad essi converrebbe provocare l’uscita prematura delle forze combattenti indiane per identificarle e decapitare il movimento generale. Così alla Francia converrebbe che la destra nazionalista tedesca fosse coinvolta in un colpo di stato avventuroso, che costringerebbe l’organizzazione militare illegale sospettata a manifestarsi prematuramente, permettendo un intervento, tempestivo dal punto di vista francese. Ecco che in queste forme di lotta miste, a carattere militare fondamentale e a carattere politico preponderante (ma ogni lotta politica ha sempre un sostrato militare), l’impiego degli arditi domanda uno sviluppo tattico originale, alla concezione del quale l’esperienza di guerra può dare solo uno stimolo, non un modello.
Una trattazione a parte deve avere la quistione dei «comitagi» balcanici, che sono legati a particolari condizioni dell’ambiente fisico‑geografico regionale, alla formazione delle classi rurali e anche all’efficienza reale dei governi. Così è delle bande irlandesi, la cui forma di guerra e di organizzazione era legata alla struttura sociale irlandese. I cornitagi, gli irlandesi, e le altre forme di guerra da partigiani devono essere staccate dalla quistione dell’arditismo, sebbene paiano avere con esso punti di contatto. Queste forme di lotta sono proprie di minoranze deboli ma esasperate contro maggioranze bene organizzate: mentre l’arditismo moderno presuppone una grande riserva, immobilizzata per varie ragioni, ma potenzialmente efficiente, che lo sostiene e lo alimenta con apporti individuali.
Q1 §135 Americanismo. L’articolo di Carlo Pagni A proposito di un tentativo di teoria pura del corporativismo («Riforma Sociale», settembre‑ottobre 1929) esamina il volume di N. Massimo Fovel Economia e corporativismo (Ferrara, S.A.T.E., 1929) e accenna a un altro scritto dello stesso Rendita e salario nello Stato Sindacale (Roma, 1928), ma non si accorge che il Fovel in questi scritti fa del «corporativismo» la premessa all’introduzione in Italia dei sistemi industriali americani. Sarebbe interessante sapere se il Fovel scrive «estraendo dal suo cervello» o ha dietro di sé (praticamente, non solo teoricamente) delle forze economiche che lo sorreggono e lo spingono. La figura del Fovel è interessante per più rispetti; in un certo senso rientra nella galleria del tipo Ciccotti‑Naldi‑Bazzi‑Preziosi ecc., ma è più complessa.
Il Fovel, che io sappia, ha cominciato come «radicale», prima della guerra: egli voleva ringiovanire il movimento radicale tradizionale, civettando un po’ coi repubblicani specialmente federalisti o regionalisti («Critica Politica» di Oliviero Zuccarini). Durante la guerra doveva essere giolittiano. Nel 1919 entra nel P.S. a Bologna, ma non scrive mai nell’«Avanti! ». Nel 19 (o nel 18 ancora?) lo conobbi a Torino molto di sfuggita. Gli industriali torinesi avevano acquistato la vecchia e malfamata «Gazzetta di Torino» per farne un loro organo. Ebbi l’impressione che il Fovel aspirasse a diventare il direttore della nuova combinazione; certo egli era in contatto con gli ambienti industriali. Invece direttore fu chiamato Tomaso Borelli, giovane liberale, al quale successe Italo Minunni dell’«Idea Nazionale» (la «Gazzetta di Torino» diventò il «Paese», ma non attecchì e fu soppressa). Nel 19 il Fovel mi scrisse una lettera curiosa, in cui diceva che «sentiva il dovere» di collaborare all’«Ordine Nuovo» settimanale; gli risposi fissando i limiti della sua possibile collaborazione, molto freddamente e seccamente e non ne ebbi più notizia.
Il Fovel passò alla banda Passigli‑Gardenghi‑Martelli, che aveva fatto dei «Lavoratore» di Trieste un centro d’affari assai lucroso e che doveva avere dei contatti con l’ambiente industriale torinese. È notevole a questo proposito il tentativo di Passigli di trasportarmi a Trieste, come redattore del «Lavoratore», la cui amministrazione avrebbe gestito anche l’O.N. conservandone io la direzione (Passigli venne a Torino per parlarmi e sottoscrisse 100 lire per l’O.N.): io rifiutai e non volli neanche essere collaboratore del «Lavoratore». Nel 21 negli uffici del «Lavoratore» furono trovate delle carte appartenenti a Fovel e a Gardenghi, da cui appariva che essi giocavano in borsa sui valori tessili e, durante lo sciopero dei tessili veneti guidato dai sindacalisti di Nicola Vecchi, dirigevano il giornale secondo gli interessi del loro gioco. Dopo Livorno non so cosa abbia fatto il Fovel. Nel 25 salta fuori ancora nell’«Avanti! » di Nenni e Gardenghi e imposta la campagna per i prestiti americani, subito sfruttata dalla «Gazzetta del Popolo» legata all’ing. Ponti della S.I.P. Nel 25‑26 il Fovel collaborò spesso alla «Voce Repubblicana». Oggi sostiene il «corporativismo» come premessa all’americanizzazione e scrive nel «Corriere Padano» di Ferrara.
Ciò che mi pare interessante nella tesi del Fovel è la sua concezione della corporazione come di un blocco industriale‑produttivo autonomo, destinato a risolvere in senso moderno il problema dell’apparato economico in senso accentuatamente capitalistico, contro gli elementi parassitari della società che prelevano una troppo grossa taglia sul plusvalore, contro i così detti «produttori di risparmio». La produzione del risparmio dovrebbe dunque essere funzione dello stesso blocco produttivo, attraverso un accrescimento della produzione a costo decrescente, attraverso la creazione di una più grande massa di plusvalore, che permetta più alti salari e quindi un più capace mercato interno e un risparmio operaio e più alti profitti e quindi una maggiore capitalizzazione diretta nel seno stesso delle aziende e non atraverso l’intermediario dei «produttori di risparmio» che in realtà sono divoratori di plusvalore. Il Pagni ha ragione quando dice che non si tratta di una nuova economia politica ma di una nuova politica economica; le sue obbiezioni pertanto, concretamente, non sono altro che la constatazione dell’ambiente arretrato italiano per un simile rivolgimento economico.
L’errore del Fovel consiste nel non tener conto della funzione economica dello Stato in Italia e del fatto che il regime corporativo ha avuto origini di polizia economica, non di rivoluzione economica. Gli operai italiani non si sono mai opposti neppure passivamente alle innovazioni industriali tendenti a una diminuzione dei costi, alla razionalizzazione del lavoro, all’introduzione di meccanismi più perfetti e di più perfette organizzazioni del complesso aziendale; tutt’altro. Ciò è avvenuto in America e ha portato alla liquidazione dei sindacati liberi e alla loro sostituzione con un sistema di isolate (fra loro) organizzazioni di azienda. Un’analisi accurata della storia italiana prima del 22, che non si lasciasse allucinare dal carnevale esterno, ma sapesse cogliere i motivi profondi del movimento, dovrebbe giungere alla conclusione che proprio gli operai furono i portatori delle nuove esigenze industriali e a modo loro le affermarono strenuamente: si può dire anche che alcuni industriali si accorsero di ciò e cercarono di servirsene (tentativi di Agnelli di assorbire nel complesso Fiat l’O.N. e la sua scuola).
Ma a parte queste considerazioni, si presenta la quistione: ormai le corporazioni esistono, esse creano le condizioni in cui le innovazioni industriali possono essere introdotte su larga scala, perché gli operai né possono opporsi a ciò, né possono lottare per essere essi stessi i portatori di questo rivolgimento. La quistione è essenziale, è l’hic Rhodus della situazione italiana: dunque le corporazioni diventeranno la forma di questo rivolgimento per una di quelle «astuzie della provvidenza» che fa sì che gli uomini senza volerlo ubbidiscano agli imperativi della storia. Il punto essenziale è qui: può ciò avvenire? Si è portati necessariamente a negarlo. La condizione suddetta è una delle condizioni, non la sola condizione e neanche la più importante; è solo la più importante delle condizioni immediate.
L’americanizzazione richiede un ambiente dato, una data conformazione sociale e un certo tipo di Stato. Lo Stato è lo Stato liberale, non nel senso del liberalismo doganale, ma nel senso più essenziale della libera iniziativa e dell’individualismo economico, giunto con mezzi spontanei, per lo stesso sviluppo storico, al regime dei monopoli. La sparizione dei redditieri in Italia è una condizione del rivolgimento industriale, non una conseguenza: la politica econornico‑finanziaria dello Stato è la molla di questa sparizione: ammortamento del debito pubblico, nominatività dei titoli, tassazione diretta e non indiretta. Non pare che questa sia la direzione attuale della politica o stia per diventarlo. Anzi. Lo Stato va aumentando i redditicri e creando dei quadri chiusi sociali. In realtà finora il regime corporativo ha funzionato per sostenere posizioni pericolanti di classi medie, non per eliminare queste e sta diventando, per gli interessi costituiti che crea, una macchina di conservazione dell’esistente così com’è e non una molla di propulsione. Perché? Perché il regime corporativo è in dipendenza della disoccupazione e non dell’occupazione: difende agli occupati un certo minimo di vita, che se fosse libera la concorrenza crollerebbe anch’esso, provocando gravi rivolgimenti sociali. Benissimo: ma il regime corporativo, nato in dipendenza di questa situazione delicatissima, di cui bisogna mantener l’equilibrio essenziale a tutti i costi, per evitare un’immane catastrofe potrebbe procedere a tappe piccolissime, insensibili, che modifichino la struttura sociale senza scosse repentine: anche il bambino meglio e più solidamente fasciato si sviluppa normalmente. Ed ecco perché occorrerebbe sapere se il Fovel è la voce di un individuo singolo o l’esponente di forze economiche che cercano la loro via. In ogni caso il processo sarebbe lunghissimo e nuove difficoltà, nuovi interessi che nel frattempo si costituiranno, faranno opposizione tenace al suo sviluppo regolare.
Q1 §136 Novecentismo di Bontempelli. Il manifesto del «900» di Bontempelli è l’articolo di Prezzolini Viva l’artificio! pubblicato nel 1915 e ristampato a p. 51 della raccolta di articoli del Prezzolini Mi pare... (Fiume, Edizioni Delta, 1925). Una quantità di spunti contenuti in quest’articolo sono stati svolti e illanguiditi dal Bontempelli, perché divenuti meccanici. La sua commedia Nostra Dea del 1925 è una meccanica estensione delle parole di Prezzolini riportate a pagina 56. È notevole che l’articolo di Prezzolini è molto goffo e pedantesco; risente dello sforzo fatto dall’autore dopo l’esperienza di «Lacerba» per diventare più leggero e brioso; ciò che potrebbe essere espresso in un epigramma viene masticato e rimasticato con molte smorfie tediose. Bontempelli imita la goffaggine moltiplicandola. Un epigramma in Prezzolini diventa un articolo, in Bontempelli un volume.
Q1 §137 Novecentisti e strapaesani. Barocco e Arcadia adattati ai tempi moderni.
Q1 §138 Risorgimento. Se è vero che la vita concreta degli Stati è fondamentalmente vita internazionale, è anche vero che la vita degli Stati italiani fino al 1870 e cioè la «storia italiana» è più «storia internazionale» che storia «nazionale».
Q1 §139 Azione Cattolica. Può farsi un qualsiasi paragone tra l’Azione Cattolica e le istituzioni come i terziari francescani? Credo di no, quantunque sia bene accennarvi introduttivamente, per meglio definire i caratteri dell’A.C. stessa. Certo la creazione dei terziari è molto interessante ed ha un carattere democratico; essa illumina meglio il carattere del francescanesimo, come ritorno alla chiesa primitiva, comunità di fedeli e non solo del clero come era venuta sempre più diventando. Perciò sarebbe bene studiare la fortuna di questa iniziativa, che non è stata grande, perché il francescanesimo non divenne tutta la religione, come era nell’intenzione di Francesco, ma si ridusse a uno dei tanti ordini esistenti. L’A.C. segna l’inizio di un’epoca nuova nella storia della religione cattolica: quando essa da concezione totalitaria del mondo, diventa solo una parte e deve avere un partito. I diversi ordini religiosi rappresentano la reazione della chiesa (comunità dei fedeli o comunità del clero), dal basso o dall’alto, contro la disgregazione della concezione (eresie, scismi ecc.): l’A.C. rappresenta la reazione contro l’apostasia di masse intiere, cioè contro il superamento di massa della concezione religiosa del mondo. Non è più la Chiesa che fissa il terreno e i mezzi della lotta; deve accettare il terreno impostole dal di fuori e servirsi di armi tolte dall’arsenale dei suoi avversari (l’organizzazione di massa). La Chiesa è sulla difensiva, cioè, ha perduto l’autonomia dei movimenti e delle iniziative, non è più una potenza ideologica mondiale, ma solo una forza subalterna.
Q1 §140 La costituzione spagnola del 12 nel Risorgimento. Perché fu così popolare? Bisognerebbe confrontarla con le altre costituzioni promulgate nel 48. Certo era molto liberale, specialmente nel fissare le prerogative del parlamento e dei parlamentari.
Q1 §141 Americanismo. Dal Trastullo di Strapaese di Mino Maccari (Firenze, Vallecchi, 1928).
Per un ciondolo luccicante / Il tuo paese non regalare: / Il forestiero è trafficante / Dargli retta non è affare / Se tu fossi esperto e scaltro / Ogni mistura terresti discosta: / Chi ci guadagna è sempre quell’altro / Che la tua roba un mondo costa / Val più un rutto del tuo pievano / Che l’America e la sua boria: Dietro l’ultimo italiano / C’è cento secoli di storia / ... Tabarino e ciarlestone / Ti fanno dare in ciampanelle / O Italiano ridatti al trescone / Torna a mangiare il centopelle / Italiano torna alle zolle / Non ti fidar delle mode di Francia / Bada a mangiar pane e cipolle / E terrai a dovere la pancia.
Il Maccari, però, è andato a fare il redattore capo della «Stampa» di Torino, a mangiar cipolle nel centro più stracittadino e industriale d’Italia.
Q1 § 142. Giuseppe Prezzolini e gli intellettuali. Il Codice della vita italiana (Editrice la S. A. «La Voce» di Firenze, 1921) conchiude il periodo prezzoliniano originario, di scrittore moralista sempre in campagna per rinnovare e ammodernare la cultura italiana. Dopo egli entra in crisi, con alti e bassi curiosissimi, fino a imbrancarsi nella corrente tradizionale e a lodare ciò che aveva vituperato.
Una fase di questa crisi è rappresentata dalla lettera del 1923 a P. Gobetti Per una società degli Apoti, ripubblicata nel volumetto Mi pare... (Fiume, Edizioni Delta, 1925). Sente che la sua posizione di «spettatore» è «un po’, un pochino, vigliacca». «Non sarebbe nostro dovere di prender parte? Non c’è qualche cosa di uggioso, di antipatico, di mesto, nello spettacolo di questi giovani ... che stanno (quasi tutti) fuori della lotta, guardando i combattenti e domandandosi soltanto come si danno i colpi e perché e per come?». Trova la soluzione, comoda: «Il nostro compito, la nostra utilità, per il momento presente ed anche ... per le contese stesse che ora dividono e operano, per il travaglio stesso nel quale si prepara il mondo di domani, non può essere che quello al quale ci siamo messi e cioè di chiarire delle idee, di far risaltare dei valori, di salvare, sopra le lotte, un patrimonio ideale, perché possa tornare a dare frutti nei tempi futuri». Il suo modo di vedere la situazione è strabiliante: «Il momento che si traversa è talmente credulo, fanatico, partigiano, che un fermento di critica, un elemento di pensiero, un nucleo di gente che guardi sopra agli interessi, non può che fare del bene. Non vediamo tanti dei migliori accecati? Oggi tutto è accettato dalle folle: il documento falso, la leggenda grossolana, la superstizione primitiva vengono ricevute senza esame, a occhi chiusi, e proposte come rimedio materiale e spirituale. E quanti dei capi hanno per aperto programma la schiavitù dello spirito come rimedio agli stanchi, come rifugio ai disperati, come sanatutto ai politici, come calmante agli esasperati. Noi potremmo chiamarci la congregazione degli Apoti, di “coloro che non le bevono”, tanto non solo l’abitudine ma la generale volontà di berle è evidente e manifesta ovunque».
Un’affermazione digesuitismo sofistico singolare: «Ci vuole che una minoranza, adatta a ciò, si sacrifichi se occorre e rinunzi a molti successi esterni, sacrifichi anche il desiderio di sacrifizio e di eroismo, non dirò per andare proprio contro corrente, ma stabilendo un punto solido, dal quale il movimento in avanti riprenderà», ecc. ecc.
Differenze tra Prezzolini e Gobetti: vedere se questa lettera ha avuto risposta e come.
Q1 §143 Qualità e quantità. Nel mondo della produzione significa nient’altro che buon mercato e alto prezzo, cioè soddisfazione o no dei bisogni elementari delle classi popolari ed elevazione o depressione del loro tenore di vita. Tutto il resto è romanzo ideologico d’appendice. In un’azienda‑nazione dove esiste molta mano d’opera e poche materie prime, il grido: «Qualità» significa solo voler impiegare molto lavoro su poca materia, cioè voler specializzarsi per un mercato di lusso. Ma è possibile ciò? 1°) Dove esiste molta materia prima sono possibili i due sistemi, qualitativo e quantitativo, mentre non c’è reciproca per i paesi poveri; 2°) La produzione quantitativa può essere anche qualitativa, cioè fare la concorrenza all’industria puramente qualitativa tra quella parte della classe consumatrice di oggetti «distinti» che non è tradizionalista perché di nuova formazione; 3°) Quale industria procurerà gli oggetti di consumo delle classi povere? Si formerà una situazione di divisione internazionale del lavoro?
Si tratta insomma di una formula da letterati perdigiorno, e di politici demagogici che nascondono la testa per non vedere la realtà. La qualità dovrebbe attribuirsi agli uomini e non alle cose. E la qualità umana si eleva nella misura in cui l’uomo soddisfa un maggior numero di bisogni e se ne rende quindi indipendente. Il caro prezzo del pane, dovuto al fatto di voler mantenere legata a determinate attività una maggior quantità di uomini, porta alla denutrizione. La politica della qualità determina sempre il suo opposto: quantità squalificata.
Q1 §144 Auguste Boullier, L’île de Sardaigne. Description, Histoire, Statistique, Mœurs, État social, Paris, E. Dentu, 1865. Il Boullier fu in Sardegna quando si parlava di una sua cessione alla Francia. Scrisse anche un altro volume, Le Dialecte et les Chants Populaires de la Sardaigne. Il libro è ormai senza valore. È interessante per alcuni aspetti. Il Boullier cerca di spiegare le cause delle difficoltà che si presentarono in Sardegna contro la sparizione dei relitti feudali (beni collettivi ecc.), ciò che ringalluzziva i sostenitori dell’antico regime. Naturalmente il Boullier, che si pone da un puro punto di vista ideologico, non capisce niente della quistione. Vi sono ricordati inoltre alcuni elementi interessanti i rapporti internazionali della Sardegna e la sua importanza nel Mediterraneo: per es. la insistenza di Nelson perché il governo inglese comprasse la Sardegna dal re (di Piemonte) dietro un canone di 500 000 sterline annue. Secondo Nelson la Sardegna strategicamente è superiore a Malta; inoltre potrebbe diventare economicamente redditizia sotto una gestione inglese, mentre Malta economicamente sarà sempre passiva.
Q1 §145 Il talento. Hofmannsthal rivolse a Strauss queste parole, a proposito dei detrattori del musicista: «Abbiamo buona volontà, serietà, coerenza, il che val di più del malaugurato talento, di cui è fornito ogni briccone». (Ricordato da L. Beltrami in un articolo sullo scultore Quadrelli nel «Marzocco» del 2 marzo 1930).
Q1 §146 Nella recensione fatta da A. De Pietri Tonelli nella «Rivista di politica economica» (febbraio 1930) del libro di Anthony M. Ludovici, Woman. A vindication (2a ed., 1929, Londra) si dice: «Quando le cose vanno male nella struttura sociale di una nazione, a cagione della decadenza nelle capacità fondamentali dei suoi uomini, afferma l’autore, due distinte tendenze sembrano sempre rendersi rilevabili: la prima è quella di interpretare cambiamenti, che sono puramente e semplicemente segni della decadenza e della rovina di vecchie e sane istituzioni, come sintomi di progresso; la seconda, dovuta alla giustificata perdita di confidenza nella classe governante, è di dare a ciascuno, abbia o ho le qualità volute, la sicurezza di essere indicato per fare uno sforzo al fine di aggiustare le cose». L’autore fa del femminismo un’espressione di questa seconda tendenza (ciò che è errato, perché l’affermazione di essere una cosa non è la prova che lo si sia: il femminismo ha cause più vaste e profonde). L’autore domanda una rinascita del «maschilismo».
Q1 §147 «In mille circostanze della mia vita ho dato a conoscere essere veramente il priore della confraternita di San Simpliciano». V. Monti.
Q1 §148 Lorianismo. A proposito delle teorie altimetriche del Loria si potrebbe ricordare, per ridere, che Aristotele trovava che «le acropoli sono opportune per i governi oligarchici e tirannici, le pianure ai governi democratici».
Q1 §149 Nord e Sud. La egemonia del Nord sarebbe stata «normale» e storicamente benefica, se l’industrialismo avesse avuto la capacità di ampliare con un certo ritmo i suoi quadri per incorporare sempre nuove zone economiche assimilate. Sarebbe allora stata questa egemonia l’espressione di una lotta tra il vecchio e il nuovo, tra il progressivo e l’arretrato, tra il più produttivo e il meno produttivo; si sarebbe avuta una rivoluzione economica di carattere nazionale (e di ampiezza nazionale), anche se il suo motore fosse stato temporaneamente e funzionalmente regionale. Tutte le forze economiche sarebbero state stimolate e al contrasto sarebbe successa una superiore unità. Ma invece non fu così. L’egemonia si presentò come permanente; il contrasto si presentò come una condizione storica necessaria per un tempo indeterminato e quindi apparentemente «perpetua» per l’esistenza di una industria settentrionale.
Emigrazione. Si fa il confronto tra Italia e Germania. È vero che lo sviluppo industriale provocò, in un primo tempo, una forte emigrazione in Germania, ma in un secondo tempo non solo la fece cessare, ma ne riassorbì una parte e determinò una notevole immigrazione. Ciò sia detto per un puro confronto meccanico dei due fenomeni emigratori italiano e tedesco: che se il confronto viene approfondito, allora appaiono altre differenze essenziali. In Germania l’industrialismo produsse in un primo tempo esuberanza di «quadri industriali» stessi, e furono questi che emigrarono, in condizioni economiche ben determinate: emigrò un certo capitale umano già qualificato e dotato, insieme con una certa scorta di capitale finanziario. L’emigrazione tedesca era il riflesso di una certa esuberanza di energia attiva capitalistica che fecondava economie di altri paesi più arretrati, o dello stesso livello, ma scarso di uomini e di quadri direttivi. In Italia il fenomeno fu più elementare e passivo e ciò che è fondamentale non ebbe un punto di risoluzione, ma continua anche oggi. Anche se praticamente l’emigrazione è diminuita e ha cambiato di qualità, ciò che importa notare è che tale fatto non è funzione di un assorbimento delle forze rimaste in ampliati quadri industriali, con un tenore di vita conguagliatosi con quello dei paesi «normali». È un portato della crisi mondiale, cioè dell’esistenza in tutti i paesi industriali di armate di riserva nazionali superiori al normale economico. La funzione italiana di produttrice di riserva operaia per tutto il mondo è finita non perché l’Italia abbia normalizzato il suo equilibrio demografico, ma perché tutto il mondo ha sconcertato il proprio.
Intellettuali e operai. Altra differenza fondamentale è questa: l’emigrazione tedesca fu organica, cioè insieme alla massa lavoratrice emigrarono elementi organizzativi industriali. In Italia emigrò solo massa lavoratrice prevalentemente ancora informe sia industrialmente, sia intellettualmente. Gli elementi corrispondenti intellettuali rimasero e anch’essi informi, cioè non modificati per nulla dall’industrialismo e dalla sua civiltà; si produsse una formidabile disoccupazione di intellettuali, che provocò tutta una serie di fenomeni di corruzione e di decomposizione politica e morale, con riflessi economici non trascurabili. Lo stesso apparato statale, in tutte le sue manifestazioni, ne fu intaccato assumendo un particolare carattere. Così i contrasti si invelenivano anziché sparire e ognuna di queste manifestazioni contribuiva ad approfondire i contrasti.
Q1 §150 La concezione dello Stato secondo la produttività funzione delle classi sociali. Il libro di R. Ciasca sulle Origini del programma nazionale può dare ampi materiali per svolgere questo argomento. Per le classi produttive (borghesia capitalistica e proletariato moderno) lo Stato non è concepibile che come forma concreta di un determinato mondo economico, di un determinato sistema di produzione. Conquista del potere e affermazione di un nuovo mondo produttivo sono inscindibili: la propaganda per l’una è anche propaganda per l’altra: in realtà solo in questa coincidenza risiede la origine unitaria della classe dominante che è economica e politica insieme. Invece quando la spinta al progresso non è strettamente legata a uno sviluppo economico locale, ma è riflesso dello sviluppo internazionale che manda alla periferia le sue correnti ideologiche nate sulla base dello sviluppo produttivo dei paesi più progrediti, allora la classe portatrice delle nuove idee è la classe degli intellettuali e la concezione dello Stato muta d’aspetto. Lo Stato è concepito come una cosa a sé, come un assoluto razionale. Si può dire questo: essendo lo Stato la cornice concreta di un mondo produttivo, ed essendo gli intellettuali l’elemento sociale che si identifica meglio col personale governativo, è proprio della funzione degli intellettuali porre lo Stato come un assoluto: così è concepita come assoluta la loro funzione storica, è razionalizzata la loro esistenza. Questo motivo è basilare dell’idealismo filosofico ed è legato alla formazione degli Stati moderni in Europa come «reazione - superamento nazionale» della Rivoluzione francese e del napoleonismo rivoluzione passivaAggiunto a margine in epoca posteriore.. Si può osservare: che alcuni criteri di valutazione storica e culturale devono essere capovolti. 1°) Le correnti italiane che vengono «bollate» di razionalismo francese e di «illuminismo» sono invece proprio le più aderenti alla realtà empirica italiana, in quanto concepiscono lo Stato come forma concreta di uno sviluppo economico italiano. A ugual contenuto conviene uguale forma politica. 2°) Invece sono proprio «giacobine» le correnti che appaiono più autoctone, in quanto pare sviluppino una corrente tradizionale italiana. Questa corrente è «italiana», perché essendo stata per molti secoli la «cultura» l’unica manifestazione italiana nazionale, ciò che è sviluppo di questa manifestazione tradizionale più antica pare più autoctono. Ma è una illusione storica. Ma dove era la base materiale di questa cultura italiana? Essa non era in Italia. Questa «cultura italiana» è la continuazione del «cosmopolitismo» medioevale legato alla Chiesa e all’Impero, concepiti universali. L’Italia ha una concentrazione intellettuale «internazionale», accoglie ed elabora teoricamente i riflessi della più soda e autoctona vita del mondo non italiano. Gli intellettuali italiani sono «cosmopoliti», non nazionali; anche Machiavelli nel Principe riflette la Francia, la Spagna ecc. col loro travaglio per la unificazione nazionale, più che l’Italia. Ecco perché io chiamerei veri «giacobini» i rappresentanti di questa corrente: essi veramente vogliono applicare all’Italia uno schema intellettuale razionale, elaborato sull’esperienza altrui e non sull’esperienza nazionale. La quistione è molto complessa ed irta di apparenti contraddizioni, e perciò occorre esaminarla ancora profondamente su una base storica. In ogni modo gli intellettuali meridionali nel Risorgimento appaiono con chiarezza essere questi studiosi del «puro» Stato, dello Stato in sé. E ogni volta che gli intellettuali appaiono «dirigere», la concezione dello Stato in sé riappare con tutto il corteo «reazionario» che di solito la accompagna.
Q1 §151 Rapporto storico tra lo Stato moderno francese nato dalla Rivoluzione e gli altri Stati moderni europei. La quistione è di sommo interesse, purché non sia risolta secondo schemi astratti sociologici. Essa storicamente risulta da questi elementi: 1°) Esplosione rivoluzionaria in Francia; 2°) Opposizione europea alla rivoluzione francese e alla sua espansione per i «meati» di classe; 3°) Guerre rivoluzionarie della Francia con la Repubblica e con Napoleone e costituzione di una egemonia francese con tendenza a uno Stato universale; 4°) Riscosse nazionali contro Pegernonia francese e nascita di Stati moderni europei per ondate successive, ma non per esplosioni rivoluzionarie come quella originaria francese. Le «ondate successive» sono date da una combinazione di lotte sociali di classi e di guerre nazionali, con prevalenza di queste ultime. La «Restaurazione» è il periodo più interessante da questo punto di vista: essa è la forma politica in cui la lotta delle Classi trova quadri elastici che permettono alla borghesia di giungere al potere senza rotture clamorose, senza l’apparato terroristico francese. Le vecchie classi sono degradate da «dirigenti» a «governative», ma non eliminate né tanto meno fisicamente soppresse; da classi diventano «caste» con caratteri psicologici determinati, non più con funzioni economiche prevalenti. Questo «modello» della formazione degli Stati moderni può ripetersi? È da escludere, per lo meno in quanto alla ampiezza e per quanto riguarda i grandi Stati. Ma la quistione è di somma importanza, perché il modello francese‑europeo ha creato una mentalità.
Altra quistione importante legata alla suddetta è quella dell’ufficio che hanno creduto di avere gli intellettuali in questa fermentazione politica covata dalla Restaurazione. La filosofia classica tedesca è la filosofia di questa epoca ed è quella che vivifica i movimenti liberali nazionali del 48 fino al 70. A questo proposito vedere la riduzione che fa Marx della formula francese «liberté, fraternité, égalité» con i concetti filosofici tedeschi (Sacra famiglia). Questa riduzione mi pare teoricamente importantissima: è da porre accanto a ciò che ho scritto sulla Concezione dello Stato secondo la produttività (funzione) delle classi sociali (p. 95 bis). Ciò che è «politica» per la classe produttiva diventa «razionalità» per la classe intellettuale.
Ciò che è strano è che dei marxisti ritengano superiore la «razionalità» alla «politica», la astrazione ideologica alla concretezza economica. Su questa base di rapporti storici è da spiegare l’idealismo filosofico moderno.
Q1 §152 Marx ed Hegel. Nello studio dello hegelismo di Marx occorre ricordare (dato specialmente il carattere eminentemente pratico‑critico del Marx) che Marx partecipò alla vita universitaria tedesca poco dopo la morte di Hegel, quando doveva essere vivissimo il ricordo dell’insegnamento «orale» di Hegel e delle discussioni appassionate, con riferimento alla storia concreta, che tale insegnamento certamente suscitòA cominciare da: «partecipò alla vita universitaria tedesca», fino a: «tale insegnamento certamente suscitò», il testo sostituisce alcune righe cancellate a penna e rese illegibili dallo stesso G., nelle quali, cioè, la concretezza storica del pensiero di Hegel doveva risultare molto più evidente di quanto risulti dagli scritti sistematici. Alcune affermazioni di Marx mi pare siano da ritenere specialmente legate a questa vivacità «conservativa»: per esempio l’affermazione che Hegel «fa camminare gli uomini con la testa in giù». Hegel si serve veramente di questa immagine parlando della Rivoluzione francese; egli scrive che in un certo momento della Rivoluzione francese (quando fu organizzata la nuova struttura statale), «pareva» che il mondo camminasse sulla testa o qualcosa di simile (cfr). Mi pare che il Croce si domandi cercare il punto di dove Marx abbia preso questa immagine: essa è certamente in un libro di Hegel (forse la Filosofia del Diritto: non ricordo), ma mi pare che per l’insistenza con cui Marx ci ritorna (mi pare che Marx ripeta l’immagine: vedere) mi pare che essa sia stata in un certo momento oggetto di conversazione: essa veramente sembra scaturita da una conversazione tanto è fresca, spontanea, poco «libresca».
Q1 §153 Conversazione e cultura (vedi a p. 80 la nota: Spunti e stimoli). L’osservazione del Macaulay è contenuta nel suo saggio sugli Oratori attici (vedere, per riferire con esattezza, se del caso). L’osservazione può essere ancora svolta. È certo che la cultura per un grande periodo si è svolta specialmente nella forma oratoria o retorica, cioè con nullo o scarso sussidio di scritti e altri mezzi didattici o di studio in generale. Una nuova tradizione comincia nel Medio Evo, coi conventi e con le scuole regolari. La scolastica rappresenta il punto più importante di questa tradizione. Se si osserva bene, lo studio fatto dalla scolastica della logica formale è appunto anche una reazione contro il «facilonismo» dimostrativo dei vecchi metodi di cultura. Gli errori logici sono specialmente comuni nell’argomentazione parlata. L’arte della stampa ha poi rivoluzionato tutto il mondo culturale. In questa ricerca è implicita dunque l’altra delle modificazioni qualitative oltre che quantitative (estensione di massa) apportate al modo di pensare dallo sviluppo tecnico dell’organizzazione culturale. Anche oggi ideologicamente il teatro e il cinematografo hanno una rapidità e area d’azione enormemente più vasta del libro (il teatro e il cinematografo si possono paragonare al giornale e alle riviste) ma in superficie, non in profondità. Le accademie e le Università come mezzi e organizzazioni di cultura. Nelle Università la lezione orale e il seminario. Il professore e l’assistente; l’assistente professionale e gli «anziani di Santa Zita» della scuola del Puoti di cui parla il De Sanctis, cioè la formazione nella stessa classe di un’«avanguardia» », di una selezione spontanea di allievi che aiuti l’insegnante e prosegua le sue lezioni, insegnando praticamente a studiare.
Queste osservazioni mi sono state suggerite dal Materialismo storico di Bukharin1 che risente di tutte le deficienze della conversazione. Sarebbe curioso fare una esemplificazione di tutti i passi che corrispondono agli errori logici indicati dagli scolastici, ricordando la giustissima osservazione di Engels che anche i «modi» del pensare sono elementi acquisiti e non innati, il cui possesso corrisponde a una qualifica professionale. Non possederli, non accorgersi di non possederli, non porsi il problema di acquistarli attraverso un apprendissaggio equivale a voler costruire un’automobile sapendo impiegare e avendo a propria disposizione l’officina e gli strumenti di fabbro ferraio da villaggio.
Lo studio della «vecchia logica formale» è ormai caduto in discredito e in parte a ragione. Ma il problema di far fare l’apprendissaggio della logica si ripresenta se si pone il problema di creare una nuova cultura su una base sociale nuova, che non ha tradizioni, come la vecchia classe degli intellettuali. Un «blocco intellettuale» tradizionale, con la complessità delle sue articolazioni, riesce ad assimilare nello svolgimento organico di una scienza l’elemento «apprendista» anche senza bisogno di sottoporlo al tirocinio formale. Ma neanche ciò avviene senza difficoltà e senza perdite. Lo sviluppo delle scuole tecniche professionali in tutti i gradi post‑elementari, ha ripresentato il problema. Ricordare l’affermazione del prof. Peano che anche nel Politecnico e nelle matematiche risultavano meglio preparati gli allievi provenienti dal ginnasio‑liceo in confronto con quelli provenienti dalle scuole‑istituti tecnici. Questa migliore preparazione era data dal complesso insegnamento «umanistico» (storia, letteratura, filosofia). Perché la matematica non può dare gli stessi risultati?
È stata avvicinata la matematica alla logica. Pure c’è una enorme differenza. La matematica si basa essenzialmente sulla serie numerica, cioè su un’infinita serie di eguaglianze (1 = 1) che possono essere combinate in modi teoricamente infiniti. La logica formale «tende» a far lo stesso, ma fino a un certo punto. La sua astrattezza si mantiene solo nell’inizio dell’apprendimento, nella sua formulazione immediata nuda e cruda, ma si attua concretamente nel discorso stesso in cui questa stessa formulazione astratta si compie. Gli esercizi di lingua che si fanno nel ginnasio liceo fanno vedere questo: nelle traduzioni latino‑italiano, greco‑italiano, non c’è mai identità fra le due lingue, o almeno questa identità che pare esista agli inizi dello studio (rosa = rosa) va sempre più complicandosi col progredire dell’apprendimento, va cioè allontanandosi dallo schema matematico per giungere a quello storico e psicologico in cui le sfumature, l’espressività «unica e individuale» ha la prevalenza. E non solo ciò avviene nel confronto tra due lingue, ma avviene nello studio della storia della stessa «lingua», cioè nelle variazioni «semantiche» dello stesso suono‑parola attraverso il tempo e delle sue cambiate funzioni nel periodo. (Cambiamenti di suoni, di morfologia, di sintassi, di semantica). (Questa serie di osservazioni deve essere continuata e messa in rapporto con precedenti ).
Q1 §154 Clero e intellettuali. Esiste uno studio organico sulla storia del clero come «classe‑casta»? Mi pare che sarebbe indispensabile, come avviamento e condizione di tutto il rimanente studio sulla funzione della religione nello sviluppo storico ed intellettuale dell’umanità. La precisa situazione giuridica e di fatto della chiesa e del clero nei vari periodi e paesi, le sue condizioni e funzioni economiche, i dirigenti e con lo Stato ecc. ecc.
Q1 §155 Marx ed Hegel (cfr p. 97). Antonio Labriola nello scritto Da un secolo all’altro: «Gli è proprio quel codino di Hegel che disse come quegli uomini (della Convenzione) avessero per primi, dopo Anassagora, tentato di capovolgere la nozione del mondo, poggiando questo su la ragione» (cfr A. Labriola, Da un secolo all’altro, ediz. Dal Pane, p. 45).
Q1 §156 Passato e presente. Come il presente sia una critica del passato, oltre che e perché un suo «superamento». Ma il passato è perciò da gettar via? È da gettar via ciò che il presente ha criticato «intrinsecamente» e quella parte di noi stessi che a ciò corrisponde. Cosa significa ciò? Che noi dobbiamo aver coscienza esatta di questa critica reale e darle un’espressione non solo teorica, ma politica. Cioè dobbiamo essere più aderenti al presente, che noi stessi abbiamo contribuito a creare, avendo coscienza del passato e del suo continuarsi (e rivivere).
Q1 §157 Croce e gli intellettuali. Che importanza ha avuto il suo libro sulla Storia d’Italia dal 71 al 1915? È interessante osservare lo spostamento del Croce dalla posizione «critica» a quella «attiva» libro di Bonomi su Bissolati. il libro di Zibordi su Prampolini. La traduzione di Schiavi del libro del De Man. Il libro del De Man serve di ponticello.
È interessante però la lettera di Orazio Raimondo riportata dal Castellano nel suo libro Introduzione allo studio delle opere di Benedetto Croce. Dimostra che anche prima, l’influenza del Croce si era fatta sentire per meati che rimanevano incontrollati: proprio Raimondo, massone e vero massone, cioè imbevuto dell’ideologia massonica fino alle ossa, e democratico; nella sua difesa della (Tiepolo?) c’è tutto il teismo massonico in forma chiara ed evidente.
Q1 §158 «Animalità» e industrialismo. L’industrialismo è una continua vittoria sull’animalità dell’uomo, un processo ininterrotto e doloroso di soggiogamento degli istinti a nuove e rigide abitudini di ordine, di esattezza, di precisione. C’è una meccanizzazione o l’aspetto di una meccanizzazione. Ma ogni nuovo modo di vivere, nel periodo in cui si impone e lotta contro il vecchio, non appare una meccanizzazione? Ciò avviene perché finora i mutamenti sono avvenuti per coercizione brutale, cioè per imposizione di una classe su un’altra. La selezione degli uomini adatti al nuovo tipo di civiltà, cioè al nuovo tipo di lavoro è avvenuta con inaudita brutalità, gettando nell’inferno delle sottoclassi i deboli, i refrattari. Ci sono state delle crisi. Ma chi era coinvolto in questa crisi? Non le masse lavoratrici, ma le classi medie che avevano sentito anch’esse la pressione ma indirettamente, per il loro stesso sistema di vita e di lavoro. Le crisi di libertinismo sono state numerose: ogni epoca storica ne ha una. Per ottenere un nuovo adattamento al nuovo lavoro, si esercita una pressione su tutta l’area sociale, si sviluppa una ideologia puritana che dà l’esterna forma di persuasione e di consenso all’intrinseca coercizione brutale. Ottenuto in una certa misura il risultato, la pressione si spezza (storicamente questa rottura si verifica in modi diversissimi, come è naturale, perché la pressione ha assunto forme originali, spesso personali, si è identificata con movimenti di religiosità, ha creato un proprio apparato che si è impersonato in determinati strati o caste, ha preso il nome da un re ecc.) e avviene la crisi di libertinismo (crisi francese dopo la morte di Luigi XIV per esempio), che però non tocca che superficialmente le masse lavoratrici o le tocca sentimentalmente perché deprava le loro donne; queste masse hanno infatti già acquisito i nuovi sistemi di vita e rimangono sottoposte alla pressione per le necessità elementari di vita.
Il dopoguerra ha avuto una crisi simile, forse la più vasta che si sia mai vista nella storia; ma la pressione era stata esercitata non per imporre una nuova forma di lavoro, ma per le necessità di guerra. La vita di trincea è stata l’oggetto principale della pressione. Si sono scatenati specialmente gli istinti sessuali, repressi per tanti anni in grandi masse di giovani dei due sessi e resi formidabili dalla sparizione di tanti maschi e da uno squilibrio dei sessi. Le istituzioni legate alla riproduzione sono state scosse: matrimonio, famiglia ecc. ed è nata una nuova forma di «illuminismo» in queste quistioni. La crisi è resa più forte dal contrasto tra questo contraccolpo della guerra e le necessità del nuovo metodo di lavoro che si va imponendo (taylorismo, razionalizzazione). Il lavoro domanda una rigida disciplina degli istinti sessuali, cioè un rafforzamento della «famiglia» in senso largo (non di questa o quella forma storica), della regolamentazione e stabilità dei rapporti sessuali.
In questa questione il fattore ideologico più depravante è l’illuminismo, la concezione «libertaria» legata alle classi non manualmente produttive. Fattore che diventa grave se in uno Stato le classi lavoratrici non subiscono più la pressione violenta di un’altra classe, se la nuova abitudine di lavoro deve essere acquisita solo per via di persuasione e di convinzione. Si forma una situazione a doppio fondo, tra l’ideologia «verbale» che riconosce le nuove necessità e la pratica «animalesca» che impedisce ai corpi fisici di realmente acquistare le nuove abitudini. Si forma cioè una situazione di grande ipocrisia sociale totalitaria. Perché totalitaria? In altre situazioni, la massa lavoratrice è costretta a osservare la virtù: chi la predica, non la osserva, pur rendendole omaggio verbale: l’ipocrisia è di classe, non totale; è una forma transitoria, perché scoppierà in una crisi di libertinismo, ma quando già le masse avranno assimilato la «virtù» in abitudini acquisite. In questo secondo caso, invece, non esistendo il dualismo di classe, la «virtù» viene affermata, ma non osservata né per convinzione né per coercizione: non vi sarà pertanto acquisizione di nuove abitudini, necessarie per il nuovo sistema di lavoro. È una crisi in «permanenza» che solo la coercizione può troncare, una coercizione di nuovo tipo, perché, essendoci una sola classe, sarà autodisciplina (Alfieri che si fa legare alla sedia!) In ogni caso, il nemico da combattere è l’illuminismo. E se non si crea l’autodisciplina, nascerà una qualche forma di bonapartismo, o ci sarà un’invasione straniera, cioè si creerà la condizione di una coazione esterna che faccia cessare d’autorità la crisi.
QUADERNO 2
MISCELLANEA I
Q2 §1 Vittorio Giglio, Milizie ed eserciti d’Italia, in 8°, 404 pp., illustr., L. 80, C. E. Ceschina (Dall’epoca romana alle milizie comunali, all’esercito piemontese, alla M.V.S.N.). Cercare come mai nel 48 in Piemonte non esistesse nessun capo militare e sia stato necessario ricorrere a un generale polacco. Nel Quattrocento‑Cinquecento e anche dopo, buonissimi capitani (condottieri, ecc.), sviluppo notevole della tattica e strategia, eppure impossibilità di creare esercito nazionale, per il distacco tra il popolo e le classi alte.
Q2 §2 Italo Raulich, Storia del Risorgimento politico d’Italia, Zanichelli, cinque volumi, vol. IV, marzo‑novembre 1848, L. 32; vol. V, 1849, L. 36.
Q2 §3 Giorgio Macaulay Trevelyan, Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 48. Con pref. di P. Orsi, Zanichelli, L. 35.
Q2 §4 Dal rapporto letto dall’ing. Giacinto Motta all’Assemblea ordinaria del 27 marzo 1927 della «Edison»: – L’industria della produzione e distribuzione dell’energia elettrica alla fine del 1926 ha preso decisamente la testa nell’attività industriale italiana. Secondo le statistiche della Confederazione Bancaria, il capitale delle anonime esercenti l’industria elettrica ammontava alla fine del 26 a 6260 milioni, mentre quello delle industrie meccaniche, metallurgiche, ed affini, che nella statistica seguono immediatamente, ammontava a 4 757 000 000. Una statistica più completa dell’Unione Nazionale Industrie Elettriche (Uniel), considera i dati di 1785 aziende private e 340 enti pubblici e tenendo conto anche delle obbligazioni propriamente dette, indica l’ammontare degli investimenti al settembre 1926 in 7857 milioni di lire, corrispondenti a circa 2650 milioni lire oro.
Mancano le statistiche dei debiti, però, e solo si può ritenere che mentre nel 23‑24‑25, le società elettriche preferivano gli aumenti di capitale, dallo scorcio del 25 in poi ricorsero ai mutui, specialmente in dollari, per una cifra che si aggira sul miliardo di lire carta; perciò nonostante minore incremento del capitale, si mantenne lo stesso ritmo di accrescimento negli impianti.
Produzione e consumo dell’energia: cifre non attendibili. Statistiche ufficiali per esercizi 23‑24‑25, per il consumo: da 6488 a 7049 e 7355 milioni Kwh; ma doppioni nelle denunce, quindi inferiore circa 25%. Statistica dell’Uniel su dati riferentisi in grandissima parte al 25 e in piccola parte al 26: 6212 milioni Kwh. Il gruppo Edison rappresenta il 30% dell’attività complessiva.
Utili: investimenti ingentissimi, con giro d’affari modesto. Utili annuali minori di 1/5 e 1/6 delle somme che bisogna annualmente investire. Industria sempre affamata di danaro, controindicata per gli Enti pubblici i quali soffrono di penuria di mezzi quanto maggiore ritmo di sviluppo. (Condizioni di monopolio. Ricordare interpellanze di Aldo Finzi).
Q2 §5 Angiolo Gambaro, Riforma religiosa nel Carteggio inedito di Raffaello Lambruschini, 2 voll., G. B. Paravia, 1926. Recenti opere di studiosi della preparazione spirituale del Risorgimento: Ruffini, Gentile, Anzilotti, Luzio. Raccogliere bibliografia in proposito. Il Lambruschini legato da relazioni personali con molti protagonisti (liberali moderati) del Risorgimento, esercitando un’influenza che il Gambaro sostiene di prim’ordine, finora quasi ignorata (pour cause!). Il Gambaro mette in rilievo il tormento intimo che l’associazione, nello stesso problema, dei termini politici e religiosi suscitò in quella generazione, in una parte della quale prevalse la visione politica, in altra la religiosa. Lambruschini espressione principale di questo secondo gruppo. Gambaro sostiene che Lambruschini non sansimoniano, non lamennaisiano, non giansenista, ma perfettamente ortodosso; i suoi accusatori spiriti malevoli o incapaci di comprendere. Concezione evangelica della religione, in cui affiora il principio della libertà interiore concorde con l’autorità. Precorse e superò con maggiore audacia ed estensione ideale il blando riformismo del Rosmini e mirò a sanare un quadruplice ordine di piaghe da lui stesso così riassunte (Vol. I Gamb. p. CXCIX): «1) moltiplicare, sminuzzare, materializzare il culto esterno, e trascurare il sentimento; 2) falsare il concetto morale e il concetto delle relazioni nostre con Dio; 3) soggiogare le coscienze, annullare la libertà, per abuso dell’autorità sacerdotale; 4) sostituire alla fede ragionevole una stupida credulità». (Cenni dalla Nuova Antologia del 16 aprile 1927).
(In queste riesumazioni non si tiene abbastanza conto, per valutare l’importanza storica e l’influsso di questi «eroi» del Risorgimento, che la loro opera si esaurì quasi completamente nei carteggi privati e rimase clandestina).
Q2 §6 Articolo «Problemi finanziari» firmato Verax (Tittoni) nella «Nuova Antologia» del 1° giugno 1927. Nella «Nuova Antologia» del 1925 (16 maggio), Tittoni aveva pubblicato un articolo, I problemi finanziari dell’ora, nel quale trattava questi punti: equilibrio del bilancio; economie; perequazione del sistema tributario; mania spendereccia e tassatrice degli enti locali; circolazione monetaria e suoi problemi: deflazione; stabilizzazione; debiti interalleati; regime bancario; ordinamento delle società anonime; difesa del risparmio nazionale.
Equilibrio del bilancio raggiunto; le confusioni, sperequazioni e duplicazioni del sistema tributario eliminate con la riforma De Stefani; i debiti interalleati regolati dal Volpi, il quale ha preso provvedimento per la rapida liquidazione della sezione autonoma del Consorzio valori, per l’unificazione dell’emissione, per il trasferimento delle operazioni di cambio all’Istituto dei cambi sotto il patronato della Banca d’Italia, per la vigilanza in difesa del risparmio nazionale: discorso di Pesaro per la politica monetaria.
Nuovi problemi, attuali: consolidamento del pareggio del bilancio; freno alle crescenti spese; sano impiego delle eccedenze di bilancio; condizioni della tesoreria; necessità di un ammortamento graduale e continuativo del debito pubblico; i prestiti esteri e il miglioramento dei cambi; la difesa della riforma tributaria da iniziate deviazioni; eliminazione di ogni inutile fiscalismo.
L’esercizio 25‑26 chiuso con un avanzo di competenza di 2268 milioni ridotto con due regi decreti a 468 milioni. Ma occorre esaminare l’esercizio 25-26 considerando 1) le maggiori spese sopravvenute durante l’esercizio; 2) quelle deliberate dopo chiuso l’esercizio, ma attribuite a questo; 3) rapporti tra le risultanze del bilancio di competenza ed il conto di cassa; 4) i conti fuori bilancio. Durante l’esercizio 25‑26 furono deliberate maggiori spese, oltre quelle preventivate in bilancio, per 3605 milioni e, chiuso l’esercizio, con due regi decreti (ricordati) furono deliberate 1800 milioni di nuove spese, addebitate all’esercizio stesso mediante iscrizione nel bilancio delle finanze di un capitolo aggiunto. Senza tener conto del movimento dei capitali e delle spese per le PP. e TT. che dal bilancio generale sono state trasferite in quello speciale dell’azienda autonoma, e detratti 247 milioni di economie realizzate durante l’esercizio, si ha, malgrado la diminuzione delle spese residuali della guerra, un aumento di 4158 milioni di spesa sui 17 217 preventivati (aumento del 24%). Ma anche le entrate, preventivate in 17 394 milioni, salirono a 21 043 milioni, e perciò avanzo di 468 milioni.
È necessario un più rigoroso e completo accertamento delle spese, i risultati dell’esercizio devono allontanarsi il meno possibile dalle previsioni, altrimenti il bilancio preventivo diverrebbe inutile, e per una ragione psicologica (!), perché l’annunzio di grandi avanzi incita alle spese. Un insigne economista, R. C. Adams, è giunto a dire che preferisce un bilancio presentato con un lievissimo disavanzo a quello presentato con un eccessivo avanzo poiché il primo incita alle economie, il secondo sospinge alle prodigalità («e a imporre nuove tasse se successivamente l’avanzo è in pericolo sul nuovo piano di spese»; A. G.). Questi avanzi sono fondati su incrementi di entrate che non sono necessariamente continuativi. L’avanzo di un bilancio di competenza può non coincidere con una cassa egualmente florida. «Perciò a situazioni di bilancio eccellenti possono corrispondere situazioni di cassa richiedenti provvedimenti eccezionali come quelli adottati dal Governo Nazionale nello scorso autunno». Politica di economie. Se non riduzione delle spese, desiderabile almeno freno alle nuove spese.
Bilancio italiano non è un conto di fatto, di tipo inglese, che registra incassi e spese effettivamente avvenuti, ma un conto di diritto, di tipo francese, comprendente da una parte le entrate accertate e scadute, da un’altra parte le spese ordinate, liquidate ed impegnate nei modi prescritti dalla legge. Il bilancio di competenza, a quelli che non sanno leggerlo, non dà una chiara visione della situazione finanziaria del paese. L’inconveniente maggiore del bilancio di competenza è nel fatto che nessun esercizio si esaurisce in sé; esso lascia sempre dei residui attivi e passivi, in modo che alla gestione del bilancio proprio dell’esercizio si aggiunge quella dei residui attivi e passivi dei precedenti esercizi che la cassa va a sopportare. Ne deriva pertanto che aumentando le spese di competenza si è normalmente avuto un aumento di residui, specialmente di residui passivi che malamente si contrappongono agli attivi e la maturazione dei quali può depauperare la cassa al di là del prevedibile. I residui passivi mal si contrappongono agli attivi perché questi, dati i nostri congegni di esazione, non possono essere e non sono di un ammontare ragguardevole per la parte effettiva, la sola che costituisce una vera entrata, giacché i residui attivi per movimenti di capitale rappresentano prestiti da contrarsi o da collocarsi. Costituirebbe quindi un grave errore il valutare alla stessa stregua i residui attivi e passivi circa la possibilità di trasformarsi rispettivamente in incassi e pagamenti.
A questo si aggiunge una consuetudine che ormai comincia a trovare larga applicazione: l’art. 154 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità di Stato stabilisce che in nessun caso si possa iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra la competenza degli esercizi anteriori; ma purtroppo la parola della legge non vieta che per lo stesso esercizio si cancelli la iscrizione di un capitolo per aumentarne un altro: così è, ad esempio, quando tra i residui passivi si trova iscritta una somma che presumibilmente non sarà spesa e che non traducendosi quindi in un pagamento sarebbe passata in economia, e viceversa si viene ad aumentare un altro capitolo di spesa, sempre dei residui, e, s’intende, dello stesso esercizio, spesa che sarà realmente effettuata e si tradurrà in un pagamento. Così la contabilità è salva, l’ammontare di residui passivi non viene aumentato, ma le condizioni della cassa vengono peggiorate. La gestione dei residui, e in special modo il saldo dei residui, va tenuto in seria considerazione, tanto più che esso è in continuo aumento, ed infatti la differenza passiva dei residui era al 30 giugno 1926 di 10 513 milioni contro 9442 milioni al 30 giugno 1925.
Francia, Belgio, Italia. I tre paesi, dopo aver assicurato l’equilibrio del bilancio, dovettero fronteggiare una crisi di Tesoreria; il deficit, cioè, non era scomparso, ma passando dal bilancio alla tesoreria si era semplicemente spostato. Si è dovuto correre ai ripari procurando di eliminare anzitutto il pericolo del debito fluttuante, divenuto enorme dopo la guerra, poiché le Tesorerie si trasformarono di fatto in Banche di deposito. («Questo è un paragone capzioso: non si trasformarono per nulla in Banche di deposito, ma commisero una truffa in grande stile, perché le somme incassate furono spese come entrate ordinarie di bilancio, senza che i futuri bilanci potessero prevedersi talmente incrementabili da assicurare la restituzione delle somme alla data fissata: si rastrellò il risparmio diffuso, sotto la pressione del pericolo nazionale, per esonerare da aggravi la ricchezza imponibile; fu una decimazione larvata del capitale, ma di quello delle classi medie, per no n decimare apertamente e realmente il capitale delle classi alte dei maggiori detentori di ricchezza: il confronto tra paesi latini e paesi anglosassoni mette più in rilievo questa truffa colossale, che si è risolta in parte con l’inflazione e in parte con colpi di Stato»).
Il primo progetto di stabilizzazione del franco belga del ministro Jansens fallì in gran parte per aver omesso la sistemazione preventiva del debito fluttuante. La Francia provvide al debito fluttuante con la creazione di una cassa autonoma di consolidamento ed ammortamento. A questa cassa furono destinati i proventi di alcune tasse e quelli della gestione dei tabacchi, in tutto 3700 milioni di franchi all’anno. Il pagamento di queste tasse può farsi con titoli di Stato, che vengono annullati: colla diminuzione dei titoli diminuisce l’interesse e la differenza disponibile va ad aumentare il fondo di ammortamento. Per un emendamento al progetto primitivo del governo l’ammortamento fu esteso a tutto il debito pubblico («cioè fu prolungata l’esistenza presumibile della Cassa»). Così in Francia si ottenne non solo di arrestare la ressa dei rimborsi, ma si ottennero nuove sottoscrizioni: il Tesoro fu rinsanguato; coi mezzi ordinari di Tesoreria poté procurarsi 14 miliardi, di cui 9 furono rimborsati alla Banca di Francia e 5 per acquisto di divise estere. Belgio: si procedette ad una conversione semicoattiva. Ai portatori dei buoni fu posta l’alternativa: o consentire il cambio dei buoni con azioni della società nazionale delle ferrovie belghe costituite dallo Stato, o farli stampigliare. I buoni dati in cambio delle azioni ferroviarie, i 3/4, furono distrutti; gli altri furono convertiti in nuovi buoni coll’interesse ridotto dal 7 al 5% e col rimborso subordinato non a scadenza fissa ma alle disponibilità avvenire del bilancio.
Italia: conversione obbligatoria dei buoni del Tesoro in titoli del debito consolidato, con un premio ai portatori che ha aumentato il debito pubblico di circa 3 miliardi. «Non è il caso di discutere teoricamente quest’operazione che in fatto era inevitabile». Un recentissimo comunicato ai giornali, illustrando il conto del Tesoro a fine marzo, segnala l’esistenza di un fondo di cassa, al 31 marzo (1927) di 2311 milioni. La cifra «lascia fredda una parte dell’opinione pubblica, la quale non riesce a vedere come sì floride condizioni di cassa e di bilancio si concilino con la recente necessità di assai drastici provvedimenti, che investirono una parte cospicua della popolazione e toccarono a fondo molte private economie». La cassa del Tesoro può presentare un’apparente floridezza ed una reale penuria. Ciò rilevò già la Commissione di finanza del Senato, il cui relatore, on. Mayer, nella sua relazione sugli stati di previsione del Ministero delle Finanze e del Bilancio dell’entrata pel 1926‑27, constatava che, mentre dai conti mensili del Tesoro risultavano disponibilità cospicue di cassa (al 31 marzo 1926 quasi 4 miliardi) risultava anche l’aumento dei debiti pubblici per oltre 1800 milioni. Ciò avviene perché il fondo di cassa esposto nella accennata cifra di 2311 milioni non rappresenta tutto danaro di cui il Tesoro possa effettivamente disporre come contante. Così nei 2311 milioni è inclusa la somma di 1554 milioni attribuita alle «contabilità speciali» le quali comprendono numerose assegnazioni fatte ad enti come: fondo per il culto, monte pensioni insegnanti elementari, cassa di previdenza degli enti locali, ospedali riuniti di Roma ecc., epperò rappresentano somme erogate dall’Erario o destinate a pagamenti preveduti dall’amministrazione, e quindi vincolate.
Più significativa è la cifra denotante l’ammontare del fondo di cassa presso la Tesoreria provinciale, vale a dire del fondo cui attingonsi i mezzi per la massima parte dei pagamenti nel Regno; certamente sarebbe un errore considerare questo soltanto, perché il Tesoro ha altre disponibilità liquide, presso la Tesoreria centrale, e fra esse dovrebbero avere una certa importanza quelle in divisa presso i suoi corrispondenti esteri, ma il fondo di dotazione rappresenta sempre la condizione fondamentale delle disponibilità di cassa del Tesoro per fronteggiare i suoi bisogni correnti.
Nulla può essere più eloquente della differenza fra il così
detto «fondo generale di cassa» del Tesoro e la situazione del
«fondo di dotazione» dello Stato per l’esercizio della Tesoreria
provinciale presso la Banca d’Italia, cioè del vero e proprio
conto corrente del Tesoro presso l’Istituto di Emissione:
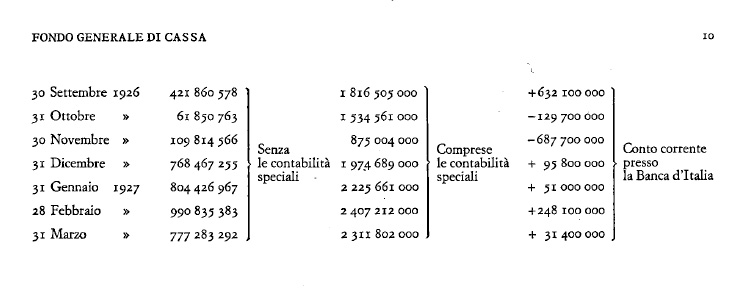
Come si vede, al 31 ottobre e al 30 novembre, cioè prima degli incassi ottenuti con l’emissione del Prestito del Littorio, il detto conto corrente si presentava in deficit, per cui la Banca dovette provvedere a pagamenti del Tesoro con propri biglietti. Nel conto dei debiti della Tesoreria richiama l’attenzione l’ammontare di vaglia del Tesoro nel 1925-1926 in 71 349 milioni per rimborsi e 70 498 milioni per incassi. Queste enormi cifre richiederebbero qualche chiarimento affinché il pubblico potesse rendersi ragione delle operazioni che rappresentavano. Ad esso intanto una cosa appare evidente e cioè che la politica di Tesoreria ha preso il sopravvento su quella di bilancio i cui risultati sono subordinati a quelli della prima.
Bisogna dunque provvedere a rinforzare la cassa del Tesoro (la Francia e il Belgio l’hanno già fatto). Come? Non ricorrendo ad antecipazioni da parte della Banca d’Italia che non potrebbe fornirle che mediante restrizioni del credito al commercio o mediante l’inflazione. Non mediante emissioni di Buoni del Tesoro, perché sarebbe impossibile dopo il recente consolidamento. Non mediante nuovo prestito consolidato. Il debito pubblico va diminuito, non aumentato, è poi recente il consolidamento e prestito del Littorio. Bisogna invece rifornire la cassa mediante le eccedenze di bilancio, nelle quali, se non ci saranno gravi perturbazioni dei cambi e se faremo una politica di economie, potremo continuare a contare. («Ma in realtà avanzi reali di bilancio non ce ne sono mai stati, come risulta dall’esposizione precedente, ma solo spostamenti contabili e mascherature di deficit attraverso i residui passivi, il debito pubblico aumentato surretiziamente e il ricorso a partite incontrollabili, senza contare l’assorbimento dei bilanci locali, tutti deficitari in misura spaventevole.
Bisognerebbe fissare con esattezza cos’è l’avanzo di bilancio effettivo, anche dopo aver fissato una quota ragionevole per rafforzare il tesoro e per ammortare il debito pubblico: è quello che, oltre a tutto ciò, permette di diminuire le imposte effettivamente, e di migliorare le condizioni del personale; diminuire specialmente le imposte indirette che pesano di più sulla parte più povera della popolazione, cioè che permettono un più elevato tenore di vita»). Con decreto regio 3 dicembre 1926 fu elevata a 4/5 la quota dell’avanzo di bilancio da destinare ad opere inerenti alla ricostruzione economica e alla difesa militare della nazione già fissato in 3/4 dal R. D. del 5 giugno. Nessuno ha contestato le ragioni impellenti (!) che indussero il governo a prendere questo provvedimento eccezionalissimo, che è contrario alla dottrina finanziaria di tutti gli economisti senza distinzioni di scuole e che non trova riscontro nella pratica finanziaria di nessun altro paese. Non dovrebbe diventare una consuetudine: il Direttore Generale della Banca d’Italia nella relazione all’assemblea degli azionisti del 27 l’ha «denunziata cautamente come una tendenza nuova di far pesare sugli avanzi passati spese riguardanti l’avvenire».
Il relatore della Giunta del Bilancio della Camera dei Deputati, Olivetti, parlando sul disegno di legge per la conversione in legge del R. D. 3 dicembre 1926 fece l’obbiezione che, come ai disavanzi registrati dall’esercizio 1911‑12 a quello 23‑24 si era fatto fronte con mezzi di tesoreria e accensioni di debito, così bisognerebbe devolvere integralmente alla riduzione dei debiti prebellici gli avanzi registrati dal 24‑25 in poi; inoltre l’avanzo potrebbe essere assegnato a dare maggiore elasticità alla Tesoreria. Però date le gravi ragioni contingenti, la Giunta concludeva per l’approvazione, augurandosi un futuro graduale ammortamento del debito pubblico. (A parole tutti sostengono questa necessità ma non se ne fa niente lo stesso). (Il senato fin dal 1920 domandò sempre: prudente riduzione della circolazione, rigorose economie, sosta nell’indebitamento ed inizio del pagamento dei debiti, vigile attenzione alla cassa del Tesoro, alleviamento delle imposte).
Necessità di chiarezza nei conti finanziari. Il denaro deve trovarsi non solo sui conti, ma nelle casse dello Stato. «Occorre studiare a fondo la quistione delle operazioni fuori bilancio le quali costituiscono una minaccia permanente a danno dei risultati attivi del bilancio. Ed invero più che una minaccia noi avemmo il danno effettivo nel periodo dall’agosto al novembre 1926 come lo dimostra il progressivo impoverimento, durante quei mesi, della cassa».
Le operazioni finanziarie sono quelle che si fondano sul credito pubblico ed hanno effetto sul patrimonio dello Stato: l’emissione di un prestito, il rimborso di obbligazioni rientrano propriamente fra queste. Esse dovrebbero far parte delle operazioni di bilancio e direttamente essere contabilizzate fra le spese e le entrate, fra gli incassi e i pagamenti in conto bilancio. Le operazioni di Tesoreria propriamente dette riguardano invece i provvedimenti che servono ai bisogni immediati della cassa e perciò comprenderebbero l’emissione di buoni del Tesoro ordinari. Tra queste operazioni sono anche operazioni fuori bilancio, almeno temporaneamente, mentre non dovrebbero essere tali in una situazione normale. Ora le operazioni fuori bilancio tendono ad eliminare gli effetti della gestione di bilancio assorbendone le eccedenze attive. L’azienda del Portafoglio ha un significato così delicato che delle principali operazioni si redige processo verbale (art. 534 del regolamento di contabilità). Il Contabile del Portafoglio è tenuto a rendere ogni anno il conto giudiziale. La gestione del Contabile del Portafoglio dà luogo a profitti e perdite. Dal l’luglio 1917 al 30 giugno 1925 non fu presentato conto giudiziale e con R. decreto‑legge 7 maggio 1925 fu concesso di potere eseguire un sol conto giudiziale per gli otto esercizi finanziari precedenti riguardanti la guerra. Il Governo deve attenersi alla pratica del conto giudiziale e restringere l’azienda del portafoglio alle sue proprie specifiche funzioni.
Ammortamento del debito pubblico. L’Inghilterra, gli Stati Uniti, l’Olanda da più di un secolo compiono ammortamenti. Hamilton pel primo dimostrò nel 1814 che un vero ammortamento non può farsi che mediante l’eccedenza delle entrate sulle spese e pose il principio che la creazione di un debito deve essere accompagnata dal piano della sua graduale estinzione. Dal 19 al 24 l’Inghilterra diminuì il suo debito di 650 milioni di sterline, cioè l’intiero debito prebellico. Il debito può essere ammortizzato: 1°, con una cassa speciale; 2°, con le eccedenze di bilancio; 3°, con lo stanziamento di una somma fissa. Si danno le cifre degli ammortamenti stanziati in bilancio e degli avanzi di bilancio dal 21 al 26‑27. È notevole e significativo il fatto che se è vero che nel 26‑27 c’è stato un deficit di 36 694 000 sterline, però in quell’esercizio furono stanziate in bilancio per ammortamento 60 000 000 di sterline, cifra superiore e di molto a quelle degli anni precedenti: 25 000 000 nel 21‑22, 24 000 000 nel 22‑23, 40 000 000 nel 23‑24, 45 000 000 nel 24‑25, 50 000 000 nel 25‑26 (con deficit di 14 000 000). C’è una flessione di bilancio che comincia dal 24‑25: nel 26‑27 il deficit di 36 milioni è ottenuto aumentando lo stanziamento fisso per propaganda contro i minatori, cioè si aumenta la quota di bilancio a favore dei capitalisti a danno della classe operaia.
Per la storia della finanza inglese ricordare che alla fine del XVIII secolo fu adottato da Pitt il meccanismo del sinking fund – fondo di ammortamento – di Price, che poi fu dovuto abbandonare. Hamilton. Fino al 1857 l’eccedenza del bilancio fu destinata di preferenza ad alleviare l’imposta. In seguito l’ammortamento regolare del debito fu ripreso e costituì la base fondamentale delle finanze britanniche. Sospeso durante la guerra fu ripreso dopo l’armistizio. Per andamento del bilancio ricordare le cifre dedicate all’ammortamento dal 21 in poi – prese dal Financial Statements. Prima cifra = ammortamenti stanziati in bilancio; seconda cifra = l’avanzo ulteriore impiegato pure all’ammortamento: 21‑22: 25 010 000 e 45 693 000; 22‑23: 24 711 000 e 101 516 000; 23‑24: 40 000 000 e 48 329 000; 24‑25: 45 000 000 e 3 659 000; 25‑26: 50 000 000, deficit 114 milioni 38 000; 26‑27: 60 000 000, deficit 36 694 000. Il calcolo dell’avanzo reale dà queste cifre: 70 703 000; 126 milioni 227 000; 88 329 000; 48 659 000; 35 962 000; 23 milioni 306 000: c’è una flessione di bilancio, ma non un deficit reale.
La Commissione d’inchiesta per lo studio dei debiti pubblici, presieduta da Lord Colwyn, in una sua recente relazione conchiude raccomandando di intensificare l’ammortamento portando il fondo da 75 a 100 milioni di sterline l’anno. Si capisce benissimo il significato politico di questa proposta, data la crisi industriale inglese: si vuole evitare ogni intervento efficace dello Stato, ponendo tutte le larghe possibilità di bilancio nelle mani dei privati, i quali poi, probabilmente, invece di investire nell’industria nazionale in crisi questi enormi capitali, li investiranno all’estero mentre lo Stato potrebbe riorganizzare, con questi fondi, le industrie fondamentali a favore degli operai.
Negli Stati Uniti il sistema di amministrazione è fondato sulla conversione dei debiti consolidati in debiti redimibili con riduzione degli interessi.
In Francia, la Cassa costituzionalmente autonoma e indipendente dal Tesoro, per diffidenza verso il Tesoro, che potrebbe mettere le mani sui fondi di ammortamento se si trovasse all’asciutto.
Nel Belgio il ministro Francqui aumentò il fondo di ammortamento.
Italia. Con R. D. 3 marzo 1926 fu costituita una Cassa per l’ammortamento del debito inglese e americano. Ma non è stata fissata una somma annua fissa ed intangibile, secondo il sistema inglese (senza pregiudizio degli avanzi di bilancio, che dopo aver provveduto alle esigenze della cassa e a temperare certi fiscalismi esagerati, dovrebbero essere destinati all’amministrazione. 500 milioni annui sono già stanziati per la graduale riduzione del debito verso la Banca d’Italia per i biglietti anticipati allo Stato; i 90 milioni di dollari del prestito Morgan passati alla Banca d’Italia hanno diminuito di 2 miliardi e mezzo il debito della circolazione per conto dello Stato: coi 500 milioni stanziati l’intero debito sarà estinto in 8 anni (questo debito fu estinto quando la riserva aurea della Banca d’Italia fu valutata secondo la stabilizzazione della lira col passaggio allo Stato della plusvalenza). Nell’ultimo conto del Tesoro il debito consolidato apparisce al 31 marzo 1927 in circa 44 miliardi e mezzo, cui vanno aggiunti circa 23 miliardi e mezzo provenienti dall’operazione dei Buoni del Tesoro e circa 3 miliardi e mezzo del prestito del Littorio; circa 71 miliardi e mezzo, nei quali la parte relativa al periodo prebellico concorre per circa 10 miliardi; e ciò senza dire né dei debiti redimibili inscritti nel gran Libro del Debito Pubblico per 3784 milioni, dei quali la metà relativi alla guerra, né dei buoni poliennali che formano una massa di 7 miliardi e 1/3; né degli altri debiti, quasi tutti redimibili, gestiti dal Debito Pubblico; né del debito per circolazione bancaria, che è ancora di 4229 Milioni (estinto in seguito come detto sopra). Trascurando i debiti redimibili, pei quali è in regolare corso l’estinzione graduale e lasciando da parte i buoni (!), poliennali, rimane il debito perpetuo.
Benefizi dell’ammortamento del debito: 1°, allevia il bilancio, se pure in misura modesta; 2°, rialza il credito dello Stato; 3°, rende possibile ottenere un nuovo prestito in circostanze gravi e imprevedute; 4°, rende possibili future conversioni; 5°, mette a disposizione della produzione le somme ammortate, creando nuovi cespiti di entrata; 6°, tiene alta la quotazione dei titoli di Stato.
Sir Felix Schuster sostenne innanzi alla Commissione d’inchiesta dei debiti pubblici che anche ed anzi specialmente nei momenti più difficili della pubblica finanza l’ammortamento del debito deve essere mantenuto perché costituisce il miglior modo di salvare il credito dello Stato ed impedisce il crollo dei suoi titoli. Ridurre il debito vuol dire rivalutare il consolidato («perciò l’impostare una volta tanto una somma per ridurre il debito pubblico, cioè la mancanza di stanziamenti fissi e intangibili, si riduce ad essere un vero e proprio agiotaggio: lo Stato compra i suoi titoli non per estinguerli gradatamente ma come operazione di borsa che ne faccia elevare la quotazione, magari per emetterne subito degli altri», A. G.). L’ammortamento deve essere necessariamente lento e moderato per non determinare bruschi spostamenti di capitale.
Prestiti americani. Da prima tali prestiti non erano assecondati. Sistemati i debiti di guerra con l’America e l’Inghilterra, la direttiva del Tesoro è mutata, con questo nuovo elemento essenziale, che il più delle volte l’alea dei cambi per i rimborsi anziché dagli Enti contrattanti il debito viene assunto dallo Stato, il che imprime agli occhi dei prestatori uno speciale carattere a tutta l’operazione. Questa garanzia va giudicata in relazione all’accentramento del controllo dei cambi prima presso il Tesoro, ed ora, molto opportunamente, presso l’Istituto dei cambi. Debiti per industria, opportuni. Debiti ai Comuni pericolosi, perché si spende e non si saprà come restituire. La contrazione di debiti all’estero è sottoposta al consenso del governo.
Imposte. 12 577 milioni d’imposte nell’esercizio 1922-1923. 16 417 milioni nell’esercizio 25‑26 con un aumento in tre anni di 3840 milioni. Inoltre nel 1925 le imposte locali erano previste in 4947 milioni, sicché carico annuale di 22 miliardi, cioè un onere superiore a quelli di tutti gli Stati europei e americani. Stati Uniti, diminuite le imposte in quattro anni, di 2 milioni di dollari. Inghilterra diminuite le imposte. In Italia, almeno non aumento e cessazione di terrore fiscale. Così nei Comuni, che affetti da manìa spendereccia e tassatrice. Mantenere le basi fondamentali della riforma tributaria unificatrice, semplificatrice e perequatrice De Stefani. Già si sono avute deviazioni da questa riforma. La nuova imposta complementare sul reddito aveva il pregio di aver ripudiato il sistema di accertamento indiziario. Ma la nuova imposta sul celibato, che varia secondo il reddito, dà luogo a un nuovo accertamento a base indiziaria, invece di essere basata sul reddito accertato agli effetti della complementare. Così si hanno due accertamenti del reddito che conducono a risultati diversi, e poiché il contrasto non è ammissibile, finisce col prevalere per ambedue la procedura indiziaria. Scopo della imposta complementare sul reddito con partecipazione degli enti locali al provento era di eliminare tutte le forme imperfette e sperequate di tasse locali sul reddito quali la tassa di famiglia e il valore locativo.
Un tentativo per l’istituzione di una strana tassa sul reddito consumato fu sventato (sic) per l’opportuno intervento del Senato. Poiché l’imposta complementare sul reddito doveva eliminare le tasse di famiglia e sul valore locativo quando fossero pagate insieme ad essa, per evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, era giusto che continuassero a pagarle coloro che non erano stati iscritti sui ruoli della complementare perché in questo caso non esisteva duplicato. Invece si lasciò ai Comuni facoltà o di continuare ad applicare la tassa di famiglia a coloro che non erano inscritti ai ruoli della complementare, ovvero applicare la tassa sul valore locativo anche a quelli che pagavano la complementare. Quasi tutti i Comuni hanno scelto quest’ultima e così siamo tornati alla doppia tassazione. Inoltre.
Gli agenti del fisco hanno sostenuto e la Commissione centrale delle imposte dirette ha sanzionato che i vecchi accertamenti della tassa di famiglia, di cui tutti avevano riconosciuto le sperequazioni, possono essere presi a base dell’accertamento per l’mposta della complementare sul reddito. Invece di essere soppressa, cioè, ha preso il sopravvento. Certo la complementare ha dato un gettito inferiore allo sperato, ma perché il gettito delle imposte nuove è sempre nel primo anno inferiore a quello che dovrebbe essere, e perché per tre anni la complementare risente delle volissime riduzioni che sono state accordate a chi ha riscattato la tassa sul patrimonio. Contro il fiscalismo. Nella seduta del Senato del 14 giugno 26 il relatore del bilancio on. Mayer, disse: «Penso che sia necessaria una completa riforma del nostro sistema tributario che data dal 1862, dei nostri sistemi di accertamento, dei nostri antiquati e deficienti regolamenti, in modo da ottenere che i cittadini non debbano considerare il rappresentante dell’Erario come un implacabile nemico». Nella fine dell’articolo si accenna addirittura a Necker, che cercò liberare la Francia dall’«impôt», cioè dalla corvée, dalla taille ecc., modernamente «vessazione fiscale», e si augura al ministro delle Finanze di emulare Necker. (Questo articolo di Tittoni deve essere considerato come l’esposizione dei desiderata della borghesia al governo dopo gli avvenimenti del novembre 1926; il linguaggio è molto cauto e involuto, ma la sostanza è molto forte. La critica risulta specialmente dal paragone tra quanto hanno fatto negli altri paesi e in Italia).
Nel fascicolo seguente della Nuova Antologia del 16 giugno1927, Alberto De Stefani, al quale Tittoni aveva in nota attribuito di preconizzare una politica di maggiori imposte e di più rigoroso regime fiscale, pubblica una lettera in cui si dichiara invece d’accordo col Tittoni e avversario della politica che gli viene attribuita. Dichiara di voler solo la rigida obbedienza alle leggi tributarie, cioè la lotta contro le evasioni fiscali. Tra le altre citazioni che fa per dimostrare l’accordo con Tittoni, è interessante questa dal «Corriere della Sera» del 28 novembre 26: «È naturale, per esempio, che l’aumento delle tariffe doganali, e così pure dei dazi interni, possa annullare la politica monetaria... È desiderabile: ... che non si influisca attraverso la finanza di Stato e la finanza locale, o in altro modo, a fare aumentare i costi di produzione». Per mitigare l’aliquota domanda: 1°, una maggiore universalità (!) nell’applicazione dei tributi (giustizia distributiva); 2°, minore evasione di quella oggi esistente, documentata dai ruoli dei contribuenti, di cui è stata interrotta la pubblicazione; 3°, economie nella spesa. Criterio generale: diminuire la pressione finanziaria nominale proporzionatamente alla rivalutazione monetaria, per non rendere più onerosa la pressione finanziaria reale.
Q2 §7 Articoli di Luzzatti nella Nuova Antologia che potrebbero essere interessanti: La tutela del lavoro nelle fabbriche (febbraio 1876); Il socialismo e le quistioni sociali dinanzi ai Parlamenti d’Europa (gennaio e febbraio 1883); Schulze‑Delitzsch (maggio 1883); I recenti scioperi del Belgio (aprile 1886); Le diverse tendenze sociali degli operai italiani (ottobre 1888); Il Risorgimento dell’internazionale (dicembre 1888); La pace sociale all’Esposizione di Parigi (dicembre 1889 ‑ gennaio 1890); Le classi dirigenti e gli operai in Inghilterra. A proposito della lotta di classe (novembre 1892); La partecipazione degli operai ai profitti dell’azienda industriale (16 maggio 1899); Le riforme sociali (1° novembre 1908); La cooperazione russa (1° luglio 1919); Gli ordinamenti tecnici delle industrie in relazione all’obbligo internazionale delle 8 ore di lavoro (1° marzo 1922).
Nella Nuova Antologia del 16 aprile 1927 è data la lista completa degli articoli pubblicati dal Luzzatti nella rivista: sono molti quelli sulla cooperazione, la previdenza, ecc. Probabilmente esiste qualche libro su questa attività del Luzzatti di cui occorre tener conto in un quadro completo del movimento operaio italiano.
Q2 §8 Un giudizio di Manzoni su Victor Hugo. «Il Manzoni mi diceva che Victor Hugo con quel suo libro sopra Napoleone rassomigliasse a uno che si creda gran suonatore d’organi e si metta a suonare, ma gli manchi chi gli tenga il mantice». R. Bonghi, I fatti miei e i miei pensieri, «Nuova Antologia», 16 aprile 27.
Q2 §9 I filosofi e la Rivoluzione francese. Nello stesso zibaldone il Bonghi scrive di aver letto un articolo di Carlo Louandre nella «Revue des deux mondes» in cui si parla di un giornale (diario) di Barbier allora pubblicato, che riguarda la società francese dal 1718 al 1762. Il Bonghi ne trae la conclusione che la società francese di Luigi XV era peggiore per ogni parte di quella che seguì la rivoluzione. Superstizione religiosa in forme morbose, mentre l’incredulità cresceva nell’ombra. Il Louandre dimostra che i «filosofi» dettero la teoria di una pratica già fatta, non la fecero.
Q2 §10 Un gondoliere veneziano faceva delle grandi sberrettate a un patrizio e dei piccoli saluti alle chiese. Un patrizio gli domandò perché facesse così e il gondoliere: Perché coi santi non si cogliona. (Bonghi, ibidem).
Q2 §11 Manzoni e Rosmini su Napoleone III. «A lui (Manzoni) che questo Luigi Napoleone non sia un miracolo, né altro la crisi presente di Francia che una fermata nella Rivoluzione di Francia. Il Rosmini invece ne fa un braccio della Provvidenza, un inviato di Dio; il che riconosce alla sua moralità e Religione; e spera assai, assai. Io sto col Manzoni». (Bonghi, ibidem).
Q2 §12 La marina mercantile italiana. Estratti dall’articolo La nostra marina transatlantica di L. Fontana Russo, nella «Nuova Antologia» del 16 aprile 1927.
Le perdite complessive della marina mercantile italiana per sottomarini e sequestri durante la guerra salirono a 872 341 tonn. lorde (238 piroscafi per 769 450 tonn. e 395 velieri per 10 891), cioè il 49% dell’intera flotta, mentre le perdite inglesi furono del 41% e le francesi del 46% («ciò nonostante la più tarda entrata in guerra, e la ritardata dichiarazione di guerra alla Germania»; A. G.: come spiegare questa percentuale così alta?) Inoltre altri 9 piroscafi per 57 440 tonn. affondarono per disgraziati accidenti dovuti allo speciale regime imposto alla navigazione (incagli per sfuggire ad attacchi di sommergibili, collisioni nella navigazione in convoglio ecc.) («quanto fu la percentuale di questi casi nelle altre marine», A. G.; la risposta interessa per giudicare nostra organizzazione e capacità dei comandi; inoltre interessante sapere l’età di questi piroscafi, per vedere come era esposta la vita dei nostri marinai). Il danno finanziario (navi e carico) fu di L. 2 202 733 047, così ripartito: naviglio da pesca L. 4 391 706; velieri L. 59 792 591; piroscafi di bandiera nazionale L. 1 595 467 786; piroscafi di bandiera estera noleggiati dall’Italia (216 piroscafi affondati, 2 danneggiati: L. 543 080 964). (Evidentemente questi piroscafi esteri non sono calcolati nel tonnellaggio precedente e anche in questo caso sarebbe interessante sapete se essi furono affondati essendo guidati da personale italiano: inoltre se le altre nazioni subirono perdite dello stesso genere).
Il totale dei carichi perduti fu di 1 271 252 tonn. I rifornimenti italiani durante la guerra furono: 49 mil. di tonn. da Gibilterra e 2 milioni dal Mediterraneo e da Suez. Le perdite subite durante la guerra furono riparate subito. Il naviglio mondiale perduto durante la guerra fu di 12 804 902 tonn. (piroscafi e velieri), cioè il 27 % del tonnellaggio complessivo. Nel 1913 la marina mondiale era di 43 079 000 tonn.; nel 1919 era di 48 milioni, nel 2 1 di 58 841 000, nel 26 di 62 671 000. I cantieri, dal 13 al 19, dopo aver colmato le perdite, accrebbero di 4 milioni il tonnellaggio. Le navi impostate furono continuate dopo l’armistizio: così si spiega che, nel 19, le navi varate raggiunsero i 7 milioni di tonnellate («ciò spiega la crisi dei noli del dopoguerra, in cui coincise un naviglio anormale con una caduta del commercio»).
Italia. Il 31 dicembre 1914 il nostro naviglio (piroscafi superiori a 250 tonn. lorde) era di 644 piroscafi per tonn.
D. W. C. 1 958 838; le perdite al 31 dicembre 1921 furono: piroscafi 354, per tonn. 1 270 348. Della vecchia flotta rimanevano 290 piroscafi, per tonn. 688 496. Fino al 31 dicembre 1921 furono costruiti 122 piroscafi per tonn. D. W. C. 698 979 e comprati all’estero 143 per 845 049, furono ricuperati dalla Regia Marina 60 per 131 725 e incorporati dalla Venezia Giulia 210 per 763 945, cioè l’aumento complessivo fu di 535 per 2 437 698, portando la flotta complessiva a 856 per 3 297 987. Alla fine del 1926 l’Italia aveva costruito inoltre 33 navi per 239 776 tonn. lorde. Le motonavi tendono ad aumentare in confronto dei piroscafi. Le 763 945 tonn. provenienti dalla Venezia Giulia furono il risultato di negoziati al Congresso della Pace con l’Inghilterra, la Francia e la Jugoslavia.
Le perdite della marina di linea (piroscafi per viaggiatori) furono meno gravi che per la flotta da carico e perciò non prontamente riparate. Così, nel dopoguerra si ebbe naviglio da carico eccessivo e di linea manchevole. Disarmo e caduta di noli per quello, richiesta e rialzo di noli per questo. Avvenne così specializzazione delle compagnie: alcune si dedicarono al carico, altre alla linea, alienando la propria flotta di carico e specializzandosi («teoricamente la specializzazione è un progresso, perché porta a minor costo: ma in caso di crisi di uno o altro ramo, la specializzazione porta al fallimento, perché non esiste più il compenso reciproco»; A. G.). Alla flotta di linea si pose un problema fondamentale: navi per emigranti o navi per viaggiatori di classe? Le maggiori compagnie si decisero nel senso di dare maggior peso ai piroscafi di lusso. Crisi dell’emigrazione per restrizioni legislative. Così si ebbe sviluppo di grandi piroscafi di lusso, per i quali non c’è limitazione di spazio e di comfort dati i noli alti.
Tendenza verso il grande tonnellaggio. Per legge economica del rendimento crescente. L’aumento della lunghezza, altezza, larghezza porta ad un aumento più che proporzionale della portata utile, cioè dello spazio dedito al carico. Cresce pure, più che proporzionalmente alla spesa di costruzione e d’esercizio, il rendimento dell’armatore. La velocità invece deve essere moderata, per essere economica (non può oltrepassare per ora i 24 nodi). Altra è la questione per la marina di guerra, i cui scopi sono bellici, non di carattere economico. Le macchine marine capaci di imprimere grandi velocità sono insaziabili divoratrici di combustibile. La velocità segue la legge dei rendimenti decrescenti, all’opposto di quella che regola la portata delle navi. Venti anni fa velocità di 11 nodi, costo orario 295 lire, 13 nodi 370 lire 21 nodi 1800 lire. Al criterio dei viaggi brevi si sostituì quello dei viaggi comodi («oggi la radio, e specialmente l’aeroplano per chi ha veramente fretta, compensano la relativa scarsa velocità delle navi di lusso; con la radio si può sempre mantenersi in comunicazione e non interrompere gli affari; con l’aeroplano si ottengono due effetti: 1°, percorrere in poche ore spazi relativamente brevi – Parigi‑Londra, ecc. – con sicurezza; 2°, i transatlantici trasportano anche aeroplani e giunti a una distanza dal capolinea che dà sicurezza di traversata, permettono ai più frettolosi di abbreviare il viaggio»; A. G.). Alla velocità di 23 nodi si è giunti sia trasformando le macchine motrici, sia adottando nuovo combustibile. La turbina sostituì le macchine alternative: il motore Diesel tende a sostituire la turbina. Il combustibile liquido sostituisce il carbone. Notevole risparmio che permise una nuova velocità economica (23 nodi).
Nuove e vecchie costruzioni. Una nave nuova, che rappresenti un forte progresso, svaluta subito, automaticamente, tutte le precedenti. Il vecchio naviglio deve essere radiato, trasformato se possibile, o adibito ad altri trasporti. Le vecchie navi rendono poco o nulla (anche se in parte ammortizzate), se non sono addirittura passive. Perciò, dati i continui progressi tecnici, gli attuali transatlantici devono atrunortizzare il capitale in poco meno d’un decennio. («Ed ecco perché nel valutare l’efficienza reale delle varie flotte nazionali, oltre al numero delle unità e alla somma complessiva delle tonnellate bisogna badare all’età del naviglio; ciò spiega anche come il rendimento di flotte inferiori per tonnellaggio sia superiore a quello di flotte che statisticamente sono più elevate: oltre al fatto dei maggiori rischi – assicurazioni – e pericoli per le vite umane rappresentati dalle vecchie navi»).
Q2 §13 Eugenio Di Carlo, Un carteggio inedito del P. L. Taparelli D’Azeglio coi fratelli Massimo e Roberto, Anonirna Romana Editoriale, Roma, 1926, L. 16,50.
Libro importante. Prospero Taparelli D’Azeglio, fratello di Massimo e di Roberto, nato a Torino il 24 ottobre 1793, entrò nella Compagnia di Gesù nel 1814 col nome di Luigi. Accanito oppositore del liberalismo, difensore dei diritti della chiesa e del potere cattolico contro il potere laicale nei suoi libri e nella «Civiltà Cattolica». Propugnò il tomismo, quando questa filosofia non godeva molte simpatie tra i gesuiti. Prima giobertiano, avversario dopo il Gesuita moderno; sostenitore della necessità di un avvicinamento e di un accordo tra liberali moderati e cattolicismo, contro il liberalismo che voleva la separazione della Chiesa dallo Stato: per il potere temporale. Il Di Carlo lo difende dall’accusa di austriacantismo e di nemico della libertà. Oltre la prefazione del Di Carlo, 44 lettere dal 21 al 62, in cui trattati i temi del giorno.
(Mi pare che anche in questo libro ci sia la tendenza a riabilitare i nemici del Risorgimento, con la scusa della «cornice dei tempi». Ma qual era questa «cornice», la reazione o il Risorgimento?).
Q2 §14 Amy A. Bernardy, Forme e colori di vita regionale italiana. Piemonte, Vol. I, Zanichelli, Bologna, L. 20. (Fare bibliografie di tutte le collezioni che si occupano della vita regionale e che abbiano un certo valore. Bibliografia legata alla quistione del folklore).
Q2 §15 Gli Albanesi d’Italia. Quando fu occupata Scutari dopo le guerre balcaniche, l’Italia vi mandò un battaglione e in esso fu incorporato un certo numero di soldati albanesi d’Italia. Siccome parlavano l’albanese, solo con la pronunzia un po’ diversa, furono accolti cordialmente. (Da un articolo molto scemo di Vico Mantegazza nella Nuova Antologia del 1° maggio 1927 Sulle vie dell’Oriente).
Q2 §16 Francesco Tommasini, Politica mondiale e politica europea, Nuova Antologia, 1° maggio ‑ 16 maggio 1927.
Egemonia politica dell’Europa prima della guerra mondiale. Il Tommasini dice che la politica mondiale è stata diretta dall’Europa fino alla guerra mondiale, dalla battaglia di Maratona (490 a. C.). (Però fino a poco tempo fa non esisteva il «mondo» e non esisteva una politica mondiale; d’altronde la civiltà cinese e quella indiana hanno pur contato qualcosa). All’inizio del secolo esistevano tre potenze mondiali europee, mondiali per l’estensione dei loro territori, per la loro potenza economica e finanziaria, per la possibilità di imprimere alla loro attività una direzione assolutamente autonoma, di cui tutte le altre potenze, grandi e minori, dovevano subire l’influsso: Inghilterra, Russia, Germania. (Il Tommasini non considera la Francia come potenza mondiale!) Inghilterra: aveva battuto tre grandi potenze coloniali (Spagna, Paesi Bassi, Francia) e asservito la quarta (Portogallo), aveva vinto le guerre napoleoniche ed era stata per un secolo arbitra del mondo intero. Two powers standard. Punti strategici mondiali nelle sue mani (Gibilterra, Malta, Suez, Aden, isole Bahrein, Singapore, Hong‑Kong). Industrie, commercio, finanze. Russia: minacciava India, tendeva a Costantinopoli. Grande esercito. Germania: attività intellettuale, concorrenza industriale all’Inghilterra, grande esercito, flotta minacciosa per il two powers standard.
Formazione della potenza degli Stati Uniti. Indipendenza nel 1783, riconosciuta dall’Inghilterra col trattato di Versailles: comprendevano allora 13 Stati, di cui 10 di originaria colonizzazione britannica e 3 (New‑York, New Jersey e Delaware) ceduti dai Paesi Bassi all’Inghilterra nel 1667, con circa 2 milioni di Km2 ma la parte effettivamente popolata era solo quella sulla costa orientale dell’Atlanti co. Secondo il censimento del 1790, la popolazione non arrivava a 4 milioni, compresi 700 000 schiavi. Su quello stesso territorio nel 1920 esistevano 20 Stati con 71 milioni di abitanti. Allora gli Stati Uniti confinavano a Nord col Canadà, che la Francia aveva ceduto all’Inghilterra nel 1763, dopo la guerra dei 7 anni; ad Ovest con la Luisiana, colonia francese che fu comperata nel 1803 per 15 milioni di dollari (territorio di 1 750 000 Km2) così che tutto il bacino del Mississipì si trovò in suo dominio e il confine cadde sul fiume Sabine colla colonia spagnola del Messico. A Sud colla Florida spagnola che fu acquistata nel 1819.
Il Messico, che allora era il doppio dell’attuale, insorse nel 1810 contro la Spagna e nel 1821 fece riconoscere la sua indipendenza col trattato di Cordova. Da quel momento gli Stati Uniti iniziarono una politica intesa ad accaparrarsi il Messico: l’Inghilterra sosteneva l’imperatore Yturbide, gli Stati Uniti favorirono un movimento repubblicano che trionfò nel 1823. Intervento francese in Spagna. Opposizione dell’Inghilterra e degli Stati Uniti alla politica della Santa Alleanza di aiutare la Spagna a riconquistare le colonie americane. Da ciò è determinato il messaggio del Presidente Monroe al Congresso (2 dicembre 1823) in cui enunciata la teoria famosa. Si domanda di non intervenire contro le ex‑colonie che hanno proclamato la loro indipendenza, che l’hanno mantenuta e che è stata riconosciuta dagli Stati Uniti, i quali non potrebbero rimanere indifferenti spettatori di un simile intervento qualunque forma fosse per assumere.
Nel 1835 il Texas (690 mila Km2) si dichiarò indipendente dal Messico e dopo un decennio si unì agli Stati Uniti. Guerra fra Stati Uniti e Messico. Col trattato di Guadalupa Hidalgo (1848) il Messico dovette cedere il territorio costituente gli attuali Stati della California, dell’Arizona, del Nevada, dell’Utah e del Nuovo Messico (circa 1 700 000 Km2). Gli Stati Uniti arrivarono così sulla costa del Pacifico, che fu occupata poi fino alla frontiera del Canadà, e raggiunsero le dimensioni attuali.
Dal 60 al 65 guerra di secessione: Francia e Inghilterra incoraggiarono il movimento separatista del Sud e Napoleone III cercò di approfittare della crisi per rafforzare il Messico con Massimiliano. Gli Stati Uniti, finita la guerra civile, ricordarono la dottrina di Monroe a Parigi, esigendo il ritiro delle truppe francesi dal Messico. Nel 1867 acquisto dell’Alaska. L’espansione degli Stati Uniti come grande potenza mondiale, comincia alla fine dell’800.
Problemi principali americani: 1°, regolamento dell’emigrazione per assicurare una maggiore omogeneità della popolazione (veramente questo problema si pose dopo la guerra ed è legato, oltre che alla quistione nazionale, anche e specialmente alla rivoluzione industriale); 2°, egemonia sul mar Caraibico e sulle Antille; 3°, dominio sull’America Centrale, specialmente sulle regioni dei canali; 4°, espansione nell’Estremo Oriente.
Guerra mondiale. Imperi centrali bloccati: l’Intesa padrona dei mari: gli S. U. rifornirono l’Intesa, sfruttando tutte le buone occasioni che si offrivano. Il costo colossale della guerra, i profondi turbamenti della produzione europea (la rivoluzione russa), hanno fatto degli Stati Uniti gli arbitri della finanza mondiale. Quindi la loro affermazione politica.
Inghilterra e Stati Uniti dopo la guerra. L’Inghilterra è uscita dalla guerra come trionfatrice. La Germania privata della flotta e delle colonie. La Russia, che poteva ridiventare rivale, ridotta a fattore secondario per almeno qualche decennio (questa opinione è discutibile molto: forse gli inglesi avrebbero preferito come rivale la Russia zarista, anche vittoriosa, all’attuale Russia, che non solo influisce sulla politica imperiale, ma anche sulla politica interna inglese). Ha acquistato circa altri 10 milioni di Km2 di possedimenti con circa 35 milioni di abitanti. Tuttavia l’Inghilterra ha dovuto riconoscere tacitamente la supremazia degli Stati Uniti, e ciò sia per ragioni economiche sia per la trasformazione dell’Impero. La ricchezza degli Stati Uniti che si calcolava in 925 miliardi di franchi oro nel 1912, era salita nel 1922 a 1600 miliardi. La marina mercantile: 7 928 688 tonn. nel 1914, 12 500 000 nel 1919. Le esportazioni: 1913, 15 miliardi franchi oro; nel 1919, 37 miliardi e 1/2, ridiscendendo a circa 24 miliardi nel 1924‑25. Importazioni: 10 miliardi circa nel 1913, 16 nel 191, 19 nel 1924‑25.
La ricchezza della Gran Bretagna nel decennio 1912‑22 è salita solo da 387 a 445 miliardi di franchi oro. Marina mercantile: 1912, 13 850 000 tonn.; 1922, 11 800 000. Esportazioni: 1913, 15 miliardi circa di franchi oro; 1919, 17 miliardi; 1924, 20 miliardi. Importazioni: 1913, 19 miliardi; 1919, 281/2 miliardi circa; 1924, 271/2 miliardi. Debito pubblico: 31 marzo 1915: 1162 milioni di sterline; 1919: 7481 milioni; 1929: 8482 milioni; all’attivo vi erano, dopo la guerra, crediti per prestiti a Potenze alleate, colonie e domìni, nuovi Stati dell’Europa orientale ecc., che nel 1919 ascendevano a 2541 milioni di sterline e nel 1924 a 2162. Ma non erano di sicura riscossione integrale. Per es. il debito italiano era nel 1924 di 553 e nel 1925 di 584 mil. di sterline, ma con l’accordo del 27 gennaio 1926 l’Italia pagherà in 62 anni solo 276 750 000 sterline interessi compresi. Nel 1922 l’Inghilterra invece consolidò il suo debito verso gli Stati Uniti in 4600 milioni di dollari, rimborsabili in 62 anni con interesse del 3 % fino al 1932 e del 3 1/2% in seguito.
Impero inglese. Da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda è diventato l’«Unione britannica di Nazioni» (British Commonwealth of Nations). Tendenze particolarisfiche. Canadà, Australia e Nuova Zelanda in una posizione intermedia tra Inghilterra e Stati Uniti. Rapporti tra Stati Uniti e Canadà sempre più intimi. Canadà speciale ministro plenipotenziario a Washington. Se urto serio tra Stati Uniti e Inghilterra l’Impero inglese si sgretolerebbe.
Wilson. Politica mondiale di Wilson. Suo contrasto con le forze politiche preponderanti negli Stati Uniti. Fallimento della sua politica mondiale. Warren G. Harding diventa presidente il 4 marzo 1921. Colla sua nota del 4 aprile seguente Harding, a proposito della quistione dell’isola di Yap, precisa che gli Stati Uniti non intendono intervenire nei rapporti fra gli Alleati e la Germania, né chiedere la revisione del trattato di Versailles, ma mantenere tutti i diritti che le derivano dal suo intervento nella guerra. Questi principii furono svolti nel messaggio del 12 aprile e condussero alla conferenza di Washington che durò dal 12 novembre 1921 al 6 febbraio 1922 e si occupò della Cina, dell’equilibrio nei mari dell’Estremo Oriente e della limitazione degli armamenti navali.
Popolazione degli Stati Uniti. Sua composizione nazionale data dall’immigrazione. Politica governativa. Nel 1882 proibito l’accesso agli operai cinesi. Col Giappone furono dapprima usati certi riguardi, ma nel 1907 col così detto Gentlemen’s agreement Root‑Takahira l’immigrazione giapponese, senza essere respinta come tale, fu grandemente ostacolata mediante clausole circa la cultura, le condizioni igieniche e la fortuna degli immigranti. Ma il gran mutamento della politica d’immigrazione è avvenuto dopo la guerra: la legge 19 maggio 1921, rimasta in vigore fino al 1° luglio 1924, stabilì che la quota annua d’immigrazione di ogni singola nazione dovesse limitarsi al 3% dei cittadini americani della rispettiva nazione, secondo il censimento del 1910. (Successive modifiche). L’immigrazione gialla definitivamente esclusa.
Gli Stati Uniti nel Mar Caraibico. Guerra ispano‑americana. Col trattato di pace di Parigi (10 dicembre 1898) la Spagna rinunciò a ogni suo diritto su Cuba e cedette agli Stati Uniti Porto Rico e le altre sue isole minori. L’isola di Cuba, che domina l’entrata del golfo del Messico, doveva essere indipendente e si promulgò una costituzione il 12 febbraio 1901; ma gli Stati Uniti, per riconoscere l’indipendenza e ritirare le truppe, si fecero garantire il diritto d’intervento. Col trattato di reciprocità del 2 luglio 1903 gli Stati Uniti ottennero vantaggi commerciali e l’affitto come base navale della baia di Guantanamo.
Gli Stati Uniti intervennero nel 1914 ad Haiti: il 16 settembre 1915 un accordo dette il diritto agli Stati Uniti di avere a Port‑au‑Prince un loro alto commissario da cui dipende l’amministrazione delle dogane. La repubblica di San Domingo fu posta sotto il controllo finanziario americano nel 1907 e durante la guerra vi furono sbarcate truppe, ritirate nel 1924. Nel 1917 gli Stati Uniti comprarono dalla Danimarca l’arcipelago delle Vergini. Così gli Stati Uniti dominano il golfo di Messico e il Mare Caraibico.
Gli Stati Uniti e l’America Centrale. Canale di Panama e altri possibili canali. La repubblica di Panama si è impegnata col trattato di Washington del 15 dicembre 1926 a dividere le sorti degli Stati Uniti in caso di guerra. Il trattato non ancora ratificato perché incompatibile con lo Statuto della Società delle Nazioni di cui il Panama fa parte, ma la ratifica non necessaria. Quistione del Nicaragua.
La Cina. L’America nel 1899 proclamò la politica dell’integrità territoriale cinese e della porta aperta. Nel 1908, con lo scambio di Root‑Takahira, Stati Uniti e Giappone rinnovarono dichiarazioni solenni sull’integrità e l’indipendenza politica della Cina. Dopo l’accettazione da parte della Cina delle così dette «ventun domande» del Giappone (ultimatum 1915) gli Stati Uniti dichiarano ( del 13 maggio 1915 a Pekino e Tokio) che non riconoscevano gli accordi conclusi. Alla Conferenza di Washington gli Stati Uniti ottennero che le potenze europee e il Giappone rinunziassero a buona parte dei vantaggi speciali e dei privilegi che si erano assicurati. Il Giappone si impegnò a sgombrare il Kiau‑Ceu. Solo in Manciuria il Giappone mantenne la sua posizione. Fin dal 1908 gli Stati Uniti avevano rinunziato alle indennità loro spettanti dopo la rivolta dei boxers e avevano adibito le somme relative a scopi culturali in Cina. Nel 1917 la Cina sospese i pagamenti. Accordi: Giappone e Inghilterra hanno rinunziato come gli Stati Uniti; la Francia si è servita dei fondi per risarcire i danneggiati del fallimento della Banca industriale di Cina: Italia e Belgio hanno consentito a consacrare a scopi culturali circa i 4/5 delle somme ancora dovute.
Estremo Oriente. Possessi degli Stati Uniti: le Filippine e l’isola di Guam (Marianne); le Hawai; l’isola di Tutuila nel gruppo della Samoa. Prima del trattato di Washington la situazione nell’Estremo Oriente era dominata dall’alleanza anglo‑giapponese, conclusa col trattato difensivo di Londra del 30 gennaio 1902, basato sull’indipendenza della Cina e della Corea, con prevalenza di interessi inglesi in Cina e giapponesi in Corea; dopo la disfatta russa, fu sostituito dal trattato del 12 agosto 1905: l’integrità della Cina ribadita e l’eguaglianza economica e commerciale di tutti gli stranieri, i contraenti si garantivano reciprocamente i loro diritti territoriali e i loro interessi speciali nell’Asia Orientale e in India: supremazia giapponese in Corea e diritto dell’Inghilterra di difendere l’India nelle regioni cinesi vicine, cioè il Tibet. Questa alleanza vista di malocchio da Stati Uniti. Attriti durante la guerra. Nella seduta del 10 dicembre 1921 della Conferenza di Washington lord Balfour annunziò la fine dell’alleanza, sostituita col trattato 13 dicembre 1921 con cui la Francia, l’Inghilterra, gli Stati Uniti e il Giappone si impegnano per dieci anni: 1°, a rispettare i loro possedimenti e domìni insulari nel Pacifico e a deferire ad una Conferenza degli Stati stessi le controversie che potessero sorgere fra alcuni di loro circa il Pacifico e i possedimenti e domìni in quistione; 2°, a concertarsi nel caso di attitudine aggressiva di altra potenza. Il trattato si limita ai possedimenti insulari e per ciò che riguarda il Giappone si applica a Karafuto (Sakhalin meridionale) a Formosa e alle Pescadores, ma non alla Corea e a Porto Arthur. Una separata dichiarazione specifica che il trattato si applica anche alle isole sotto mandato nel Pacifico, ma che ciò non implica il consenso ai mandati da parte degli Stati Uniti. La reciproca garanzia dello statu quo ha speciale importanza per le Filippine, poiché impedisce al Giappone di fomentarvi il malcontento degli indigeni.
Nel trattato per la limitazione degli armamenti navali c’è una disposizione importantissima (art. 19) con cui Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, si impegnano fino al 31 dicembre 1936 di mantenere lo statu quo per ciò che riguarda le fortificazioni e le basi navali nei possedimenti e domìni situati ad oriente del meridiano 110 di Greenwich, che passa per l’isola di Hainan. Il Giappone è sacrificato, perché ha le mani legate anche per i piccoli arcipelaghi vicini alle grandi isole metropolitane. L’Inghilterra può fortificare Singapore e gli Stati Uniti le Hawai, dominando così entrambi gli accessi al Pacifico. Limitazione delle navi di linea. Ottenimento della parità navale tra Stati Uniti e Inghilterra.
Egemonia degli Stati Uniti. Il Tommasini prevede alleanza tra Stati Uniti e Inghilterra e che dall’Asia partirà la riscossa contro di essa per una coalizione che può comprendere la Cina, il Giappone e la Russia col concorso tecnico-industriale della Germania. Egli si basa ancora sulla prima fase del movimento nazionalista cinese.
Q2 §17 Guido Bustico, Gioachino Murat nelle memorie inedite del generale Rossetti, Nuova Antologia, fascicoli del 16 maggio e 1° giugno e 16 giugno 1927.
Il generale Giuseppe Rossetti, piemontese di nascita, francese di elezione, fu prima ufficiale superiore dell’esercito francese e poi dell’esercito napoletano di Murat. Scrisse quattro grossi volumi di ricordi, rimasti inediti, in francese, dal 20 dicembre 1796 al 6 novembre 1836, ricchi di notizie politiche riguardanti l’Italia e la Francia. Il Bustico ne assicura la serenità ed imparzialità e ne estrae notizie sulla «nuova politica» di Murat dopo la battaglia di Lipsia (avvicinamento all’Austria), sulla missione data a un certo G. Grassi nel marzo 1815 di recarsi nell’alta Italia e vedere quali appoggi avrebbe avuto un’iniziativa di Murat per l’indipendenza italiana, e sulla fuga di Murat da Napoli fino alla sua fucilazione.
Q2 §18 Una politica di pace europea, di Argus, «Nuova Antologia», 1° giugno 1927. Parla delle frequenti visite in Inghilterra di uomini politici e letterati tedeschi. Questi intellettuali tedeschi, interrogati, dichiarano che ogni qualvolta riescono a prendere contatto con influenti personalità anglosassoni viene loro posto questo problema: «Qual è l’atteggiamento della Germania di fronte alla Russia?» e soggiungono con disperazione (!): «Ma noi non possiamo prendere parte nelle controversie tra Londra e Mosca!» Al fondo della concezione britannica della politica estera sta la convinzione che il conflitto con la Russia non solo è inevitabile ma è già impegnato, benché sotto forme strane e insolite che lo rendono invisibile agli occhi della grande massa nazionale. Articolo ultra‑anglofilo (nello stesso periodo ricordo un articolo di Manfredi Gravina nel «Corriere della Sera» di una anglofilia così scandalosa da maravigliare: si predicava la subordinazione dichiarata dell’Italia all’Inghilterra): gli Inglesi vogliono la pace, ma hanno dimostrato di saper fare la guerra. Sono sentimentali e altruisti: pensano agli interessi europei; se Chamberlain non ha rotto con la Russia è perché ciò poteva nuocere a altri Stati in condizioni meno favorevoli dell’Inghilterra ecc.
Politica inglese di intesa con la Francia è la base, ma il governo inglese può favorire anche altri Stati: l’Inghilterra vuol essere amica di tutti. Quindi avvicinamento all’Italia e alla Polonia. In Inghilterra un certo numero di persone non favorevoli al regime italiano. Ma la politica inglese lealmente amica e sarà tale anche mutando regime, anche perché la politica italiana è coraggiosa, ecc. ecc.
Q2 §19 Articolo di Roger Labonne nel «Correspondant» del 10 gennaio 1927 su Italia e Asia Minore. L’Italia si interessa per la prima volta nel 1900 dell’Asia Minore invia una serie di missioni che studiano l’Anatolia meridionale, stabilisce ad Adalia un vice‑console, delle scuole, un ospedale, sovvenziona le linee di navigazione che portano la sua bandiera lungo il litorale. S’interessa soprattutto di Smirne, del cui porto fa il centro della sua influenza nel Levante. Gli articoli 8 e 9 del Patto di Londra dicono: «L’Italia riceverà l’intera sovranità del Dodecanneso. In caso di divisione totale o parziale della Turchia, essa otterrà la regione mediterranea che avvicina la provincia di Adalia e che ha già fatto (!) una convenzione coll’Inghilterra». A San Giovanni di Moriana l’Italia precisa nuovamente la sua richiesta (21 aprile 1917).
Venizelos, approfittando della partenza di Orlando e Sonnino da Parigi, spinse gli alleati ad assegnare Smirne alla Grecia. Il 1° gennaio 1926, nel discorso di Milano, Mussolini dice: «Bisogna aver fede nella Rivoluzione, che avrà nel 1926 il suo anno napoleonico». Nel 26 non si produsse nulla di veramente notevole, ma per due volte si fu alla vigilia di avvenimenti serii. Cessione di Mossul all’Irak (cioè agli inglesi). La Turchia cedette davanti all’imminenza di un intervento italiano, dopo di aver invano domandato il concorso militare di Mosca in caso di conflitto sul Meandro e sul Tigri. I giornali londinesi confessano ingenuamente che il successo di Mossul è dovuto alla pressione italiana, ma il governo inglese non si preoccupa troppo dell’Italia. Nel gioco anatolico l’Italia ha perduto nel 1926 le sue due carte migliori: con l’accordo di Mossul e con la caduta di Pangalos.
Q2 §20 Per i rapporti tra il Centro tedesco e il Vaticano e quindi per studiare concretamente la politica tradizionale del Vaticano nei vari paesi e le forme che essa assume è interessantissimo un articolo di André Lavedan nella «Revue Hebdomadaire» riassunto nella «Rivista d’Italia» del 15 marzo 1927. Leone XIII domandava al Centro di votare a favore della legge sul settennato di Bismarck, avendo avuto assicurazioni che ciò avrebbe portato a una soddisfacente modificazione delle leggi politico‑ecclesiastiche. Frankestein e Windthorst non vollero uniformarsi all’invito del Vaticano. Del Centro solo 7 votarono la legge: 83 si astennero.
Q2 §21 L’Etiopia d’oggi (articolo della «Rivista d’Italia» firmato tre stelle). L’Etiopia è il solo Stato indigeno indipendente in un’Africa ormai tutta europea (oltre la Liberia). Menelik è stato il fondatore della moderna unità etiopica: i nazionalisti abissini si richiamano a Menelik, il «grande e buono imperatore». Degli elementi che hanno contribuito ad assicurare l’indipendenza dell’Etiopia due sono evidenti: la struttura geografica del paese e la gelosia fra le potenze. La struttura geografica fa dell’Etiopia un immenso campo trincerato naturale, espugnabile solo con forze smisurate e sacrifizi non proporzionati alle scarse risorse economiche che il paese può offrire all’eventuale conquistatore. Lo Scioa, che ha creato l’unità abissina, è a sua volta una fortezza nel campo trincerato e tutto lo guarda e lo domina. Nell’ultimo trentennio è stato creato un esercito imperiale, distinto dai piccoli eserciti dei ras e ad essi superiore tecnicamente; la creazione dell’esercito nazionale è dovuta a Menelik.
Già prima della morte di Menelik (1913) la Corte, dato lo sfacelo intellettuale del vecchio imperatore, aveva proclamato (14 aprile 1910) imperatore Ligg Jasu, figlio di una figlia di Menelik, e di ras Mikael. Alla morte di Menelik (11 dicembre 1913) le lotte si scatenarono: Zeoditù, altra figlia di Menelik, e ras Tafari, figlio di ras Makonnen, si coalizzarono e riuscirono ad avere un imponente numero di partigiani. Tafari aveva con sé i giovani. Ras Mikael, tutore di Ligg Jasu minorenne, fu incapace di imporsi alle fazioni e di assicurare l’ordine pubblico come risultò in occasione dell’assalto del 17 maggio 1916 alla Legazione d’Italia. La guerra europea salvò l’Abissinia da un intervento straniero e dette la possibilità all’Abissinia di superare la crisi da sé. Zeoditù e Tafari si unirono per detronizzare Ligg Lasu e dividersi il potere, Zeoditù come imperatrice nominale, l’altro quale erede al trono e reggente (27 settembre 1916). Tafari, appoggiato dai capi militari, ha saputo con energia e scaltrezza ridurre all’obbedienza il paese. Ma il condominio con Zeoditù offrì spesso il destro a intrighi di palazzo non sempre innocui. (Alla fine del 26 o principio del 27) sparirono quasi contemporaneamente il ministro della guerra, fitaurari Hapte Gheorghes e il capo della Cheesa, abuna Mattheos.
La morte dell’abuna ha scatenato la quistione della chiesa nazionale. La chiesa etiopica riconosceva la suprema autorità del patriarca copto di Alessandria che nominava all’alto ufficio di abuna un egiziano (Mattheos era egiziano). Il nazionalismo etiopico vuole un abuna abissino. L’abuna ha in Abissima una grandissima importanza (più che l’arcivescovo‑primate delle Gallie in Francia) e il fatto che sia straniero presenta dei pericoli, nonostante che la sua autorità sia corretta e in un certo senso controllata dall’echegheh indigeno dal quale dipendono direttamente i numerosi ordini monastici.
La parte presa da Mattheos nel colpo di Stato del 27 settembre 1912 a favore di Tafari ha mostrato ciò che potrebbe avvenire. (Quando l’articolo veniva pubblicato il patriarca d’Alessandria resisteva ancora alla pretesa abissina: vedere il seguito della quistione). (L’Abissinia ha una capitale religiosa: Aksum). Tafari ha cercato di imprimere un ritmo nuovo alla politica estera abissina. Menelik aveva cercato di limitare la schiavitù e di introdurre l’istruzione obbligatoria, avviando lo Stato verso forme moderne, ma si teneva in un’attitudine di dissidente isolamento. Tafari invece ha cercato di partecipare alla vita europea e si è fatto ammettere nella Lega delle Nazioni, impegnandosi formalmente a estirpare nel più breve termine possibile la schiavitù. E infatti emanò un bando che imponeva la graduale liberazione degli schiavi, ma finora senza risultato. Gli schiavisti molto forti. (D’altronde l’Etiopia ancora feudale).
Convenzione di Londra del 13 dicembre 1906 fra Italia, Francia, Inghilterra, con cui i tre confinanti si impegnarono: a rispettare lo statu quo politico e territoriale dell’Etiopia; a mantenere, in caso di contese o mutamenti interni, la più stretta neutralità, astenendosi da ogni intervento negli affari interni del paese; qualora lo statu quo fosse turbato, a cercare di mantenere l’integrità dell’Etiopia, tutelando in ogni caso i rispettivi interessi: per l’Inghilterra il bacino del Nilo e la regolarizzazione delle acque di quel fiume e dei suoi affluenti; per l’Italia l’hinterland dei suoi possedimenti dell’Eritrea e della Somalia e l’unione territoriale tra essi ad ovest di Addis Abeba; per la Francia l’hinterland di Gibuti e la zona necessaria per la costruzione e il traffico della ferrovia Gibuti ‑ Addis Abeba. Le tre potenze si impegnavano di aiutarsi scambievolmente per la protezione dei loro rispettivi interessi.
L’accordo fu concepito in pieno «giro di valzer» dell’Italia con le potenze occidentali, e cioè in pieno sviluppo di quel vasto programma di intese mediterranee (l’accordo di Londra era stato conchiuso in massima il 6 luglio, tre mesi dopo Algesiras) che fu troncato un paio d’anni dopo sotto il ricatto (!) dello stato maggiore austriaco. Così alla politica di cooperazione succedette una lotta a colpi di spillo: la sola a guadagnarci fu la Francia che poté prolungare la ferrovia fino ad Addis Abeba (la diplomazia sostiene che l’accordo di Londra fu sottoposto preventivamente a Menelik e firmato solo quand’egli ebbe dato il nulla osta ai ministri delle tre potenze accreditati presso di lui, cosicché le stipulazioni dell’accordo sarebbero anche concessioni implicitamente (!) promesse dall’Abissinia qualcosa come la situazione del famoso trattato di Uccialli, ancora peggiorato).
Dopo la guerra europea, durante le trattative per i compensi coloniali fissati dal patto di Londra, l’Italia propose di ravvivare l’accordo del 1906, volendo risolvere il problema del congiungimento ferroviario tra l’Eritrea e la Somalia. Ma Londra e Parigi rifiutarono. La Francia non aveva nulla da chiedere all’Abissinia dopo la ferrovia Gibuti ‑ Addis Abeba; l’Inghilterra credeva di ottenere tutto senza unirsi all’Italia. Ma l’Inghilterra fece poi l’accordo del 1925 (due scambiate tra Mussolini e l’ambasciatore inglese a Roma il 14 e il 20 dicembre 1925). Per esso: l’Italia si impegna ad appoggiare l’Inghilterra nei suoi tentativi per ottenere dall’Etiopia la concessione di lavori di sbarramento al Lago Tana, nella zona che nel 1906 era riservata all’influenza italiana e la concessione di un’autostrada fra il Sudan e il Tana; l’Inghilterra ad appoggiare l’Italia per ottenere la costruzione e l’esercizio di una ferrovia tra l’Eritrea e la Somalia italiana ad ovest di Addis Abeba; l’Inghilterra riconosce all’Italia l’influenza esclusiva (!) nella zona occidentale dell’Etiopia e in tutto il territorio destinato ad essere attraversato dalla ferrovia, con l’impegno da parte dell’Italia di non compiere in quella zona, sulle sorgenti del Nilo Azzurro e del Nilo Bianco e dei loro affluenti, alcuna opera che possa sensibilmente modificare il loro afflusso nel fiume principale. La Francia sollevò gran rumore su questo accordo, presentato come una minaccia dell’indipendenza abissina. La campagna francese ebbe gravi ripercussioni sul nazionalismo etiopico. Ras Tafari ha creato due tipografie per la stampa in lingua amarica: sviluppo di letteratura nazionalista incoraggiato da Tafari: xenofobia. Il Giappone è il modello del nazionalismo abissino.
L’articolo della «Rivista d’Italia» riporta brani di articoli e opuscoli: uno studente che è stato educato in America scrive: «Impariamo fortemente, apprendiamo molto, perché non vengano gli stranieri a governarci! ... Dobbiamo studiare più che possiamo, perché, se non studiamo, la nostra patria è finita». La Francia desta meno sospetti ad Addis Abeba, perché dopo Fascioda, Gibuti ha per essa solo l’importanza di uno scalo sulla via dell’Indocina. Inoltre, la ferrovia Gibuti ‑ Addis Abeba, che serve tutto il traffico esterno dell’Etiopia, dà alla Francia un monopolio che essa vorrebbe conservare: la Francia può quindi fare una politica di apparente disinteressamento. Ma Ras Tafari vuol far progredire l’Etiopia e quindi è favorevole ad altre ferrovie, opere idrauliche ecc.
Esiste ancora tra l’Etiopia e l’Italia una piccola quistione a proposito dei confini tra Etiopia e Somalia. Quando dopo la convenzione di Addis Abeba del 16 maggio 1908 fu definita la frontiera, la missione Citerni eseguì il tracciato sul terreno per quel che riguardava il Benadir. Si lasciò da parte la frontiera del sultanato di Obbia che non presentava urgenza data la speciale situazione di quel protettorato. Ma oggi Obbia è occupata dalle armi italiane e bisognerà fissare il tracciato del confine con l’Etiopia.
Q2 §22 Stefano Jacini, Un conservatore rurale della nuova Italia. Due volumi di complessive 600 pagine con indice dei nomi. Bari, Laterza.
È la biografia di Stefano Jacini senior scritta da suo nipote. Lo Jacini ha utilizzato l’archivio domestico, ricco fra l’altro di un epistolario in molta parte inedito. Chiarisce e completa periodi ed episodi della storia 1850‑1890. Lo Jacini non fu personalità di prima linea, ma ebbe un carattere proprio. Ebbe una parte non trascurabile nell’opera di unificazione economica della nazione (unificazione ferroviaria, valico del Gottardo, inchiesta agraria). Sostenitore di un partito conservatore nazionale (clericale) (lo Jacini agricoltore e filatore di seta). Non prese parte al movimento del 48. («Aveva una cultura internazionale fatta in molti viaggi, ciò che gli diede una visione europea della rivoluzione del 48, visione che lo trattenne dal prendervi parte attiva quando scoppiò in Italia»: così su per giù scrive Filippo Meda). Insomma lo Jacini seguì l’atteggiamento della sua classe che era reazionaria ed austriacante.
Sotto il governo di Massimiliano, collaborò. Si occupò di quistioni tecniche ed economiche. Fautore di Cavour, cioè dell’indipendenza senza rivoluzione. Fu attaccato quando era ministro con Cavour, per il suo passato prima del 59 e difeso dal Cattaneo.
Nel gennaio 1870 uscì il suo libro Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dove appare la tesi di un’Italia reale diversa e dissenziente dall’Italia legale (formula poi usata dai clericali): contro il Parlamento che voleva ridotto alle grandi quistioni della difesa dello Stato, della politica estera, della finanza centrale; decentramento regionale; suffragio universale indiretto col voto agli analfabeti (cioè potere agli agrari).
Nel 1879 pubblica I conservatori e la evoluzione naturale dei partiti politici in Italia. lmmagina l’equilibrio politico così: estrema sinistra, repubblicani; estrema destra, clericali intransigenti (egli pensava a un prossimo abbandono dell’astensionismo); nel mezzo, due partiti di governo, uno decisamente conservatore nazionale, l’altro liberale‑monarchico progressivo.
Contro Crispi e la megalomania politica. (Emanuele Greppi, Gaetano Negri, Giuseppe Colombo accettavano il suo pensiero: moderati lombardi). Lo Jacini offre un esemplare compiuto di una classe, gli agrari settentrionali: la sua attività politica e letteraria è interessante perché da essa hanno tratto spunto e motivi movimenti posteriori (Partito Popolare, ecc.). (Contrario nel 71 al trasferimento della capitale a Roma).
Q2 §23 Eurasiatismo. Il movimento si svolge intorno al giornale Nakanune, che tende alla revisione dell’atteggiamento assunto dagli intellettuali emigrati: è cominciato nel 1921. La prima tesi dell’eurasiatismo è che la Russia è più asiatica che occidentale. La Russia deve mettersi alla testa dell’Asia nella lotta contro il predominio europeo. La seconda tesi è che il bolscevismo è stato un avvenimento decisivo per la storia della Russia: ha «attivato» il popolo russo ed ha giovato all’autorità e all’influenza mondiale della Russia con la nuova ideologia che ha diffuso. Gli Eurasiatici non sono bolscevichi ma sono nemici della democrazia e del parlamentarismo occidentale. Essi si atteggiano spesso a fascisti russi, come amici di uno Stato forte in cui la disciplina, l’autorità, la gerarchia abbiano a dominare sulla massa. Sono partigiani di una dittatura e salutano l’ordine statale vigente nella Russia dei Soviet per quanto essi vagheggino di sosostituire l’ideologia nazionale a quella proletaria. L’ortodossia è per loro l’espressione tipica del carattere popolare russo; essa è il cristianesimo dell’anima eurasiatica.
Q2 §24 Politica mondiale e politica europea. Non sono una stessa cosa. Un duello tra Berlino e Parigi o tra Parigi e Roma non fa del vincitore il padrone del mondo. L’Europa ha perduto la sua importanza e la politica mondiale dipende da Londra, Washington, Mosca, Tokyo più che dal continente.
Q2 §25 Il nazionalismo italiano. Primo congresso del Partito Nazionalista (Associazione Nazionalista) a Firenze nel dicembre 1910, con la presidenza di Scipio Sighele: Gualtiero Castellini, Federzoni, Corradini, Paolo Arcari, Bevione, Bodrero, Gray, Rocco, Del Vecchio. Gruppo ancora indistinto, che cercava di cristallizzare intorno ai problemi della politica estera e dell’emigrazione le correnti meno pacchiane del tradizionale patriottismo (è un’osservazione poco fatta che in Italia, accanto al cosmopolitismo e apatriottismo più superficiale è sempre esistito uno sciovinismo frenetico, che si collegava alle glorie romane e delle repubbliche marinaresche e alle fioriture individuali di artisti, letterati, scienziati di fama mondiale. Lo sciovinismo italiano è caratteristico ed ha dei tipi assolutamente suoi: esso era accompagnato da una xenofobia popolaresca anch’essa caratteristica). Il primo nazionalismo comprendeva molti democratici e liberali e anche massoni. Poi il movimento si andò distinguendo e precisando per opera di un piccolo gruppo di intellettuali che saccheggiarono le ideologie e i modi di ragionare secchi, imperiosi, pieni di mutria e di suffisance di Carlo Maurras: Coppola, Forges Davanzati, Federzoni. (Importazione sindacalista nel nazionalismo). In realtà i nazionalisti erano antirredentisti: la loro posizione fondamentale era antifrancese. Subirono l’irredentismo perché non volevano fosse un monopolio dei repubblicani e dei radicali massoni, cioè un’arma dell’influenza francese in Italia.
Teoricamente la politica estera dei nazionalisti non aveva fini precisi: si poneva come una astratta rivendicazione imperiale contro tutti; in realtà voleva sopprimere la francofilia democratica e rendere popolare la alleanza tedesca.
Q2 §26 I giornali tedeschi. Tre grandi concentrazioni giornalistiche: Ullstein, Mosse, Scherl, le due prime democratiche, la terza di destra (stampa di Hugenberg).
La casa Ullstein stampa: la «Vossische Zeitung», per il pubblico colto, di scarsa tiratura (40 000 copie?) ma di importanza europea, diretta da Giorgio Bernhard (passa per essere troppo francofila); la «Morgenpost», il più diffuso giornale di Berlino e forse della Germania (forse 500 000 copie), per la piccola borghesia e gli operai; la «Berliner Allgemeine Zeitung», che si occupa di quistioni cittadine; la «Berliner Illustrierte» (come «La Domenica del Corriere»), diffusissima: la «Berliner Zeitung am Mittag», sensazionale e che trova ogni giorno 100 000 lettori; l’«Uhu», il «Querschnitt» (la traversale) e «Die Koralle», tipo «Lettura»; e altre pubblicazioni di mode, di commercio, di tecnica, ecc. La UlIstein è legata col «Telegraaf» di Amsterdam, l’«Az Est» di Budapest, la «Neue Freie Presse» (a UlIstein si appoggia per le informazioni da Berlino il «Corriere della Sera»).
La casa editrice Rudolph Mosse pubblica il grande quotidiano democratico «Berliner Tageblatt» (300 000 copie), diretto da Teodoro Wolf con 17 supplementi (Beilagen) e con edizioni speciali per l’estero in tedesco, in francese, in inglese, di importanza europea, costoso e difficile per la piccola gente; «Berliner Morgenzeitung», «Berliner Volkszeitung», in istile popolare, ma delle stesse direttive politiche. Alla casa Mosse si appoggia la «Stampa» di Torino.
Casa editrice Scherl: «Lokal Anzeiger», lettura prediletti, dei bottegai e della piccola borghesia fedele alla vecchia Germania imperiale; il «Tag», per un pubblico più scelto; la «Woche», la «Gartenlaube» (il pergolato).
Giornali da destra a sinistra: «Deutsche Zeitung», ultra nazionalista, ma poco diffusa; «Volkischer Beobachter» di Hitler, poco diffuso (20 000). Poco diffusa è anche la «Neue Preussische Zeitung» (10 000) che continua ad esser chiamata «Kreuzzeitung»: è l’organo classico degli Junker (latifondisti prussiani), ex‑ufficiali nobili, monarchici, e assolutisti, rimasti ricchi e solidi perché poggianti sulla proprietà terriera; ma invece tira 100 000 copie la «Deutsche Tageszeitung» organo del Bund der Landwirte (federazione degli agrari) che va in mano dei minori proprietari e dei fattori e contribuisce a mantenere fedele all’antico regime l’opinione pubblica delle campagne.
Tedesco nazionali: il «Tag» (100 000); «Lokal Anzeiger» (180 000); «Schlesische Zeitung»; «Berliner Börsen Zeitung» (giornale finanziario di destra); «Tägliche Rundschau» (30 000) ma importante perché era ufficioso di Streseman; «Deutsche Allgemeine Zeitung» organo dell’industria pesante, anch’esso tedesco‑popolare. Altri giornali tedesco‑popolari, cioè di destra moderata con adesione condizionata all’attuale regime e diffusi tra gli industriali sono: la «Magdeburgische Zeitung», la «Kölnische Zeitung» (52 000), di fama europea per la sua autorità in politica estera, l’«Hannoverschej Kurier», le «Münchner Neueste Nachrichten» (135 000) e le «Leipziger Neueste Nachrichten» (170 000).
Giornali del centro: la «Germania» (10 000), ma diffusissimi sono i giornali cattolici di provincia come la «Kölnische Volkszeitung».
I giornali democratici sono i meglio fatti: «Vossische Zeitung», «Berliner Tageblatt», «Berliner Börsen Courier», «Frankfurter Zeitung». I socialdemocratici hanno un giornale umoristico: «Lachen links» (risa a sinistra).
Q2 §27 Il «Correspondant» del 25 luglio 1927 (vedi «Rivista d’Italia» del 15 luglio 1927: forse c’è errore nelle date, a meno che la «Rivista d’Italia» non sia uscita molto più tardi della sua datazione) in un articolo, La pression italienne, ha scritto: «Il Duce, lo teniamo da fonte eccellente, avrebbe già voluto due volte la guerra dopo il suo avvento al potere: due volte il maresciallo Badoglio avrebbe rifiutato di prenderne la responsabilità ed avrebbe domandato ed ottenuto di attendere fino al 1935 per essere sicuro». Il discorso sull’anno cruciale è del giugno 1927: il «Correspondant» cercherebbe quindi di dare una spiegazione di questa determinazione avvenire. Il «Correspondant» è rivista molto autorevole conservatrice‑cattolica.
Q2 §28 Articolo di Frank Simonds, Vecchi torbidi nei nuovi Balcani, nella «American Review of Reviews». Il Simonds fa un parallelo tra Mussolini e Stresemann, come uomini politici più attivi di Europa. L’uno e l’altro sacrificano allo spirito di opportunismo (forse vuol dire «del momento», ma anche forse si riferisce alla mancanza di prospettive larghe e lontane e quindi di principii). I trattati di Mussolini come quelli di Stresemann non rappresentano una politica permanente. Sono cose fatte al momento per le condizioni contemporanee. E poiché possono intervenire dei fatti atti a precipitare il conflitto, l’uno e l’altro sono egualmente ansiosi di evitare le ostilità acquistando pei rispettivi paesi e per se stessi il necessario prestigio con vittorie diplomatiche incidentali.
Q2 §29 Quintino Sella. (Articolo di Cesare Spellanzon nella «Rivista d’Italia» del 15 luglio 1927).
Quintino Sella è uno dei pochi borghesi, tecnicamente industriali, che partecipano in prima fila alla formazione dello Stato moderno in Italia. Egli si differenzia in modo volissimo dal rimanente personale politico del suo tempo e della sua generazione, per la cultura specializzata (è un grande ingegnere e anche un uomo di scienza); conosce l’inglese e il tedesco oltre che il francese; ha viaggiato molto all’estero e si è tuffato nella vita di altri paesi per conoscerne le abitudini di lavoro e di vita (non ha cioè viaggiato come turista, visitando alberghi e salotti); ha una vasta cultura umanistica oltre che tecnica; è uomo di forti convinzioni morali, anzi di un certo puritanismo, e cerca di mantenersi indipendente dalla corte, che esercitava una funzione degradante sugli uomini al governo (molti uomini di Stato facevano i ruffiani come il D’Azeglio) fino a porsi apertamente contro il re per la sua vita privata e a domandargli decurtazioni di lista civile (si sa quanto la quistione della lista civile e delle oblazioni occasionali avesse importanza nella scelta degli uomini di governo) e a staccarsi dalla così detta destra che era più una cricca di burocrati, generali, proprietari terrieri che un partito politico (vedere meglio questo problema) per avvicinarsi ad altre correnti più progressive (il Sella partecipò al trasformismo che significava tentativo di creare un forte partito borghese all’infuori delle tradizioni personalistiche e settarie delle formazioni del Risorgimento).
Quintino Sella tassatore spietato: il macinato; perché fu scelta questa tassa? Per la facilità di riscossione o perché tra l’odio popolare e il sabotaggio delle classi proprietarie si aveva più paura di questo?
Poca partecipazione al 48 (egli aveva visto a Parigi la caduta della monarchia di luglio). A Milano si trovò in un’assemblea dove si voleva votare un biasimo a Brescia che piemontesizzava: Sella sostenne Brescia e fu fischiato. Apparteneva alla Destra ma fu ministro la prima volta con Rattazzi, capo del centro sinistro (1862), fu avversario del primo ministero Minghetti (63‑64) e col Lanza combatté il ministero Menabrea (68‑69). Deciso per la conquista di Roma. Il Lamarmora nel 1871 scrisse che il Sella «corre sempre, ora in alto ora in basso, un po’ a destra, un po’ a sinistra; non si sa mai da che parte egli sia e sovente non lo sa nemmeno lui».
Nel 1865 si reca alla Reggia a chiedere al re il sacrificio di 3 milioni annui della lista civile per far fronte alle immediate difficoltà di tesoreria. Come industriale, andato al governo, cessa i rapporti di fornitura allo Stato. Nel Parlamento «osa rivolgersi con chiara allusione al re, del quale deplora certe sregolatezze della vita intima, per ammonirlo che il popolo non fa credito ai suoi governanti se essi non danno esempio costante di moralità». Si oppone all’approvazione del disegno di legge per la Regìa dei tabacchi, presentato da un ministero di Destra perché c’era odor di corruzione e di loschi maneggi in quel grosso affare che il ministero Menabrea si accingeva a convalidare. Sella si oppone risolutamente all’alleanza con la Francia nel 70. Il re intrigava per sostituire Lanza con Cialdini; Sella nel Senato rispose con asprezza all’attacco sferrato da Cialdini. (Nato nel 1827, morto nell’84).
Q2 §30 Italia e Yemen nella nuova politica arabica. Articolo di «tre stelle» nella «Rivista d’Italia» del 15 luglio 1927. Trattato di Sana del 2 settembre 1926 tra Italia e Yemen. Lo Yemen è la parte più fertile dell’Arabia (Arabia felice). È stato sempre autonomo di fatto, sotto una dinastia di imam che discende da el‑Usein, secondo figlio dei califfo Alì e di Fatimah, figlia di Maometto. Solo nel 1872 i turchi stabilirono il loro dominio nello Yemen. Nel 1903 insurrezione, che nel 1904 trovò nel nuovo imam Yahyà ibn‑Mohammed Hamid, di 28 anni, il suo capo.
Vinto nel 1905, Yahyà riprese la lotta nel 1911 aiutato dall’Italia che era in guerra con la Turchia e consolidò la sua indipendenza. Nella guerra europea Yahyà parteggiò per la Turchia per opporsi alla politica inglese imperniata sull’ingrandimento dello sceriffo Husein (proclamatosi re dell’Arabia il 6 novembre 1916) e sull’indipendenza dell’Asir. Dopo la pace, tramontato il programma unitario di Husein che abdicò nel 24 e nel 25 fu relegato a Cipro, rimase la quistione dell’Asir. L’Asir è un emirato creato durante la guerra italo- turca. Nell’Asir si era stabilito il famoso santone marocchino Ahmed ibn‑Idris el‑Hasani el‑Idrisi, il cui discendente Mohammed Alì, noto come lo sceicco Idris durante la guerra libica, appoggiato dall’Italia, sollevò le tribù dell’Asir. Riconosciuto emiro indipendente dagli Inglesi nel 1914, Mohammed collaborò con Husein ed ebbe dagli Inglesi la Tihamah con Hodeidah; fece la concessione a una compagnia inglese di giacimenti petroliferi delle isole Farsan. Stretto tra Husein a Nord e Yahyà a Sud, l’emiro si legò nel 1920 al sultano del Negged (Ibn Saud) cedendogli, per averne la protezione, Abha, Muhail e Beni Shahr, cioè la parte estrema dell’Asir settentrionale e assicurandogli uno sbocco sul mar Rosso. I Wahhabiti occuparono quelle terre e se ne servirono per combattere meglio l’Heggias (Husein). Nel 1926 (8 gennaio) i Wahhabiti vittoriosi proclamarono Ibn Saud re dell’Heggias. I Wahhabiti si mostravano i più capaci di unificare l’Arabia; Yahyà con un proclama del 18 giugno 1923 aveva posto la sua candidatura a califfo e a campione della nazione araba. Riuscì con imprese fortunate ad assicurarsi l’effettivo controllo dei numerosi sultanati e tribù del così detto Hadramaut e a restringere volmente l’hinterland di Aden, senza nascondere le sue mire su Aden stessa. Si gettò poi contro l’emiro dell’Asir (che per lui era un usurpatore) e conquistò tutta la parte meridionale sino a Loheyyah e compresa Hodeidah, venendo a contatto coi Wahhabiti che avevano allargato, a richiesta dell’emiro, la loro occupazione dell’Asir. L’emiro dell’Asir si lasciò spingere dall’ex‑senusso ad atti di ostilità verso l’Italia (l’ex‑senusso era ospite alla Mecca di Ibn Saud dopo la sua espulsione da Damasco – dicembre 1924).
Col trattato italo‑yemenita, a Yahyà è riconosciuto il titolo regio e la piena e assoluta indipendenza. Lo Yemen importerà le sue forniture dall’Italia, ecc. (Ibn Saud fece un trattato con l’Inghilterra il 26 dicembre 1915 ed ebbe il possesso non solo del Negged, ma anche di el‑Hasa, el‑Qatif e Giubeil, in cambio del suo disinteressamento per Koweit, el‑Bahrein e Oman che, come è noto, sono sotto il protettorato inglese. In una discussione ai Comuni del 28 novembre 1922 risultò ufficialmente che Ibn Saud percepiva dal governo inglese regolare stipendio. Coi trattati del 1° e 2 novembre 1925, dopo la conquista dello Heggias, Ibn Saud accettò confini molto infelici con l’Irak e la Transgiordania che Husein non aveva voluto accettare, ciò che dimostrò la sua stretta intesa con l’Inghilterra). Il trattato italo‑yemenita fece rumore: si parlò di una alleanza politica e militare segreta; in ogni modo i Wahhabiti non attaccarono lo Yemen (si parlò di attriti italo‑inglesi ecc.). Rivalità tra Ibn Saud e Yahyà: ambedue aspirano a promuovere e dominare l’unità araba.
Wahhabiti: setta musulmana fondata da Abd‑el‑Wahhab che cercò di allargarsi con le armi; ebbe molte vittorie ma fu ricacciata nel deserto dal famoso Mehemet Alì e da suo figlio Ibrahim pascià. Il sultano Abdallah, catturato, fu giustiziato a Costantinopoli (dicembre 1818) e suo figlio Turki a stento riuscì a mantenere uno staterello nel Negged. I Wahhabiti vogliono tornare alla pura lettera del Corano, sfrondando tutte le superstrutture tradizionali (culto dei santi, ricche decorazioni delle moschee, pompe religiose). Appena conquistata la Mecca hanno abbattuto cupole e minareti, distrutto i mausolei di santoni celebri, fra cui quello di Khadigia, la prima moglie di Maometto, ecc. Ibn Saud emanò ordinanze contro il vino e il fumo, per la soppressione del bacio della «pietra nera» e dell’invocazione a Maometto nella formula della professione di fede e nelle preghiere.
Le iniziative puritane dei Wahhabiti sollevarono proteste nel mondo musulmano; i governi di Persia e dell’Egitto fecero rimostranze. Ibn Saud si moderò. Yahyà cerca di speculare su questa reazione religiosa. Yahyà e la maggioranza degli yemeniti seguono il rito zeidita, cioè sono eretici per la maggioranza sunnita degli arabi. La religione è contro di lui, egli cerca di premere perciò sulla nazionalità e sul fatto della sua discendenza dal profeta che gli fa rivendicare la dignità di califfo. (Nel tallero da lui coniato c’è la scritta: «coniato nella sede del califfato a Sana»). La sua regione, essendo delle più fertili dell’Arabia, e la sua posizione geografica gli danno una certa possibilità economica.
Pare che lo Yemen abbia 170 000 Km2 di superficie, con una popolazione tra 1 e 2 milioni. Sull’altipiano la popolazione è araba pura, bianca, sulla costa è prevalentemente negra. C’è un certo apparato amministrativo, scuole embrionali, esercito con leva obbligatoria. Yahyà è intraprendente e di tendenze moderne sebbene geloso della sua indipendenza. Per l’Italia lo Yemen è la pedina per il mondo arabico.
Q2 §31 Niccolò Machiavelli. La «Rivista d’Italia» del 15 giugno 1927 è interamente dedicata al Machiavelli per il IV centenario della sua morte. Eccone l’indice: 1) Charles Benoist, Le Machiavélisme perpétuel; 2) Filippo Meda, Il machiavellismo; 3) Guido Mazzoni, Il Machiavelli drammaturgo; 4) Michele Scherillo, Le prime esperienze politiche del Macbiavelli; 5) Vittorio Cian, Machiavelli e Petrarca; 6) Alfredo Galletti, Niccolò Machiavelli umanista; 7) Francesco Ercole, Il Principe; 8) Antonio Panella, Machiavelli storico; 9) Plinio Carli, Niccolò Machiavelli scrittore; 10) Romolo Caggese, Ciò che è vivo nel pensiero politico di Machiavelli.
L’articolo del Mazzoni è mediocre e prolisso: erudito‑retorico‑divagativo. Mi pare addirittura che, come capita spesso a questo tipo di scrittori, il Mazzoni non abbia ben capito la lettera della commedia e falsifichi il carattere di messer Nicia che non si attendeva un figlio dall’accoppiamento di sua moglie con Callimaco travestito, ma si attendeva solo di avere una moglie resa feconda dalla Mandragola e liberata per l’accoppiamento dalle conseguenze micidiali della pozione. Il genere di scimunitaggine di Messer Nicia è ben circoscritto e rappresentato: egli crede che il non aver figli non dipenda da lui, vecchio, ma dalla moglie giovane ma fredda, e a questa presunta infecondità della moglie vuol mettere riparo non facendola ingravidare da un altro, ma facendosela trasformare da infeconda in feconda. Che si lasci convincere a far accoppiare la moglie con uno che deve morire per liberarla da un presunto male che altrimenti sarebbe causa di allontanamento per lui dalla moglie o di morte per lui, è un elemento comico che si trova in altra forma in novellette popolari dove si vuol dipingere la protervia delle donne che, per dare la sicurezza agli amanti, si fanno possedere addirittura in presenza del marito (questo motivo, in altre forme, c’è anche nel Boccaccio). Nel caso del Machiavelli è la stoltezza del marito che è messa in ridicolo e rappresentata e non la protervia della donna.
L’articolo di Vittorio Cian è anche peggiore di quello del Mazzoni: la rettorica stopposa del Cian prende tutto il campo. Il Machiavelli non deve evidentemente nulla al Petrarca, il cui pensiero politico è embrionale e i cui accenni all’Italia sono puramente letterari. Ma il Cian che vede precursori da per tutto e divinazioni miracolose in ogni frasetta banale distende dieci pagine sull’argomento per non dire che i soliti luoghi comuni dei libri per le scuole medie ed elementari.
Q2 §32 Augur. Collaboratore della Nuova Antologia per quistioni di politica mondiale, specialmente sulla funzione dell’Impero Inglese e sui rapporti tra Inghilterra e Russia. Augur deve essere un fuoruscito russo. La sua collaborazione alla «Nuova Antologia» deve essere indiretta: articoli pubblicati in riviste inglesi e tradotti nella «Nuova Antologia». La sua attività di giornalista ha per scopo di predicare l’isolamento morale della Russia (rottura delle relazioni diplomatiche) e creazione di un fronte unico antirusso come preparazione di una guerra. Legato all’ala destra dei conservatori inglesi nella politica russa, se ne stacca nella politica americana: egli predica stretta unione anglo-americana e insiste perché l’Inghilterra ceda all’America o almeno disarmi le isole che possiede ancora nel mare Caraibico (Bahamas, ecc.). I suoi articoli sono pieni di grande sicumera (derivata forse dalla presunta grande autorità della fonte ispiratrice); egli cerca di trasfondere la certezza che una guerra di sterminio sia inevitabile tra l’Inghilterra e la Russia, guerra in cui la Russia non può che soccombere. I rapporti ufficiali tra i due paesi sono come le ondate superficiali dell’oceano, che vanno e vengono capricciosamente: ma nel profondo c’è la corrente storica potente che porta alla guerra.
Q2 §33 Documenti diplomatici. Un articolo di A. De Bosdari nella «Nuova Antologia» del 1° luglio 1927: I documenti ufficiali britannici sull’origine della guerra (1898-1914).
Il De Bosdari pone la quistione se i documenti tanto tedeschi che inglesi siano effettivamente riprodotti nella loro integrità e senza omissione di nulla che abbia vera importanza per lo svolgimento storico dei fatti. «Per ciò che riguarda le pubblicazioni tedesche, posso, come mio ricordo personale, asserire che essendomi un giorno doluto al Ministero tedesco degli Affari Esteri che fra i documenti pubblicati ne fossero stati inseriti alcuni scioccamente ingiuriosi per l’Italia, specialmente i rapporti dell’Ambasciatore Monts, mi fu risposto che ciò era una circostanza assai dolorosa, ma che quei documenti non si sarebbero potuti sopprimere senza togliere alla pubblicazione il carattere di imparziale documentazione storica». Dopo questo suo ricordo personale, il De Bosdari era pronto a giurare sull’integrità della documentazione tedesca.
Per i documenti inglesi, dopo aver ricordato la buona fede del Governo inglese, di cui non si ha motivo di dubitare, dice che costituiscono una prova abbastanza sicura di autenticità e di completezza, le numerose integrazioni che vi avvengono di documenti che, per motivi politici abbastanza plausibili, erano stati mutilati nei libri blù (ma i libri inglesi sono bianchi, mi pare!) antecedentemente pubblicati. (Veramente altri «motivi politici abbastanza plausibili» possono aver indotto a non pubblicare altri documenti e a non integrarne qualcuno: per es. i documenti dovuti a spionaggio saranno mai pubblicati?)
Il De Bosdari ha una buona osservazione: nota la scarsezza, tanto nei documenti inglesi che in quelli tedeschi, di quei documenti che riguardano le deliberazioni del Governo, le discussioni e le decisioni dei Consigli dei ministri (che non sono «diplomatici» in senso tecnico, ma che sono evidentemente i decisivi). Nota invece la grande abbondanza di telegrammi e rapporti di funzionari diplomatici e consolari, la cui importanza è relativa, perché questi funzionari, nei momenti di crisi, telegrafano a getto continuo (per non essere accusati di negligenza e di distrazione) senza avere il tempo di controllare le proprie notizie e le proprie impressioni. (Questa osservazione nasce da esperienza personale del De Bosdari e può essere una prova di come lavorano i funzionari diplomatici italiani: forse per gli inglesi le cose vanno diversamente).
Q2 §34 Per una politica annonaria razionale e nazionale di Guido Borghesani, nella Nuova Antologia del 1° luglio 1927, è un mediocre articolo, con dati poco sicuri e elaborati primitivamente. Sostiene la tesi generale che in Italia si consuma troppo grano e che perciò oltre alla lotta per avere un miglior raccolto granario dove è tecnicamente più produttiva la semina di questo cereale, si dovrebbe tendere a sostituire il grano con altri cibi. La quistione è però questa, che per es. la Francia, le cui abitudini sono nel mangiare molto simili a quelle dell’Italia, non solo consuma per abitante tanto grano quanto l’Italia, ma consuma molto più di altri cibi fondamentali (zucchero: Francia, kg. 24,5; Italia, kg. 8), (formaggio e burro calcolati in latte: Francia, hl. 3; Italia, hl. 0,8). Il problema del grano in Italia è di miseria, non di soverchio consumo, anche se la tesi generale è giusta, nel senso del grande squilibrio: in Italia il maggior consumo di grano in confronto del granoturco, ecc., è l’unico indice di un certo miglioramento dietetico.
Q2 §35 Francesco Orestano, La Chiesa Cattolica nello Stato Italiano e nel mondo, Nuova Antologia, 16 luglio 1927. Articolo importante nel periodo delle trattative per il Concordato. (Confrontare con polemiche tra «Popolo d’Italia», Gentile, «Osservatore Romano», riprodotte in opuscolo dalla «Civiltà Cattolica»). (La legge delle guarantigie, in quanto avente valore statutario, aveva abrogato l’articolo 1° dello Statuto?).
L’articolo dell’Orestano pare scritto da un gesuita. È favorevole alla concessione di un territorio al Papa e nei limiti del plebiscito del 2 ottobre 1870 (cioè tutta la città Leonina, che mi pare fu appunto esclusa dal plebiscito ufficiale). (L’Orestano scrisse nel 1924 uno studio, Lo Stato e la Chiesa in Italia, Roma, Casa Editrice Optima, e nel 1915 una Quistione Romana ristampata in Verso la nuova Europa, Casa Editrice Optima, 1917).
Q2 §36 Machiavelli. Pasquale Villari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, a cura di Michele Scherillo, Ed. Hoepli, Milano, 1927, voll. 2, L. 60.
È la ristampa della celebre opera del Villari, con in meno i documenti, che nell’edizione Le Monnier occupavano l’intero terzo volume e parte del secondo. Nell’edizione Scherillo questi documenti sono stati elencati, con cenni sommari sul loro contenuto, in modo che facilmente si può andarli a ricercare nell’edizione Le Monnier).
Q2 §37 L’Unione internazionale dei Soccorsi. Iniziativa di origine italiana. Creata nel 1927 in una Conferenza internazionale alla quale furono invitati anche gli Stati che non fanno parte della Società delle Nazioni (Stati Uniti, U.R.S.S., ecc.). L’Unione coordina l’attività delle organizzazioni di soccorso esistenti, aggiungendovi la partecipazione dei governi. Le calamità considerate sono i disastri e i rivolgimenti dovuti a casi di forza maggiore quando colpiscono popolazioni intere, quando superano i calcoli di un’amministrazione anche previdente, quando hanno un carattere eccezionale. L’aiuto non comporta riparazioni né ricostruzione. Stretta neutralità nazionale, politica, religiosa, ecc.
Q2 §38 Gioviano Pontano. Sua attività politica come affine a quella del Machiavelli. (Cfr M. Scherillo, Origini e svolgimento della letteratura italiana, II, dove sono riportati due memoriali del Pontano sulla situazione italiana nel periodo della calata di Carlo VIII; e Gothein, Il Rinascimento nell’Italia Meridionale, tradotto nella Biblioteca storica del Rinascimento, Firenze, 1915). Il Pontano era membro napoletanizzato. (La religione come strumento di governo. Contro il potere temporale del Papa: doversi «li Stati temporali» governare da «re e principi secolari»).
Q2 §39 La Geopolitica. Già prima della guerra Rodolfo Kjellén, sociologo svedese, cercò di costruire su nuove basi una scienza dello Stato o Politica, partendo dallo studio del territorio organizzato politicamente (sviluppo delle scienze geografiche: geografia fisica, geografia antropica, geopolitica) e della massa di uomini viventi in società in quel territorio (geopolitica e demopolitica). I suoi libri, specialmente i due: Lo Stato come forma di vita e Le grandi Potenze attuali (Die Grossmächte der Gegenwart, del 1912, rielaborato dall’autore, divenne Die Grossmächte und die Weltkrise, pubblicato nel 1921; il Kjellén è morto nel 1922) ebbero grande diffusione in Germania dando luogo a una corrente di studi. Esiste una «Zeitschrift für Geopolitik»; e appaiono opere voluminose di geografia politica (una di esse, Weltpolitisches Handbuch, vuol essere un manuale per gli uomini di Stato) e di geografia economica. In Inghilterra e in America e in Francia.
Q2 §40 Il problema scandinavo e baltico, articolo di A. M. (?) nella Nuova Antologia del 1° agosto 1927. Articolo un po’ balzellante e pieno di fumosità pretenziose ma interessante nel complesso anche perché l’argomento è di solito poco trattato. Unità culturale dei popoli scandinavi molto più intima di quella dei popoli di cultura latina. Esiste un movimento per una Lega interscandinava, che dà luogo a riunioni periodiche e solenni, ma la Lega non può divenire realtà concreta di organismo politico: rimangono i vincoli culturali e di razza da cui il movimento nasce e che da esso sono mantenuti e rinforzati. Le ragioni della impossibilità della Lega sono più sostanziali che non quella del pericolo di una egemonia svedese. La Svezia e la Finlandia hanno interessi diversi della Danimarca e Norvegia. Eliminate le flotte tedesca e russa il Baltico è in certo qual modo neutralizzato, ma tale neutralità è controllata dall’Inghilterra. La Lega creerebbe un’altra situazione di cui l’Inghilterra potrebbe non essere soddisfatta, almeno che la Lega stessa fosse una sua creatura. Così si dica per la Germania (e anche per la Russia, anzi più di tutto per la Russia) restituita a grande potenza.
Danimarca nell’anteguerra gravitava nell’orbita inglese. Oggi ancor più. Ha rinunziato a ogni apparato militare (bisogna vedere se ciò non sia avvenuto per suggerimento inglese, che così può entrare nel Baltico senza violare nessun «piccolo Belgio»). In ogni modo la neutralità disarmata della Danimarca pone il Baltico sotto il controllo inglese, quindi diminuisce la posizione della Germania, che tende a esercitare una influenza nel Nord. La Danimarca, col suo disarmo, ha rinunziato alla sua posizione e funzione internazionale. Paese piccolo borghese.
La Svezia è apatica e quietista, senza volontà di potenza.
La Norvegia sotto influsso inglese, in istato di quasi disarmo, ma in ascesa. Piena di vigore la Finlandia, dotata di un forte sistema statale e di governo. La Svezia paese di grande industria e di alta borghesia con rigida differenziazione di classi (tradizione aristocratica‑militare e conservatrice); riduzione di spese militari e navali; sotto influenza tedesca; il suo prestigio decaduto; avrebbe potuto forse annettersi la Finlandia: invece vide assegnare alla Finlandia le isole Aland, la Gibilterra baltica.
La Finlandia ha assorbito dalla Svezia la cultura occidentale. I suoi interessi permanenti e profondi legati alla Germania. Atteggiamento riservato verso la Polonia. La Polonia vorrebbe costituirsi grande protettrice degli Stati baltici e raggrupparli intorno a sé di fronte alla Russia e alla Germania. (Ma Lituania avversa, Finlandia molto riservata e altri Stati baltici diffidenti e sospettosi). La Russia ha finora sventato queste manovre polacche.
Inghilterra, potenza navale contro blocco tedesco‑russo (l’autore prevede una ripresa della potenza tedesca che organizza la Russia sotto il suo controllo e le si unisce territorialmente): in cui la tradizionale supremazia del mare (inglese) sul continente verrebbe a perdere la sua efficienza data la grandezza territoriale del blocco tedesco‑russo. L’Inghilterra in posizione di difesa, perché satura di territori dominati e la sua flotta diminuita come fattore egemonico. Il blocco russo‑tedesco rappresenterebbe la rivolta anti‑inglese. Verrebbe a formarsi una continuità ininterrotta dal Mar Glaciale al Mediterraneo e dal Reno al Pacifico: la Turchia sarebbe il secondo fattore in sottordine; l’adesione della Bulgaria e dell’Ungheria non sarebbe improbabile in caso di conflitto. (Lituania già congiunge Russia e Germania).
La minaccia dell’Inghilterra di forzare gli stretti danesi (a parte la funzione germanica del canale di Kiel) neutralizzata dai possibili campi di mine che la Germania può disporre ai confini meridionali della Danimarca e della Svezia. La influenza francese nel Nord è irrilevante. La Svezia e la Finlandia rifuggono dall’inimicarsi l’Inghilterra, ma tendono sempre più verso la Germania.
Risorgere del germanesimo. La Germania «potenzialmente» è ancora la più forte nazione continentale. L’unità nazionale è rafforzata; la compagine statale è intatta. Essa oggi si destreggia fra Occidente e Oriente in attesa di riprendere la sua libertà politica di fronte all’Inghilterra che tenta invano di separarla dalla Russia, per avere ragione di entrambe.
La Russia: i concetti dell’autore sulla Russia sono molto superficiali e fumosi. «L’amorfismo russo è incapace di organizzare lo Stato e neppure di concepirlo. Tutti i fondatori di Stato russo furono stranieri o d’origine straniera (Rurik, i Romanoff). La potenza organizzatrice non può essere che la Germania, per ragioni storiche e geografiche e politiche. Non conquista militare ma solo subordinazione economica, politica, culturale. Sarebbe antistorico frazionare la Russia e sottoporla ad esperimenti coloniali, come avrebbero voluto certi teorici della politica. Il popolo russo è mistico, ma non religioso, per eccellenza femmineo e dissolvitore», ecc. ecc. (La quistione è molto meno verbalmente complessa: la Russia è troppo contadina e di un’agricoltura primitiva, per potere con «facilità» organizzare uno Stato moderno: la sua industrializzazione è il processo della sua modernizzazione).
Q2 §41 Niccolò Machiavelli. Articolo di Luigi Cavina nella Nuova Antologia del 16 agosto 1927: Il sogno nazionale di Niccolò Machiavelli in Romagna e il governo di Francesco Guicciardini. L’episodio cui l’articolo si riferisce è interessante, ma il Cavina non ne sa trarre tutte le conseguenze necessarie (l’articolo è di carattere descrittivo‑rettorico). Dopo la battaglia di Pavia e la definitiva sconfitta dei Francesi che assicurava l’egemonia spagnola, i signori italiani entrano in uno stato di panico: il Machiavelli, recatosi a Roma per consegnare personalmente a Clemente VII le Istorie fiorentine che aveva ultimato, propone al papa di creare una milizia nazionale e lo convince a fare un esperimento. Il papa manda il Machiavelli in Romagna presso Francesco Guicciardini che era Presidente della Romagna con un breve in data 6 giugno 1525. Il Machiavelli doveva esporre al Guicciardini il suo progetto e il Guicciardini doveva dare il suo parere. (Il breve del papa deve essere tutto interessante: egli espone lo sconvolgimento in cui si trova l’Italia, così grande da indurre a cercare anche rimedi nuovi e inconsueti e concludeva: «Res magna est, ut iudicamus, et salus est in ea cum status ecclesiastici, tum totius Italiae ac prope universae christianitatis reposita»). Perché l’esperienza in Romagna? I Romagnoli buoni soldati: avevano combattuto con valore e fedeltà per i Veneziani all’Agnadello, quantunque da mercenari. C’era poi stato in Romagna il precedente del Valentino che aveva reclutato tra il popolo buoni soldati.
Il Guicciardini fino dal 1512 aveva scritto che il dare le armi ai cittadini «non è cosa aliena da uno vivere di repubblica e popolare, perché quando vi si dà una giustizia buona e ordinate leggi, quelle arme non si adoperano in pernizie, ma in utilità della patria», e aveva anche lodato l’istituzione dell’ordinanza ideata dal Machiavelli (tentativo del Machiavelli di creare a Firenze la milizia cittadina). Ma il Guicciardini non credeva possibile fare il tentativo in Romagna per le fierissime divisioni di parte che vi dominavano (interessanti i giudizi del Guicciardini sulla Romagna): i ghibellini dopo la vittoria di Pavia sono pronti ad ogni novità; anche se non si danno le armi nascerà qualche subbuglio; non si può dare le armi per opporsi agli imperiali proprio ai fautori degli imperiali. Inoltre la difficoltà è accresciuta dal fatto che lo Stato è ecclesiastico, cioè senza direttive a lunga scadenza, e con facili grazie e impunità, alla più lunga ad ogni nuova elezione di papa. In altro Stato le fazioni si potrebbero domare, non nello Stato della chiesa. Poiché Clemente VII nel suo breve aveva detto che al buon risultato dell’impresa occorrevano non solo ordine e diligenza, ma anche l’impegno e l’amore del popolo, il Guicciardini dice che ciò non può essere perché «la Chiesa in effetto non ci ha amici, né quelli che desidererebbero bene vivere, né per diverse ragioni i faziosi e tristi».
Ma la cosa non ebbe altro seguito, perché il papa lasciò cadere il progetto. (Rimane interessante l’episodio, per dimostrare la volontà del Machiavelli, per i giudizi pratici del Guicciardini, e anche del papa). Non si conoscono le ragioni che il Machiavelli deve aver contrapposto alle osservazioni del Guicciardini, perché questi non ne parla nelle sue lettere, e le lettere del Machiavelli a Roma non si conoscono.
Q2 §42 Quintino Sella. A Teodoro Mommsen che domandò con quale idea universale l’Italia andasse a Roma, Quintino Sella rispose: quella della scienza. (Mommsen diceva che a Roma non si può stare senza un’idea universale. Questo motivo è stato ripreso dal Capo del Governo nel suo discorso sul Concordato alla Camera dei deputati. La risposta del Sella è interessante e appropriata: in quel periodo storico la scienza era la nuova «idea universale», la base della nuova cultura che si andava elaborando. Ma Roma non divenne la città della scienza; sarebbe stato necessario un grande programma industriale, ciò che non fu. La parola d’ordine del Sella è tuttavia notevole per descrivere l’uomo). Tuttavia il Sella non era né un ateo né un positivista che volesse sostituire la scienza alla religione. (Vedere i documenti, scritti o riportati da altri, del Sella stesso).
Q2 §43 Il macinato. Nel discorso tenuto da Alberto De Stefani a Biella per commemorare il centenario della nascita del Sella (riportato nella Nuova Antologia del 16 settembre 1927), si accenna al macinato collegandolo al dazio doganale sul grano (si abolì il balzello sulle farine, ma poco dopo il doganiere lasciò il mulino e andò sul confine a riscuotere la gabella sul grano).
La quistione non è posta bene (è un epigramma, non una critica o un giudizio). Il macinato era insopportabile dai piccoli contadini che consumavano il poco grano prodotto da loro stessi; e la tassa sul macinato era causa di svendite per procurarsi il denaro e occasione di pratiche usuraie pesantissime; bisogna collocare la tassa nel suo tempo, con una economia famigliare molto più diffusa di ora: per il mercato producevano i grandi e medi proprietari; il piccolo contadino (piccolo proprietario o colono parziario) produceva per il proprio consumo e non aveva mai numerario; tutte le imposte erano per lui un dramma catastrofico; per il macinato si aggiungeva l’odiosità immediata. Le rivolte contro la tassa sul macinato, le uccisioni e le bastonature agli esattori non erano certo inspirate dalle agitazioni politiche: erano spontanee.
Q2 §44 Su Quintino Sella, cfr nella Nuova Antologia del 16 settembre 1927: P. Boselli, Roma e Quintino Sella; Alberto De Stefani, Quintino Sella (1827‑1884); Bruno Minoletti, Quintino Sella storico, archeologo e paleografo.
Q2 §45 America e Europa. Madison Grant (scienziato e scrittore di grande fama), presidente della Società biologica di New York, ha scritto un libro Una grande stirpe in pericolo in cui «denuncia» il pericolo di un’invasione «fisica e morale» dell’America da parte degli Europei, ma restringe questo pericolo nell’invasione dei «mediterranei», cioè dei popoli che abitano nei paesi mediterranei. Il Madison Grant sostiene che, fin dal tempo di Atene e di Roma, l’aristocrazia greca e romana era composta di uomini venuti dal Nord e soltanto le classi plebee erano composte di mediterranei. Il progresso morale e intellettuale dell umanità fu dunque dovuto ai «nordici», Per il Grant i mediterranei sono una razza inferiore e la loro immigrazione è un pericolo; essa è peggiore di una conquista armata e va trasformando New York e gran parte degli Stati Uniti in una «cloaca gentium». Questo modo di pensare non è individuale: rispecchia una notevole e predominante corrente di opinione pubblica degli Stati Uniti, la quale pensa che l’influsso esercitato dal nuovo ambiente sulle masse degli emigranti è sempre meno importante dell’influsso che le masse degli emigranti esercitano sul nuovo ambiente e che il carattere essenziale della «miscela delle razze» è nelle prime generazioni un difetto di armonia (unità) fisica e morale nei popoli e nelle generazioni seguenti un lento ma fatale ritorno al tipo dei vari progenitori.
Su questa quistione delle «razze» e delle «stirpi» e della loro boria alcuni popoli europei sono serviti secondo la misura della loro stessa pretesa. Se fosse vero che esistono razze biologicamente superiori, il ragionamento del Madison Grant sarebbe abbastanza verosimile. Storicamente, data la separazione di classe‑casta, quanti romani‑ariani sono sopravvissuti alle guerre e alle invasioni? Ricordare la lettera di Sorel al Michels, «Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica», settembre‑ottobre 1929: «Ho ricevuto il vostro articolo su la “sfera storica di Roma”, le cui tesi sono quasi tutte contrarie a ciò che lunghi studi m’hanno mostrato essere la verità più probabile. Non c’è paese meno romano dell’Italia; l’Italia è stata conquistata dai Romani perché essa era altrettanto anarchica quanto i paesi berberi; essa è rimasta anarchica per tutto il Medio Evo, e la sua propria civiltà è morta quando gli Spagnoli le imposero il loro regime amministrativo; i Piemontesi hanno compiuto l’opera nefasta degli Spagnoli. Il solo paese di lingua latina che possa rivendicare l’eredità romana è la Francia, dove la monarchia si è sforzata di mantenere il potere imperiale. Quanto alla facoltà d’assimilazione dei Romani, si tratta di uno scherzo. I Romani hanno distrutto la nazionalità sopprimendo le aristocrazie». Tutte queste quistioni sono assurde se si vuole fare di esse elementi di una scienza e di una sociologia politica. Rimane solo il materiale per qualche osservazione di carattere secondario che spiega qualche fenomeno di secondo piano.
Q2 §46 Istituzioni internazionali. La Camera di Commercio Internazionale. (Un articolo sul IV Congresso della Camera di Commercio Internazionale tenuto a Stoccolma nel giugno‑luglio 1927 è nella Nuova Antologia del 16 settembre 1927).
Q2 §47 Ada Negri. Articolo di Michele Scherillo nella Nuova Antologia del 16 settembre 1927. Su Ada Negri bisognerebbe fare uno studio storico‑critico. Può chiamarsi, in un periodo della sua vita, «poetessa proletaria» o semplicemente «popolare»? Nel campo della cultura mi pare rappresenti l’ala estrema del romanticismo del 48; il popolo diventa sempre più proletariato, ma è visto ancora sotto la specie di popolo, non per i germi di originale ricostruzione che contiene in sé (ma piuttosto per la caduta che rappresenta da «popolo» a «proletariato»?) (In Stella mattutina, Treves, 1921, la Negri ha narrato i casi della sua vita di bambina e adolescente).
Q2 §48 Costituzione dell’Impero Inglese. Articolo nella «Nuova Antologia» del 16 settembre 1927 di «Junius», Le prospettive dell’Impero Britannico dopo l’ultima conferenza imperiale.
Ricerca di equilibrio tra esigenze di autonomia dei Dominions e esigenze di unità imperiale. (Nel Commonwealth l’Inghilterra porta il peso politico della sua potenza industriale e finanziaria, della sua flotta, delle sue colonie o domini della Corona o stabilimenti d’altro nome – India, Gibilterra, Suez, Malta, Singapore, Hong Kong, ecc. –, della sua esperienza politica, ecc. Elementi di disgregazione dopo la guerra sono stati: la potenza degli Stati Uniti, anglosassoni anch’essi e che esercitano un influsso su certi dominions, e i movimenti nazionali e nazionalistici che sono in parte una reazione al movimento operaio – nei paesi a capitalismo sviluppato – e in parte un movimento contro il capitalismo stimolato dal movimento operaio: India, negri, cinesi, ecc. Gli inglesi trovano una soluzione al problema nazionale per i dominions a capitalismo sviluppato, e questo aspetto è molto interessante: ricordare che Iliic sosteneva appunto che non è impossibile che le quistioni nazionali abbiano una soluzione pacifica anche in regime borghese: esempio classico la separazione pacifica della Norvegia dalla Svezia. Ma gli inglesi sono specialmente colpiti dai movimenti nazionali nei paesi coloniali e semicoloniali: India, negri dell’Africa, ecc.).
La difficoltà maggiore dell’equilibrio tra autonomia e unità si presenta naturalmente nella politica estera. Giacché i Dominions non riconoscono più il Governo di Londra come rappresentante della loro volontà nel campo della politica internazionale, si discusse di creare una nuova entità giuridico‑politica destinata ad indicare ed attuare l’unità dell’Impero: si parlò di costituire un organo di politica estera imperiale. Ma esiste una reale unità «internazionale»? I Dominions attraverso l’Impero partecipano alla politica mondiale, sono potenze mondiali; ma la politica estera dell’Inghilterra, europea e mondiale, è talmente complicata che i Dominions sono riluttanti ad essere trascinati in quistioni che non li interessano direttamente; d’altronde attraverso la politica estera l’Inghilterra potrebbe togliere o limitare ai Dominions qualcuno di quei diritti di indipendenza che hanno conquistato. Per l’Inghilterra stessa questo organo di politica imperiale potrebbe essere ragione di difficoltà, specialmente appunto nella politica estera, in cui si esige prontezza e unità di volere, difficili da realizzare in un organo collettivo rappresentante paesi sparsi in tutto il mondo.
Incidente col Canadà a proposito del trattato di Losanna: il Canadà rifiutò di ratificarlo perché non firmato dai propri rappresentanti. Baldwin lasciò cadere la quistione dell’«organo imperiale» e temporeggiò. Il Governo conservatore riconobbe al Canadà e all’Irlanda il diritto di aver propri rappresentanti a Washington (primo passo verso il diritto attivo e passivo di Legazione ai Domini); all’Australia il diritto di avere a Londra oltre all’Alto Commissario (con mansioni specialmente economiche) un funzionario per il diretto collegamento politico; favorì e incoraggiò la formazione di flotte autonome (flotta australiana, canadese, indiana); base navale di Singapore per la difesa del Pacifico; esposizione di Wembley per valorizzare l’economia dei dominions in Europa; Comitato Economico Imperiale per associare i Dominions all’Inghilterra di fronte alle difficoltà commerciali e industriali, e parziale attuazione del principio preferenziale.
Nella politica estera: il Patto di Locarno fu firmato dall’Inghilterra con la dichiarazione di assumere per sé sola gli impegni in esso contemplati. (Prima vari metodi: per il Trattato di Losanna l’Inghilterra firmò a nome di tutto l’Impero, onde incidente col Canadà; nella Conferenza di Londra per le riparazioni tedesche, nel luglio 1924, intervennero i dominions singoli, con apposite delegazioni, ciò che domandò un meccanismo pesante e complicato, non sempre praticamente applicabile; nel Patto di Sicurezza di Ginevra del 1928, l’Inghilterra si riservò di firmare dopo aver consultato i dominions e averne ottenuta la preventiva approvazione).
La Conferenza Imperiale (del novembre 1926) ha voluto dare una definizione precisa dei membri dell’Impero: essi sono «comunità autonome, uguali in diritto, in nessun modo subordinate l’una all’altra nei rispetti dei loro affari interni ed esteri, sebbene unite da un comune dovere di obbedienza alla Corona e liberamente associate quali membri dell’Impero britannico». Uguaglianza di status non significa uguaglianza di funzioni, e viene espressamente dichiarato che la funzione della politica estera, e della difesa militare e navale incombe principalmente alla Gran Bretagna. Ciò non esclude che determinate mansioni di questi due rami dell’attività statale vengano in parte assunte da qualcuno dei Dominions: flotta australiana e indiana (l’India però non è un Dominion); rappresentanza a Washington dell’Irlanda e del Canadà, ecc. Viene infine stabilito il principio generale che nessun obbligo internazionale incombe su uno qualsiasi dei soci dell’Impero se quest’obbligo non è stato volontariamente riconosciuto e assunto.
È stato fissato il rapporto dei Domini con la Corona, che diviene il vero organo supremo imperiale. I Governatori Generali nei Dominions, essendo puri rappresentanti del Re, non possono avere nel riguardo dei Dominions che l’esatta posizione che ha il re nell’Inghilterra: essi perciò non sono rappresentanti od agenti del governo inglese, le cui comunicazioni coi governi dei Dominions avverranno per altro tramite.
La politica estera inglese non può non subire l’influenza dei Dominions.
Q2 §49 Alessandro Mariani. Di questo bellissimo tipo la «Nuova Antologia» del 1° ottobre 1927 pubblica una scelta d’impressioni e di pensieri (Interpretazioni) da una raccolta che avrebbe dovuto essere pubblicata prossimamente. Sono paragrafi molto pretenziosi e confusi, di scarso valore e teorico e artistico, ma talvolta curiosi per la decisa avversione al luogo comune e al pregiudizio banale (sostituiti da altri luoghi comuni e altre trivialità). Nella sezione «Arte politica», la «Nuova Antologia» riporta tre paragrafi sulle «Tre potenze»: 1°, La Chiesa di Roma; 2°, L’Internazionale Rossa; 3°, L’Internazionale ebraica.
La Chiesa cattolica è «la più possente forza conservatrice governante sotto la specie del divino, salvezza ultima ove la decadenza dei valori mette a repentaglio la struttura sociale». L’Internazionale rossa è «deviazione dell’ideologia cristiana», «è attiva dovunque, ma specialmente ove una società economica abbia preso sviluppo secondo il metro dell’Occidente. Sovvertitrice di valori, è forza rivoluzionaria ed espansiva. Nega l’ordine, l’autorità, la gerarchia in quantoché costituiti, ma obbedisce all’ordine proprio, più ferreo ed imperioso dell’antico per necessità di conquista. Nega il divino, disconosce lo Spirito, ma ad esso inconsciamente ed ineluttabilmente obbedisce affermando un’inesausta sete di giustizia pur sotto il fallace miraggio dell’Utopia. Vuol riconoscere soltanto i valori materiali e gli interessi, ma obbedisce inconsapevolmente ai più profondi impulsi spirituali ed agli istinti che hanno le più profonde radici nell’anima umana. È mistica. È assoluta. È spietata. È religione, è dogma. Altrettanto è pieghevole nella trattazione degli affari quanto intransigente nell’ideologia. Relazione di mezzo a fine. È politica». «Come la Chiesa, è sussidiata dai credenti ed alimentata da un servizio d’informazioni mondiale. L’intelligenza di tutte le nazioni è al suo servizio; tutte le risorse degli innumerevoli insoddisfatti che aguzzano l’ingegno verso la possibilità di un loro migliore domani. Come tutte le società umane ha le sue aristocrazie». «Come la Chiesa dice a tutti i popoli la stessa parola, tradotta in tutte le favelle. Il suo potere eversivo è sotterraneo. Mina la costruzione sociale dalle fondamenta. La sua politica manca di tradizione; non di intelligenza, di abilità, di pieghevolezza, sostenute da una ferma determinazione. Trattare con essa o combatterla può essere avvedutezza o errore, a seconda delle contingenze della politica. Non considerarla o rifiutarsi di considerarla è stoltezza».
Q2 §50 Roberto Cantalupo, La Nuova Eritrea, Nuova Antologia, 1° ottobre 1927. (Funzioni dell’Eritrea: 1) economica: intensificare la sua capacità produttiva e commerciale di esportazione e di importazione, cercando di farne un complemento della Madre Patria e di renderla attiva finanziariamente; 2) politica: dare all’Eritrea una posizione e una funzione tali da rendere possibile un maggior contatto con gli stati arabici della riva asiatica del Mar Rosso, nel restaurare i rapporti economici tra Asmara ed il confinante Ovest etiopico, in modo che l’Eritrea diventi il naturale sbocco al mare delle regioni dell’Abissinia settentrionale e naturale porto di transito delle zone centrali e meridionali della Penisola arabica, dopo che Porto Sudan è diventato sbocco di tutto l’Ovest sudanese e entrepôt dell’Arabia settentrionale) .
Dati del Cantalupo ormai invecchiati. Problemi dell’Etiopia: oltre a lotta d’influenza tra Inghilterra, Italia, Francia, potenze confinanti, quali influssi esercitano o possono esercitare ad Addis Abeba gli Stati Uniti e la Russia. Come unico Stato indigeno libero dell’Africa, l’Etiopia può diventare la chiave di tutta la politica mondiale africana, cioè il punto di collisione delle tre potenze mondiali (Inghilterra, Stati Uniti, Russia). L’Etiopia potrebbe mettersi alla testa di un movimento per l’Africa agli Africani.
Sulla situazione sociale etiopica, in cui la chiesa ha grande importanza per struttura feudale, cfr Alberto Pellera, Lo Stato etiopico e la sua Chiesa, pubblicato a cura della Regia Società Geografica (il Pollera è un funzionario coloniale italiano).
Q2 §51 Giovanni Pascoli. Sulle tendenze politiche di Giovanni Pascoli (il Pascoli da giovane fu incarcerato come membro dell’Internazionale), che ebbero pubblicamente il massimo di ripercussione al tempo della guerra libica col discorso La grande proletaria si è mossa e che sono da connettere con le dottrine di Enrico Corradini, in cui il concetto di «proletario» dalle classi è trasportato alle nazioni (quistione della «proprietà nazionale» legata con l’emigrazione; ma si osserva che la povertà di un paese è relativa ed è l’«industria» dell’uomo – classe dirigente – che riesce a dare a una nazione una posizione nel mondo e nella divisione internazionale del lavoro; l’emigrazione è una conseguenza della incapacità della classe dirigente a dar lavoro alla popolazione e non della povertà nazionale: esempio dell’Olanda, della Danimarca, ecc.; quistioni relative si capisce), sono interessanti le Lettere inedite di Giovanni Pascoli a Luigi Mercatelli, pubblicate da G. Zuppone‑Strani nella Nuova Antologia del 16 ottobre 1927. (Il Mercatelli era corrispondente della «Tribuna» dall’Eritrea; rientrò al giornale nel 1896; nel 97 andò in Africa con F. Martini, nel 99 fu direttore della «Tribuna» con Federico Fabbri; nel 1903 fu Console generale allo Zanzibar, nel 1904 governatore del Benadir).
In una lettera scritta da Barga il 30 ottobre 1899 il Pascoli scrive: «Io mi sento socialista, profondamente socialista, ma socialista dell’umanità, non d’una classe. E col mio socialismo, per quanto abbracci tutti i popoli, sento che non contrasta il desiderio e l’aspirazione dell’espansione coloniale. Oh! io avrei voluto che della colonizzazione italiana si fosse messo alla testa il baldo e giovane partito sociale; ma ahimè esso fu reso decrepito dai suoi teorici». (Vedere nell’opera poetica del Pascoli il riflesso di questa sua concezione e nelle Antologie scolastiche).
In una lettera da Messina, dell’8 giugno 1900, si accenna alla sua collaborazione alla «Tribuna»: «Oh! potessi io settimanalmente o bimensilmente pubblicare le mie “Conversazioni coi giovani”! Nel discorso che feci l’altrieri e che ti mando purgato dai molti idioti errori di stampa, è un cenno di ciò che io reputo la mia missione: introdurre il pensiero della patria e della nazione e della razza nel cieco e gelido socialismo di Marx».
In una lettera da Barga del 2 luglio 1900 annunzia una rubrica che vorrebbe scrivere nella «Tribuna», intitolata «Nell’avvenire», di cui presto manderà il proemio: «La rubrica conterrebbe articoli di ogni sorta, diretti a quelli che ora sono tra fanciulli e adolescenti, che contemplerebbero le quistioni presenti alla luce dell’avvenire. Il primo articolo proemiale, dopo una breve dichiarazione mia, di rinunzia formale e solenne alla “vita attiva” – cioè, vuol dire, a diventare deputato – tratterebbe quest’argomento. “I giovani, quelli almeno che sono veramente giovani, hanno in sé qualcosa d’eroico. Quelli, di qualche tempo fa, si sentivano spinti all’eroismo patriottico, quelli d’ora all’eroismo, diciamo, socialistico. Però in fondo al loro cuore è un dissidio profondo. Sentendo la difesa d’Amba Alagi, anche quelli, che avevano fatto dedizione dei loro sentimenti eroici all’idea umanitaria, provarono una scossa.., Ebbene, bisogna conciliare questo dissidio che travaglia (io lo so, io lo sento) il cuore della gioventù, etc., etc.”».
Più oltre scrive: «E non parlerei mica sempre di simili questioni: parlerei d’arte e di letteratura e di scienza e di inorale, cercando sempre di sradicare i pregiudizi e di porre in faccia alla moda l’Ewig e di contro all’oggi, l’ieri e il domani», senza accorgersi dell’intima contraddizione in cui egli stesso si dibatteva, dato che dell’Ewig avesse una concezione giusta.
In una lettera da Barga del 12 agosto 1900 accenna a un suo scritto, Nel carcere di Ginevra, a proposito di Luccheni, che la «Tribuna» non pubblicò e che il Pascoli pubblicò dopo; non ricordo questo scritto.
In una lettera dell’11 dicembre 1900 da Messina, firmata «Giovanni Pascoli socialista‑patriota messo all’indice dai giornali politici, cioè finanzieri d’Italia», parla della sua collaborazione a un giornale locale e pare che abbia iniziato la pubblicazione pensata come rubriche permanenti della «Tribuna», ma che la «Tribuna» non volle pubblicare. (Vedere la bibliografia del Pascoli. La rubrica «Nell’ o Per l’Avvenire», in una lettera del 14 dicembre 1900, è detta essere stata iniziata nella «Tribuna» da Ojetti),
In una lettera senza data, ma che lo Zuppone‑Strani dice scritta da Barga sul finire del 1902 o nella prima metà del 1903 è scritto: «Eppure il poeta ti ama là, ti vede là, ti sogna là, eppure il patriota e l’“umano” (“socialista” non mi conviene più essere chiamato e chiamarmi) si esalta nel saperti investito d’una altissima missione d’utile o onore italico e di civiltà. Ti chiamavo “negriero”, e tu vai a distruggere i negrieri» (il Pascoli chiamava scherzosamente il Mercatelli «ras», «negriero», ecc.). E più oltre: «Perché a rifuggire dal socialismo politico dei nostri giorni aiuta me non solo l’orrore al dispotismo della folla o del numero dei più, ma specialmente la necessità che io riconosco e idoleggio, d’una grande politica coloniale».
Q2 §52 Giovanni Pascoli. La Nuova Antologia del 1° dicembre 1927 pubblica un articolo inedito del Pascoli, mandato nel 1897 alla «Tribuna» e non pubblicato perché al Mercatelli sembrò «troppo ardito per l’indole del giornale» e «troppo compromettente per l’autore». L’articolo era intitolato Allecto («la Erinni dell’odio implacabile e della vendetta interminabile») e prendeva lo spunto da un telegramma del ministro francese Méline ai Lorenesi. Per il Pascoli la Francia e la Russia avrebbero fatto la guerra alla Germania (quindi alla Triplice, quindi all’Italia) «tra poco o tra molto, ma certo». Il Pascoli si rivolge alle madri. C’è un «profeta»: un «dolce e fiero profeta ammantato d’una tunica rossa gira per il mondo, tra i popoli eletti e le genti, predicando un suo vangelo di pace. In suo nome girano e parlano migliaia d’apostoli, dei quali tutti stupiscono e ammirano, perché ognuno li ode parlare nella lingua sua. Essi hanno convertito il cuore stupidamente feroce degli uomini». Questi uomini «dicono ai sinistri trombettieri della distruzione: “No: non vogliamo: non potrete! ”», ma «d’or innanzi ci saranno nella proprietà e in genere nella convivenza sociale alcune modificazioni». Che direbbero le madri? ecc.
«Questo profeta voleva essere il Marxismo. Voleva e certo vorrebbe ancora; ma non può. Non è riuscito. L’atroce guerra che si minaccia, che è il delitto più enorme... non può essere stornata dal Marxismo. Essa con tante vite e tanti tesori e tante idealità travolgerà anche questa scuola, questo sistema, che si mostrò impotente. Per colpa sua? Io non sono mosso da avversione a tale scuola e sistema; ma non posso fare a meno di riconoscere che gli è mancato l’afflato, l’impeto, le lingue di fuoco. Ha voluto essere una scuola e doveva essere una religione. Doveva parlare più d’amore e meno di plus‑valore, più di sacrifizio che di lotta, più d’umanità che di classi. Doveva diffondersi equabilmente da per tutto; doveva aver di mira tutti i popoli, anche quelli più guardati dalle forche e dai princìpi dell’89... Mi spiego».
Secondo il Pascoli «la Germania, e però la Triplice, ha, rispetto alla Francia e alla Russia, un elemento di debolezza: il socialismo». Il Pascoli «teme» che «si sia ottenuto» nel cuore degli operai tedeschi e italiani di «far germinare... l’amore universale al posto dell’atavismo belluino e bellicoso», Italiani e tedeschi sarebbero diventati agnelli, mentre Francesi e Russi sarebbero rimasti leoni e tigri ecc.
«Ma il Marxismo parlerà prima dello squillo. Che dirà? Sentiremo. Saranno, credo, parole degne del gran momento. Serviranno, spero, a rimediare ai danni che involontariamente esso ha recato o è per recare alle nazioni che l’hanno accolto. Faranno, anzi, come da nuovo fermento ideale, che valga a compensare l’impeto bestiale, negli animi nostri. Oh! specialmente l’Italia lo merita! Non è essa la nazione povera, il proletario tra i popoli? Per l’Italia ci dica una parola animosa. Dove non è la traccia ciclopica del lavoro italiano? Quali ferrovie non furono costruite e quali monti non furono forati e quali istmi non furono aperti, nella massima parte, da braccia italiane? E il loro lavoro non arricchì né loro né la loro nazione, poiché era al servizio del capitale straniero. Noi abbiamo esportato ed esportiamo lavoratori; importammo e importiamo capitalisti. Fuori e dentro noi arricchiamo gli altri, rimanendo poveri noi. E quelli, che arricchimmo, ci spregiano e ci chiamano pitocchi. Io non so dar ragione di questo fatto, ma così è. So però che nel fatto non è peccato nostro d’indolenza o d’altro. Come si può chiamare indolente il popolo più faticante e industrioso e parco del mondo? Io dico che è una ingiustizia». Attacca la Francia, «la sorella padrona», e conclude: «o patria grande di lavoratori e di eroi! poiché lo vogliono, poiché anche la tua povertà fa ombra e la tua umiltà fa dispetto, accetta, quando che sia, la sfida, e combatti disperatamente».
Il Pascoli aspirava a diventate il leader del popolo italiano; ma come egli stesso dice in una lettera al Mercatelli, citata in una nota precedente, il carattere «eroico» delle nuove generazioni si rivolge al «socialismo», come quello delle generazioni precedenti si era rivolto alla quistione nazionale: perciò il suo temperamento lo porta a farsi banditore di un socialismo nazionale che gli sembra all’altezza dei tempi. Egli è il creatore del concetto di nazione proletaria, e di altri concetti poi svolti da E. Corradini e dai nazionalisti di origine sindacalista: questo concetto in lui era molto antico. Egli si illudeva che questa sua ideologia sarebbe stata favorita dalle classi dirigenti: ma la «Tribuna», nonostante la stretta amicizia del Pascoli col Mercatelli, non gli dà le sue colonne e la sua autorità. È interessante questo dissidio nello spirito pascoliano: voler essere poeta epico e aedo popolare mentre il suo temperamento era piuttosto «intimista». Di qui anche un dissidio artistico, che si manifesta nello sforzo, nell’anfanamento, nella retorica, nella bruttezza di molti componimenti, in una falsa ingenuità che diventa vera puerilità. Che il Pascoli tenesse molto a questa sua funzione si vede da un brano di lettera al Mercatelli, in cui dice che sarebbe stato lieto di essere incaricato delle scuole all’estero o delle scuole coloniali, più che di fare il professore di lettere all’Università, per avere agio di fare appunto il profeta della missione d’Italia nel mondo. (Del resto qualcosa di simile, pensò di sé stesso il D’Annunzio: vedi il volume Per l’Italia degli Italiani).
Q2 §53 Giovanni Cena. La figura di Cena deve essere studiata
sotto due punti di vista: come scrittore e poeta «popolare» (Cfr
Ada Negri) e come uomo attivo nel cercare di creare istituzioni
per l’educazione dei contadini (scuole dell’Agro Romano e delle
Paludi Pontine, fondate con Angelo e Anna Celli). Il Cena nacque
a Montanaro Canavese il 12 gennaio 1870, morì a Roma il 7
dicembre 1917. Nel 1900-1901 fu corrispondente della Nuova
Antologia a Parigi e a Londra. Nel 1902 redattore‑capo della
rivista fino alla morte. Discepolo di Arturo Graf. (Nei
Candidati all’Immortalità di Giulio De Frenzi è pubblicata una
lettera autobiografica del Cena). Ricordare l’articolo del Cena
Che fare? pubblicato
dalla «Voce» nel 1912 (mi pare).
Q2 §54 Olii, petrolii e benzine, di Manfredi Gravina nella «Nuova Antologia» del 16 dicembre 1927 (l’articolo continua nella «Nuova Antologia» del 1° gennaio 1928 ed è interessante per avere un accenno generale al problema del petrolio). L’articolo è un riassunto delle recenti pubblicazioni sul problema del petrolio. Estraggo qualche notizia bibliografica e qualche osservazione: Karl Hoffmann, Oelpolitik und angelsächsischer Imperialismus (Ring‑Verlag, Berlino, 1927) che il Gravina dice lavoro magistrale, un compendio eccellente dei grandi problemi petrolieri del mondo ed indispensabile per chi voglia, sulla scorta di dati precisi, approfondirne lo studio (con la riserva che vede troppo «petrolio» in ogni atto internazionale). Il «Federal Oil Conservation Board» formato in America nel 1924 con la missione di studiare ogni mezzo atto a razionalizzare l’eccessivo sfruttamento del patrimonio petrolifero americano ed assicurargli il massimo e il migliore rendimento (lo Hoffmann definisce questo Ufficio «grandioso ente di preparazione industriale alla eventuale guerra del Pacifico»). In questo Board il senatore Hugues, già ministro degli affari Esteri, rappresenta gli interessi diretti di due Società del gruppo Standard (la «Standard» di New York e la «Vacuum Oil»). Lo «Standard Oil Trust» costituito nel 1882 da John D. Rockefeller dovette adattarsi alle leggi contro i trusts. La «Standard» di New Jersey è considerata tuttora come una vera e propria centrale della attività petrolifera della Casa Rockefeller: essa controlla il 20‑25% della produzione mondiale, il 40‑45% delle raffinerie, il 50‑60% delle condutture dai pozzi alle stazioni di avviamento. Accanto alla Standard e società affiliate sono sorte altre imprese, fra cui da ricordare i così detti Big Independents.
La «Standard» è collegata con il Consorzio Harriman (trasporti ferroviari e marittimi, 8 società di navigazione) e col gruppo bancario Kuhn Loeb & Co. di New York, del quale è a capo Otto Kahn. Nel campo inglese i due gruppi più importanti sono la «Shell Royal‑Dutch» e l’«Anglo-Persian Burmah». Direttore generale della «Shell» è l’olandese sir Henry Deterding. La Shell è asservita all’Impero Inglese nonostante i grandi interessi finanziari e politici dell’Olanda. L’«Anglo‑Persian Burmah» può considerarsi governativa britannica e più specialmente dell’Ammiragliato che vi è rappresentato da tre fiduciari. Presidente dell’«Anglo‑Persian» è sir Charles Greenway, coadiuvato da un consulente tecnico, sir John Cadman, che durante la guerra fu a capo del servizio governativo dei petroli. Greenway, Cadman, Deterding e i fratelli Samuel (fondatori della «Shell» inglese poi fusasi colla «Royal‑Dutch») sono considerati di fatto i dirigenti della politica petroliera inglese.
Q2 §55 L’enfiteusi. Il proprietario si chiama direttario, il possessore utilista. Praticamente l’enfiteusi è un affitto che abbia il carattere speciale di essere perpetuo, con la cessione di ogni diritto inerente alla vera proprietà, ma col diritto di fare riacquistare il dominio del fondo, nel caso di mancato pagamento del canone (o censo o livello – prestazioni perpetue). (Teoricamente la figura del proprietario si sdoppia). Il contratto di enfiteusi è più frequente nel meridionale e nel ferrarese: nelle altre regioni è scarsamente applicato. È legato, mi pare, al bracciantato elementare, o meglio al contadino senza terra, che prende in enfiteusi dei piccoli appezzamenti per impiegarvi le giornate in cui non ha lavoro o perché di morta stagione o in rapporto alla monocultura: l’enfiteuta, così, introduce grandi migliorie e dissoda terreni impervi o enormemente sassosi; poiché è disoccupato, non calcola il lavoro presente nella speranza di un utile futuro, data la scarsità dei canoni per le terre quasi sterili. Il lavoro del contadino spesso è tale che il capitale‑lavoro impiegato pagherebbe due o tre volte l’appezzamento. Tuttavia, se per qualsiasi ragione l’utilista non paga il canone, perde tutto.
Dato il carattere di prestazione perpetua, il contratto dovrebbe essere scrupolosamente osservato e lo Stato non dovrebbe intervenire mai. Invece nel 1925 fu accordato ai proprietari l’aumento di un quinto delle corrisposte dei canoni. Nel giugno del 1929 i senatori Garofalo, Libertini, Marcello, Amero d’Aste ebbero la faccia tosta di presentare un progetto di legge in cui si aumentavano ancora i canoni, nonostante la rivalutazione della lira: il progetto non fu preso in considerazione, ma rimane come segno dei tempi, come prova dell’offensiva generale dei proprietari contro contadini.
Q2 §56 Massimo D’Azeglio. In questi anni molte pubblicazioni apologetiche di Massimo D’Azeglio, specialmente del nominato Marcus De Rubris (vedere quanti titoli il De Rubris ha inventato per il D’Azeglio: il cavaliere della nazione, l’araldo della vigilia, ecc. ecc.). Raccogliere materiali per un capitolo di «fame usurpate».
Nel 1860, il D’Azeglio, governatore di Milano, impedì che fossero mandate armi e munizioni a Garibaldi per l’impresa di Marsala, «sembrandogli poco leale (!) aiutare una insurrezione contro il regno di Napoli, con cui si era in relazioni diplomatiche», come scrive il senatore Mozziotti («Nuova Antologia», 1° marzo 1928, La spedizione garibaldina del «Utile». Cfr Luzio, Il milione di fucili e la spedizione dei Mille nella «Lettura» dell’aprile 1910 e la letteratura su Garibaldi in generale: come Garibaldi giudicò il D’Azeglio? Cfr le Memorie). Poiché il D’Azeglio, in altre occasioni, non fu così attaccato alla «lealtà», il suo atteggiamento deve essere spiegato con l’avversione cieca e settaria al partito d’azione e a Garibaldi. L’atteggiamento del D’Azeglio spiega la politica pavida e ondeggiante di Cavour nel 60: D’Azeglio era un Cavour meno intelligente e meno uomo di Stato, ma politicamente si rassomigliavano: non si trattava tanto per loro di unificare l’Italia, quanto di impedire che operassero i democratici.
Q2 §57 Tendenze contro le città. Ricordare nel libro del Gerbi sulla Politica del 700 l’accenno alle opinioni di Engels sulla nuova disposizione da dare agli agglomerati cittadini industriali, dal Gerbi malamente interpretate (e le opinioni di Ford che il Gerbi anche interpreta male). Questi modi di vedere non sono da confondere con le tendenze «illuministiche» contro la città. Vedere le opinioni di Spengler sulle grandi città, definite «mostruosi crematorii della forza del popolo, di cui essi assorbono e distruggono le energie migliori». Ruralismo, ecc.
Q2 §58 Sulla moda. Un articolo molto interessante e intelligente nella Nuova Antologia del 16 marzo 1928: Formazione e organizzazione della moda di Bruno De Pol. (Il De Pol credo sia un industriale milanese del cuoio). Molti spunti, spiegazione della moda dallo sviluppo economico (lusso non è la moda, la moda nasce col grande sviluppo industriale); spiegazione dell’egemonia francese per la moda femminile e inglese per la maschile; situazione attuale di lotta per ridurre queste egemonie a un «condominio»: attività dell’America e della Germania in questo senso. Conseguenze economiche specialmente per la Francia, ecc.
Q2 §59 Tittoni. Ha certamente avuto sempre molta importanza l’opinione di Tittoni nello stabilire i programmi di politica estera del governo dal 23 in poi: seguire l’attività pratica e letteraria di Tittoni in questi anni. Alla sua raccolta di articoli di politica estera del 1928, Quistioni del giorno, ha fatto precedere una interessante prefazione politica il Capo del Governo. Passato di Tittoni. Sua attività. Giudizi su Tittoni di diplomatici stranieri (vedi i Carnets di Georges Louis, ecc.). Suoi rapporti con Isvolsky. (Libro nero di Marchand).
Tittoni come letterato e la sua fissazione linguaiola, curiosa perché la Nuova Antologia pubblica cose errorose per la lingua, specialmente traduzioni, ecc. Vedi l’articolo Per la verità storica, firmato «Veracissimus», nella Nuova Antologia del 16 marzo ‑ 1° aprile 1928: l’autore (Tittoni) vi parla dei suoi rapporti con Isvolsky, dei suoi rapporti con la stampa francese (Isvolsky in un rapporto pubblicato dal Libro Nero aveva accennato al molto denaro che Tittoni distribuì alla stampa al tempo della guerra libica, ecc.), fa degli accenni interessanti al convegno di Racconigi del 1909. Ricordare il libro di Alberto Lumbroso sulle cause economiche della guerra e i suoi accenni a Tittoni (nell’episodio del Carthage e Manouba accennato dal Lumbroso quanta responsabilità spetta a Tittoni?). Nell’articolo c’è anche un accenno rozzo (da mercante di campagna, direbbe Georges Louis) all’ambasciata attuale russa a Parigi e ai suoi possibili contatti col conte Manzoni. (Perché questo animus particolarmente aggressivo di Tittoni? Ricordare lo scandalo provocato nel 1925 – mi pare –, dal Tittoni come Presidente del Senato e per cui il governo dovette domandare scusa. L’episodio più interessante della vita di Tittoni è la sua permanenza a Napoli come prefetto in un tempo di grandi scandali: nella stampa del tempo si potrà trovare il materiale; forse nella «Propaganda», ecc.).
Q2 §60 Su Emanuele Filiberto, è interessante, scritto con serietà (non agiografico) l’articolo di Pietro Egidi nella «Nuova Antologia» del 16 aprile 1928, Emanuele Filiberto di Savoia. Le capacità militari di Emanuele Filiberto sono delineate con perspicuità: Emanuele Filiberto segna il passaggio dalla strategia degli eserciti di ventura alla nuova strategia che troverà poi i suoi rappresentanti in Federico II e in Napoleone: la grande guerra di movimento per obbiettivi capitali e decisivi. A Cateau Cambrésis riesce a riottenere, per l’aiuto della Spagna, il suo Stato, ma nel trattato è stabilita la «neutralità» del Piemonte, cioè è stabilita l’indipendenza sia da Francia che da Spagna (l’Egidi sostiene che sia stato Emanuele Filiberto a suggerire ai francesi di domandare questa neutralità, per essere in grado di sfuggire alla soggezione spagnola, ma si tratta di ipotesi: in questo caso gli interessi della Francia e quelli del Piemonte coincidevano perfettamente): così si inizia la politica estera moderna dei Savoia di equilibrio tra le due potenze principali dell’Europa. Ma dopo questa pace il Piemonte perde già da allora irreparabilmente alcune terre: Ginevra e le terre intorno al lago di Ginevra.
In una storia bisognerebbe almeno accennare alle varie fasi territoriali attraversate dal Piemonte, da prevalentemente francese a franco‑piemontese, a italiano. (Emanuele Filiberto fu fondamentalmente un generale della Controriforma).
L’Egidi delinea abbastanza perspicuamente anche la politica estera di Emanuele Filiberto, ma non dà che cenni in sufficienti sulla politica interna e specialmente militare, e i pochi cenni sono legati a quei fatti di politica interna che dipendevano strettamente dall’estero, cioè dall’unificazione territoriale dello Stato per le retrocessioni delle terre ancora occupate da francesi e spagnoli dopo Cateau Cambrésis o dagli accordi coi Cantoni Svizzeri per riacquistare qualche elemento delle terre perdute. (Per lo studio su Machiavelli studiare specialmente gli ordinamenti militari di Emanuele Filiberto e la sua politica interna per rispetto all’equilibrio di classi su cui si fondò il principato assoluto dei Savoia).
Q2 §61 Controriforma. Nella Nuova Antologia del 16 aprile 1928 Guido Chialvo pubblica una Istruttione di Emanuele Filiberto a Pierino Belli, suo Cancelliere ed Auditore di guerra, sul «Consiglio di Stato» in data 1° dicembre 1559. Ecco l’inizio di questa Istruttione: «Si come il timor di Dio è principio di sapienza et non c’è maggior morbo né più capital peste nel governo de li stati, che quando gl’huomini che ne hanno la cura non temono Dio, et attribuiscono a la prudenza loro quello che si deve solo riconoscer dalla Divina Provvidenza et Inspiratione, et che da questa empia heresia, come dal fonte di ogni vitio derivano tutte le malvagità et scelleratezze del mondo, et gl’huomini ardiscono violar le divine et humane leggi».
Q2 §62 Giuseppe De Maistre. Nel 1927 fu pubblicato a Firenze dalla Libreria editrice fiorentina il libro del De Maistre sul papa (Il papa, traduzione di Tito Casini). In un articolo della «Nuova Antologia» del 16 aprile 1928 (Guelfismo e nazionalismo di Giuseppe De Maistre) Niccolò Rodolico ricorda come il De Maistre nel 1820, in un tempo di restaurate antiche Monarchie e di rinnovata autorità della Santa Sede, ebbe amareggiato l’ultimo anno di sua vita da indugi e da difficoltà opposti per la dedica e per la stampa della seconda edizione di questo libro (che fu pubblicata a Lione nel 1822 postuma). Il De Maistre desiderava dedicare il libro a Pio VII che aveva per lui grandissima stima, e desiderava pubblicarlo in Piemonte, il cui re egli aveva fedelmente servito durante la Rivoluzione, ma non riuscì.
Secondo il Rodolico la condotta di questi cattolicissimi governanti si spiega con le condizioni dello spirito pubblico dal 19 al 20 in Europa, quando liberali, giansenisti e settari anticlericali si agitavano, e con la paura di provocare nuove e più vivaci polemiche. «Dopo più di un secolo – aggiunge il Rodolico – compare in Italia, e senza provocare polemiche, una buona traduzione del libro Du pape, che può ora serenamente essere esaminato sotto un aspetto politico, collegandolo ad altre manifestazioni del pensiero politico del tempo».
La quistione però è che questa pubblicazione, come altre del genere, non è stata fatta «serenamente», per dare agli studiosi un documento, ma è stata fatta come «polemica attuale». Si tratta di un segno dei tempi. La stessa Libreria editrice fiorentina pubblica tutta una collana di tal genere, dove è apparso il Sillabo e altri fossili del genere, preceduti da introduzioni «attuali» scritte da neocattolici del tipo Papini, Manacorda, ecc.
Allo stesso clima di serra calda è dovuta la ristampa del Memorandum di Solaro della Margarita, lanciato in commercio come «attualità». (A questo proposito occorre ricordare la discussione in Senato tra Ruffini e il capo del governo a proposito dello Statuto e il paragone spiritosissimo di Ruffini col Solaro della Margarita).
Notare queste pubblicazioni che sono tipiche, anche se la loro importanza abbia o possa avere una efficacia trascurabile, distinguendole da quelle puramente «clericali». Ma si pone il problema: perché gli stessi clericali non le hanno stampate prima di ora e preferivano essi stessi che non se ne parlasse? Sarebbe interessante vedere quante ristampe abbia avuto il Sillabo negli ultimi tempi: credo che lo stesso Vaticano preferisse lasciarlo cadere nel dimenticatoio e che dopo Pio X «seccasse» la Cattedra del Sillabo creata da monarchici francesi nelle loro scuole di partito. (Questo argomento di De Maistre, Solaro, Sillabo, ecc., occorre tenerlo presente per un paragrafo della rubrica «Passato e presente».
L’articolo del Rodolico è interessante per ciò che dice sulle opinioni antiaustriache del De Maistre, sulle sue convinzioni che il Piemonte dovesse fare una politica nazionale e non angustamente piemontese, ecc. Dal corso dell’articolo appare che il libro sul papa non fu lasciato stampare in Piemonte perché erano al governo i «piemontesisti» assoluti e nel libro del De Maistre sono esposte opinioni che poi saranno riprese dal Gioberti del Primato, sulla funzione nazionale italiana del Papato.
Sul De Maistre libro del Mandoul, Joseph De Maistre et la politique de la Maison de Savoie, Paris, Alcan. (Questa opposizione al De Maistre, moderatissimo uomo, bisogna studiarla nel suo complesso politico per giungere alla esatta comprensione del nesso storico 1848‑49 e alla spiegazione di Novara: rivedere questo articolo del Rodolico, se del caso, e cercare l’altra letteratura documentaria).
Q2 §63 Italia ed Egitto. Articolo di Romolo Tritonj nella «Nuova Antologia» del 16 aprile 1928, Le Capitolazioni e l’Egitto (che sarebbe un capitolo di un Manuale di quistioni politiche dell’Oriente musulmano di prossima pubblicazione ma che non ho visto annunziato o recensito. Il Tritonj è anche autore di un volume, È giunto il momento di abolire le Capitolazioni in Turchia?, pubblicato a Roma nel 1916, e collabora spesso alla «Nuova Antologia» e alla «Politica» di Coppola. Chi è? È uno dei vecchi nazionalisti? Non ricordo. Mi pare serio e informato: è specialista nelle quistioni del prossimo Oriente. Vedere).
È favorevolissimo alle Capitolazioni, specialmente in Egitto, da un punto di vista europeo e italiano: sostiene la necessità della unità fra gli Stati europei nella quistione, ma prevede che questa unità d’azione non sarà mantenuta per il distacco dell’Inghilterra. Coi 4 punti sull’Egitto già l’Inghilterra tentò di staccarsi dall’Europa affermando di riservarsi la «protezione degli interessi stranieri», clausola non chiara perché sembrava che l’Inghilterra s’arrogasse la protezione, escludendone le altre potenze; ma fu spiegato che alla prossima conferenza sulle Capitolazioni l’Inghilterra parteciperebbe su di un piede di uguaglianza con gli altri Stati capitolari.
L’Inghilterra ha in Egitto una colonia molto esigua (se si tolgono i funzionari britannici nell’Amministrazione egiziana e i militari) e accettando l’abolizione delle Capitolazioni venderebbe la pelle degli altri. Per ingraziarsi i nazionalisti, metterebbe in cattiva luce gli altri europei (questo è il punto delicato che preme agli italiani: essi vorrebbero aver amici i nazionalisti, ma fare la politica della colonia italiana in Egitto lasciando l’odiosità della situazione creata dall’Europa all’Egitto sulle spalle dell’Inghilterra: vedere nelle riviste i giudizi sugli avvenimenti egiziani nel 1929‑30: sono contradditori, impacciati: l’Italia è favorevole alle nazionalità ma... ecc.; la stessa situazione per l’India, ma nell’Egitto gli interessi sono molto forti e le ripercussioni dei giudizi più immediate).
La colonia italiana in Egitto è molto selezionata, cioè è di quel tipo i cui elementi sono giunti già alla terza o quarta generazione passando dall’emigrato proletario all’industriale, commerciante, professionista; mantenuto il carattere nazionale, aumentano la clientela commerciale dell’Italia, ecc. ecc. (sarebbe interessante vedere la composizione sociale della colonia italiana: è però probabile che un ragguardevole numero di emigrati dopo tre o quattro generazioni sia salito di classe sociale: in ogni modo le Capitolazioni dànno unità alla colonia e permettono ai funzionari italiani e ai borghesi di controllare tutta la massa degli emigrati).
Nei paesi del Mediterraneo dove sono abolite le Capitolazioni, l’emigrazione italiana o è cessata, o viene gradualmente eliminata (Turchia) o si trova nelle condizioni della Tunisia, dove si cerca di snazionalizzarla. Abolizione delle Capitolazioni significa snazionalizzazione dell’emigrazione (altra quistione, data dal fatto che l’Italia è potenza esclusivamente mediterranea e ogni mutamento in questo mare la interessa più che ogni altra potenza).
Naturalmente il Tritonj vorrebbe mantenersi amici gli Egiziani con queste sue opinioni e riconosce che «è di capitale importanza per noi essere amici del loro Paese».
Q2 §64 R. Garofalo, Criminalità e amnistia in Italia, Nuova Antologia del 1° maggio 1928. Per la figura del Garofalo.
Q2 §65 Claudio Faina, Foreste, combustibili e carburante nazionale, Nuova Antologia del 1° maggio 1928. Interessante. Dimostra che la selvicultura italiana, se coltivata e sfruttata industrialmente, può aumentare di molto il suo rendimento e dare sottoprodotti numerosi. (In questo articolo del Faina, che è il figlio del senatore Eugenio Faina, relatore dell’inchiesta parlamentare sul Mezzogiorno e che si occupa assiduamente di attività organizzative e propagandistiche di carattere agrario – scuole rurali istituite dal padre nell’Umbria, ecc. –, si accenna a un disboscamento intensivo e irrazionale nella montagna della Sardegna meridionale per vendere carbone alla Spagna. Ricordare questo accenno alla Sardegna).
Q2 §66 La quistione agraria. Nella Nuova Antologia del 16 maggio 1928 è pubblicato un articolo di Nello Toscanelli, Il latifondo, che contiene già nella prima pagina una perla come questa: «Da quando l’arte di scrivere ha permesso agli Italiani di avere una storia (!), l’argomento della divisione delle terre è sempre stato all’ordine del giorno» dei comizi popolari. Infatti, in un paese, nel quale si può viver bene per la maggior parte dell’anno all’aria aperta, il diventar padrone, sia pur di un piccolo appezzamento di terra, rappresenta l’aspirazione segreta del cittadino (!?), convinto di poter trovare le più facili gioie ed una fonte perenne di prodotti nei campi, da lui visti soltanto nel rigoglio primaverile delle mèssi o nell’epoca dell’allegra vendemmia. Ed, in minor grado (!?), la dolce visione della proprietà terriera scuote anche (!) il campagnolo, che pur sa (!) le lentezze e le disillusioni dell’agricoltura». (Questo Nello Toscanelli è un tipo bislacco come Loria).
Secondo il Toscanelli la formula: «La terra ai contadini» fu presentata nel 1913 in un programma elettorale dall’onorevole Aurelio Drago. (Ripresa durante la guerra, nel 1917, da un presidente del Consiglio e divulgata nel «Resto del Carlino» dal senatore Tanari). L’articolo del Toscanelli è una verbosa scorribanda giornalistica senza alcun valore (contro la riforma agraria, naturalmente).
Il Toscanelli, nel suo articolo, aveva accennato molto cortesemente al fatto che nel 1917 il senatore Tanari aveva illustrato la formula «la terra ai contadini», per dire che essa non faceva più paura a nessuno se un noto conservatore come il Tanari e un Presidente del Consiglio (chi è stato? Orlando? o si riferisce a Nitti che diventò più tardi Presidente e allora era ministro del Tesoro?) la propugnavano e illustravano. Ma nel 1928 il Tanari si è fortemente adombrato e ha avuto paura che qualcuno credesse essere egli stato, in un qualsiasi momento, un Ravachol (sic) della proprietà.
Nella Nuova Antologia del 1° giugno 1928 è pubblicata una Lettera al Direttore della Nuova Antologia in cui il Tanari si giustifica, cercando di spiegare e di attenuare il suo atteggiamento del 1917: «Tengo a dichiarare che in un articolo: La terra ai contadini? (con tanto di punto interrogativo), e successivamente in un mio studio pubblicato Sulla quistione agraria, non intesi illustrare proprio nulla! Ecco invece come stanno le cose. Ero piuttosto (sic) al corrente di ciò che si prometteva in trincea ai contadini, e quando mi accorsi che la divisione della terra diventava programma di dopo guerra (in corsivo dall’autore) mi pare fosse venuto il tempo di convogliarla nei suoi argini; onde difendere al possibile il principio di proprietà, che io ritenevo... (ecc. ecc.). In qual modo raggiungere questo intento? Erano tempi nei quali con il suffragio sempre più allargato, con i Comuni presi d’assalto dal socialismo (nel 1917?!!), nei Consigli Comunali su dieci consiglieri vi erano forse due aniministratori che pagavano tasse (tasse dirette, vuol dire, ma quelle indirette, tra cui il dazio sul grano a beneficio dei vari Tanari?) mentre altri otto, nullatenenti, le mettevano (cioè cercavano di impedire che le amministrazioni, come avrebbero voluto i vari Tanari, vivessero solo con le imposte indirette). Questo numero esiguo di abbienti di fronte ai non abbienti sottostava alla teoria social‑comunista del così detto “carciofo” (la teoria, a dire il vero, è molto più antica, è precisamente la teoria della politica piemontese nell’unificazione italiana e il Tanari commette un delitto di lesa maestà affermando che si tratta di una teoria socialcomunista, e nel 1917, per giunta); metter cioè sempre più tasse a carico di coloro che possedevano e piano piano, foglia per foglia, giungere alla espropriazione. In alcuni Comuni ci si era quasi arrivati (!?). Cosa mi venne in mente allora?... In Francia, pensavo, sopra una popolazione di 40 milioni di abitanti vi erano nell’anteguerra quattro milioni di proprietari: in Italia sopra 35 milioni non eravamo che un milione e mezzo. Evidentemente in pochi, per difendersi con l’aria che tirava in quei tempi! (“in quei tempi” era poi il 1917!) Ed allora azzardai questa idea veramente “rivoluzionaria”: “Se venisse una legge che facilitasse non coattivamente (notate bene), ma liberamente il trapasso della media e grande proprietà assenteista (in corsivo dall’autore) nei coltivatori diretti del suolo, quando risultassero tecnicamente, moralmente e finanziariamente idonei, pagando la terra, si noti bene (in corsivo dall’autore), con obbligazioni garantite in parte dal reddito della nuova proprietà ed in parte dallo Stato, io non sarei stato contrario (come, Dio me lo perdoni, non lo sono neanche ora) ad una simile legge”. Non l’avessi mai detto! Socialisti più evoluti e intelligenti capirono benissimo dove andavo a vulnerarli e me lo dissero. Altri meno onesti tolsero al mio articolo il punto interrogativo; così che da una questione posta dubitativamente ed interrogativa, si passò ad una affermativa. Nell’altro campo dei proprietari, parecchi che non mi avevano letto, o che non capivano nulla, mi considerarono come un vero espropriatore; e così con la migliore intenzione in difesa del principio di proprietà, bersagliato tra i due fuochi di opposti interessi mi convinsi... che avevo ragione! (corsivo dall’autore)».
Questa lettera del senatore G. Tanari è notevole per la sua ipocrisia politica e per le sue reticenze. Occorre notare: che il Tanari si guarda bene dal dare le indicazioni precise dei suoi scritti, che risalgono alla fine del 17 o ai primi del 18, mentre egli, molto abilmente, ma anche con molta rozza slealtà, cerca di far credere del dopo guerra. Ciò che spinse il Tanari a occuparsi della divisione della terra e a sostenerla esplicitamente (naturalmente egli ha ragione quando sostiene che voleva rafforzare la classe dei proprietari, ma non è questa la quistione) fu lo spavento che invase la classe dirigente per le crisi militari del 17 e che la spinse a fare larghe promesse ai soldati contadini (cioè alla stragrande maggioranza dell’esercito). Queste promesse non furono mantenute e oggi il marchese Tanari si «vergogna» di essere stato debole, di avere avuto paura, di avere fatto della demagogia la più scellerata. In ciò consiste l’ipocrisia politica del Tanari e da ciò le sue reticenze e i suoi tentativi di far apparire la sua iniziativa nell’atmosfera del dopoguerra e non in quella del 1917‑18. Bologna era allora zona di guerra e il Tanari scrisse l’articolo nel «Resto del Carlino», cioè nel giornale che, dopo il «Corriere», era il più diffuso in trincea.
Il Tanari esagera nel descrivere la reazione contro di lui dei proprietari. Di fatto avvenne che il suo primo articolo fu discusso molto serenamente dal senatore Bassini, grande proprietario veneto, il quale mosse al Tanari obbiezioni di carattere tecnico («come possono essere divise le aziende agricole industrializzate») non di carattere politico. L’articolo del Tanari, quello del Bassini e la risposta del Tanari (mi pare che ci sia stata una risposta «illustrativa») furono riportati dalla «Perseveranza», giornale moderato e legato agli agrari lombardi, diretto allora o dal conte Arrivabene o da Attilio Fontana, noto agrario. Il rimprovero che i proprietari avranno certamente fatto al Tanari sarà stato quello di averli compromessi pubblicamente di fronte ai soldati‑contadini, di non aver lasciato che solo degli irresponsabili facessero promesse che si sapeva non sarebbero state mantenute. Ed è questo il rimprovero che anche oggi continueranno a fargli, perché comprendono che non tutti hanno dimenticato come le promesse fatte nel momento del pericolo non sono state mantenute. L’episodio merita di essere esaminato e studiato perché molto educativo. (Su questo episodio devo aver scritto una nota in altro posto, senza aver davanti la lettera del Tanari: vedere e raggruppare).
Q2 §67 Nicola Zingarelli, Le idee politiche del Petrarca, «Nuova Antologia», 16 giugno 1928.
Q2 §68 E. De Cillis, Gli aspetti e le soluzioni del problema della colonizzazione agraria in Tripolitania, Nuova Antologia, 16 luglio 1928. Vedere la letteratura in proposito e seguire le pubblicazioni del De Cillis. L’articolo è interessante perché realistico.
Q2 §69 H. Nelson Gay, Mazzini e Antonio Gallenga apostoli dell’Indipendenza italiana in Inghilterra (con nove lettere inedite di Mazzini), Nuova Antologia, 16 luglio 1928. Tratta specialmente della violazione di segreto epistolare compiuta dal governo inglese a danno di Mazzini nel 1844 prima della spedizione dei fratelli Bandiera e del servizio reso dall’Inghilterra ai Borboni, comunicandogli i dati della congiura. I fratelli Bandiera furono arrestati per «merito» del governo inglese o di un mazziniano traditore (Boccheciampe)? Bisogna vedere con maggiore esattezza, perché l’arresto dei Bandiera domandò misure militari e spese così cospicue, che solo una grande autorità nella fonte d’informazione poteva decidere il governo a fare, dato che non dovevano mancare le informazioni infondate da parte di provocatori e speculatori su congiure, iniziative rivoluzionarie, ecc. Perciò bisogna precisare meglio se la responsabilità del governo inglese (lord Aberdeen) fu solo morale (in quanto realmente informò) o anche decisiva e immediata (in quanto senza di essa non ci sarebbe stata la repressione così come avvenne). Il deputato radicale Duncombe, che presentò in Parlamento la petizione di Mazzini, in un discorso affermò: «Se un monumento dovesse essere eretto in memoria di coloro che caddero a Cosenza, come spero sarà fatto, la lapide commemorativa dovrebbe ricordare che essi caddero per la causa della giustizia e della verità, vittime della bassezza e dell’inganno di un Ministro Britannico».
Q2 §70 La Rivoluzione francese e il Risorgimento. Un motivo che ricorre spesso nella letteratura italiana, storica e non storica, è questo espresso da Decio Cortesi in un articolo, Roma centotrent’anni fa (Nuova Antologia, 16 luglio 1928): «È da deplorare che nella pacifica Italia, che s’incamminava verso un miglioramento graduale e senza scotimenti (!!?), le teorie giacobine, figlie di un idealismo pedantesco, che nei nostri cervelli non ha mai allignato, dessero occasione a tante scene di violenze; ed è da deplorare tanto più perché se queste violenze, nella Francia ancora oppressa dagli ultimi avanzi del feudalismo e da un dispotismo regale, potevano, fino ad un certo punto, essere giustificate, in Italia, dai costumi semplici e schiettamente democratici in pratica (!!?), non avevano uguale (ragione) d’essere. I reggitori d’Italia potevano essere chiamati «tiranni» nei sonetti dei letterati, ma chi senza passione prende a considerare il benessere del quale godé il nostro paese nello splendido secolo XVIII non potrà non pensare con qualche rimpianto a tutto quell’insieme di sentimenti e di tradizioni che l’invasione straniera colpì a morte».
L’osservazione potrebbe essere vera se la restaurazione stessa avvenuta dopo il 15 non dimostrasse che anche in Italia la situazione del secolo XVIII era tutt’altro da quella ritenuta. L’errore è di considerare la superficie e non le condizioni reali delle grandi masse popolari. In ogni modo è giusto che senza l’invasione straniera i «patriotti» non avrebbero acquistato quell’importanza e non avrebbero subìto quel relativamente rapido processo di sviluppo che poi ebbero. L’elemento rivoluzionario era scarso e passivo.
Q2 §71 Sui bilanci dello Stato. Vedere i discorsi in Senato dell’on. Federico Ricci, ex Sindaco di Genova. Questi discorsi sono da leggere prima di ogni lavoro sulla storia di questi anni.
Nel discorso del 16 dicembre 1929 sul rendiconto dell’esercizio finanziario 1927‑28 il Ricci osservò:
1) A proposito della Cassa d’ammortamento del debito estero istituito con decreto‑legge 3 marzo 1926 dopo gli accordi di Washington (14 novembre 1925) e di Londra (27 gennaio 1926): che gli avanzi realizzati sulla differenza fra quota pagata dalla Germania e quota pagata dall’Italia all’America e all’Inghilterra viene imprestata alla Tesoreria che a un certo punto dovrà restituirla (si arriverà a miliardi) quando l’Italia dovrà pagare più di quanto riceve. Pericolo che la Tesoreria non possa pagare. L’Italia ha ricevuto dalla Germania pagamenti in natura e in denaro. Non vengono più pubblicati i resoconti dettagliati delle vendite fatte dallo Stato delle merci ricevute dalla Germania, e delle somme realizzate: non si sa se esse sono maggiori o minori di quelle accreditate.
2) A proposito della Cassa d’ammortamento dei debiti interni, istituita con decreto‑legge 5 agosto 1927 per provvedere all’estinzione del Consolidato e degli altri debiti di Stato. Doveva essere dotata cogli avanzi di bilancio, coi proventi degli interessi dei capitali, coi ricuperi per capitale e interesse dei prestiti fatti dallo Stato a certe industrie private, ecc. Dopo il primo anno, tutti i cespiti principali sono mancati, specialmente gli avanzi di bilancio. Essa è accreditata semplicemente per tali somme, sicché nei residui passivi il suo credito è di lire 1728 milioni. Le offerte dei privati nel resoconto ultimo fino al dicembre 1928 sono di 4 800 000 lire, somma molto inferiore a quella pubblicata nei giornali.
3) Polizze di assicurazione per i combattenti, istituite con decreto‑legge 10 dicembre 1917, in ragione di 500 lire per i soldati, 1000 lire per i sottufficiali e 5000 lire per gli ufficiali (è esatto? O non si parlava di 1000 lire per i soldati?) Esse verranno a scadenza nel 1947 o 1948, rappresentando un carico grandissimo per il bilancio (naturalmente gli interessati non hanno avuto quasi nulla e gli accaparratori saranno loro a riscuotere: ecco un argomento interessante). Il Governo con decreto 10 maggio 1923 aveva provvisto alla costituzione di una riserva presso la Cassa depositi e prestiti dando una prima dotazione di 600 milioni e più di 50 milioni annui I 600 milioni però non furono mai versati: sono iscritti fra i residui all’attivo come prestito da contrarre al 3,50% (portato poi al 4,75% con decreto 10 maggio 1925, n. 852) e al passivo come credito della C.D.P. Quanto ai 50 milioni, furono inscritti in bilancio per qualche anno e poi intervenne un decreto ministeriale il quale cancellò per l’anno in corso (1927) e per i successivi quel versamento (Decreto ministeriale 6 ottobre 1927, n. 116 635). «È curioso (!!?) che sia possibile mutare radicalmente la fisionomia del bilancio solennemente (!) approvato dalle Camere, con semplici decreti ministeriali che non compaiono sulla “Gazzetta Ufficiale”, dei quali lo stesso Capo del Governo potrebbe non saper nulla; e lo stesso ministro competente potrebbe averli firmati inavvertitamente»; queste parole del Ricci sono di colore oscuro)
Una osservazione del Ricci: La Cassa di ammortamento del debito interno, ha fatto un «debituccio» di 80 milioni per ammortizzare il Debito Pubblico!!! La Tesoreria, non sapendo dove sbattere la testa, si fece prestare denaro dall’Alto Commissario della Città di Napoli, dal Consorzio del Porto di Genova, ecc. Si fece prestare dalle Casse d’ammortamento del debito estero e di quello interno, facendo loro un trattamento curioso, non pagando cioè gli interessi!, ecc.
Q2 §72 A proposito dei bilanci. Occorre sempre confrontare il bilancio preventivo normale con le aggiunte, correzioni e variazioni che di solito vengono fatte dopo qualche mese; spesso in questo supplemento di bilancio, si annidano delle voci interessanti (per es. nel preventivo le spese segrete degli Esteri erano 1 500 000: nel supplemento ci fu un aumento di 10 000 000). Certo è che il supplemento interessa meno del preventivo ordinario, e perciò suscita meno curiosità e meno indagini: pare sia ordinaria amministrazione. La seconda parte della p. 96 è bianca.
Q2 §73 L’Action Française e il Vaticano. Bibliografia dal Mercure de France del 1° maggio 1928:
1) F. Gay., Comment j’ai défendu le Pape, «La Vie Catholique».
(Riproduzione degli articoli apparsi sulla «Vie Catholique», contro l’Action Française, dal 6 novembre 1926 al 13 agosto 1927).
2) Mermeix, Le Ralliement et l’Action Française, A. Fayard.
(Storia minutissima e documentatissima, ma molto tendenziosa, dell’adesione dei cattolici alla repubblica e delle vicende dell’Action Française, 1871‑ 1927).
3) A. Lugan, L’Action Française, de son origine à nos jours («Études sur les doctrines de l’Action Française», n. 4).
(Rimprovera all’Action Française d’aver perseguitato con la sua rabbia e le sue ingiurie Piou e l’Action libérale, Marc Sangnier e il Sillon, e di essersi associato a tutti coloro che con mezzi talvolta pochissimo onesti, come la delazione, andavano alla caccia del modernismo e del radicalismo fin tra i cardinali e i papi. La politica, presso questi atei e i loro alleati, contava più che la preoccupazione dell’integrità dottrinale; domanda che la religione venga separata da certe avventure che l’hanno compromessa anche troppo; è una notevole esposizione storica).
4) L’Equivoque du laicisme et les élections de 1928, par un Polytechnicien; Librairie du Petit Démocrate.
(Domanda la formazione di un grande partito che abbracci i «clericali» e una frazione del vecchio partito radicale. I cattolici hanno definitivamente ripudiato ogni spirito di predominio e domandano solo il diritto di sacrificarsi come hanno fatto durante la guerra; a tal fine occorre fare certe distinzioni nelle così dette «leggi laiche»).
5) Paul Rémond (vescovo di Clisma), L’heure d’obéir, «La Vie Catholique».
(«La Santa Sede domandava ai cattolici di porsi nel quadro della Costituzione, per meglio realizzare l’una nimità sul terreno puramente cattolico... L’Action Française dichiara che su questo terreno non può ricevere ordini da Roma...»).
Q2 §74 Bibliografia varia:
1) C. Smogorzeriski, Le jeu complexe des Partis en Pologne, «Geebethner et Wolff».
2) Louis Fischer, L’Impérialisme du pétrole, Rieder.
(Esposizione della storia della produzione del petrolio secondo i documenti del Ministero tedesco e del Commissariato russo. Contro Sir Henri Deterding e gli altri re del petrolio).
3) Charles Benoist, Les lois de la Politique française, A. Fayard.
(Tra l’altro: «il francese è guerriero, ma non militare», ha bisogno di essere disciplinato, perciò «il servizio militare di corta durata non è possibile che con quadri solidissimi»).
4) Georges Valois, Basile ou la Politique de la Calomnie, «Valois».
(Contro Maurras e l’Action Française: autobiografico. Storia del «Cercle Proudhon» e dei suoi «Cahiers». Vedere a proposito della partecipazione di Sorel il libro su Sorel di Pierre Lasserre e la corrispondenza Sorel‑Croce. Per la situazione esistente in Francia nel 1925 e per le speranze dei reazionari, «Maurras s’était presque engagé à faire la monarchie pour le fin de 1925». Per la storia lamentevole del movimento di Valois in Francia).
5) Edouard Champion, Le livre aux Etats Unis; lungo articolo nella «Revue des Deux Mondes» del 15 maggio e 1° giugno 1927.
6) Ottavio Cina, La Commedia Socialista, Bernardo Lux edit., Roma, 1914, pp. VIII‑102, 3° migliaio (?).
Titolo preso dal libro di Yves Guyot, La Comédie Socialiste, Paris, 1897, Charpentier (ma non lo dice).
Questo del Cina è un libercolo molto banale e pedestre, a tipo libellistico. Può essere considerato solo in una bibliografia di questa specie di letteratura ai margini estremi della polemica di quel tempo. Molto generico. Se cita fatti concreti o nomi, commette errori grossolani (cfr a p. 5, a proposito del contrasto Turati-Ferri). Vedi a che titolo lo cita Croce nella bibliografia della sua Storia d’Italia dal 1871 al 1915. Il Cina rimanda, a p. 34, a suoi articoli nell’«Economista d’Italia» del 1910. Fa un esame delle condizioni economiche in quegli anni, molto superficiale e banalmente tendenzioso, naturalmente, e finisce con un appello alla resistenza delle classi borghesi contro gli operai, anche con la violenza. Da questo punto di vista è interessante, come un segno dei tempi. Bisognerebbe vedere chi era (o è) questo signor Cina. Non pare un «nazionalista» nel senso di partito.
Q2 §75 R. Michels, Les Partis politiques e la contrainte sociale, «Mercure de France», 1° maggio 1928, pp. 513-535. «Le parti politique ne saurait être étymologiquement et logiquement qu’une partie de l’ensemble des citoyens, organisée sur le terrain de la politique. Le parti n’est donc qu’une fraction, pars pro toto» (?).
Secondo Max Weber (Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der Sozialökonomik, III, 2a ediz., Tubinga 1925, pp. 167, 639) ha la sua origine da due specie di cause: sarebbe specialmente una associazione spontanea di propaganda e d’agitazione, che tende al potere per procurare così ai suoi aderenti attivi (militanti) possibilità morali e materiali per realizzare fini oggettivi o vantaggi personali o ancora le due cose insieme. L’orientazione generale dei partiti politici consisterebbe pertanto nel Machtstreben, personale o impersonale. Nel primo caso i partiti personali sarebbero basati sulla protezione accordata a degli inferiori da un uomo potente. Nella storia (?) dei partiti politici i casi di tal genere sono frequenti. Nella vecchia dieta prussiana del 1855, che comprendeva molti gruppi politici, tutti avevano il nome dei loro capi: il solo gruppo che si diede il vero nome fu un gruppo nazionale, quello polacco (cfr Friedrich Naumann, Die politischen Parteien, Berlino, 1910, «Die Hilfe», p. 8).
La storia del movimento operaio dimostra che i socialisti non hanno sprezzato questa tradizione borghese. Spesso i partiti socialisti hanno preso il nome dai loro capi («comme pour faire aveu public de leur assujettissement complet à ces chefs») (!). In Germania, tra il e il 1875, le frazioni socialiste rivale erano i Marxisti e i Lassalliani. In Francia, in un’epoca più recente, le grandi correnti socialiste erano divise in Broussistes, Allemanistes, Blanquistes, Guesdistes e Jaurèssistes. È vero che gli uomini che davano così il nome ai diversi movimenti personificavano il più completamente possibile le idee e le tendenze che ispiravano il partito e li guidarono durante tutta la sua evoluzione (Maurice Charnay, Les Allemanistes, Parigi, Rivière, 1912, p. 25).
Forse c’è analogia tra i partiti politici e le sette religiose e gli ordini monastici; Yves Guyot, La Comédie socialiste, Parigi, 1897, Charpentier, p. 111). Ecco dei partiti-tipo, che potrebbero essere chiamati «partis de patronage». Quando il capo esercita un influsso sui suoi aderenti per qualità così eminenti che sembrano soprannaturali a questi ultimi, esso può essere chiamato capo charismatico (, dono di dio, ricompensa; cfr M. Weber, op. cit., p. 140). Questa nota è segnata 4 bis, cioè è stata inserita nelle bozze; non certo per la traduzione di «», ma forse per la citazione del Weber. Il Michels ha fatto molto baccano in Italia per la «sua» trovata del «capo charismatico» che probabilmente occorrerebbe confrontare era già nel Weber; bisognerebbe vedere anche il libro del Michels sulla Sociologia politica del 27: non accenna neanche che una concezione del capo per grazia di dio è già esistita e come!)
Tuttavia questa specie di partito si presenta talvolta in forme più generali. Lo stesso Lassalle, il capo dei Lassalliani, officialmente non era che presidente a vita dell’Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein. Egli si compiaceva di vantarsi dinanzi ai suoi fautori dell’idolatria che godeva da parte delle masse deliranti e delle vergini vestite di bianco che gli cantavano dei cori e gli offrivano dei fiori. Questa fede charismatica non era solo frutto di una psicologia esuberante e un po’ megalomane, ma corrispondeva anche a una concezione teorica. Noi dobbiamo – disse agli operai renani esponendo loro le sue idee sull’organizzazione del partito – di tutte le nostre volontà disperse foggiare un martello e metterlo nelle mani d’un uomo la cui intelligenza, il carattere e l’attaccamento ci siano una garanzia che colpisca energicamente (cfr Michels, Les partis politiques, 1914, p. 130; non rimanda all’edizione italiana ampliata e del 24). Era il martello del dittatore. Più tardi le masse domandarono almeno un simulacro di democrazia e di potere collettivo, si formarono gruppi sempre più numerosi di capi che non ammettevano la dittatura di un solo. Jaurès e Bebel sono due tipi di capi charismatici. Bebel, orfano di un sottufficiale di Pomerania, parlava altezzosamente (?) ed era imperativo (Hervé lo chiamò il Kaiser Bebel: cfr Michels, Bedeutende Männer, Lipsia, 1927, p. 29). Jaurès, oratore straordinario, senza uguali, infiammato, romantico e insieme realista, che cercava di sormontare le difficoltà, «seriando» i problemi, per abbatterli a misura che si presentavano. (Cfr Rappoport, Jean Jaurès. L’homme. Le Penseur. Le Socialiste, 2a ed., Parigi, 1916, p. 366). I due grandi capi, amici e nemici, avevano in comune una fede indomita tanto nell’efficacia della loro azione, che nei destini delle legioni delle quali erano i portabandiera. Furono ambedue deificati: Bebel ancor vivo, Jaurès da morto.
Mussolini è un altro esempio di capo partito che ha del veggente e del credente.
Egli, inoltre, non è solo capo unico di un grande partito, ma è anche il capo unico di un grande Stato. Con lui anche la nozione dell’assioma: «il partito sono io», ha avuto, nel senso della responsabilità e del lavoro assiduo, il massimo sviluppo. (Storicamente inesatto. Intanto è proibita la formazione di gruppi e ogni discussione di assemblea, perché esse si erano verificate disastrose. Mussolini si serve dello Stato per dominare il partito e del partito, solo in parte, nei momenti difficili, per dominare lo Stato. Inoltre il cosidetto «charisma», nel senso del Michels, nel mondo moderno coincide sempre con una fase primitiva dei partiti di massa, con la fase in cui la dottrina si presenta alle masse come qualcosa di nebuloso e incoerente, che ha bisogno di un papa infallibile per essere interpretata e adattata alle circostanze; tanto più avviene questo fenomeno, quanto più il partito nasce e si forma non sulla base di una concezione del mondo unitaria e ricca di sviluppi perché espressione di una classe storicamente essenziale e progressiva, ma sulla base di ideologie incoerenti e arruffate, che si nutrono di sentimenti ed emozioni che non hanno raggiunto ancora il punto terminale di dissolvimento, perché le classi (o la classe) di cui è espressione, quantunque in dissoluzione, storicamente, hanno ancora una certa base e si attaccano alle glorie del passato per farsene scudo contro l’avvenire).
L’esempio che Michels dà come prova della risonanza nelle masse di questa concezione è infantile, per chi conosce la facilità delle folle italiane all’esagerazione sentimentale e all’entusiasmo «emotivo»: una voce su diecimila presenti dinanzi a palazzo Chigi avrebbe gridato: «No, sei tu l’Italia», in un’occasione di commozione obbiettivamente reale della folla fascista. Mussolinia avrebbe poi manifestato l’essenza charismatica del suo carattere nel telegramma inviato a Bologna in cui diceva di essere sicuro, assolutamente sicuro (e certamente lo era, pour cause) che niente di grave poteva capitargli prima d’aver portato a termine la sua missione.
«Nous n’avons pas ici à indiquer les dangers que la conception charismatique peut entraîner» (?). La direzione charismatica porta in sé un dinamismo politico vigorosissimo. Saint‑Simon, nel suo letto di morte, disse ai suoi discepoli di ricordarsi che per fare grandi cose, bisogna essere appassionati. Essere appassionati significa avere il dono di appassionare gli altri. È uno stimolante formidabile. Questo è il vantaggio dei partiti charismatici su gli altri basati su un programma ben definito e sull’interesse di classe. È vero, però, che la durata dei partiti charismatici è spesso regolata dalla durata del loro slancio e dal loro entusiasmo, che talvolta danno una base molto fragile. Perciò vediamo i partiti charismatici portati ad appoggiare i loro valori psicologici (!) sulle organizzazioni più durature degli interessi umani.
Il capo carismatico può appartenere a qualsiasi partito, sia autoritario sia antiautoritario (dato che esistano partiti antiautoritari, come partiti; avviene anzi che i «movimenti» antiautoritari, anarchici, sindacalisti‑anarchici, diventano «partito» perché l’aggruppamento avviene intorno a personalità «irresponsabili» organizzativamente, in un certo senso «carismatiche»).
La classificazione dei partiti del Michels è molto superficiale e sommaria, per caratteri esterni e generici: 1) partiti «carismatici», cioè raggruppamenti intorno a certe personalità, con programmi rudimentali; la base di questi partiti è la fede e l’autorità d’un solo. (Di tali partiti non se n’è mai visti; certe espressioni d’interessi sono in certi momenti rappresentate da certe personalità più o meno eccezionali: in certi momenti di «anarchia permanente» dovuta all’equilibrio statico delle forze in lotta, un uomo rappresenta l’«ordine» cioè la rottura con mezzi eccezionali dell’equilibrio mortale e intorno a lui si raggruppano gli «spauriti», le «pecore idrofobe» della piccola borghesia: ma c’è sempre un programma, sia pure generico, anzi generico appunto perché tende solo a rifare l’esteriore copertura politica a un contenuto sociale che non attraversa una vera crisi costituzionale, ma solo una crisi dovuta al troppo numero di malcontenti, difficili da domare per la loro mera quantità e per la simultanea ma meccanicamente simultanea manifestazione del malcontento su tutta l’area della nazione); 2) partiti che hanno per base interessi di classe, economici e sociali, partiti di operai, contadini o di «petites gens» (poiché) i borghesi non possono da soli formare un partito; 3) partiti politici generati (!) da idee politiche o morali, generali e astratte: quando questa concezione si basa su un dogma più sviluppato ed elaborato fino nei dettagli, si potrebbe parlare di partiti dottrinari, le cui dottrine sarebbero privilegio dei capi: partiti libero scambisti o protezionisti o che proclamano dei diritti di libertà o di giustizia come: «a ciascuno il prodotto del suo lavoro! a ciascuno secondo le sue forze! a ciascuno secondo i suoi bisogni!»
Il Michels trova, meno male, che questa distinzione non può essere netta né completa, perché i partiti «concreti» rappresentano per lo più sfumature intermedie o combinazioni di tutte e tre. A questi tre tipi ne aggiunge altri due: i partiti confessionali e i partiti nazionali (bisognerebbe ancora aggiungere i partiti repubblicani in regime monarchico e i partiti monarchici in regime repubblicano). Secondo il Michels i partiti confessionali più che una Weltanschauung professano una Ueberweltanschauung (che poi è lo stesso). I partiti nazionali professano il principio generale del diritto di ogni popolo e di ogni frazione di popolo alla completa sovranità senza condizioni (teorie di P. S. Mancini). Ma dopo il 48 questi partiti sono spariti, e sono sorti i partiti nazionalisti, senza principi generali perché negano agli altri ecc. (sebbene i partiti nazionalisti non sempre neghino «teoricamente» agli altri popoli ciò che affermano per il proprio: pongono la risoluzione del conflitto nelle armi, quando non partano da concezioni vaghe di missioni nazionali, come poi il Michels dice).
L’articolo è pieno di parole vuote e imprecise. «Il bisogno dell’organizzazione … e le tendenze ineluttabili (!) della psicologia umana, individuale e collettiva, cancellano alla lunga la maggior parte delle distinzioni originarie». (Cosa vuol dire tutto ciò: il tipo «sociologico» non corrisponde al fatto concreto). «Il partito politico come tale ha la sua propria anima (!), indipendente dai programmi e dai regolamenti che si è dato e dai principi eterni di cui è imbevuto». Tendenza all’oligarchia. «Dandosi dei capi, gli stessi operai si creano, con le proprie mani, nuovi padroni, la cui principale arma di dominio consiste nella loro superiorità tecnica e intellettuale, e nell’impossibilità d’un controllo efficace da parte dei loro mandanti». Gli intellettuali hanno una funzione (in questa manifestazione). I partiti socialisti, grazie ai numerosi posti retribuiti e onorifici di cui dispongono, offrono agli operai (a un certo numero di operai, naturalmente!) una possibilità di far carriera, ciò che esercita su di essi una forza di attrazione considerevole (questa forza si esercita, però, più sugli intellettuali).
Complessità progressiva del mestiere politico per cui i capi dei partiti diventano sempre più dei professionisti, che devono avere nozioni sempre più estese, un tatto, una pratica burocratica, e spesso una furberia sempre più vasta. Così i dirigenti si allontanano sempre più dalla massa e si vede la flagrante contraddizione che nei partiti avanzati esiste tra le dichiarazioni e le intenzioni democratiche e la realtà oligarchica (bisogna però osservare che altra è la democrazia di partito e altra la democrazia nello Stato: per conquistare la democrazia nello Stato può essere necessario – anzi è quasi sempre necessario – un partito fortemente accentrato; e poi ancora: le quistioni di democrazia e di oligarchia hanno un significato preciso che è loro dato dalla differenza di classe tra capi e gregari: la quistione diventa politica, acquista un valore reale cioè e non più solo di schematismo sociologico, quando nell’organizzazione c’è scissione di classe: ciò è avvenuto nei sindacati e nei partiti socialdemocratici: se non c’è differenza di classe la quistione diventa puramente tecnica – l’orchestra non crede che il direttore sia un padrone oligarchico – di divisione del lavoro e di educazione, cioè l’accentramento deve tener conto che nei partiti popolari l’educazione e l’«apprendissaggio» politico si verifica in grandissima parte attraverso la partecipazione attiva dei gregari alla vita intellettuale – discussioni – e organizzativa dei partiti. La soluzione del problema, che si complica appunto per il fatto che nei partiti avanzati hanno una grande funzione gli intellettuali, può trovarsi nella formazione tra i capi e le masse di uno strato medio quanto più numeroso è possibile che serva di equilibrio per impedire ai capi di deviare nei momenti di crisi radicale e per elevare sempre più la massa).
Le idee di Michels sui partiti politici sono abbastanza confuse e schematiche, ma sono interessanti come raccolta di materiale grezzo e di osservazioni empiriche e disparate.
Anche gli errori di fatto non sono pochi (il partito bolscevico sarebbe nato dalle idee minoritarie di Blanqui e dalle concezioni, più severe e più diversificate, del movimento sindacalista francese, inspirate da G. Sorel). La bibliografia degli scritti del Michels si può sempre ricostruire dai suoi stessi scritti, perché egli si cita abbondantemente.
La ricerca può incominciare dai libri che ho già. Un’osservazione interessante per il modo di lavorare e di pensare del Michels: le sue scritture sono zeppe di citazioni bibliografiche, in buona parte oziose e ingombranti. Egli appoggia anche i più banali truismi con l’autorità degli scrittori più disparati. Si ha spesso l’impressione che non è il corso del pensiero che determina le citazioni, ma il mucchio di citazioni già pronte che determina il corso del pensiero, dandogli un che di saltellante e improvvisato. Il Michels deve aver costruito un immenso schedario, ma da dilettante, da autodidatta. Può avere una certa importanza sapere chi ha fatto per la prima volta una certa osservazione, tanto più se questa osservazione ha dato uno stimolo a una ricerca o ha fatto progredire in qualsiasi modo una scienza. Ma annotare che il tale o il tal altro ha detto che due e due fanno quattro è per lo meno inetto.
Altre volte le citazioni sono molto addomesticate: il giudizio settario, o, nel caso migliore, epigrammatico, di un polemista, viene assunto come fatto storico o come documento di fatto storico. Quando a p. 514 di questo articolo sul «Mercure de France», egli dice che in Francia la corrente socialista era divisa in Broussisti, Allemanisti, Blanquisti, Guesdisti e Jauressisti per trarne l’osservazione che nei partiti moderni avviene come negli ordini monastici medioevali (benedettini, francescani, ecc.), con la citazione della Comédie socialiste di Yves Guyot, da cui deve aver preso lo spunto, egli non dice che quelle non erano le denominazioni ufficiali dei partiti, ma denominazioni di «comodo» nate dalle polemiche interne, anzi quasi sempre contenevano implicitamente una critica e un rimprovero di deviazione personalistica, critica e rimprovero scambievoli che si irrigidivano poi nell’effettivo uso della denominazione personalistica (per la stessa ragione «corporativa» e «settaria» per cui i «Gueux» si chiamarono anch’essi così). Per questa ragione tutte le considerazioni epigrammatiche del Michels cadono nel superficialismo da salotto reazionario.
La pura descrittività e classificazione esterna della vecchia sociologia positivistica sono un altro carattere essenziale di queste scritture del Michels: egli non ha nessuna metodologia intrinseca ai fatti, nessun punto di vista critico che non sia un amabile scetticismo da salotto o da caffè reazionario che ha sostituito la sbarazzineria altrettanto superficiale del sindacalismo rivoluzionario e del sorellismo.
Rapporti tra Michels e Sorel: lettera di Sorel a Croce in cui accenna alla superficialità di Michels e tentativo meschino del Michels per togliersi di dosso il giudizio del Sorel. Nella lettera al Croce del 30 maggio 1916 («Critica», 20 settembre 1929, p. 357) il Sorel scrive: «Je viens de recevoir une brochure de R. Michels, tirée de Scientia, mai 1916: “La débacle de L’Internatioriale ouvrière et l’avenir”. Je vous prie d’y jeter les yeux; elle me semble prouver que l’auteur n’a jamais rien compris à ce qui est important dans le marxisme. Il nous présente Garibaldi, L. Blanc, Benoit Malon (!!) comme les vrais maîtres de la pensée socialiste…». (L’impressione del Sorel deve essere esatta – io non ho letto questo scritto del Michels – perché essa colpisce in modo più evidente nel libro del Michels sul movimento socialista italiano, Edizioni della «Voce»).
Nei «Nuovi studi di Diritto, Economia e Politica» del settembre‑ottobre 1929, il Michels pubblica cinque letterine inviategli dal Sorel (1a nel 1905,2a nel 1912 3a nel 1917, 4a nel 17, 5a nel 17) di carattere tutt’altro che confidenziale, ma piuttosto di corretta e fredda convenienza, e in una nota (v. p. 291) scrive a proposito del su citato giudizio: «Il Sorel evidentemente non aveva compreso (!) il senso più diretto dell’articolo incriminato, in cui io avevo accusato (!) il marxismo di lasciarsi sfuggire (!) il lato etico del socialismo mazziniano ed altro, e di aver, esagerando il lato meramente economico, portato il socialismo alla rovina. D’altronde, come risulta dalle lettere già pubblicate (quali lettere? quelle pubblicate dal Michels, queste cinque in parola? esse non dicono nulla), lo scatto (in corsivo dal Michels, ma si tratta di ben altro che scatto; per il Sorel si tratta, pare, di conferma di un giudizio già fatto da un pezzo) del Sorel nulla tolse ai buoni rapporti (!) coll’autore di queste righe». In queste nei «Nuovi Studi», il Michels mi pare tende ad alcuni fini discretamente interessanti e ambigui: a gettare un certo discredito sul Sorel come uomo e come «amico» dell’Italia e a far apparire se stesso come patriotta italiano di vecchia data. Ritorna questo motivo molto equivoco nel Michels (credo di aver notato altrove la sua situazione allo scoppio della guerra). È interessante la letterina di Sorel a Michels del 10 luglio 1912: «Je lis le numéro de la Vallée d’Aoste che vous avez bien voulu m’envoyer. J’y ai remarqué que vous affirmez un droit au séparatisme qui est bien de nature à rendre suspect aux Italiens le maintien de la langue française dans la Vallée d’Aoste», Michels nota che si tratta di un numero unico: «La Vallée d’Aoste pour sa langue française», pubblicato nel maggio 1912 ad Aosta dalla tipografia Margherittaz, sotto gli auspici di un Comitato locale valdostano per la protezione della lingua francese (collaboratori, Michels, Croce, Prezzolini, Graf, ecc.). «Inutile dire che nessuno di questi autori aveva fatta sua, come con soverchia licenza poetica si esprime il Sorel, una qualsiasi tesi separatista». Il Sorel accenna solo al Michels ed io sono portato a credere che egli abbia veramente per lo meno accennato al diritto al separatismo (bisognerebbe controllare nel caso di una presentazione del Michels che sarà necessaria un giorno).
Q2 §76 Gli ufficiali in congedo. Traggo le notizie dal discorso del senatore Libertini tenuto al Senato il 10 giugno 1929. L’Unione Nazionale degli Ufficiali in congedo illimitato (U.N.U.C.I.) è sorta in relazione al R. D. L. 9 dicembre 1926 (n. 2352) convertito in legge il 12 febbraio1928 n. 261: diede frutti molto scarsi, perché, dice il Libertini, «mancava in essa lo spirito necessario a darle vita».
(Questa affermazione è interessante, in quanto per «spirito» si intende precisamente la concessione di benefici materiali, i quali, in questo caso, vengono velati eufemisticamente nell’espressione «giuste aspirazioni della benemerita classe degli ufficiali in congedo, i quali sentivano di avere bene meritato dalla Patria per i servizi da loro prestati nella guerra di redenzione ed intendono perciò esser tenuti nella considerazione che meritano, moralmente e materialmente». Se si fosse trattato di classi popolari, non si sarebbe trattato di «spirito» ma di basse avidità materialistiche, suscitate dalla demagogia, ecc. Questo modo di pretendere «gratuitamente» dalle masse popolari ciò che invece è «pagato» alle altre classi è caratteristico dei dirigenti italiani: se le masse rimangono passive, la colpa non è dell’insipienza dei dirigenti e del loro gretto egoismo, ma dei demagoghi: è poi notevole il modo di ragionare per cui è «materialistico» chi vuole migliorare le proprie condizioni economiche ma non è tale chi non vuole peggiorare sia pure di poco le proprie: si domanda «materialisticamente», si rifiuta «idealisticamente»; chi non ha è gretto, chi ha è altruista perché non dà, ecc.).
Nuova legge del 24 dicembre 1928, n. 3242, che concede benefizi. Il Libertini a questo punto esamina la situazione degli ufficiali in congedo in Jugoslavia e in Francia. In Francia gli ufficiali di riserva, se viaggiano per recarsi alle conferenze ed esercitazioni nelle scuole di perfezionamento fuori residenza, ricevono indennità dai 12 ai 32 franchi giornalieri a seconda della durata dell’assenza; indennità chilometriche di prima classe (tariffa militare) andata e ritorno, ecc. ecc. A partire dal 1° gennaio1925 l’ufficiale di riserva francese riceve 700 franchi a titolo di indennità di prima vestizione; a chi non ha riscosso questa indennità, si dà un vestito gratis.
In Jugoslavia: sono iscritti all’Albo degli ufficiali in congedo ed ex combattenti costituito nel 1922, 18 000 ufficiali di riserva e 35 000 ex combattenti, cioè a dire la quasi totalità degli ufficiali in congedo. In caso di «servizio» per istruzione, ecc., sono vettovagliati, alloggiati e rimborsati delle spese di viaggio.
Ancora a proposito dello «spirito», nel discorso alla Camera il generale Gazzera, sottosegretario alla guerra, ammise che il provvedimento di invitare gli ufficiali in congedo a prestare volontariamente servizio durante il periodo estivo di esercitazioni ha avuto questo risultato: nel 1926 si presentarono 1007 ufficiali, nel 27 206 e nel 28 165!!
(Lo Stato deve curare gli ufficiali in congedo per due fondamentali ordini di ragioni: la prima di carattere tecnico, perché questi ufficiali, che saranno richiamati come tali in caso di mobilitazione, non perdano la qualifica professionale acquistata e la sviluppino anzi coll’apprendimento teorico-pratico delle innovazioni che vengono introdotte nei sistemi tattici e strategici; la seconda di carattere ideologico facilmente comprensibile.
A proposito dello «spirito» e della «materia» le osservazioni non riguardano naturalmente gli ufficiali, ma i dirigenti. Le cifre del Gazzera sono molto interessanti, più ancora se si considera che molti sono gli ufficiali appartenenti alle organizzazioni ufficiali politiche: sono da mettere insieme alle cifre sull’appartenenza alle associazioni di propaganda coloniale citate da Carlo Curcio nella «Critica fascista» del luglio 1930: da tener presente per la rubrica Passato e Presente).
Q2 §77 La politica militare. Leggere attentamente le discussioni specialmente del Senato sui bilanci militari. Si possono trovare molte osservazioni interessanti sulla reale efficienza delle forze armate e per il confronto tra il vecchio e nuovo regime.
Q2 §78 Atlantico‑Pacifico. Funzione dell’Atlantico nella civiltà e nell’economia moderna. Si sposterà questo asse nel Pacifico? Le masse più grandi di popolazione del mondo sono nel Pacifico: se la Cina e l’India diventassero nazioni moderne con grandi masse di produzione industriale, il loro distacco dalla dipendenza europea romperebbe appunto l’equilibrio attuale: trasformazione del continente americano, spostamento dalla riva atlantica alla riva del Pacifico dell’asse della vita americana, ecc. Vedere tutte queste quistioni nei termini economici e politici (traffici, ecc.).
Q2 §79 I contadini italiani. Problemi contadini: malaria, brigantaggio, terre incolte, pellagra, analfabetismo, emigrazione. (Nel Risorgimento questi problemi furono trattati? come? da chi?). Nel periodo del Risorgimento alcuni di questi malanni raggiungono il grado massimo di gravità: il Risorgimento coincide con un periodo di grande depressione economica in larghe regioni italiane, che viene aumentata dal sommovimento politico. La pellagra apparve in Italia nel corso del 700, e andò sempre più aggravandosi nel secolo successivo: ricerche sulla pellagra di medici ed economisti. (Quali le cause della pellagra e della cattiva nutrizione dei contadini che ne è l’origine?). Confrontare il libro di Luigi Messedaglia: Il Mais e la vita rurale italiana (Piacenza, Ed. Federazione dei consorzi agrari, 1927). Questo libro del Messedaglia è necessario per lo studio della quistione agraria italiana, come il libro del Jacini e quelli di Celso Ulpiani.
Q2 §80 Sull’emigrazione italiana. Articolo di Luigi Villari nella Nuova Antologia del 16 febbraio 1928: L’emigrazione italiana vista dagli stranieri. Sull’emigrazione il Villari ha scritto parecchio: vedere. (In questo articolo recensisce alcuni libri americani, inglesi e francesi che parlano dell’emigrazione italiana).
Q2 §81 I volontari nel Risorgimento. Paulo Fambri scrisse un articolo sui volontari nella Nuova Antologia (o «Antologia») del 1867 (?). Nella Nuova Antologia del 1° agosto 1928, L’Archivio inedito di Paulo Fambri (di A. F. Guidi), è riportata una lettera diretta al Fambri del generale C. di Robilant che era direttore della Scuola Superiore di Guerra di Torino (la lettera è del 31 gennaio 1868) in cui si approva la prima parte dell’articolo del Fambri. Il Di Robilant aggiunge che dei 21 000 volontari del 1859 solo la metà o poco più era presente nelle file combattenti (cfr i giudizi di Plon‑Plon contro i volontari in questa stessa guerra del 59).
Q2 §82 Giolitti. Articolo nella Nuova Antologia del 1° agosto 1928 su G. Giolitti di Spectator (che deve essere Mario Missiroli). L’articolo è interessante e bisogna servirsene nel caso di trattazione dello stesso argomento. Giolitti e il movimento operaio e socialista, Giolitti e il dopoguerra, ecc. Molti aspetti della politica di Giolitti sono appena sfiorati: in realtà il nocciolo della sua azione non è toccato, sebbene ci siano accenni che potrebbero far pensare che il Missiroli avrebbe potuto dire di più.
Q2 §83 Francesco Tommasini, La Conferenza panamericana dell’Avana, Nuova Antologia del 16 agosto e 1° settembre 1928. Articolo molto analitico e minuzioso.
Q2 §84 G. E. di Palma Castiglione L’organizzazione internazionale del lavoro e la XI sessione della Conferenza internazionale del lavoro, Nuova Antologia del 16 agosto.
Q2 §85 Daniele Varé, Pagine di un diario in Estremo Oriente, «Nuova Antologia» del 16 settembre, 1° e 16 ottobre 1928. Il Varé è un diplomatico italiano ministro in Cina non so di che grado: ha firmato l’accordo tra il governo italiano e quello di Ciang‑Kai‑Sceck nel 28 o 29. Queste pagine di diario sono disastrose sia letterariamente che da ogni altro punto di vista. Ai diplomatici dovrebbe essere proibita ogni pubblicazione (non solo per ciò che riguarda la politica) senza il placet di un ufficio speciale di revisione costituito di persone intelligenti, perché le loro fesserie extra‑diplomatiche nuocciono al governo tanto quanto quelle diplomatiche e feriscono il prestigio dello Stato che ha dato loro incarichi di rappresentanza.
Q2 §86 Giuseppe Tucci, La religiosità dell’India, Nuova Antologia 16 settembre 1928. Articolo interessante. Critica tutti i luoghi comuni che di solito si ripetono sull’India e sull’«anima» indiana, sul misticismo, ecc. L’India attraversa una crisi spirituale; il nuovo (spirito critico) non è ancora così diffuso da formare un’«opinione pubblica» che si contrapponga al vecchio: superstizione nelle classi popolari, ipocrisie, mancanza di carattere nelle classi superiori così dette colte. In realtà anche in India, le quistioni e gli interessi pratici assorbono l’attenzione pubblica. (È evidente che in India, dato il secolare intorpidimento sociale, e le stratificazioni ossificate della società e data anche, come avviene nei grandi paesi agrari, la grande quantità di intellettuali medii, specialmente ecclesiastici, la crisi durerà molto a lungo e sarà necessaria una grande rivoluzione perché si abbia l’inizio di una soluzione). Molte osservazioni che il Tucci fa a proposito dell’India si potrebbero fare per molti altri paesi e altre religioni. Tenere presente.
Q2 §87 Oscar di Giamberardino, Linee generali della politica marittima dell’Impero britannico, Nuova Antologia, 16 settembre 1928. Utile.
Q2 §88 Ettore Fabietti, Il primo venticinquennio delle Biblioteche popolari milanesi, Nuova Antologia, 1° ottobre 1928. Articolo molto utile per le informazioni che dà sull’origine e lo sviluppo di questa istituzione che è stata la più cospicua iniziativa per la cultura popolare del tempo moderno. L’articolo è abbastanza serio, sebbene il Fabietti abbia dimostrato di non essere lui molto serio: bisognerà riconoscergli tuttavia molte benemerenze e una indiscutibile capacità organizzativa nel campo della cultura operaia in senso democratico. Il Fabietti mette in luce come gli operai fossero i migliori «clienti» delle biblioteche popolari: curavano i libri, non li smarrivano (a differenza delle altre categorie di lettori: studenti, impiegati, professionisti, donne di casa, benestanti (?), ecc.); le letture di «belletristica» rappresentavano una percentuale relativamente bassa, inferiore a quella di altri paesi: operai che proponevano di pagare la metà di libri costosi pur di poterli leggere: operai che davano oblazioni fino di cento lire alle biblioteche popolari; un operaio tintore che è divenuto «scrittore» e traduttore dal francese con le letture e gli studi fatti nelle biblioteche popolari, ma continua a rimanere operaio.
La letteratura delle biblioteche popolari milanesi dovrà essere studiata per avere spunti «reali» sulla cultura popolare: quali libri più letti come categoria e come autori, ecc.; pubblicazioni delle biblioteche popolari, loro carattere, tendenze, ecc. Come mai una tale iniziativa solo a Milano in grande stile? Perché non a Torino o in altre grandi città? Carattere e storia del «riformismo» milanese; Università Popolare, Umanitaria, ecc. Argornento molto interessante ed essenziale.
Q2 §89 I primordi del movimento unitario a Trieste, di Camillo de Franceschi, Nuova Antologia, 1° ottobre 1928. Articolo incoerente e a base retorica. Ci sono però degli accenni all’intervento del «materialismo storico» nella trattazione della quistione nazionale, argomento che sarà interessante studiare concretamente.
Di Angelo Vivante: Socialismo, Nazionalismo, Irredentismo nelle provincie adriatiche orientali, Trieste, 1905; Irredentismo adriatico, Firenze, 1912 (opuscoli della «Voce»?). Del Vivante, che fu uomo molto serio e di molto carattere, furono pubblicati opuscoli dall’editrice «Avanti!» per cura di Mussolini, che difese il Vivante dagli attacchi feroci degli irredentisti e nazionalisti. Alla bibliografia su questo argomento bisogna aggiungere gli articoli di Mussolini sull’«Avanti!» a proposito di Trieste e il suo opuscolo sul Trentino pubblicato dalla «Voce». Articoli furono pubblicati dal «Viandante» di Monicelli, dovuti ad Arturo Labriola, a Francesco Ciccotti e mi pare ad altri (il problema nazionale fu uno dei punti critici per cui una parte degli intellettuali sindacalisti passò al nazionalismo: Monicelli, ecc.). Vedere in quanto il Vivante seguiva l’austro‑marxismo sulla quistione nazionale e in quanto se ne distaccava; vedere le critiche dei russi all’austro‑marxismo sulla quistione nazionale. Speciale forma che assumeva la quistione nazionale a Trieste e in Dalmazia (per gli italiani): articolo di Ludo Hartmann nella «Unità» del 1915 riprodotto nel volumetto sul Risorgimento (ed. Vallecchi): polemiche sulla «Voce» a proposito dell’irredentismo e della quistione nazionale con molti articoli (mi pare uno del Borgese) favorevoli alla tesi «austriaca» (Hartmann).
Q2 §90 La nuova evoluzione dell’Islam, 1) Michelangelo Guidi, 2) Sirdar Ikbal Ali Shah, Nuova Antologia, 1° ottobre 1928. Si tratta di un articolo mediocre del diplomatico afgano anglofilo Ikbal Ali Shah e di una breve nota introduttiva del prof. Michelangelo Guidi. La nota del Guidi pone, senza risolverlo, il problema se l’Islam sia come religione conciliabile con il progresso moderno e se esso sia suscettibile d’evoluzione. Si riferisce a un recente libretto del prof. R. Hartmann, «profondo e diligente studioso tedesco di lingue e civiltà orientali», Die Krisis des Islams, pubblicato dopo un soggiorno ad Angora e che risponde affermativamente alla quistione; e riporta il giudizio espresso dal prof. Kampffmeyer in una recensione pubblicata del libretto dello Hartmann nell’«Oriente Moderno» (agosto 1928) che un breve soggiorno in Anatolia non può essere sufficiente per giudicare su quistioni così vive, ecc., e che troppe delle fonti dell’Hartmann sono di origine letteraria e le apparenze ingannano, in Oriente più che altrove, ecc. Il Guidi (almeno in questa nota) non conclude, ricordando solo che può soccorrerci l’opinione degli orientali stessi (ma non sono essi «apparenza» che inganna, presi uno per uno ecc.?), sebbene all’inizio abbia scritto che sarebbe utopistico pensare che l’Islam possa mantenersi nel suo splendido isolamento e che nell’attesa maturino in esso nuovi formidabili agenti religiosi e la forza insita nella concezione orientale della vita abbia ragione del materialismo occidentale e riconquisti il mondo.
Mi pare che il problema sia molto più semplice di quanto lo si voglia fare apparire, per il fatto che implicitamente si considera il «cristianesimo» come inerente alla civiltà moderna, o almeno non si ha il coraggio di porre la quistione dei rapporti tra cristianesimo e civiltà moderna. Perché l’Islam non potrebbe fare ciò che ha fatto il cristianesimo? Mi pare anzi che l’assenza di una massiccia organizzazione ecclesiastica del tipo cristiano‑cattolico dovrebbe rendere più facile l’adattamento. Se si ammette che la civiltà moderna nella sua manifestazione industriale economico‑politica finirà col trionfare in Oriente (e tutto prova che ciò avviene e che anzi queste discussioni sull’Islam avvengono perché c’è una crisi determinata appunto da questa diffusione di elementi moderni) perché non bisogna concludere che necessariamente l’Islam si evolverà? Potrà rimanere tal quale? No: già non è più quello di prima della guerra. Potrà cadere d’un colpo? Assurdo. Potrà essere sostituito da una religione cristiana? Assurdo pensarlo per le grandi masse. Il Vaticano stesso si accorge come sia contradditorio voler introdurre il cristianesimo nei paesi orientali in cui viene introdotto il capitalismo: gli orientali ne vedono l’antagonismo che nei nostri paesi non si vede perché il cristianesimo si è adattato molecolarmente ed è diventato gesuitismo, cioè una grande ipocrisia sociale: da ciò le difficoltà dell’opera delle missioni e lo scarso valore delle conversioni, d’altra parte molto limitate.
In realtà la difficoltà più tragica per l’Islam è data dal fatto che una società intorpidita da secoli di isolamento e da un regime feudale imputridito (naturalmente i signori feudali non sono materialisti!!) è troppo bruscamente messa a contatto con una civiltà frenetica che è già nella sua fase di dissoluzione. Il Cristianesimo ha impiegato nove secoli a evolversi e ad adattarsi, lo ha fatto a piccole tappe, ecc.: l’Islam è costretto a correre vertiginosamente. Ma in realtà esso reagisce proprio come il cristianesimo: la grande eresia su cui si fonderanno le eresie propriamente dette è il «sentimento nazionale» contro il cosmopolitismo teocratico. Appare poi il motivo del ritorno alle «origini» tale e quale come nel cristianesimo; alla purezza dei primi testi religiosi contrapposta alla corruzione della gerarchia ufficiale: i Wahabiti rappresentano proprio questo e il Sirdar Ikbal Ali Shah spiega con questo principio le riforme di Kemal Pascià in Turchia: non si tratta di «novità» ma di un ritorno all’antico, al puro, ecc. ecc. Questo Sirdar Ikbal Ali Shah mi pare dimostri proprio come tra i mussulmani esista un gesuitismo e una casistica altrettanto sviluppati che nel cattolicismo.
Q2 §91 Giuseppe Gallavresi, Ippolito Taine storico della Rivoluzione francese, «Nuova Antologia», 1° novembre 1928. Cabanis (Giorgio) 1750‑1808, sue teorie materialiste esposte nel libro dedicato allo studio dei rapporti tra le physique et le moral. Il Manzoni ammirava profondamente l’angélique Cabanis e anche quando si convertì continuò ad ammirare questo suo libro. Il Taine discepolo del Cabanis.
Il metodo induttivo e le norme dell’osservazione presi a prestito dalle scienze naturali dovevano portare il Taine, secondo il Gallavresi, alla conclusione che la Rivoluzione francese sia stata una mostruosità, una malattia. «La democrazia egualitaria è una mostruosità alla luce delle leggi della natura; ma il fatto che è stata concepita dall’uomo ed anche realizzata tratto tratto nella storia di taluni popoli deve far riflettere gli spiriti più riluttanti ad accettare un regime pur così convenzionale». (Interessanti questi concetti di «convenzionale», di «artificiale», ecc., applicati a certe manifestazioni storiche: «convenzionale» e «artificiale» sono implicitamente contrapposti a «naturale», cioè a uno schema «conservatore» veramente convenzionale e artificiale perché la realtà lo ha distrutto: in verità i peggiori «scientifisti» sono i reazionari che si proiettano una «evoluzione» di proprio comodo e ammettono l’importanza e l’efficacia dell’intervento della volontà umana fortemente organizzata e concentrata, solo quando è reazionaria, quando tende a restaurare ciò che è stato, come se ciò che è stato ed è stato distrutto non sia altrettanto «ideologico», «astratto», «convenzionale», ecc., di ciò che ancora non è stato effettuato e anzi molto più).
Questa quistione del Taine e della Rivoluzione Francese deve essere studiata perché ha avuto una certa importanza, nella storia della cultura del secolo scorso: confronta i libri di Aulard contro Taine e le pubblicazioni di Augustin Cochin su tutti e due. Questo articolo del Gallavresi è molto superficiale. (Confronta anche il fatto per cui la letteratura pamphletistica che precedette e accompagnò la Rivoluzione Francese sembra stomachevole agli spiriti raffinati: ma la letteratura gesuitica contro la Rivoluzione fu migliore o non fu peggiore? La classe rivoluzionaria intellettualmente è sempre debole da questo punto di vista: essa lotta per farsi una cultura ed esprimere una classe colta consapevole e responsabile: di più, tutti i malcontenti e i falliti delle altre classi si buttano dalla sua parte per rifarsi una posizione. Lo stesso non può dirsi della vecchia classe conservatrice, anzi il contrario: eppure la sua letteratura di propaganda è peggiore e più demagogica, ecc.).
Q2 §92 I problemi dell’automobilismo al Congresso mondiale di Roma, di Ugo Ancona, nella Nuova Antologia del 1° novembre 1928. (Contiene qualche spunto interessante sulla mania delle autostrade dispendiosissime di questi anni e sul «puricellismo»; possono servire per Passato e presente: bisognerebbe fissare quanto nelle spese statali e locali è andato a strade indispensasabili e quanto a strade di lusso.
Q2 §93 Sull’americanismo. Roberto Michels, Cenni sulla vita universitaria negli Stati Uniti, Nuova Antologia, 1° novembre 1928. Qualche spunto interessante,
Q2 §94 Sulla finanza dello Stato. Le riforme del Tesoro, di «Alacer», nella Nuova Antologia del 16 novembre 1928. Integra l’articolo di Tittoni del giugno 27: da tener presente per seguire tutte le varie fasi della lotta sorda che gli elementi conservatori conducono intorno alla politica finanziaria.
Q2 §95 Quistioni interessanti della storia e della politica italiana. Confrontare Il mistero dei «Ricordi diplomatici» di Costantino Nigra di Delfino Orsi nella Nuova Antologia del 16 novembre 1928.
Articolo molto importante, sebbene pieno di particolari sciocchezze – (alcune delle quali dimostrano a che punto di esasperazione bestialmente acritica erano giunti molti borghesi italiani: a p. 148 l’Orsi scrive: «Il 19 ottobre 1904 il conte Nigra era giunto a Torino per recarsi il giorno dopo a Racconigi, dove il Re l’aveva chiamato per averlo testimonio, insieme al Bianchieri, alla rogazione dell’atto di nascita del Principe Ereditario. Da due giorni con un pretesto di sustrato economico, ma in verità coll’intenzione (!!) di turbare l’esultanza della Nazione per il faustissimo evento della Reggia, il partito socialista, messosi come al solito vilmente a rimorchio dei comunisti (!! nel 1904!), aveva proclamato lo sciopero generale in tutta Italia». Come le frasi fatte sostituiscono ogni forma responsabile di pensiero fino a condurre alle sciocchezze più esilaranti! Si potrebbe collocare in rubrica in Passato e Presente) –, perché riguarda uno di quei fatti che rimangono misteriosi: la sparizione dei Ricordi diplomatici del Nigra che l’Orsi ha visto ultimati, corretti, rifiniti e che sarebbero stati preziosissimi per la storia del Risorgimento. Collegare con l’affare Bollea per l’epistolario di M. D’Azeglio, coi costituti Confalonieri, ecc.
Q2 §96 Alfredo Oriani. È interessante una nota di Piero Zama, Alfredo Oriani candidato politico, nella Nuova Antologia del 16 novembre 1928.
Q2 §97 Augur, Il nuovo aspetto dei rapporti tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d’America, Nuova Antologia del 16 dicembre 1928. (Espone questa ipotesi: che gli Stati Uniti cerchino di diventare la forza politica egemone dell’Impero inglese, cioè conquistino l’impero inglese dall’interno e non dall’esterno con una guerra).
Nello stesso fascicolo della Nuova Antologia vedi anche Oscar di Giamberardino La politica marittima degli Stati Uniti d’America; questo articolo è molto interessante e da tener presente.
Q2 §98 Nino Cortese, L’esercito napoletano e le guerre napoleoniche, Napoli, Ricciardi, 1928, pp. 199, in 8°, L. 12).
Q2 §99 Giuseppe Brindisi, Giuseppe Salvioli, Napoli, Casella, 1928, pp. 142, L. 5 (collezione «Contemporanei».
Il Brindisi è l’editore e il prefattore dell’edizione postuma del Capitalismo antico del Salvioli: vedere se in questo volumetto tratta la quistione dei rapporti tra il Salvioli e il materialismo storico nella forma crociana, ecc. (La prefazione al Capitalismo antico è però mediocre e balzellante). Da una recensione del Tilgher in «Italia che scrive» (settembre 1928) vedo che questo argomento è trattato ampiamente, insieme ad un altro, anch’esso interessante: le concezioni sociali del Salvioli, che lo portavano a una specie di socialismo giuridico di Stato (!?) non senza somiglianza con la legislazione sociale fascista.
Q2 §100 Pietro Silva, Bilanci consuntivi. La Storiografia, nell’«Italia che scrive» del settembre 1928. Interessante nota bibliografica sulle più recenti pubblicazioni storiche italiane. Da tener presente. Deve essere interessante, per le mie particolari ricerche, il volumetto di Arrigo Solmi, L’unità fondamentale della storia italiana (ed. Zanichelli), diretto a rintracciare e ad additare nella storia della penisola una continuità nazionale mai spezzata dai tempi di Roma in poi. Concezione interessante, ma certamente indimostrabile e riflesso indubbio degli attuali bisogni di propaganda.
(Contro questa tesi: Croce e Volpe).
Q2 §101 Albano Sorbelli, Opuscoli, stampe alla macchia e fogli volanti riflettenti il pensiero politico italiano (1830‑35). Saggio di bibliografia storica, Firenze, Leo S. Olschki, 1927, pp. LXXXVIII‑273, L. 70.
Il Sorbelli registra quasi un migliaio di fogli volanti e opuscoli, raggruppati in ordine cronologico e con un cenno del contenuto. Nella prefazione studia le correnti di pensiero di quegli anni, che si raggrupperanno nei partiti più tardi.
Q2 §102 Giuseppe Ferrari, Corso su gli scrittori politici italiani. Nuova edizione completa con prefazione di A. O. Olivetti. 1928, Milano, Monanni, pp. 700, L. 25.
Q2 §103 Adriano Tilgher, Perché l’artista scrive o dipinge, o scolpisce, ecc.?, nell’«Italia che scrive» del febbraio 1929.
Articolo tipico della incongruenza logica e della leggerezza morale del Tilgher, il quale dopo aver «sfottuto» banalmente la teoria del Croce in proposito, alla fine dell’articolo la ripresenta tale e quale come sua, in una forma fantasiosa e immaginifica. Dice il Tilgher che secondo il Croce «l’estrinsecazione fisica … del fantasma artistico ha scopo essenzialmente mnemonico», ecc. Questo argomento è da vedere: cosa significa per il Croce in questo caso «memoria»? Ha un valore puramente personale, individuale, o anche di gruppo? Lo scrittore si preoccupa solo di sé o storicamente è portato a pensare anche agli altri? ecc.
Q2 §104 Recensione del libro del Bonomi sul Bissolati nell’«Italia che scrive» del maggio 1929, di Giuseppe A. Andriulli. (Bisognerebbe poter seguire tutte queste recensioni di simili libri, specialmente se dovute a ex socialisti come l’Andriulli).
Q2 §105 «Mente et Malleo». Organo ufficiale dell’Istituto «M. Fossati», pubblicato a cura dell’Associazione Nazionale Esperti nell’Ordinamento della Produzione, Torino, via Rossini 18, Anno 1°, n. 1, 10 aprile 1929, in 4°, pp. 44‑XVI.
Bollettino tecnico quindicinale, si propone di portare un contributo all’organizzazione scientifica del lavoro od ordinamento razionale della produzione in qualsiasi campo dell’Industria, dell’Agricoltura, del Commercio.
Q2 §106 Risorgimento italiano. I giacobini italiani. Di solito sono trattati assai male nei libri e negli articoli divulgativi e se ne sa anche assai poco. Negli Atti del XIV Congresso nazionale per la storia del Risorgimento Italiano (1927) è pubblicato uno studio di Renato Sòriga, L’idea nazionale e il ceto dei «patrioti» avanti il maggio 1796, che rende noti alcuni documenti estratti dal copialettere di Filippo Buonarroti. Da questo studio si potranno avere dati bibliografici e indicazioni per studiare questo primo periodo del liberalismo italiano.
Q2 §107 Lo «stellone d’Italia». Come è nato questo modo di dire sullo «stellone» che è entrato a far parte dell’ideologia patriottica e nazionale italiana? Il 27 novembre 1871, il giorno in cui Vittorio Emanuele II inaugurò a Roma il Parlamento, fu visto di pieno giorno il pianeta Venere, che di solito (poiché Venere è un pianeta interno all’orbita della terra) non si può vedere che al mattino prima del nascere del sole o alla sera dopo il tramonto. Se poi certe condizioni atmosferiche favoriscono la visibilità del pianeta, non è raro il caso che esso possa vedersi anche dopo che il sole è spuntato ed anche prima che sia tramontato, ciò che appunto avvenne il 27 novembre 1871. Il fatto è ricordato nel modo più preciso da Giuseppe Manfroni, allora commissario di Borgo, che nelle sue Memorie scrive: «Il più grande avvenimento del mese di novembre è stata la inaugurazione della nuova sessione del Parlamento, avvenuta il 27 con un discorso pronunziato dal Re... non è mancato il miracolo; in pieno giorno si vedeva brillare sul Quirinale una stella lucentissima; Venere, dicono gli astronomi; ma il popolo diceva che la stella d’Italia illuminava il trionfo delle idee unitarie». La visibilità di Venere in pieno giorno pare sia fenomeno raro, non rarissimo, già osservato dagli antichi e nel Medio Evo. Nel dicembre 1797 quando Napoleone tornò trionfalmente a Parigi dopo la guerra italiana si vide il pianeta di giorno e il popolo diceva che era la stella di Napoleone.
Q2 §108 Letteratura popolare. Edoardo Perino. Sull’attività editoriale del Perino, che segnò un’epoca a Roma (il Perino stampò letteratura anticlericale a dispense illustrate, cominciando con la Beatrice Cenci di Guerrazzi), cfr il Memoriale di G. De Rossi, che dovrebbe essere stato pubblicato nel 27 o nel 28.
Q2 §109 Gli intellettuali francesi e la loro attuale funzione cosmopolita. La funzione cosmopolita degli intellettuali francesi dal 700 in poi è di carattere assolutamente diverso da quella esercitata dagli italiani precedentemente. Gli intellettuali francesi esprimono e rappresentano esplicitamente un compatto blocco nazionale, di cui sono gli «ambasciatori» culturali, ecc.
Per la situazione attuale dell’egemonia culturale francese confrontare il libro dell’editore Bernardo Grasset, La chose littéraire, Paris, Gallimard, 1929, in cui si parla specialmente dell’organizzazione libraria della produzione culturale francese nel dopo guerra coi nuovi fenomeni tipici dell’epoca presente.
Q2 §110 Cultura popolare. I poeti del popolo siciliano di Filippo Fichera, Isola del Liri, Soc. Tip. A. Macioce e Pisani, 1929. Credo si possano trovare in questo volume indicazioni per identificare l’importanza in Sicilia delle «gare poetiche» o «tenzoni» tenute in pubblico come rappresentazioni teatrali popolari. Che carattere hanno? Da una recensione pubblicata nel «Marzocco» del 1929 pare puramente religioso.
Q2 §111 Risorgimento, Il popolo e il Risorgimento. Nel «Marzocco» del 30 settembre 1928 è riassunto, col titolo La Serenissima meritava di morire?, un opuscolo miscellaneo di Antonio Pilot (Stabil. Grafico U. Bortoli), in cui si estraggono da diari e memorie di veneziani opinioni sulla caduta della Repubblica Veneta.
La responsabilità del patriziato era idea fissa delle classi popolari. L’ultimo doge, Lodovico Manin racconta in certe sue Memorie: «La cosa arrivò al grado che, passando un giorno per una corticella a San Marcuola, una donna, conoscendomi, disse: Almeno venisse la peste, che così moriressimo noi altre, ma morirebbero anche questi ricchi che ci hanno venduti e che sono cagione che moriamo di freddo e di fame». Il vecchio desistette dalla passeggiata e si ritirò. Il Bertucci Balbi‑Valier in un sonetto intitolato I nobili veneti del 1797 non tradirono la Repubblica scrive: «No, no xe vero, i nobili tradio ‑ No ga la patria nel novantasete» (ciò che significa quanto profonda fosse la convinzione e come si cercasse di combatterla).
Q2 §112 Letteratura popolare. Victor Hugo. A proposito di V. Hugo ricordare la sua dimestichezza con Luigi Filippo e quindi il suo atteggiamento monarchico costituzionale nel 48. È interessante notare che, mentre scriveva i Miserabili, scriveva anche le di Choses vues (pubblicate postume) e che le due scritture non sempre vanno d’accordo. Vedere queste quistioni, perché di solito l’Hugo è considerato uomo d’un blocco solo, ecc. (Nella «Revue des Deux Mondes» del 28 o 29, più probabilmente del 29, ci deve essere un articolo su questo argomento).
Q2 §113 Risorgimento. Il popolo e il Risorgimento. Nella «Lettura» del 1928 Pietro Nurra pubblica il diario inedito di un combattente delle cinque giornate di Milano, il mantovano Giovanni Romani, stabilitosi una prima volta a Milano nel 1838 come cuoco alla Croce d’Oro in contrada delle Asole, poi, dopo aver girato quasi tutta Italia, ritornato a Milano, alla vigilia delle cinque giornate, all’osteria del Porto di Mare in Santo Stefano. Il diario si compone di una specie di taccuino di 199 pagine numerate, delle quali 186 scritte con calligrafia grossolana, e dicitura scorrettissima.
Mi pare molto interessante perché i popolani non sono soliti scrivere di questi diarii, tanto più 80 anni fa. Perciò è da studiare per il suo valore psicologico e storico: forse si trova nel Museo del Risorgimento a Milano: vedere nella «Lettura» se sono dati altri estremi bibliografici.
Q2 §114 Storia politica e storia militare. Nel«Marzocco» del 10 marzo 1929 è riassunto un articolo di Ezio Levi nella «Glossa perenne» sugli Almògavari, interessante per due rispetti. Da un lato gli Almògavari (truppe leggere catalane, addestrate nelle aspre lotte della «reconquista» a combattere contro gli arabi col modo stesso degli arabi, cioè in ordine sparso, senza una disciplina di guerra, ma con impeti, agguati, avventure individuali) segnano l’introduzione in Europa di una nuova tattica, che può essere paragonata a quella degli arditi, sebbene in condizioni diverse. Dall’altro lato essi, secondo alcuni eruditi, segnano l’inizio delle compagnie di ventura.
Un corpo di Almògavari fu mandato in Sicilia dagli Aragonesi per le guerre del Vespro: finisce la guerra, ma parte degli Almògavari si reca in Oriente al servizio del basileus dell’Impero bizantino Andronico. L’altra parte fu arruolata da Roberto d’Angiò per la guerra contro i ghibellini toscani. Poiché gli Almògavari avevano mantelli neri, mentre i fiorentini, in processione o in «cavallata» vestivano il camice bianco crociato e gigliato, da ciò sarebbe nata, secondo Gino Masi, la denominazione di Bianchi e Neri. Certo è che, quando gli Angioini lasciarono Firenze, molti Almògavari rimasero al soldo del Comune, rinnovando d’anno in anno la loro «condotta».
La «compagnia di ventura» nacque così come un mezzo per determinare uno squilibrio del rapporto delle forze politiche a favore della parte più ricca della borghesia, a danno dei ghibellini e del popolo minuto.
Q2 §115 Sul Risorgimento e il Mezzogiorno. I libri di Marc
Monnier, Notizie storiche sul
brigantaggio nelle province napoletane, da Fra diavolo al 1862,
e La Camorra, mysteres de
Naples.
Q2 §116 La funzione cosmopolita degli intellettuali italiani . Da un articolo di Nello Tarchiani nel «Marzocco» del 3 aprile 1927: Un dimenticato interprete di Michelangelo (Emilio Ollivier): «Per lui (Michelangelo) non esisteva che l’arte. Papi, principi, repubbliche erano la stessa cosa, purché gli dessero modo di operare; pur di fare, si sarebbe dato al Gran Turco, come una volta minacciò; ed in ciò gli si avvicinava il Cellini». E non solo il Cellini: e Leonardo? Ma perché ciò avvenne? E perché tali caratteri esistettero quasi solo in Italia? Questo è il problema. Vedere nella vita di questi artisti come risalti la loro anazionalità. E nel Machiavelli il nazionalismo era poi così forte da superare l’«amore dell’arte per l’arte»? Una ricerca di questo genere sarebbe molto interessante: il problema dello Stato italiano lo occupava più come «elemento nazionale» o come problema politico interessante in sé e per sé, specialmente data la sua difficoltà e la grande storia passata dell’Italia?
Q2 §117 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. «Nel 1563, durante la guerra civile contro gli Ugonotti, all’assedio di Orléans, intrapreso dal Duca di Guisa, l’ingegnere militare Bartolomeo Campi di Pesaro, il quale aveva nell’esercito attaccante la carica che ora si direbbe di comandante del Genio, fece fare una grande quantità di sacchetti che, riempiti di terra, furono portati sulle spalle dei soldati nella posizione, ed, in un istante, fabbricati con quelli i ripari, ivi, in attesa del momento di avanzare, si fermarono gli assalitori al coperto dalle offese della piazza». (Enrico Rocchi, Un notevole aspetto delle campagne di Cesare nelle Gallie, «Nuova Antologia», 1° gennaio 1929).
Q2 §118 Sull’Anschluss. Tener presente: 1) la posizione della socialdemocrazia austriaca come è stata espressa da Otto Bauer: favorevoli all’Anschluss ma attendere, per realizzarlo, quando la socialdemocrazia tedesca sia padrona dello Stato tedesco, cioè in definitiva Anschluss socialdemocratico; 2) posizione della Francia: non coincide con quella dell’Italia: la Francia è contro l’unione dell’Austria alla Germania ma spinge l’Austria ad entrare in una Confederazione danubiana: l’Italia è contro l’Anschluss e contro la Confederazione. Se si ponesse il problema come una scelta tra le due soluzioni probabilmente l’Italia preferirebbe l’Anschluss alla Confederazione.
Q2 §119 Il tentativo di riforma religiosa francescana. Quanto rapidamente sia decaduto lo spirito di san Francesco appare dalla Cronaca di fra Salimbene da Parma. Cfr Nuova Antologia del 16 febbraio 1929: Vittorio Marvasi, Frate Salimbene da Parma e la sua Cronaca. La Cronaca è stata tradotta nel 1928 da F. Bernini ed edita da un Carabba di Lanciano. Vedere in quanto il tentativo «laico» di Federico II coincide col francescanesimo: certo dei rapporti ci sono stati e lo stesso Salimbene è ammiratore di Federico, anche scomunicato.
Q2 §120 Sull’America. Nella Nuova Antologia del 16 febbraio 1929 questi articoli: 1) Il trattato di Washington per la limitazione degli armamenti navali e le sue conseguenze, di Ulisse Guadagnini; 2) Il patto Kellogg, di Carlo Schanzer; 3) La dottrina di Monroe, di Antonio Borgoni.
Q2 §121 Cadorna. Spectator (M. Missiroli), Luigi Cadorna, Nuova Antologia del 1° marzo 1929. Osservazioni brillanti, ma superficiali, sulla tradizione politico‑militare della famiglia Cadorna e sulle condizioni di crisi dell’esercito italiano nel periodo in cui Luigi iniziò e compì la sua carriera. Importanza del generale napoletano Pianell nell’infondere uno spirito nuovo nel nuovo esercito nazionale, contro la tradizione burocraticamente francese dello Stato maggiore piemontese, composto di elementi mediocri: ma Pianell era vecchio e la sua eredità è stata più di critica che di costruzione. Importanza della guerra del 70 nel mutare le idee sull’arte militare, fossilizzate sulla base della tradizione francese. Cadorna collabora con Pianell. Si «fossilizza» sull’aspetto tecnico, di organizzazione della guerra, e trascura l’aspetto storico‑sociale.
(Mi pare che questa sia un’accusa esagerata: la colpa non è di Cadorna, ma dei governi che devono essi educare politicamente i militari). Il modello napoleonico non può essere richiamato: Napoleone rappresentava la società civile e il militarismo della Francia, congiungeva in sé le due funzioni di capo del governo e di capo dell’esercito. La classe dominante italiana non ha saputo preparare dei capi militari, ecco tutto. Perché si dovrebbe domandare a Cadorna una grande capacità politica, se non si domanda ai capi politici una corrispondente capacità militare? Certo il capo militare deve avere, per la sua stessa funzione, una capacità politica, ma l’atteggiamento politico verso le masse militari e la politica militare devono essere fissati dal governo sotto la sua responsabilità. Ecco una serie di quistioni molto interessanti da studiare a proposito della guerra fino a Caporetto: c’era identità di vedute tra Governo e Cadorna sulla politica militare, sui fini strategici e sui mezzi generali per raggiungerli e sull’amministrazione politica delle masse militari? Sul primo punto c’era disaccordo tra Cadorna e Sonnino, e Cadorna era miglior politico di Sonnino: Cadorna voleva fare una politica delle nazionalità in Austria, voleva cioè cercare di disgregare l’esercito austriaco, Sonnino si oppose; egli non voleva la distruzione dell’Austria. Sul secondo punto non si hanno elementi: è molto probabile che il governo abbia trascurato di occuparsene, pensando che rientrasse nei poteri discrezionali del capo dell’esercito. Non così avvenne in Francia, dove gli stessi deputati si recavano al fronte e controllavano il trattamento fatto ai soldati: in Italia ciò appariva un’enormità, ecc., e avrà magari dato luogo a qualche inconveniente, ma gli inconvenienti non furono certo della importanza di Caporetto).
«Le deficienze naturali di senso storico e di intuito dei sentimenti delle masse si resero più sensibili per una concezione della vita militare che aveva assorbito alla scuola del Pianell e che s’era intrecciata ad una fede religiosa tendente al misticismo». (Sarebbe più esatto parlare di bigotteria e precisare che sull’influsso del sentimento religioso Cadorna fondava la sua politica verso le masse militari: l’unico coefficente morale del regolamento era infatti affidato ai cappellani militari). Avversione di Cadorna per la vita politica parlamentare, che è incomprensione (ma non lui solo responsabile, bensì anche e specialmente il governo). Non ha partecipato alle guerre d’Africa. Diventa capo dello Stato Maggiore il 27 luglio 1914. Ignoto al gran pubblico, «con un alone di rispetto senza effusione nel ceto dei militari». (L’accenno alla Memoria di Cadorna pubblicata nelle Altre pagine sulla grande guerra è ingenuo e gesuitesco).
Il piano strategico «contemplava due possibilità egualmente ragionevoli: offensiva su la fronte Giulia e difensiva sul Trentino, o viceversa? Egli si attenne alla prima soluzione». (Perché ugualmente ragionevoli? Non era la stessa cosa: l’offensiva vittoriosa nel Trentino portava la guerra in piena tedescheria, cioè avrebbe galvanizzato la resistenza germanica e determinato «subito» lo scontro tra Italiani e Tedeschi di Guglielmo; l’offensiva vittoriosa sulla fronte giulia avrebbe invece portato la guerra nei paesi slavi e, appoggiata a una politica delle nazionalità avrebbe permesso di disgregare l’esercito austriaco. Ma il governo era contrario alla politica delle nazionalità e non voleva urtare la Germania, alla quale non aveva dichiarato la guerra: così la scelta di Cadorna – scelta relativa, come si vede, per l’equivoca posizione verso la Germania – mentre poteva essere politicamente ottima, divenne pessima; le truppe slave videro nella guerra una guerra nazionale di difesa delle loro terre da un invasore straniero e l’esercito austriaco si rinsaldò).
Cadorna era un burocratico della strategia; quando aveva fatto le sue ipotesi «logiche», dava torto alla realtà e si rifiutava di prenderla in considerazione.
Caporetto: dalle Memorie di Cadorna appare che egli era da qualche tempo informato, prima di Caporetto, che il morale delle truppe era infiacchito. (E in questo punto bisogna collocare una sua particolare attività «politica», molto pericolosa: egli non cerca di rendersi conto se occorre mutare qualcosa nel governo politico dell’esercito, se cioè l’infiacchimento morale delle truppe non sia dovuto al comando militare egli non sa esercitare l’autocritica; è persuaso che il fatto dipende dal governo civile, dal modo con cui è governato il paese, e domanda misure reazionarie, domanda repressioni, ecc. Nel paese trapela qualcosa di questa sua attività «politica» e gli articoli della «Stampa» sono l’espressione di una crisi e del paese e dell’esercito. La «Stampa» oggettivamente ha ragione: la situazione è molto simile a quella che ha preceduto la «fatal Novara». Anche in questo caso la responsabilità è del governo, che doveva allora sostituire Cadorna e occuparsi «politicamente» dell’esercito).
Il «mistero» militare di Caporetto. Il Comando supremo era stato avvertito dell’offensiva fino al giorno e l’ora, alla zona, alle forze austro‑tedesche che vi avrebbero partecipato. (Vedere il libro di Aldo Valori sulla guerra italiana). Perché invece ci fu «sorpresa»? L’articolista se la cava con dei luoghi comuni: Cadorna capo militare di secondo grado; critica dei militari italiani che erano appartati dal paese e dalla sua vita reale (il contrasto esercito piemontese ‑ garibaldini continua nel contrasto tra esercito e paese: cioè continua a operare la negatività nazionale del Risorgimento).
Molti luoghi comuni: è poi vero che prima della guerra in Italia l’esercito fosse trascurato? Bisognerebbe dimostrare che la percentuale italiana di spese militari sul bilancio totale sia stata più bassa che negli altri paesi: mi pare invece in Italia fosse più alta di molti paesi. (Ostinato più che volitivo: energia del testardo).
Q2 §122 Giuseppe Paratore, La economia, la finanza, il denaro d’Italia alla fine del 1928, Nuova Antologia, 1° marzo 1929.
Articolo interessante ma troppo rapido e troppo conformista. Da tener presente per ricostruire la situazione del 26 fino alle leggi eccezionali. Il Paratore fa una lista delle principali contraddizioni del dopo guerra: 1) le divisioni territoriali hanno moltiplicato le barriere doganali; 2) ad una complessiva riduzione di capacità di consumo ha risposto dappertutto un aumento di impianti industriali; 3) ad una tendenziale depressione economica, un accentuato spirito di nazionalismo economico (ogni nazione vuole produrre tutto e vuole vendere senza comprare); 4) ad un impoverimento complessivo, una tendenza all’aumento reale delle spese statali; 5) ad una maggiore disoccupazione, una minore emigrazione (nell’anteguerra lasciavano annualmente l’Europa circa 1 300 000 lavoratori, oggi emigrano solo 600‑700 mila uomini); 6) la ricchezza distrutta dalla guerra in parte è stata capitalizzata e dà luogo ad interessi che per molto tempo sono stati pagati con altro debito; 7) un indebitamento verso gli Stati Uniti d’America (per debiti politici e commerciali) che se dovesse dar luogo a reali trasferimenti, metterebbe in pericolo qualunque stabilità monetaria.
Per l’Italia il Paratore nota questi elementi della sua situazione post‑bellica: 1) considerevole diminuzione del suo capitale umano; 2) debito di circa 100 miliardi di lire; 3) volume di debito fluttuante preoccupante; 4) bilancio statale dissestato; 5) ordinamento monetario sconvolto, espresso da una profonda riduzione e da una pericolosa instabilità del valore interno ed esterno della unità di denaro; 6) bilancia commerciale singolarmente passiva, aggravata da un completo disorientamento dei suoi rapporti commerciali con l’estero; 7) molti ordinamenti finanziari riguardanti la pubblica e privata economia logorati.
Q2 §123 La riforma fondiaria cecoslovacca, del padre Veriano Ovecka, nella «Civiltà Cattolica» del 16 febbraio e 16 marzo 1929, pubblicata in opuscolo separato poco dopo. È uno studio molto accurato e ben fatto dal punto di vita degli interessi della Chiesa. La riforma è accettata, e giustificata come dovuta a forza maggiore. (In una ricerca generale sulla quistione agraria questo opuscolo sintetico è da rivedere per fare dei confronti con gli altri tipi di riforma agraria; rumena, per esempio, e trarne qualche indicazione generale metodica. Quistioni di programma).
Q2 §124 Giorgio Mortara, Natalità e urbanesimo in Italia, «Nuova Antologia», 16 giugno ‑ 1° luglio 1929.
Tratta le quistioni più strettamente statistiche, osservando una grande cautela nel dare giudizi, specialmente di portata più immediata. Il numero annuo dei nati vivi in Italia è andato aumentando, attraverso oscillazioni, nel primo quarto di secolo successivo all’unità nazionale (massimo di 1 152 906 nel 1887), ha declinato gradualmente fino a un minimo di 1 042 090 nel 1903, è risalito ad un massimo secondario di 1 144 410 nel 1910 e si è mantenuto negli anni prima della guerra a 1 100 000. Nel 1920 (molte nozze dopo l’armistizio) si ha il massimo assoluto di 1 158 041, che scende rapidamente a 1 054 082 nel 1927, e circa 1 040 000 nel 1928 (territorio antebellico; nei nuovi confini 1 093 054 nel 27, e 1 077 000 nel 28), cifra la più bassa negli ultimi 48 anni. In altri paesi la diminuzione assai maggiore. Diminuzione correlativa nelle morti: da un massimo di 869 992 nel 1880 ad un minimo di 635 788 nel 1912, diminuzione che, dopo il periodo bellico, con 1 240 425 morti nel 18, è ricominciata: nel 1927 solo 611 362 morti, nel 1928 614 mila (vecchi confini; nei nuovi confini, 635 996 morti nel 27 e 639 000 nel 28). Così l’eccedenza dei nati sui morti nel 1928 è stata di 426 000 circa (nuovi confini 438 000) cioè più favorevole che nel 1887, in cui solo 323 914, per l’alta percentuale di morti. Il massimo di eccedenza, 448 mila circa, si è avuto nel quinquennio 1910‑14. (Si può dire, approssimativamente, che in un certo periodo storico, il grado di benessere di un popolo non può desumersi dal numero alto delle nascite, ma piuttosto dalla percentuale dei morti e dall’eccedenza dei nati sui morti: ma anche in questa fase storica incidono delle variabili che devono essere analizzate, infatti, più che di benessere popolare assoluto può parlarsi di migliore organizzazione statale e sociale per l’igiene, ciò che impedisce a una epidemia, per esempio, di diffondersi tra una popolazione a basso livello, decimandola, ma non eleva per nulla questo livello stesso, se non si può dire che lo mantenga addirittura, evitando la sparizione dei più deboli e improduttivi che vivono sul sacrificio degli altri).
Le cifre assolute delle nascite e delle morti danno solo l’incremento assoluto della popolazione. L’intensità dell’incremento è data dal rapporto di questo incremento col numero degli abitanti. Da 39,3 per 1000 abitanti del 1876 la frequenza delle nascite scende a 26 nel 1928, con una diminuzione del 33%; la frequenza delle morti da 34,20/00 nel 1867 scende a 15,6 nel 28, con una diminuzione del 54%. La mortalità comincia a discendere nettamente col quinquennio 1876‑80; la natalità inizia la discesa nel quinquennio 91‑95.
Per gli altri paesi d’Europa, su 1000 abitanti: Gran Bretagna 17 nati ‑ 12,5 morti, Francia 18,2‑16,6, Germania 18,4‑12, Italia 26,9‑15,7, Spagna 28,6‑18,9, Polonia 31,6-17,4, Urss (europea) 44,9‑24,4, Giappone 36,2‑19,2. (I dati si riferiscono, per l’Urss, al 1925, per il Giappone al 1926, per gli altri paesi al 1927).
Per la diminuzione della mortalità il Mortara fissa tre cause principali: progresso dell’igiene, progresso della medicina, progresso del benessere, che riassumono in forma schematica un gran numero di fattori di minore mortalità (un fattore è anche la minore natalità, in quanto le età infantili sono soggette ad alta mortalità). Il fattore preponderante della bassa natalità è la decrescente fecondità di matrimoni, dovuta a volontaria limitazione, inizialmente per previdenza, poi per egoismo. Se il movimento si svolgesse uniformemente in tutto il mondo, non altererebbe le condizioni relative delle varie nazioni, pur avendo effetti gravi per lo spirito d’iniziativa, e potendo essere causa d’inerzia e di regresso morale ed economico. Ma il movimento non è uniforme: vi sono oggi popoli che si accrescono rapidamente mentre altri lentamente, vi saranno domani popoli che cresceranno celermente mentre altri diminuiranno.
Già oggi in Francia l’equilibrio tra nascite e morti è faticosamente mantenuto coll’immigrazione, che determina altri gravi problemi morali e politici: in Francia la situazione è aggravata dalla relativamente alta percentuale di mortalità in confronto dell’Inghilterra e della Germania.
Calcolo regionale per il 1926: Piemonte (proporzione per 1000 abitanti, nati e morti) 17,7‑15,4, Liguria 17,1-13,8, Lombardia 25,1‑17,9, Venezia Tridentina 25,0‑17,5, Venezia Euganea 29,3‑15,3, Venezia Giulia 22,8‑16,1, Emilia 25,0‑15,3, Toscana 22,2‑14,3, Marche 28,0‑15,7, Urribria 28,4‑16,5, Lazio 28,1‑16,3, Abruzzi 32,1‑18,9, Campania 32,0‑18,3, Puglie 34,0‑20,8, Basilicata 36,6-23,1, Calabria 32,5‑17,3, Sicilia 26,7‑15,7, Sardegna 31,7-18,9. Prevalgono i livelli medi, ma con tendenza piuttosto verso il basso che verso l’alto.
Per il Mortara la causa della denatalità è da ricercarsi nella limitazione volontaria. Altri elementi possono contribuirvi saltuariamente, ma sono trascurabili (emigrazione degli uomini). C’è stato un «contagio» della Francia nel Piemonte e in Liguria, dove il fenomeno è più grave (emigraz!one temporanea ha servito di veicolo) e di più lontana origine, ma non si può parlare di contagio «francese» per la Sicilia, che nel Mezzogiorno è un focolaio di denatalità. Non mancano indizi di limitazione volontaria in tutto il Mezzogiorno. Campagna e città: la città ha meno nascite che la campagna. Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze hanno (nel 1926) una media di natalità inferiore a Parigi.
Q2 §125 Lodovico Luciolli, La politica doganale degli Stati Uniti d’America, Nuova Antologia del 16 agosto 1929.
Articolo molto interessante e utile da consultare perché fa un riassunto della storia tariffaria negli Stati Uniti e della funzione particolare che le tariffe doganali hanno sempre avuto nella politica degli Stati Uniti. Sarà interessante una rassegna storica delle varie forme che ha assunto e sta assumendo la politica doganale dei vari paesi, ma specialmente dei più importanti economicamente e politicamente, ciò che in fondo significa dei vari tentativi di organizzare il mercato mondiale e di inserirsi in esso nel modo più favorevole dal punto di vista dell’economia nazionale, o delle industrie essenziali dell’attività economica nazionale.
Una nuova tendenza del nazionalismo economico contemporaneo da seguire è questa: alcuni Stati cercano di ottenere che le loro importazioni da un determinato paese siano «controllate» in blocco con un corrispettivo di «esportazione» ugualmente controllato. Che una tale misura giovi alle nazioni la cui bilancia commerciale (visibile) sia in deficit, è manifesto. Ma come spiegare che un tale principio si incominci ad affermare da parte della Francia, che esporta merci più che non ne importi? Si tratta inizialmente di una politica commerciale rivolta a boicottare le importazioni da un determinato paese, ma da questo inizio può svilupparsi una politica generale da inquadrare in una cornice più ampia e di carattere positivo che può (svilupparsi) in Europa in conseguenza della politica tariffaria americana e per cercare di stabilizzare certe economie nazionali. Cioè: ogni nazione importante può tendere a dare un sostrato economico organizzato alla propria egemonia politica su le nazioni che le sono subordinate. Gli accordi politici regionali potrebbero diventare accordi economici regionali, in cui l’importazione e l’esportazione «concordata» non avverrebbe più tra due soli Stati, ma tra un gruppo di Stati, eliminando molti inconvenienti non piccoli evidentissimi. In questa tendenza mi pare si possa far rientrare la politica di libero scambio interimperiale e di protezionismo verso il non‑Impero del gruppo nuovamente formatosi in Inghilterra intorno a lord Beaverbrook (o nome simile), così come l’intesa agraria di Sinaia poi ampliata a Varsavia.
Questa tendenza politica potrebbe essere la forma moderna di Zollverein che ha portato all’Impero Germanico federale, o dei tentativi di lega doganale fra gli Stati italiani prima del 1848, e più innanzi del mercantilismo settecentesco: e potrebbe diventare la tappa intermedia della Paneuropa di Briand, in quanto essa corrisponde a un’esigenza delle economie nazionali di uscire dai quadri nazionali senza perdere il carattere nazionale.
Il mercato mondiale, secondo questa tendenza, verrebbe ad essere costituito di una serie di mercati non più nazionali ma internazionali (interstatali) che avrebbero organizzato nel loro interno una certa stabilità delle attività economiche essenziali, e che potrebbero entrare in rapporto tra loro sulla base dello stesso sistema. Questo sistema terrebbe più conto della politica che dell’economia nel senso che nel campo economico darebbe più importanza all’industria finita che all’industria pesante. Ciò nel primo stadio dell’organizzazione. Infatti: i tentativi di cartelli internazionali basati sulle materie prime (ferro, carbone, potassa, ecc.) hanno messo di fronte Stati egemonici, come la Francia e la Germania, delle quali né l’una né l’altra può cedere nulla della sua posizione e della sua funzione mondiale. Troppo difficile e troppi ostacoli. Più semplice invece un accordo della Francia e dei suoi Stati vassalli per un mercato economico organizzato sul tipo dell’Impero Inglese, che potrebbe far crollare la posizione della Germania e costringerla a entrare nel sistema, ma sotto l’egemonia francese.
Sono tutte ipotesi molto vaghe ancora, ma da tener presenti per studiare gli sviluppi delle tendenze su accennate.
Q2 §126 Andrea Torre, Il principe di Bülow e la politica mondiale germanica, «Nuova Antologia», 1° dicembre 1929 (scritto in occasione della morte del Bülow e in base al libro dello stesso Bülow, Germania imperiale: è interessante e sobrio).
Q2 §127 Alfonso de Pietri‑Tonelli, Wall Street, «Nuova Antologia» del 1° dicembre 1929 (commenta in termini molto generali la crisi di borsa americana della fine del 29: bisognerà rivederlo per studiare l’organizzazione finanziaria americana).
Q2 §128 Azione Cattolica. Sindacalismo cattolico. Cfr nella «Civiltà Cattolica» del 6 luglio 1929 l’articolo La dottrina sociale cristiana e l’organizzazione internazionale del lavoro (del padre Brucculeri). Vi si parla della sezione riguardante il pensiero sociale della Chiesa, del rapporto fatto da Albert Thomas alla XII sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro e pubblicato a Ginevra nel 1929. Il padre Brucculeri è estremamente soddisfatto del Thomas e ne riassume i passi più importanti, riesponendo così il programma sociale cattolico.
Q2 §129 Industrie italiane. Cfr l’articolo I «soffioni» della Maremma Toscana nella «Civiltà Cattolica» del 20 luglio 1929. Come articolo di divulgazione scientifica è fatto molto bene.
Q2 §130 Storie regionali. La Liguria e Genova. Cfr Carlo Mioli, La Consulta dei Mercanti genovesi. Rassegna storica della Camera di Commercio e Industria. 1805‑1927, Genova, 1928. È recensito e riassunto nella «Civiltà Cattolica» del 17 agosto 1929. Deve essere molto interessante e irnportante per la storia economica di Genova nel periodo del Risorgimento e poi nel periodo dell’unità fino alla sostituzione dei Consigli d’Economia alle Camere di Commercio. Il Mioli era il segretario dell’ultima Camera di Commercio. Il libro ha una prefazione dell’avv. Pessagno, addetto all’archivio storico di Genova.
Q2 §131 Azione Cattolica. Il conflitto di Lilla. Nella «Civiltà Cattolica» del 7 settembre 1929 è pubblicato il testo integrale del giudizio pronunziato dalla Sacra Congregazione del Concilio sul conflitto tra industriali e operai cattolici della regione Roubaix‑Tourcoing. Il lodo è contenuto in una lettera in data 5 giugno 1929 del cardinale Sbarretti, Prefetto della Congregazione del Concilio, a mons. Achille Liénart, vescovo di Lilla.
Il documento è importante, perché in parte integra il Codice Sociale e in parte ne amplia il quadro, come per esempio là dove riconosce agli operai e ai sindacati cattolici il diritto di formare un fronte unico anche con gli operai e i sindacati socialisti nelle quistioni economiche. Bisogna tener conto che se il Codice Sociale è un testo cattolico, è però privato o soltanto ufficioso, e in tutto o in parte potrebbe essere sconfessato dal Vaticano. Questo documento invece è ufficiale.
Questo documento è certamente legato al lavorìo del Vaticano in Francia per creare una democrazia politica cattolica e l’ammissione del «fronte unico», anche se passibile di interpretazioni cavillose e restrittive, è una «sfida» all’Action française e un segno di détente coi radicali socialisti e la C.G.T.
Nello stesso fascicolo della «Civiltà Cattolica» è un diffuso e interessante articolo di commento al lodo vaticano. Questo lodo è costituito di due parti organiche: nella prima, composta di 7 brevi tesi accompagnate ognuna di ampie citazioni tolte da documenti pontifici, specialmente di Leone XIII, si dà un riassunto chiaro della dottrina sindacale cattolica; nella seconda si tratta del conflitto specifico in esame, cioè le tesi sono applicate e interpretate nei fatti reali.
Q2 §132 L’Action Française e il Vaticano. Cfr La crisi dell’«Action française» e gli scritti del suo «maestro», nella «Civiltà Cattolica» del 21 settembre 1929. (È un articolo del padre Rosa contro Maurras e la sua «filosofia»).
Q2 §133 Leggenda albanese delle «Zane» e le «Zane» sarde. Nell’articolo Antichi monasteri benedettini in Albania ‑ Nella tradizione e nelle leggende popolari del padre gesuita Fulvio Cordignano, pubblicato nella «Civiltà Cattolica» del 7 dicembre 1929 si legge: «Il «“vakùf” – ciò che è rovina di chiesa o bene che gli appartenga – nell’idea del popolo ha in se stesso una forza misteriosa, quasi magica. Guai a chi tocca quella pianta o introduce fra quelle rovine il gregge, le capre divoratrici di ogni fronda: sarà colto all’improvviso da un malanno; rimarrà storpio, paralitico, mentecatto, come se si fosse imbattuto, in mezzo agli ardori meridiani o durante la notte oscura e piena di perigli, in qualche “Ora” o “Zana”, là dove queste fate invisibili e in perfetto silenzio stanno sedute a una tavola rotonda sull’orlo della via o in mezzo al sentiero». C’è ancora qualche altro accenno nel corso dell’articolo.
Q2 §134 Cattolici, neomaltusianismo, eugenetica. A quanto pare neanche fra i cattolici le idee sono ormai più concordi sul problema del neomaltusianismo e dell’eugenetica. Dalla «Civiltà Cattolica» del 21 dicembre 1929 (Il pensiero sociale cristiano. La decima sessione dell’“Unione di Malines”) risulta: alla fine del settembre 1929 è stata tenuta l’assemblea annuale dell’«Unione Internazionale di studi sociali» che ha sede a Malines, il cui lavoro si concentrò specialmente su questi tre soggetti: lo Stato e le famiglie numerose; il problema della popolazione; il lavoro forzato. Sul problema demografico si verificarono forti differenziazioni: l’avv. Cretinon, «pur seguendo una politica della popolazione che faccia credito alla Provvidenza, fa rilevare che non bisogna rappresentare l’eugenismo come semplicemente materialistico, giacché ha pure intenti intellettuali, estetici e morali». Le conclusioni adottate furono concertate non senza difficoltà dal padre Desbuquois e dal prof. Aznar: i due compilatori erano profondamente divisi. «Mentre il primo propugnava il progresso demografico, l’altro era piuttosto inclinato a consigliar la continenza per timore che le famiglie cattoliche non si condannassero alla decadenza economica a causa della troppa prole».
Q2 §135 Pancristianesimo e propaganda del protestantesimo nell’America Meridionale. Cfr l’articolo
Il protestantesimo negli Stati Uniti e nell’America latina, nella «Civiltà Cattolica» del 1° marzo ‑ 15 marzo ‑ 5 aprile 1930. Studio molto interessante sulle tendenze espansionistiche dei protestanti nord‑americani, sui metodi di organizzazione di questa espansione e sulla reazione cattolica.
È interessante notare che i cattolici trovano nei protestanti americani i soli concorrenti, e spesso vittoriosi, nel campo della propaganda mondiale e ciò nonostante che negli Stati Uniti la religiosità sia molto poca (la maggioranza dei censiti professa di non aver religione): le Chiese protestanti europee non hanno espansività o minima. Altro fatto notevole è questo: dopo che le chiese protestanti sono andate sminuzzandosi, si assiste ora a tentativi di unificazione nel movimento pancristiano. (Non dimenticare però l’Esercito della Salute, di origine e organizzazione inglese).
Q2 §136 Azione Cattolica. Cfr l’articolo La durata del lavoro nella «Civiltà Cattolica» del 15 marzo 1930 (del padre Brucculeri). Difende il principio e la legislazione internazionale sulle 8 ore contro Lello Cangemi e il libro di costui, Il problema della durata del lavoro, Vallecchi, Firenze, pp. 526. L’articolo è interessante; il libro del Cangemi è stroncato molto bene. È interessante che un gesuita sia più «progressista» del Cangemi che è abbastanza noto nella politica economica italiana attuale come discepolo del De Stefani e della sua particolare tendenza nel campo della politica economica.
Q2 §137 Città e campagna. Giuseppe De Michelis, Premesse e contributo allo studio dell’esodo rurale, Nuova Antologia, 16 gennaio 1930. Articolo interessante da molti punti di vista. Il De Michelis pone il problema abbastanza realisticamente. Intanto cos’è l’esodo rurale? Se ne parla da 200 anni e la quistione non è mai stata posta nei termini economici precisi.
(Anche il De Michelis dimentica due elementi fondamentali della quistione: 1) i lamenti per l’esodo rurale hanno una delle loro ragioni negli interessi dei proprietari che vedono elevarsi i salari per la concorrenza delle industrie urbane e per la vita più «legale», meno esposta agli arbitrii ed abusi che sono la trama quotidiana della vita rurale; 2) per l’Italia non accenna all’emigrazione dei contadini che è la forma internazionale dell’esodo rurale verso paesi industriali ed è una critica reale del regime agrario italiano, in quanto il contadino si reca a fare il contadino altrove, migliorando il proprio tenor di vita).
È giusta l’osservazione del De Michelis che l’agricoltura non ha sofferto per l’esodo: 1) perché la popolazione agraria su scala internazionale non è diminuita; 2) perché la produzione non è diminuita, anzi c’è sopraproduzione, corne dimostra la crisi dei prezzi di prodotti agricoli. (Nella passata crisi, quando cioè esse corrispondevano a fasi di prosperità industriale, ciò era vero; oggi, però, che la crisi agraria accompagna la crisi industriale, non si può parlare di soraproduzione, ma di sottoconsumo). Nell’articolo sono citate statistiche che dimostrano la progressiva estensione della superficie coltivata a cereali e più ancora di quella coltivata per prodotti per le industrie (canapa, cotone, ecc.) e all’aumento della produzione. Il problema è osservato da un punto di vista internazionale (per un gruppo di 21 paesi) cioè di divisione internazionale del lavoro. (Dal punto di vista delle singole nazioni il problema può cambiare e in ciò consiste la crisi odierna: essa è una resistenza reazionaria ai nuovi rapporti mondiali, all’intensificarsi dell’importanza del mercato mondiale).
L’articolo cita qualche fonte bibliografica: occorrerà rivederlo. Finisce con un colossale errore: secondo il De Michelis: «La formazione delle città nei tempi remoti non fu che il lento e progressivo distacco del mestiere dall’attività agricola, con cui era prima confuso, per assurgere ad attività distinta. Il progresso dei venturi decenni consisterà, grazie soprattutto all’incremento della forza elettrica, nel riportare il mestiere alla campagna per ricongiungerlo, con forme mutate e con procedimenti perfezionati, al lavoro propriamente agricolo. In questa opera redentrice dell’artigianato rurale l’Italia si appresta ad essere anche una volta antesignana e maestra».
Il De Michelis fa molte confusioni: 1) il ricongiungimento della città alla campagna non può avvenire sulla base dell’artigianato, ma solo sulla base della grande industria razionalizzata e standardizzata. L’utopia «artigianesca» si è basata sull’industria tessile: si pensava che con la verificatasi possibilità di distribuire l’energia elettrica a distanza, sarebbe diventato possibile ridare alla famiglia contadina il telaio meccanico moderno mosso dall’elettricità; ma già oggi un solo operaio fa azionare (pare) fino a 24 telai, ciò che pone nuovi problemi di concorrenza e di capitale ingenti, oltre che di organizzazione generale irrisolvibili dalla famiglia contadina; 2) l’utilizzazione industriale del tempo che il contadino deve rimanere disoccupato (questo è il problema fondamentale dell’agricoltura moderna, che pone il contadino in condizione di inferiorità economica di fronte alla città che «può» lavorare tutto l’anno) può avvenire solo in un’economia secondo un piano, molto sviluppata, che sia in grado di essere indipendente dalle fluttuazioni temporali di vendita che già si verificano e portano alle morte stagioni anche nell’industria; 3) la grande concentrazione dell’industria e la produzione a serie di pezzi intercambiabili permette di trasportare reparti di fabbrica in campagna, decongestionando la grande città e rendendo più igienica la vita industriale. Non l’artigiano tornerà in campagna, ma viceversa l’operaio più moderno e standardizzato.
Q2 §138 America. Nel n. del 16 febbraio 1930 della «Nuova Antologia» sono pubblicati due articoli: Punti di vista sull’America: Spirito e tradizione americana del professor J. P. Rice (il Rice nel 1930 fu designato dall’Italy-America Society di New York a tenere l’annuale ciclo di conferenze stabilito dalla Fondazione Westinghouse per intensificare i rapporti tra l’America e l’Italia); l’articolo vale poco; e La rivoluzione industriale degli Stati Uniti, dell’ing. Pietro Lanino, interessante da questo punto di vista: come un accreditato pubblicista e teorico dell’industria italiana non ha capito nulla del sistema industriale capitalistico americano. (Il Lanino nel 1930 ha scritto anche una serie di articoli sull’industria americana nella «Rivista di politica economica» delle società per azioni). Fin dal primo paragrafo il Lanino afferma che in America è avvenuto «un capovolgimento completo di quelli che sino allora erano stati i criteri economici fondamentali della produzione industriale. La legge della domanda e dell’offerta rinunziata nelle paghe. Il costo di produzione diminuito pure aumentando queste». Non è stato rinunziato nulla: il Lanino non ha compreso che la nuova tecnica basata sulla razionalizzazione e il taylorismo ha creato una nuova e originale qualifica psico‑tecnica e che gli operai di tale qualifica non solo sono pochi, ma sono ancora in divenire, per cui i «predisposti» sono contesi con gli alti salari; ciò conferma la legge dell’«offerta e della domanda» nelle paghe. Se fosse vera la affermazione del Lanino non si spiegherebbe l’alto grado di turnover nel personale addetto, cioè che molti operai rinunzino all’alto salario di certe aziende per salari minori di altre. Cioè non solo gli industriali rinuncerebbero alla legge della domanda e dell’offerta, ma anche gli operai, i quali talvolta rimangono disoccupati rinunziando agli alti salari. Indovinello che il Lanino si è ben guardato dal risolvere. Tutto l’articolo è basato su questa incomprensione iniziale. Che gli industriali americani, primo Ford, abbiano cercato di sostenere che si tratta di una nuova forma di rapporti, non fa maraviglia: essi cercarono di ottenere oltre all’effetto economico degli alti salari, anche degli effetti sociali di egemonia spirituale, e ciò è normale.
Q2 §139 Mario Gianturco, La terza sessione marittima della Conferenza Internazionale del Lavoro, Nuova Antologia, 16 marzo 1930. (Riassume i punti anche delle precedenti riunioni dei marittimi; interessante e utile).
Q2 §140 Giuseppe Frisella Vella, Temi e problemi sulla così detta questione meridionale, con introduzione e bibliografia, in 8°, pp. 56, Palermo, La Luce, Casa Editr. Sicula, L. 6,00.
Q2 §141 Passato e presente. Il consumo del sale. (Cfr Salvatore Majorana, Il monopolio del sale, in «Rivista di Politica Economica», gennaio 1931, p. 38). Nell’esercizio 1928‑29, subito dopo l’aumento del prezzo del sale, il consumo del sale è risultato inferiore di Kg. 1,103 in confronto dell’esercizio precedente, cioè si è ridotto a Kg. 7,133 a testa, mentre il contributo è di L. 4,80 superiore. È stata inoltre cessata la largizione gratuita di sale nei comuni di pellagrosi, con la spiegazione che la pellagra è quasi sparita e che altre attività generali dello Stato lottano contro la pellagra (in generale), (ma i pellagrosi effettivi attuali che sorte hanno avuto?)
Q2 §142 Gaspare Ambrosini, La situazione della Palestina e gli interessi dell’Italia, Nuova Antologia del 16 giugno 1930. (Indicazioni bibliografiche sulla quistione).
Q2 §143 Maria Pasolini Ponti, Intorno all’arte industriale, «Nuova Antologia», 1° luglio 1930.
Q2 §144 Passato e presente. Un articolo interessante per constatare un certo movimento di riabilitazione dei Borboni di Napoli è quello di Giuseppe Nuzzo, La politica estera della monarchia napoletana alla fine del secolo XVIII, nella «Nuova Antologia» del 16 luglio 1930. Articolo insulso storicamente, perché parla di velleità burlesche.
Q2 §145 Luigi Villari, L’agricoltura in Inghilterra, «Nuova Antologia», 1° settembre 1930. Interessante.
Q2 §146 Passato e presente. Emigrazione. Nel Congo Belga sono 1600 immigrati italiani: nel solo Katanga, la zona più ricca del Congo, ve ne sono 942. La maggior parte di questi immigrati italiani è al servizio di Compagnie private in qualità di ingegneri, ragionieri, capomastri, sorveglianti di lavoro. Dei 200 medici che esercitano la professione al Congo per conto dello Stato e di società, i due terzi sono italiani («Corriere della Sera», 15 ottobre 1931).
Q2 §147 Risorgimento italiano. Nella Nuova Antologia del 1° ottobre 1930, Francesco Moroncini, Lettere inedite di Carlo Poerio e di altri ad Antonio Ranieri (1860‑66). Interessante per il periodo storico e per la quistione politica del Mezzogiorno.
Q2 §148 Risorgimento italiano. Vedi nel «Corriere della Sera»
del 16 ottobre 1931 l’articolo di Gioacchino Volpe, Quattro anni di governo nel
Diario autografo del Re (sul libro di Francesco Salata,
Carlo Alberto inedito). Il Volpe è anodino e prudente
all’eccesso nei suoi giudizi e nella sua esposizione. Un
capitoletto è intitolato «Contro le ingerenze straniere», ma
quali sono queste ingerenze? Carlo Alberto è favorevolissimo
all’intervento dell’Austria nelle Legazioni; è contro
l’ingerenza (?) negli affari interni del Piemonte
dell’ambasciatore francese e del ministro inglese che vorrebbero
una conferenza a Torino per regolare le faccende dello Stato e
della Chiesa: Carlo Alberto preferì l’intervento armato
dell’Austria nelle Legazioni piuttosto che fare intervenire le
proprie truppe come il Papa desiderava, perché non voleva che i
soldati piemontesi si contagiassero di liberalismo o nei
Romagnoli nascesse il desiderio di unirsi al Piemonte.
Q2 §149 Politica e comando militare. Confrontare nella «Nuova Antologia» del 16 ottobre e 1° novembre 1930 l’articolo di Saverio Nasalli Rocca La politica tedesca dell’impotenza nella guerra mondiale.
L’articolo, sulla base dell’esperienza tedesca (vincere le battaglie, perdere la guerra) raccoglie materiale per corroborare la tesi che, anche in guerra, è il comando politico che dà la vittoria, comando politico, che deve incorporarsi nel comando militare, creando un nuovo tipo di comando proprio al tempo di guerra. Il Nasalli Rocca si serve specialmente delle memorie e degli altri scritti di von Tirpitz. (Il titolo dell’articolo è anche il titolo di un libro di Tirpitz tradotto in italiano). Scrive il Nasalli Rocca: «... una delle più grandi difficoltà della guerra è rappresentata dalle relazioni fra il comando militare e il Governo: vecchio militare, non esito a riconoscere che le relazioni fra Governo e le Forze Armate corrispondono rispettivamente a quelle che corrono fra la strategia e la tattica. Al Governo la strategia della guerra, alle Forze Armate la tattica: ma come il tattico per raggiungere gli scopi fissatigli ha piena libertà di manovra nei larghi limiti fissatigli dalla strategia, così questo non ha facoltà di invadere il campo del tattico. L’assenteismo e l’invadenza sono i due grandi scogli del comando qualunque nome esso abbia: e il senso della misura è quello che fissa i limiti dell’invadenza».
La formula non mi pare molto esatta: esiste certamente una «strategia militare» che non spetta tecnicamente al governo, ma essa è compresa in una più ampia strategia politica che inquadra quella militare. La quistione può allargarsi: i conflitti tra militari e governanti non sono conflitti tra tecnici e politici, ma tra politici e politici, sono i conflitti tra «due direzioni politiche» che entrano in concorrenza all’inizio di ogni guerra. Le difficoltà del comando unico interalleato durante la guerra non erano di carattere tecnico, ma politico: conflitto di egemonie nazionali.
Q2 §150 Argomenti di cultura. Il problema: «Chi è il legislatore?» in un paese, accennato in altre , può ripresentarsi per la definizione «reale», non «scolastica», di altre quistioni. Per esempio: «Cosa è la polizia?» (a questa domanda si è accennato in altre , trattando della reale funzione dei partiti politici). Si sente spesso dire, come se si trattasse di una critica demolitrice della polizia, che il 90 % dei reati, oggi perseguiti (un gran numero non è perseguito perché o non se ne ha notizia o è impossibile ogni accertamento, ecc.) rimarrebbero impuniti se la polizia non avesse a sua disposizione i confidenti ecc. Ma in realtà, questa specie di critica è inetta. Cosa è la polizia? Certo essa non è solo quella tale organizzazione ufficiale, giuridicamente riconosciuta e abilitata alla funzione pubblica della pubblica sicurezza che di solito si intende. Questo organismo è il nucleo centrale e formalmente responsabile, della «polizia», che è una ben più vasta organizzazione, alla quale, direttamente o indirettamente, con legami più o meno precisi e determinati, permanenti o occasionali, ecc., partecipa una gran parte della popolazione di uno Stato. L’analisi di questi rapporti serve a comprendere cosa sia lo «Stato» ben più di molte dissertazioni filosofico‑giuridiche.
QUADERNO 3
Q3 §1 Gli intellettuali francesi. Nelle «Nouvelles Littéraires» del 12 ottobre 1929 in un articolo Deux époques littéraires et d’angoisse: 1815‑1830 et 1918‑1930, Pierre Mille cita un articolo di André Berge nella «Révue des deux mondes»: L’Esprit de la Littérature moderne, in cui si segnala l’inquietudine delle giovani generazioni letterarie francesi: disillusione, malessere e persino disperazione; non si sa più perché si vive, perché si è sulla terra. Secondo il Mille, questo stato d’animo rassomiglia a quello da cui nacque il romanticismo, con questa differenza che i romantici se ne liberavano con l’effusione letteraria, col lirismo, con le «parole» (ma è poi vero? al romanticismo si accompagnarono anche dei fatti: il 30, il 31, il 48; ci fu l’effusione letteraria, ma non solo questa). Oggi invece le giovani generazioni non credono più alla letteratura, al lirismo, all’effusione verbale, di cui hanno orrore: predomina la noia, il disgusto.
Per il Mille si tratta di questo: non è tanto la guerra che ha cambiato il mondo; si tratta di una rivoluzione sociale: si è formato un «supercapitalismo» che alleato tacitamente alla classe operaia e ai contadini, schiaccia la vecchia borghesia. Il Mille vuol dire che in Francia c’è stato un ulteriore sviluppo industriale e bancario e che la piccola e media borghesia che prima sembravano dominare, sono in crisi: quindi crisi degli intellettuali. La guerra e la rivoluzione russa hanno accelerato il movimento che già esisteva prima dell’agosto 14. Crisi economica delle classi medie che «n’arrivent même pas à concevoir que vingt‑cinq francs ne valent plus que cent sous» e «voudraient que ce soit comme avant»; gli operai che pensano: laggiù, all’est, c’è un paese dove il proletario è dittatore; classi che nel passato erano dirigenti, e ora non dirigono più, che sognano all’Italia fascista. Il Mille scrive che è proprio «opportuno» ciò che domanda Emmanuel Berl nella Mort de la Pensée bourgeoise quando vorrebbe che gli scrittori, borghesi per il 90%, abbiano delle simpatie per quelli che vogliono spossessarli!
Alcuni tratti del quadro mi sembrano esatti e interessanti. La vecchia Francia piccolo‑borghese attraversa una crisi molto profonda, che però è ancora più morale che immediatamente politica.
Q3 §2 Julien Benda. Un suo articolo nelle «Nouvelles Littéraires» del 2 novembre 1929: Comment un écrivain sert‑il l’universel? è un corollario del libro Il tradimento degli intellettuali. Accenna a un’opera recente, Esprit und Geist del Wechssler, in cui si cerca di dimostrare la nazionalità del pensiero e di spiegare che il Geist tedesco è ben diverso dall’Esprit francese; invita i tedeschi a non dimenticare questo particolarismo del loro cervello e tuttavia pensa di lavorare all’unione dei popoli in virtù di un pensiero di André Gide, secondo cui si serve meglio l’interesse generale quanto più si è particolari.
Il Benda ricorda il manifesto dei 54 scrittori francesi pubblicato nel «Figaro» del 19 luglio 1919 Manifeste du parti de l’Intelligence in cui si diceva: «N’est‑ce pas en se nationalisant qu’une littérature prend une signification plus universelle, un intérêt plus humainement général?». Per il Benda è giusto che l’universale si serve meglio quanto più si è particolari. Ma una cosa è essere particolari, altra cosa predicare il particolarismo. Qui è l’equivoco del nazionalismo, che in base a questo equivoco pretende spesso di essere il vero universalista, il vero pacifista. Nazionale, cioè, è diverso da nazionalista. Goethe era «nazionale» tedesco, Stendhal «nazionale» francese, ma né l’uno né l’altro nazionalista. Un’idea non è efficace se non è espressa in qualche modo, artisticamente, cioè particolarmente. Ma uno spirito è particolare in quanto nazionale?
La nazionalità è una particolarità primaria; ma il grande scrittore si particolarizza ancora tra i suoi connazionali e questa seconda «particolarità» non è il prolungamento della prima. Renan, in quanto Renan non è affatto una conseguenza necessaria dello spirito francese; egli è, per rapporto a questo spirito, un evento originale, arbitrario, imprevedibile (come dice Bergson). E tuttavia Renan resta francese, come l’uomo, pur essendo uomo, rimane un mammifero; ma il suo valore, come per l’uomo, è appunto nella sua differenza dal gruppo donde è nato.
Ciò appunto non vogliono i nazionalisti, per i quali il valore dei maestri consiste nella loro somiglianza con lo spirito del loro gruppo, nella loro fedeltà, nella loro puntualità ad esprimere questo spirito (che d’altronde viene definito come lo spirito dei maestria, per cui si finisce sempre con l’aver ragione).
Perché tanti scrittori moderni ci tengono tanto all’«anima nazionale» che dicono di rappresentare? È utile, per chi non ha personalità, decretare che l’essenziale è di essere nazionali. Max Nordau scrive di un tale che esclamò: «Dite che io non sono niente. Ebbene: sono pur qualche cosa: sono un contemporaneo!». Così molti dicono di essere scrittori francesissimi ecc. (in questo modo si costituisce una gerarchia e una organizzazione di fatto e questo è l’essenziale di tutta la quistione: il Benda, come il Croce, esamina la quistione degli intellettuali astraendo dalla situazione di classe degli intellettuali stessi e dalla loro funzione, che si è venuta precisando con l’enorme diffusione del libro e della stampa periodica). Ma se questa posizione è spiegabile per i mediocri, come spiegarla nelle grandi personalità? (forse la spiegazione è coordinata: le grandi personalità dirigono i mediocri e ne partecipano necessariamente certi pregiudizi pratici che non sono di danno alle loro opere).
Wagner (cfr l’Ecce homo di Nietzsche) sapeva ciò che faceva affermando che la sua arte era l’espressione del genio tedesco, invitando così tutta una razza ad applaudire se stessa nelle sue opere.
Ma in molti il Benda vede come ragione del fatto la credenza che lo spirito è buono nella misura in cui adotta una certa maniera collettiva di pensare e cattivo in quanto cerca di individuarsi. Quando Barrès scriveva: «C’est le rôle des maitres de justifier les habitudes et préjugés qui sont ceux de la France, de manière à préparer pour le mieux nos enfants à prendre leur rang dans la procession nationale», egli intendeva appunto che il suo dovere e quello dei pensatori francesi degni di questo nome, era di entrare, anch’essi, in questa processione.
Questa tendenza ha avuto effetti disastrosi nella letteratura (insincerità). In politica: questa tendenza alla distinzione nazionale ha fatto sì che la guerra, invece di essere semplicemente politica, è diventata una guerra di anime nazionali, con i suoi caratteri di profondità passionale e di ferocia.
Il Benda conclude osservando che tutto questo lavorio per mantenere la nazionalizzazione dello spirito significa che lo spirito europeo sta nascendo e che è nel seno dello spirito europeo che l’artista dovrà individualizzarsi se vuol servire l’universale. (La guerra appunto ha dimostrato che questi atteggiamenti nazionalistici non erano casuali o dovuti a cause intellettuali – errori logici ecc. –: essi erano e sono legati a un determinato periodo storico in cui solo l’unione di tutti gli elementi nazionali può essere una condizione di vittoria. La lotta intellettuale, se condotta senza una lotta reale che tenda a capovolgere questa situazione, è sterile. È vero che lo spirito europeo sta nascendo e non solamente europeo, ma appunto ciò inasprisce il carattere nazionale degli intellettuali, specialmente dello strato più elevato).
Q3 §3 Intellettuali tedeschi.
1) Hans Frank, Il diritto è l’ingiustizia. Nove racconti che sono nove esempi per dimostrare che summum jus, summa iniuria. Il Frank non è un giovane che voglia fare dei paradossi: ha cinquant’anni ed è stata pubblicata una antologia di suoi racconti di storia tedesca per le scuole. Uomo di forti convinzioni. Combatte il diritto romano, la dura lex, e non già questa o quest’altra legge inumana e antiquata, ma la stessa nozione di norma giuridica, quella di una giustizia astratta che generalizza e codifica, definisce il delitto e pronunzia la sanzione.
Questo di Hans Frank non è un caso individuale: è il sintomo di uno stato d’animo. Un difensore dell’Occidente potrebbe vedere in ciò la rivolta del «disordine tedesco» contro l’ordine latino, dell’anarchia sentimentale contro la regola dell’intelligenza. Ma gli autori tedeschi l’intendono piuttosto come la restaurazione di un ordine naturale sulle rovine d’un ordine artificioso. Di nuovo l’esame personale si oppone al principio d’autorità, che viene attaccato in tutte le sue forme: dogma religioso, potere monarchico, insegnamento ufficiale, stato militare, legame coniugale, prestigio paterno, e soprattutto la giustizia che protegge queste istituzioni caduche, che non è che coercizione, compressione, deformazione arbitraria della vita pubblica e della natura umana.
L’uomo è infelice e cattivo finché è incatenato dalla legge, dal costume, dalle idee ricevute. Bisogna liberarlo per salvarlo. La virtù creatrice della distruzione è diventata un articolo di fede.
Stefan Zweig, H. Mann, Remarque, Glaeser, Leonhard Frank...
2) Leonhard Frank, La ragione: l’eroe assassina il suo ex-professore, perché questi gli aveva sfigurato l’anima: l’autore sostiene l’innocenza dell’uccisore.
3) Franz Werfel: in un romanzo sostiene che non l’assassino è colpevole, ma la vittima: non c’è in lui niente del Quincey: c’è un atto morale. Un padre, generale imperioso e brutale, spezza la vita del figlio facendone un soldato senza vocazione: non commette un delitto di lesa umanità? Deve essere immolato come due volte usurpatore: come capo e come padre.
Nasce così il motivo del parricidio e la sua apologia, l’assoluzione di Oreste, non in nome della pietà per la colpa tragica, ma in ragione di un imperativo categorico, di un mostruoso postulato morale.
La teoria di Freud, il complesso di Edipo, l’odio per il padre – padrone, modello, rivale, espressione prima del principio d’autorità – posto nell’ordine delle cose naturali. L’influenza del Freud sulla letteratura tedesca è incalcolabile: essa è alla base di una nuova etica rivoluzionaria (!). Freud ha dato un aspetto nuovo all’eterno conflitto tra padri e figli. L’emancipazione dei figli dalla tutela paterna è la tesi in voga presso i romanzieri attuali. I padri abdicano al loro «patriarcato» e fanno ammenda onorevole dinanzi ai figli il cui senso morale ingenuo è solo capace di spezzare il contratto sociale tirannico e perverso, di abolire le costrizioni di un dovere menzognero (cfr Hauptmann, Michael Kramer, la novella di Jacob Wassermann, Un padre).
4) Wassermann, Der Fall Mauritius: tipico contro la giustizia.
Q3 §4 Emmanuel Berl. Ha scritto un libro Mort de la pensée bourgeoise che pare abbia fatto un certo chiasso. Nel 1929 ha tenuto, a Médan, nella casa di Zola, un discorso in occasione del pellegrinaggio annuale (credo) degli «amici di Zola» (democratici, Jeunesses laïques et républicaines ecc.). «Dopo la morte di Zola e di Jaurès nessuno più sa parlare al popolo del popolo e la nostra “letteratura di esteti” muore per il suo egocentrismo». Zola in letteratura, Jaurès in politica sono stati gli ultimi rappresentanti del popolo. Pierre Hamp parla del popolo, ma i suoi libri sono letti dai letterati. V. Margueritte è letto dal popolo, ma non parla del popolo. Il solo libro francese che continui Zola è il Fuoco di Barbusse, perché la guerra aveva fatto rinascere in Francia una certa fraternità. Oggi il romanzo popolare (cosa intende per romanzo popolare?) si separa sempre più dalla letteratura propriamente detta che è diventata letteratura di esteti. La letteratura, separata dal popolo, deperisce – il proletariato escluso dalla vita spirituale (!) perde la sua dignità (n’est plus fondé en dignité). – (è vero che la letteratura si allontana dal popolo e diventa fenomeno di casta; ma ciò porta a una maggior dignità del popolo; la tradizionale «fraternità» non è stata che l’espressione della bohème letteraria francese, un certo momento della cultura francese intorno al 48 e fino al 70; ha avuto una certa ripresa con Zola).
«Et autour de nous, nous sentons croître cette famine du peuple qui nous interroge sans que nous puissions lui répondre, qui nous presse sans que nous puissions le satisfaire, qui réclame une justification de sa peine sans que nous puissions la lui donner. On dirait que les usines géantes déterminent une zone de silence de laquelle l’ouvrier ne peut plus sortir et où l’intellectuel ne peut plus entrer. Tellement séparés que l’intellectuel, issu du milieu ouvrier, n’en retrouve point l’accès».
«La fidélité difficile, écrit Jean Guéhenno. Peut‑étre la fidélité impossible. Le boursier n’établit nullement, comme on pouvait l’espérer, un pont entre le prolétariat et la bourgeoisie. Un bourgeois de plus, et c’est bien. Mais ses frères cessent de le reconnaître. Es ne voient plus en lui un des leurs. Comme le peuple ne participe nullement aux modes d’expression des intellectuels, il faut, ou bien qu’ìl s’oppose à eux, qu’il constitue une sorte de nationalité avec son langage propre, ou bien qu’il n’ait pas de langage du tout et s’enlise dans une sorte de barbarie».
La colpa è degli intellettuali, divenuti conformisti mentre Zola era rivoluzionario (!), raffinati e preziosi nello stile, scrittori di giornali intimi mentre Zola epico. Ma anche il mondo è cambiato. Zola conosceva un popolo che oggi non esiste più, o almeno non ha più la stessa importanza. Alto capitalismo – operaio taylorizzato – sostituisce il vecchio popolo che non si distingueva ancor bene dalla piccola borghesia e che appare in Zola, come in Proudhon, in V. Hugo, nella Sand, in E. Sue. Zola descrive l’industria nascente. Ma se è più difficile il compito dello scrittore, non deve perciò essere trascurato. Quindi ritorno a Zola, ritorno al popolo. «Avec Zola donc ou avec rien, la fraternité ou la mort. Telle est notre devise. Tel notre drame. Et telle notre loi».
Q3 §5 America. È latina l’America centrale e meridionale? E in che consiste questa latinità? Grande frazionamento, che non è casuale. Gli Stati Uniti, concentrati e che attraverso la politica dell’emigrazione cercano non solo di mantenere ma di accrescere questa concentrazione (che è una necessità economica e politica come ha dimostrato la lotta interna tra le varie nazionalità per influire sulla direzione del governo nella politica della guerra, come dimostra l’influenza che l’elemento nazionale ha nell’organizzazione sindacale e politica degli operai ecc.), esercitano un grande peso per mantenere questa disgregazione, alla quale cercano sovrapporre una rete di organizzazioni e movimenti guidati da loro: 1) Unione panamericana (politica statale); 2) Movimento missionario per sostituire il cattolicismo con il protestantesimo; 3) Opposizione della Federazione del Lavoro ad Amsterdam e tentativo di creare una Unione panamericana del lavoro (vedere se esistono anche altri movimenti e iniziative di questo genere); 4) Organizzazione bancaria, industriale, di credito che si estende su tutta l’America. Questo è il primo elemento.
L’America meridionale e centrale è caratterizzata: 1) da un numero ragguardevole di pellirossa, che, sia pure passivamente, esercitano un influsso sullo Stato: sarebbe utile avere informazioni sulla posizione sociale di questi pellirossa, sulla loro importanza economica, sulla partecipazione loro alla proprietà terriera e alla produzione industriale; 2) le razze bianche che dominano nell’America centrale e meridionale non possono riallacciarsi a patrie europee che abbiano una grande funzione economica e storica: Portogallo, Spagna (Italia)Le parentesi sono state aggiunte in un secondo tempo, probabilmente in funzione dubitativa., paragonabile a quella degli Stati Uniti; esse in molti Stati rappresentano una fase semifeudale e gesuitica, per cui si può dire che tutti gli Stati dell’America Centrale e Meridionale (eccettuato l’Argentina, forse) devono attraversare la fase del Kulturkampf e dell’avvento dello Stato moderno laico (la lotta del Messico contro il clericalismo dà un esempio di questa fase). La diffusione della cultura francese è legata a questa fase: si tratta della cultura massonico‑illuministica, che ha dato luogo alle così dette Chiese positivistiche, alle quali partecipano anche molti operai che pur si chiamano sindacalisti anarchici. Apporto delle varie culture: Portogallo, Francia, Spagna, Italia. Quistione del nome: America latina, o iberica, o ispanica? Francesi e italiani usano «latina», portoghesi «iberica», spagnoli «ispanica». Di fatto la maggiore influenza è esercitata dalla Francia; le altre tre nazioni latine hanno influenza scarsa, nonostante la lingua, perché queste nazioni americane (sono) sorte in opposizione a Spagna e Portogallo e tendenti a creare proprio nazionalismo e propria cultura. Influenza italiana, caratterizzata dal carattere sociale dell’emigrazione italiana: d’altra parte in nessun paese americano gli italiani sono la razza egemone.
Un articolo di Lamberti Sorrentino, Latinità dell’America nell’«Italia Letteraria» del 22 dicembre 1929. «Le repubbliche sudamericane sono latine per tre fattori principali: la lingua spagnola, la cultura prevalentemente francese, l’apporto etnico prevalentemente (!) italiano. Quest’ultimo è, dei tre, il fattore più profondo e sostanziale, perché conferisce appunto alla nuova razza che si forma il carattere latino (!); e in apparenza (!) il più fugace, perché alla prima generazione, perdendo quanto esso ha di originale e proprio (è un bell’indovinello, tutt’insieme!), si acclimata spontaneamente (!) nel nuovo ambiente geografico e sociale».
Secondo il Sorrentino c’è un interesse comune tra Spagnuoli, Francesi e Italiani che sia conservata (!) la lingua spagnola, tramite per la formazione di una profonda coscienza latina capace di resistere alle deviazioni (!) che sospingono gli americani del sud verso la confusione (!) e il caos. Il direttore di un periodico letterario ultra‑nazionalista dell’Argentina (il paese più europeo e latino dell’America) ha affermato che l’uomo argentino «fisserà il suo tipo latino‑anglosassone predominante». Il medesimo scrittore che si autodefinisce «argentino al cento per cento» ha detto ancora più esplicitamente: «Quanto ai nordamericani, il cui Paese ci ha dato la base costituzionale e scolastica, è bene dirlo una buona volta, noi ci sentiamo più vicini a loro per educazione, gusti, maniera di vivere, che non agli europei e agli spagnoli afro‑europei, come amano qualificarsi questi ultimi; e non abbiamo mai temuto lo staffile degli Stati Uniti». (Si riferisce alla tendenza spagnola di considerare i Pirenei come una barriera culturale tra l’Europa e il mondo iberico: Spagna, Portogallo, America Centrale e Meridionale e Marocco. Teoria dell’iberismo ‑ ibero‑americanismo –, perfezionamento dell’ispanismo ‑ ispano‑americanismo –). L’iberismo è antilatino: le repubbliche americane dovrebbero solo orientarsi verso Spagna e Portogallo. (Pure esercitazioni da intellettuali e da grandi decaduti che non vogliono persuadersi di contare ormai ben poco). La Spagna fa dei grandi sforzi per riconquistare l’America del Sud in tutti i campi: culturale, commerciale, industriale, artistico. (Ma con quale risultato?). La egemonia culturale della Francia è minacciata dagli anglosassoni: esistono un Istituto Argentino di Cultura Inglese e un Istituto Argentino di Cultura Nordamericana, enti ricchissimi e già vivi: insegnano la lingua inglese con grandi agevolazioni agli alunni il cui numero è in costante aumento e con programmi di scambi universitari e scientifici di sicura attuazione. L’immigrazione italiana e spagnola è stagnante; aumenta l’immigrazione polacca e slava. Il Sorrentino desidererebbe un fronte unico franco‑italo‑iberico per mantenere la cultura latina.
Q3 §6 Cosa pensano i giovani? Nell’«Italia Letteraria» del 22 dicembre 1929 M. Missiroli (Filosofia della Rivoluzione) parla dei lavori che il prof. Giorgio del Vecchio fa fare ai suoi allievi dell’Università di Roma. Nella «Rivista internazionale di filosofia del diritto» uscita nel (novembre) 1929 sono pubblicati sotto il titolo Esercitazioni di filosofia del diritto questi lavori che nel 28‑29 ebbero per tema «la filosofia della Rivoluzione». Nota il Missiroli che la maggioranza di questi giovani è orientata verso le dottrine dello storicismo, sebbene non manchino assertori del tradizionale spiritualismo e anche reminiscenze dell’antico diritto naturale. Nessuna traccia di positivismo e di individualismo: i principî d’autorità gagliardamente affermati.
I brani riportati dal Missiroli sono veramente interessanti e la raccolta potrebbe servire come dimostrazione della crisi intellettuale che, secondo me, non può non sboccare in una ripresa del materialismo storico (gli elementi per dimostrare come il materialismo storico sia penetrato profondamente nella cultura moderna sono abbondanti in questi esercizi).
Q3 §7 Il popolo (ohibò!), il pubblico (ohibò!). I politici d’avventura domandano con cipiglio di chi la sa lunga: «Il popolo! Ma cos’è questo popolo? Ma chi lo conosce? Ma chi l’ha mai definito?» e intanto non fanno che escogitare trucchi e trucchi per avere le maggioranze elettorali (dal 24 al 29 quanti comunicati ci sono stati in Italia per annunziare nuovi ritocchi alla legge elettorale? Quanti progetti presentati e ritirati di nuove leggi elettorali? Il catalogo sarebbe interessante di per sé). Lo stesso dicono i letterati puri: «Un vizio portato dalle idee romantiche è quello di chiamare a giudice il pubblico. Chi è il pubblico? Chi è costui? Questo testone onnisciente, questo gusto squisito, quest’assoluta probità, questa perla dov’è?» (G. Ungaretti, «Resto del Carlino», 23 ottobre 1929). Ma intanto domandano che sia instaurata una protezione contro le traduzioni da lingue straniere e quando vendono mille copie di un libro fanno suonare le campane del loro paese. Il «popolo» però ha dato il titolo a molti importanti giornali, proprio di quelli che oggi domandano «cosa è questo popolo?» proprio nei giornali che si intitolano al popolo.
Q3 §8 I nipotini di padre Bresciani. Il diavolo al Pontelungo di Bacchelli. Il romanzo è stato tradotto in inglese da Orlo Williams e la «Fiera Letteraria» del 27 gennaio 1929 riporta l’introduzione di Williams alla sua traduzione. Lo Williams nota che il Diavolo al Pontelungo è «uno dei pochi romanzi veri, nel senso che noi diciamo romanzo in Inghilterra», ma non nota (sebbene parli dell’altro libro di Bacchelli Lo sa il tonno) che il Bacchelli è uno dei pochi scrittori italiani che si possano chiamare «moralisti» nel senso inglese e francese (ricordare che il Bacchelli è stato collaboratore della «Voce» e anzi in un certo tempo ne ha avuto la direzione in sostituzione di Prezzolini). Lo chiama invece raisonneur, poeta dotto: raisonneur nel senso che troppo spesso interrompe l’azione drammatica con commenti intorno ai moventi delle umane azioni in generale. (Lo sa il tonno è il romanzo tipico di Bacchelli «morale»).
In una lettera allo Williams il Bacchelli dà queste informazioni sul Diavolo: «Nelle linee generali il materiale è storico strettamente, tanto nella prima che nella seconda parte. Sono storici i protagonisti, come Bakùnin, Cafiero, Costa. Nell’intendere l’epoca, le idee e i fatti, ho cercato d’essere storico in senso stretto: rivoluzionarismo cosmopolita, primordi della vita politica del Regno d’Italia, qualità del socialismo italiano agli inizi, psicologia politica del popolo italiano e suo ironico buon senso, suo istintivo e realistico machiavellismo (direi piuttosto guicciardinismo nel senso dell’uomo del Guicciardini di cui parla il De Sanctis) ecc. Le mie fonti sono l’esperienza della vita politica fatta a Bologna, che è la città politicamente più suscettibile e sottile d’Italia (mio padre era uomo politico, deputato liberale conservatore), i ricordi di alcuni fra gli ultimi sopravvissuti dei tempi dell’Internazionale anarchica (ho conosciuto uno che fu compagno e complice di Bakùnin nei fatti di Bologna del 74) e, per i libri, sopra tutto il capitolo del professor Ettore Zoccoli nel suo libro sull’anarchia e i quaderni di Bakùnin che lo storiografo austriaco dell’anarchia, Nettlau, ha ristampato nella sua rarissima biografia stampata in pochi esemplari. Il francese (era svizzero) James Guillaume tratta anch’egli di Bakùnin e Cafiero nell’opera sull’Internazionale, che non conosco, ma dalla quale credo di discostarmi in vari punti importanti. Quest’opera fece parte di una polemica posteriore sulla Baronata di Locarno, della quale non mi sono curato. Tratta di cose meschine e di quistioni di danaro. Credo che Herzen, nelle sue memorie, abbia scritto le parole più giuste e più umane intorno alla personalità variabile, inquieta e confusa di Bakùnin. Marx, come non di rado, fu soltanto caustico e ingiurioso. In conclusione, credo di poterle dire che il libro si fonda sopra una base di concetto sostanzialmente storico. Come e con quale sentimento artistico io abbia saputo svolgere questo materiale europeo e rappresentativo, questo è argomento sul quale il giudicare non spetta a me».
Q3 §9 L’accademia dei Dieci. Vedi articolo di C. Malaparte Una specie di Accademia nella «Fiera Letteraria» del 3 giugno 1928: il «Lavoro d’Italia» avrebbe pagato 150 000 lire il romanzo Lo Zar non è morto scritto in cooperativa dai Dieci. «Per il “Romanzo dei Dieci” i tesserati della Confederazione, in grandissima maggioranza operai, hanno dovuto sborsare ben 150 000 lire. Perché? Per la sorprendente ragione che gli autori son dieci e che fra i Dieci figurano, oltre i nomi del Presidente e del Segretario generale del «Raduno», quelli del Segretario nazionale e di due membri del Direttorio del Sindacato autori e scrittori!... Che cuccagna il sindacalismo intellettuale di Giacomo di Giacomo». Il Malaparte scrive ancora: «Se quei dirigenti, cui si riferisce il nostro discorso, fossero fascisti, non importa se di vecchia o di nuova data, avremmo seguito altra via per denunciare gli sperperi e le camorre: ci saremmo rivolti, cioè, al Segretario del P.N.F. Ma trattandosi di personaggi senza tessera, politicamente poco puliti e mal compromessi alcuni, altri infilatisi nei Sindacati all’ora del pranzo, abbiamo preferito sbrigar le cose senza scandalo (!), con queste quattro parole dette in pubblico». Questo pezzo è impagabile. Nell’articolo c’è poi un attacco vivace contro Bodrero, allora Sottosegretario all’Istruzione Pubblica e contro Fedele, ministro. Nella «Fiera Letteraria» del 17 giugno, il Malaparte, pubblica un secondo articolo Coda di un’Accademia in cui rincara sornionamente la dose contro Bodrero e Fedele. (Fedele aveva mandato una lettera sulla quistione Salgari, che fu il «pezzo forte» del «Sindacato Scrittori» e che fece ridere mezzo mondo).
Q3 §10 Proudhon e i letterati italiani (Raimondi, Jahier). Articolo di Giuseppe Raimondi Rione Bolognina nella «Fiera Letteraria» del 17 giugno 1928: motto di Proudhon: «La pauvreté est bonne, et nous devons la considérer comme le principe de notre allégresse»; spunti autobiografici che culminano in queste frasi: «Come ogni operaio e ogni figlio di operaio, io ho sempre avuto chiaro il senso della divisione delle classi sociali. Io resterò, purtroppo (!), fra quelli che lavorano. Dall’altra parte, ci sono quelli che io posso rispettare, per i quali posso anche provare della sincera gratitudine; ma qualcosa mi impedisce di piangere con loro, e non mi riesce di abbracciarli con spontaneità. O mi mettono soggezione o li disprezzo». «È nei sobborghi che si sono sempre fatte le rivoluzioni e il popolo non è da nessuna parte così giovane, sradicato da ogni tradizione, disposto a seguire un improvviso moto di passione collettivo, come nei sobborghi, che non sono più città e non sono ancora campagna. ... Di qui finirà per nascere una civiltà nuova e una storia che avrà quel senso di rivolta e di riabilitazione secolare proprio dei popoli che solo la morale dell’età moderna ha fatto riconoscere degni. Se ne parlerà come oggi si parla del Risorgimento Italiano e dell’Indipendenza Americana. – L’operaio è di gusti semplici: si istruisce con le dispense settimanali delle Scoperte della Scienza e della Storia delle Crociate: la sua mentalità resterà sempre quella un poco atea e garibaldina dei circoli suburbani e delle Università popolari. … Lasciategli i suoi difetti, risparmiategli le vostre ironie. Il popolo non sa scherzare. La sua modestia è vera, come la sua fiducia nell’avvenire». (Insomma, tra i cento modi di distinguersi e di fare lo snob, c’è anche questo scelto dal Raimondi).
Q3 §11 Americanismo. Pirandello, in una intervista con Corrado Alvaro («Italia letteraria», 14 aprile 1929): «L’americanismo ci sommerge. Credo che un nuovo faro di civiltà si sia acceso laggiù». – «Il denaro che corre il mondo è americano, e dietro al denaro corre il modo di vita e la cultura. Ha una cultura l’America? Ha libri e costumi. I costumi sono la sua nuova letteratura, quella che penetra attraverso le porte più munite e difese. A Berlino lei non sente il distacco tra vecchia e nuova Europa perché la struttura stessa della città non offre resistenze. A Parigi, dove esiste una struttura storica e artistica, dove le testimonianze di una civiltà autoctona sono presenti, l’americanismo stride come il belletto sulla vecchia faccia di una mondana».
Il problema non è se in America esista una nuova civiltà, una nuova cultura, e se queste nuove civiltà e cultura stiano invadendo l’Europa: se il problema dovesse porsi così, la risposta sarebbe facile: no, non esiste ecc., e anzi in America non si fa che rimasticare la vecchia cultura europea. Il problema è questo: se l’America, col peso implacabile della sua produzione economica, costringerà e sta già costringendo l’Europa a un rivolgimento della sua assise economica‑sociale, che sarebbe avvenuto lo stesso ma con ritmo lento e che invece si presenta come un contraccolpo della «prepotenza» americana, se cioè si sta creando una trasformazione delle basi materiali della civiltà, ciò che a lungo andare (e non molto lungo, perché nel periodo attuale tutto è più rapido che nei periodi passati) porterà a un travolgimento della civiltà stessa esistente e alla nascita di una nuova.
Gli elementi di vita che oggi si diffondono sotto l’etichetta americana, sono appena i primi tentativi a tastoni, dovuti, non già all’«ordine» che nasce dalla nuova assise che non si è formata ancora, ma all’iniziativa degli elementi déclassés dagli inizi dell’operare di questa nuova assise. Ciò che oggi si chiama americanismo è in grandissima parte un fenomeno di panico sociale, di dissoluzione, di disperazione dei vecchi strati che dal nuovo ordine saranno appunto schiacciati: sono in gran parte «reazione» incosciente e non ricostruzione: non è dagli strati «condannati» dal nuovo ordine che si può attendere la ricostruzione, ma dalla classe che crea le basi materiali di questo nuovo ordine e deve trovare il sistema di vita per far diventare «libertà» ciò che è oggi «necessità». Questo criterio che le prime reazioni intellettuali e morali allo stabilirsi di un nuovo metodo produttivo sono dovute più ai detriti delle vecchie classi in isfacelo che alle nuove classi il cui destino è legato ai nuovi metodi, mi pare di estrema importanza.
Un’altra quistione è che non si tratta di una nuova civiltà, perché muta i carattere delle classi fondamentali, ma di un prolungamento ed intensificazione della civiltà europea, che ha però assunto determinati caratteri nell’ambiente americano. L’osservazione del Pirandello sulla opposizione che l’americanismo trova a Parigi e sull’accoglienza immediata che trova invece a Berlino, prova appunto la non differenza di qualità, ma di grado. A Berlino le classi medie erano state già rovinate dalla guerra e dall’inflazione e l’industria germanica era di un grado superiore a quella francese. Le classi medie francesi invece non subirono né le crisi (occasionali) come l’inflazione tedesca, né una crisi organica molto più rapida della normale per l’introduzione e la diffusione (improvvisa) di un nuovo metodo di produzione. Perciò è giusto che l’americanismo a Parigi sia come un belletto, una superficiale moda straniera.
Q3 §12 David Lazzaretti. Un articolo di Domenico Bulferetti David Lazzaretti e due milanesi, nella «Fiera Letteraria» del 26 agosto 1928, ricorda alcuni elementi della vita e della formazione di David Lazzaretti; Andrea Verga, David Lazzaretti e la pazzia sensoria (Milano, Rechiedei, 1880); Cesare Lombroso, Pazzi e anormali (questo era il costume del tempo: invece di studiare le origini di un fatto storico, si trovava che il protagonista era un pazzo); una Storia di David Lazzaretti Profeta di Arcidosso fu pubblicata a Siena nel 1905 da uno dei maggiori discepoli del Lazzaretti, l’ex‑frate filippino Filippo Imperiuzzi: altre scritture apologetiche esistono, ma, questa è la più notevole secondo il Bulferetti; libri di Giacomo Barzellotti, 1a e 2a ed. David Lazzaretti presso Zanichelli e Monte Amiata e il suo Profeta (ed. Treves) che è il precedente assai modificato.
Il Bulferetti crede che il Barzellotti abbia sostenuto che le cause del movimento lazzarettista sono «tutte particolari e dovute solo allo stato d’animo e di coltura di quella gente là» solo «un po’ per naturale amore ai bei luoghi nativi (!) e un po’ per suggestione delle teorie di Ippolito Taine».
A me pare che il libro del Barzellotti, che ha formato l’opinione pubblica sul Lazzaretti, sia nient’altro che una manifestazione della tendenza «patriottica» (per amor di patria!) e che portava a cercare di nascondere le cause di malessere generale che esistevano in Italia, dando dei singoli episodi di esplosione di questo malessere spiegazioni restrittive, individuali, patologiche ecc.
Ciò che è avvenuto per il «brigantaggio» meridionale e siciliano è avvenuto per Davide Lazzaretti. I politici non si sono occupati del fatto che la sua uccisione è stata di una crudeltà feroce e freddamente premeditata (sarebbe interessante conoscere le istruzioni mandate dal governo alle autorità locali); neanche i repubblicani se ne sono occupati, nonostante che il Lazzaretti sia morto inneggiando alla repubblica (questo carattere del movimento deve aver specialmente contribuito a determinare la volontà del governo di sterminarlo) e per la ragione forse che nel movimento il repubblicano era legato all’elemento religioso e profetico. Ma questo appunto mi pare sia la caratteristica principale di quell’avvenimento che politicamente era legato al non-expedit del Vaticano e mostrava quale tendenza sovversiva‑popolare elementare poteva nascere dall’astensionismo dei preti. (In ogni caso bisognerebbe ricercare se le opposizioni d’allora presero atteggiamento: bisogna tener conto che il governo era della sinistra appena andata al potere e ciò spiegherebbe anche la tiepidezza nel sostenere una lotta contro il governo per l’uccisione delittuosa di uno che poteva essere presentato come un codino papalino clericale ecc.).
Il Barzellotti, nota il Bulferetti, non fece ricerche sulla formazione di quella cultura cui si riferisce. Avrebbe visto che anche a Monte Amiata arrivavano allora in gran copia (! da dove lo sa il Bulferetti?) foglietti, opuscoli, e libri popolari stampati a Milano. Il Lazzaretti ne era lettore insaziabile e per il suo mestiere di barrocciaio aveva agio di procurarsene.
Davide era nato in Arcidosso il 6 novembre 1834 e aveva esercitato il mestiere paterno fino al 1868, quando, da bestemmiatore si convertì e si ritirò a far penitenza in una grotta della Sabina, dove «vide» l’ombra di un guerriero che gli «rivelò» di essere il capostipite della sua famiglia, Manfredo Pallavicino, figlio illegittimo di un re di Francia ecc. Un danese, il dottor Emilio Rasmussen trovò che Manfredo Pallavicino è il protagonista di un romanzo storico di Giuseppe Rovani intitolato appunto Manfredo Pallavicino. L’intreccio e le avventure del romanzo serio passate tali e quali nella «rivelazione» della grotta e da queste rivelazioni si inizia la propaganda religiosa del Lazzaretti.
Il Barzellotti aveva creduto invece che il Lazzaretti fosse stato influenzato dalle leggende del Trecento (le avventure del re Giannino, senese), e la scoperta del Rasmussen lo indusse solo a introdurre nell’ultima edizione del suo libro un vago accenno alle letture del Lazzaretti, senza però accennare al Rasmussen e lasciando intatta la parte del libro dedicata a re Giannino. Tuttavia il Barzellotti studia il successivo svolgimento dello spirito del Lazzaretti, i suoi viaggi in Francia e l’influenza che ebbe su di lui il prete milanese Onorio Taramelli, uomo di fino ingegno e larga cultura, che per aver scritto contro la monarchia, era stato arrestato a Milano e poi era fuggito in Francia. Dal Taramelli Davide ebbe l’impulso repubblicano. La bandiera di Davide era rossa con la scritta: «La repubblica e il regno di Dio». Nella processione del 18 agosto 1878, in cui David fu ucciso, egli domandò ai suoi fedeli se volevano la repubblica. Al «sì» fragoroso egli rispose: «la repubblica incomincia da oggi in poi nel mondo; ma non sarà quella del ’48; sarà il regno di Dio, la legge del Diritto succeduta a quella di Grazia». (Nella risposta di David ci sono alcuni elementi interessanti, che devono essere collegati alle sue reminiscenze delle parole del Taramelli; il voler distinguersi dal 48 che in Toscana non aveva lasciato buon ricordo tra i contadini, la distinzione tra Diritto e Grazia ecc. Ricordare che qualcosa di simile pensavano i preti e i contadini coinvolti col Malatesta nel processo delle bande di Benevento. In ogni caso, nel caso del Lazzaretti, all’impressionismo letterario, dovrebbe succedere una certa analisi politica).
Q3 §13 I nipotini di padre Bresciani. Alfredo Panzini: La Vita di Cavour. La Vita di Cavour del Panzini è stata pubblicata dall’«Italia Letteraria» nei numeri dal 9 giugno al 13 ottobre 1929. A tutt’oggi (30 maggio 1930) non è stata raccolta in volume. Nell’«Italia letteraria» del 30 giugno è pubblicata col titolo Chiarimento una letterina inviata dal Panzini in data 27 giugno 1929 al direttore del «Resto del Carlino». Il Panzini, con stile molto seccato, si lamenta per un commento molto piccante pubblicato dal giornale bolognese sulle due prime puntate della sua Vita di Cavour, che veniva giudicata «piacevole giocherello» e «cosa leggera». Il Panzini scrive: «Nessuna intenzione scrivere una biografia alla maniera romanzesca francese. Mia intenzione scrivere in stile piacevole e drammatico, tutto però documentato. (Carteggio Nigra‑Cavour)». Altri accenni del Panzini non si capiscono bene; bisognerebbe conoscere il commento del «Resto del Carlino» al quale egli risponde.
L’episodio vale, perché alcuni si sono cominciati ad accorgere che queste scritture del Panzini ormai sono stucchevoli e mostrano la trama: la stupidaggine storica del Panzini è incommensurabile: è, il suo, un puro gioco di parole, che sotto un’ironia di maniera fa credere di contenere chissà quali profondità: in realtà non c’è nulla oltre le parole: è un nuovo stenterellismo che si dà l’aria di machiavellismo. Un’altra puntata diretta al Panzini certamente ho letto nella «Nuova Italia»: si parla di vite di Cavour o di altri scritti come si scriverebbe la vita di Pinocchio.
In realtà non è che lo stile del Panzini sia «piacevole e drammatico»; egli rappresenta la storia come una «piacevolezza»; la sua «drammaticità» consiste nel rappresentare le cose serie come discorsi di farmacia in cui il farmacista è Panzini e il cliente è un altro Panzini.
La Vita di Cavour del Panzini mi servirà per fare una raccolta di luoghi comuni sul Risorgimento (il Panzini è tutto una miniera di luoghi comuni) e per trarne documenti del suo gesuitismo letterario.
Q3 §14 Storia della classe dominante e storia delle classi subalterne. La storia delle classi subalterne è necessariamente disgregata ed episodica: c’è nell’attività di queste classi una tendenza all’unificazione sia pure su piani provvisori, ma essa è la parte meno appariscente e che si dimostra solo a vittoria ottenuta. Le classi subalterne subiscono l’iniziativa della classe dominante, anche quando si ribellano; sono in istato di difesa allarmata. Ogni traccia di iniziativa autonoma è perciò di inestimabile valore. In ogni modo la monografia è la forma più adatta di questa storia, che domanda un cumulo molto grande di materiali parziali.
Q3 §15 Ettore Ciccotti. Il suo volume Confronti storici (Biblioteca della «Nuova Rivista Storica», n. 10, Società editr. Dante Alighieri, 1929, pp. XXXIX‑262) è stato recensito favorevolmente da Guido De Ruggiero nella «Critica» del gennaio 1930 e invece con molte cautele e in fondo sfavorevolmente da Mario de Bernardi nella «Riforma Sociale» (che non ho presente in questo momento). Del libro del Ciccotti ho letto un capitolo (che forse è l’introduzione generale al volume) pubblicato nella «Rivista d’Italia» del 15 giugno e del 15 luglio 1927: Elementi di «verità» e di«certezza» nella tradizione storica romana. Il Ciccotti esamina e combatte una serie di deformazioni professionali della storiografia romana e molte sue osservazioni sono giuste negativamente; è nella parte positiva che incominciano i dubbi e sono necessarie le cautele.
L’errore teorico del Ciccotti mi pare consista nell’errata interpretazione del principio vichiano del «certo» e del «vero»: la storia non può essere che «certezza» o almeno ricerca di «certezza». La conversione del «certo» nel «vero» dà luogo a una costruzione filosofica della storia eterna, ma non alla costruzione della storia «effettuale»: ma la storia non può che essere «effettuale»: la sua «certezza» deve essere prima di tutto «certezza» dei documenti storici (anche se la storia non si esaurisce tutta nei documenti storici). La parte sofistica della metodologia del Ciccotti appare evidente in un caso: egli dice che la storia è dramma; ma ciò non vuol dire che ogni rappresentazione drammatica di un dato periodo storico sia quella «effettuale», anche se viva, artisticamente perfetta ecc. Il sofisma del Ciccotti porta a dare un valore eccessivo alla «belletristica» storica per reazione alla erudizione pedantesca e petulante.
In un esame della attività teorica del Ciccotti bisogna tener conto di questo libro. «Materialismo storico» del Ciccotti molto superficiale: quello del Ferrero e del Barbagallo. Una sociologia molto positivistica; una interpretazione positivistica del Vico. La metodologia del Ciccotti dà luogo appunto alle storie tipo Ferrero e alle «esagerazioni» del Barbagallo: finisce col perdere il concetto di distinzione e della concretezza «individua» e col trovare che «tutto il mondo è paese» e «più tutto cambia e più si rassomiglia».
Q3 §16 Sviluppo politico della classe popolare nel Comune medioevale. Nel citato studio di Ettore Ciccotti (Elementi di»verità» e di «certezza» ecc.) ci sono alcuni accenni allo sviluppo storico della classe popolare dei Comuni specialmente degni di attenzione e di trattazione separata. Le guerre reciproche dei Comuni e quindi la necessità di reclutare una più vigorosa e abbondante forza militare col lasciare armare il maggior numero, davano la coscienza della loro forza ai popolani e ne rinsaldavano insieme le file (cioè funzionarono da eccitanti di formazioni di partito). I combattenti rimanevano uniti anche in pace, sia per il servizio da prestare ma poi, con crescente solidarietà, per fini di utilità particolare. Si hanno gli statuti delle «Società d’armi» che si costituirono a Bologna, come sembra, verso il 1230, ed emerge il carattere della loro unione e il loro modo di costituzione. Verso la metà del secolo XIII erano già ventiquattro, distribuite a seconda della contrada ove abitavano. E oltre al loro ufficio politico di difesa esterna del Comune, avevano il fine di assicurare a ciascun popolano la tutela necessaria a proteggerlo contro le aggressioni dei nobili e dei potenti. Capitoli dei loro statuti – per esempio della Società detta dei Leoni – hanno in rubrica il titolo «De adiutorio dando hominibus dicte societatis»; «Quod molestati iniuste debeant adiuvari ab hominibus dicte societatis». E alle sanzioni civili e sociali si aggiungeva, oltre al giuramento, una sanzione religiosa, con la comune assistenza alla messa ed alla celebrazione di uffici divini; mentre altri obblighi comuni, come quelli, comuni alle confraternite pie, di soccorrere i soci poveri, seppellire i defunti ecc., rendevano sempre più persistente e stretta l’unione. Per le funzioni stesse delle società si formarono poi cariche e consigli – a Bologna, per es., quattro o otto «ministeriales» foggiati sugli ordini della Società delle Arti o su quelli più antichi del Comune – che col tempo ebbero valore oltre i termini delle società e trovarono luogo nella costituzione del Comune.
Originariamente, in queste società entrano milites al pari di pedites, nobili e popolani, se anche in minor numero. Ma, a grado a grado, i milites, i nobili tendono ad appartarsene come a Siena, o, secondo i casi, ne possono essere espulsi, come nel 1270, a Bologna. E a misura che il movimento di emancipazione prende piede, oltrepassando anche i limiti e la forma di queste società, l’elemento popolare chiede e ottiene la partecipazione alle maggiori cariche pubbliche. Il popolo si costituisce sempre più in vero partito politico e per dare maggiore efficienza e centralizzazione alla sua azione si dà un capo, «il Capitano del popolo», ufficio che pare Siena abbia preso da Pisa e che nel nome come nella funzione rivela insieme origini e funzioni militari e politiche. Il popolo che già, volta a volta, ma sporadicamente, si era riunito e si era costituito e aveva prese deliberazioni distinte, si costituisce come un ente a parte, che si dà anche proprie leggi. Campana propria per le sue convocazioni «cum campana Communis non bene audiatur». Entra in contrasto col Podestà a cui contesta il diritto di pubblicar bandi e con cui il Capitano del popolo stipula delle «paci».
Quando il popolo non riesce ad ottenere dalle Autorità comunali le riforme volute, fa la sua secessione, con l’appoggio di uomini eminenti del Comune e, costituitosi in assemblea indipendente, incomincia a creare magistrature proprie ad immagine di quelle generali del Comune, ad attribuire una giurisdizione al Capitano del popolo, e a deliberare di sua autorità, dando inizio (dal 1255) a tutta un’opera legislativa. (Questi dati sono del Comune di Siena). Il popolo riesce, prima praticamente, e poi anche formalmente, a fare accettare negli Statuti generali del Comune disposizioni che prima non legavano se non gli ascritti al «Popolo» e di uso interno. Il popolo giunge quindi a dominare il Comune, soverchiando la precedente classe dominante, come a Siena dopo il 1270, a Bologna con gli Ordinamenti «Sacrati» e «Sacratissimi», a Firenze con gli «Ordinamenti di giustizia». (Provenzan Salvani a Siena è un nobile che si pone a capo del popolo).
Q3 §17 1917. Per le cause che provocarono la terribile crisi nel vettovagliamento di Torino nel luglio‑agosto 1917 è da vedere il volume di R. Bachi, L’alimentazione e la politica annonaria in Italia, nelle «Pubblicazioni della Fondazione Carnegie», Laterza, Bari, e il volume di Umberto Ricci, Il fallimento della politica annonaria, Ed. La Voce, Firenze, 1921.
Q3 §18 Storia delle classi subalterne. La maggior parte dei problemi di storia romana che il Ciccotti prospetta nel suo studio Elementi di «verità» e di «certezza» ecc. (a parte l’accertamento degli episodi «personali», Tanaquilla ecc.) si riferiscono a eventi ed istituzioni delle classi subalterne (tribuno della plebe ecc.). In questo caso il metodo dell’«analogia» affermato e teorizzato dal Ciccotti può dare qualche risultato indiziario, perché la classe subalterna mancando di autonomia politica, le sue iniziative «difensive» sono costrette da leggi proprie di necessità, più complesse e politicamente più compressive che non siano le leggi di necessità storica che dirigono le iniziative della classe dominante. (La quistione dell’importanza delle donne nella storia romana è simile a quella delle classi subalterne, ma fino a un certo punto: il «maschilismo» può solo in un certo senso essere paragonato a un dominio di classe; essa quindi ha più importanza per la storia dei costumi che per la storia politica e sociale).
Un’altra osservazione e importantissima occorre fare sui pericoli insiti nel metodo dell’analogia storica come criterio d’interpretazione: nello Stato antico e in quello medioevale, l’accentramento sia territoriale, sia sociale (e l’uno non è poi che funzione dell’altro) era minimo; in un certo senso lo Stato era una «federazione» di classi: le classi subalterne avevano una vita a sé, istituzioni proprie ecc. e talvolta queste istituzioni avevano funzioni statali: (così il fenomeno del «doppio governo» nei periodi di crisi assumeva un’evidenza estrema).
L’unica classe esclusa da ogni vita propria, era quella degli schiavi nel mondo classico e quella dei proletari nel mondo medioevale. Tuttavia se per molti rispetti schiavi antichi e proletari medioevali si trovavano nelle stesse condizioni, la loro situazione non era identica: il tentativo dei Ciompi non produsse certo l’impressione che avrebbe prodotto un tentativo simile degli schiavi a Roma (Spartaco che domanda di essere assunto al governo coi patrizi ecc.). Mentre nel Medio Evo era possibile un’alleanza tra proletari e popolo e ancor di più, l’appoggio dei proletari alla dittatura di un principe, niente di simile nel mondo classico. Lo Stato moderno abolisce molte autonomie delle classi subalterne, abolisce lo Stato federazione di classi, ma certe forme di vita interna delle classi subalterne rinascono come partito, sindacato, associazione di cultura. La dittatura moderna abolisce anche queste forme di autonomia di classe e si sforza di incorporarle nell’attività statale: cioè l’accentramento di tutta la vita nazionale nelle mani della classe dominante diventa frenetico e assorbente.
Q3 §19 Il problema dei giovani. «I fascisti hanno vissuto troppo la storia contemporanea per avere l’obbligo di conoscere alla perfezione quella passata». Mussolini, prefazione a Gli Accordi del Laterano. Discorsi al Parlamento, Libreria del Littorio, Roma 1929.
Q3 §20 Documenti del tempo. Un documento molto importante e interessante è la Relazione della Commissione d’indagine per la spedizione polare dell’aeronave «Italia», stampato per disposizione del Ministero della Marina nel 1930 a Roma dalla «Rivista Marittima». («Caporetto»).
Q3 §21 La diplomazia italiana prima del 1914. Un documento molto interessante e curioso su questo argomento è il volume di Alessandro De Bosdari, Delle guerre balcaniche, della grande guerra e di alcuni fatti preceduti ad esse, (ed. Mondadori). La Nuova Antologia del 1° settembre 1927 ne riproduce un capitolo: «Lo scoppio della guerra balcanica visto da Sofia», dove si leggono amenità di questo genere: «Non posso negare che la profonda convinzione dell’orientazione austriaca, sicura e permanente guida dello Zar dei Bulgari in tutta la sua politica estera, da me acquisita fin dagli ultimi mesi del 1911, non mi abbia impedito di vederci chiaro nella Lega balcanica e nella imminenza della guerra contro la Turchia. A tanti anni di distanza non so troppo (!) rimproverarmelo perché se non vidi venire un fatto accessorio (?!) e per così dire (!) episodico (!) della politica bulgara, ciò fu unicamente perché vedevo troppo chiara (e lo dice sul serio!) la linea principale. Fu come chi dicesse un fenomeno di presbitismo politico, ed in politica il presbitismo è migliore della miopia, come questa è senza dubbio migliore di quella cecità assoluta di cui debbo dire a mio discarico (!), fecero prova, in quella ed in tante susseguenti occasioni, molti miei colleghi».
Il brano è interessante anche da altri punti di vista, oltre quello particolare del giudizio sulla diplomazia italiana. Il candore ameno porta il De Bosdari a dire manifestamente ciò che altri pensano per giustificare i propri errori e non dicono apertamente in questa forma. Esiste una linea non formata di «fatti accessori» e di «episodi» come dice il De Bosdari? E comprendere una linea non significa riuscire a comprendere e quindi a prevedere e organizzare questa catena di fatti accessori? Chi parla di linea in questo senso, in realtà intende dire una «categoria sociologica», un’«astrazione». Qualche volta indovina? È vero, ma a questo proposito si potrebbe citare il pensiero di Guicciardini sull’«ostinazione».
Q3 §22 Lorianismo. In una nota dedicata ad Alberto Lumbroso ho scritto che questi non ha ereditato dal padre le qualità di studioso sobrio, preciso, disciplinato. Giacomo Lumbroso morto nel 1927 (mi pare) fu uno storico dell’età ellenistica, papirologo, lessicografo della grecità alessandrina. (Cfr l’articolo Giacomo Lumbroso di V. Scialoja, nella «Nuova Antologia» del 16 settembre 1927). È stato anche professore di storia moderna prima di Fedele?.
Q3 §23 Loria. Le sue memorie pubblicate nel 1927 da N. Zanichelli, Bologna, sono intitolate: Ricordi di uno studente settuagenario, L. 10.
Q3 §24 Motivi del Risorgimento. Il separatismo siciliano. Un libro di Luigi Natoli, Rivendicazioni (attraverso le rivoluzioni siciliane del 1848‑1860), Treviso, Cattedra italiana di pubblicità, 1927, L. 14. Il Natoli vuole reagire contro quella tendenza di studi e di studiosi che ancor oggi o per scarsa padronanza delle testimonianze o per residui di antiche prevenzioni politiche, mira a svalutare il contributo della Sicilia alla storia unitaria del Risorgimento. L’autore polemizza specialmente con B. Croce, il quale considera la rivoluzione siciliana del 1848 come un “moto separatista” dannoso alla causa italiana ecc. ecc.». Ciò che è interessante in questa letteratura siciliana, giornalistica o libresca, è specialmente il tono fortemente polemico e irritato.
Ora la questione dovrebbe essere semplice, dal punto di vista storico; il separatismo o c’è stato o non c’è stato o è stato solo tendenziale in una misura da determinarsi secondo il metodo storico, astraendo da ogni valutazione polemica di partito, di corrente o di ideologia. Se il separatismo ci fosse stato non sarebbe storicamente «riprovevole» o «immorale» o «antipatriottico» ma sarebbe stato un evento da spiegare e ricostruire storicamente. Il fatto che continui accanitamente la polemica significa che ci sono «interessi attuali» e non più passati in gioco, cioè significa che queste pubblicazioni stesse proprio dimostrano ciò che vorrebbero negare.
Il Natoli pare sostenga che l’accusa di separatismo gioca sull’equivoco sfruttando il programma federalista che in un primo tempo parve a taluni uomini insigni dell’Isola e alle sue rappresentanze la soluzione più rispondente alle tradizioni politiche locali ecc. In ogni modo il fatto che il programma federalista abbia avuto più forti sostenitori in Sicilia e sia durato più a lungo ha il suo significato.
Q3 §25 La funzione dei cattolici in Italia (Azione Cattolica). Nella Nuova Antologia del 1° novembre 1927, G. Suardi pubblica una nota Quando e come i cattolici poterono partecipare alle elezioni politiche, molto interessante e da ricordare come documento dell’attività e della funzione dell’Azione Cattolica in Italia. Alla fine del settembre 1904, dopo lo sciopero generale, il Suardi fu chiamato telegraficamente a Milano da Tommaso Tittoni, ministro degli Esteri nel Ministero Giolitti (il Tittoni si trovava nella sua villa di Desio al momento dello sciopero e pareva che egli, dato il pericolo che Milano fosse per essere isolata dalla mancanza di comunicazioni, dovesse assumere speciali e personali responsabilità; questo accenno del Suardi mi pare significhi che i reazionari locali avessero già pensato a qualche iniziativa d’accordo con Tittoni). Il Tittoni gli comunicò che il Consiglio dei Ministri aveva deciso di indire subito le elezioni e che bisognava unire tutte le forze liberali e conservatrici nello sforzo per contrastare il passo ai partiti estremi. Il Suardi, esponente liberale di Bergamo, era riuscito in questa città ad accordarsi coi cattolici per le amministrazioni locali: bisognerebbe ottenere lo stesso risultato per le elezioni politiche, persuadendo i cattolici che il non expedit nulla serve al loro partito, nuoce alla religione ed è di grave danno alla patria, lasciando libero il passo al socialismo. Il Suardi accettò l’incarico. A Bergamo ne parlò con l’avvocato Paolo Bonomi e riuscì a convincerlo di andare a Roma, presentarsi al Papa e aggiungere alle insistenze del Bonomelli e di altri autorevoli personaggi perché fosse tolto il non expedit anche quelle dei cattolici bergamaschi.
Pio X prima rifiutò di togliere il non expedit, ma terrorizzato dal Bonomi che gli fece un quadro catastrofico delle conseguenze che avrebbe avuto a Bergamo la rottura tra cattolici e gruppo Suardi «con lenta e grave parola, esclamò: “Fate, fate quello che vi detta la vostra coscienza”. (Bonomi): “Abbiamo ben compreso, Santità? Possiamo interpretare che è un sì?” (Papa): “Fate quello che vi detta la vostra coscienza. Ripeto”». (Subito dopo) il Suardi ebbe un colloquio col cardinale Agliardi (di tendenze liberali) che lo mise al corrente di quanto era avvenuto in Vaticano dopo l’udienza data dal Papa al Bonomi. (L’Agliardi era d’accordo col Bonomelli perché fosse tolto il non expedit). Il giorno dopo questa udienza un giornale ufficioso del Vaticano aveva pubblicato un articolo che smentiva le voci diffuse intorno all’udienza e a novità circa il non expedit decisamente affermando che in tale argomento nulla era mutato. L’Agliardi chiese subito udienza e alle sue domande il papa ripeté la sua formula: «Ho detto (ai bergamaschi) che facessero quello che dettava la loro coscienza». L’Agliardi fece pubblicare un articolo in un giornale romano, dove si affermava che del pensiero del papa per le prossime elezioni politiche erano depositari l’avvocato Bonomi e il professor Rezzara e che a questi dovevano rivolgersi le organizzazioni cattoliche. Così si presentarono candidature cattoliche (Cornaggia a Milano, Cameroni a Treviglio ecc.) e a Bergamo apparvero a sostegno di candidature politiche manifesti di cittadini fino allora astensionisti.
Per il Suardi questo avvenimento segna la fine del non expedit e rappresenta la raggiunta unità morale dell’Italia, ma egli esagera alquanto, sebbene il fatto sia importante per sé.
Q3 §26 America ed Europa. Nel 1927 l’Ufficio internazionale del Lavoro di Ginevra ha pubblicato i risultati di una indagine sui rapporti fra padroni e operai negli Stati Uniti Les rélations industrielles aux États Unis. Secondo Gompers gli scopi finali del sindacalismo americano consisterebbero nell’istituzione progressiva di un controllo paritetico, estendentesi dalla singola officina al complesso dell’industria e coronato da una specie di parlamento organico. (Vedere quale forma assuma nelle parole di Gompers e C. la tendenza degli operai all’autonomia industriale).
Q3 §27 Il Principe Carlo di Rohan. Ha fondato nel 1924 la Federazione delle Unioni Intellettuali e dirige una rivista (Europäische Gespräche?). Gli italiani partecipano a questa federazione: il suo Congresso del 25 è stato tenuto a Milano. L’Unione italiana è presieduta da S. E. l’On. Vittorio Scialoja. Nel 1927 il di Rohan ha pubblicato un libro sulla Russia (Moskau. Ein Skizzenbuch aus Sowietrussland, Verlag G. Braun in Karlsruhe), dove aveva fatto un viaggio. Il libro deve essere interessante data la personalità sociale dell’autore. Egli conclude che la Russia «seinen Weg gefunden hat».
Q3 §28 Riviste tipo. Poiché la rivista tipo «Critica» di Croce e «Politica» di Coppola e Rocco domanda immediatamente un corpo di redattori specializzati, in grado di fornire con una certa periodicità un materiale scientificamente selezionato, essa può essere anticipata con la pubblicazione di un «Annuario». Questo annuario non dovrebbe avere, come è naturale, niente di simile ad un comune «Almanacco» popolare (la cui compilazione è legata qualitativamente al giornale quotidiano, è fatta tenendo di vista il medio lettore del giornale quotidiano); esso non dovrebbe neanche essere un’antologia occasionale di scritti troppo lunghi per essere pubblicati in altro tipo di rivista; dovrebbe invece essere preparato organicamente secondo un piano generale abbracciante parecchi anni (cinque anni, per esempio) in modo da preventivare lo sviluppo di un determinato programma. Potrebbe essere dedicato a un solo argomento o essere diviso in sezioni e trattare una serie di quistioni fondamentali (la costituzione dello Stato, la politica internazionale, la quistione agraria, ecc.). Ogni «Annuario» dovrebbe stare a sé (non dovrebbe avere lavori in continuazione) ed essere fornito di indici analitici, ecc. ecc.
Q3 §29 Il Catalogo dei cataloghi del libro italiano pubblicato dalla Società generale delle Messaggerie italiane di Bologna nel 1926 (mi pare che siano stati pubblicati successivamente dei supplementi) è una pubblicazione da tener presente per le ricerche bibliografiche. Questo repertorio contiene i dati di 65 000 volumi (meno quello dell’editore) classificati in 18 classi e due indici alfabetici, uno degli autori, curatori e traduttori e uno dei soggetti coi relativi richiami alla classe e al numero d’ordine.
Q3 §30 Altra pubblicazione bibliografica da tener presente è il Catalogo metodico degli scritti contenuti nelle Pubblicazioni periodiche italiane e straniere, pubblicato dalla Biblioteca della Camera dei Deputati.
Q3 §31 Riviste tipo. Per una esposizione generale dei tipi principali di riviste ricordare l’attività giornalistica di Carlo Cattaneo: l’«Archivio Triennale» e il «Politecnico». Il «Politecnico» è un tipo di rivista da studiare accuratamente (accanto ad esso la rivista «Scientia» del Rignano).
Su Antonio Labriola: riassunto obbiettivo sistematico delle sue pubblicazioni sul materialismo storico per sostituire i volumi esauriti e che la famiglia non ristampa; questo lavoro sarebbe l’inizio dell’attività per rimettere in circolazione le posizioni filosofiche del Labriola che sono poco conosciute all’infuori di una cerchia ristretta.
Leone Davidovi nelle sue memorie parla di un «dilettantismo» del Labriola: è stupefacente! Non si capisce questo giudizio, che non è giustificato altro che come un riflesso «incosciente» di una tradizione della socialdemocrazia russa e specialmente delle opinioni di Plekhanov. In realtà il Labriola, affermando che la filosofia del marxismo è contenuta nel marxismo stesso, è il solo che abbia cercato di dare una base scientifica al materialismo storico.
La tendenza dominante ha dato luogo a due correnti: 1) a quella, rappresentata dal Plekhanov (cfr I problemi fondamentali del marxismo) che ricade nel materialismo volgare, dopo essersi sforzata di risolvere il problema delle origini del pensiero del Marx senza aver saputo impostare il problema; lo studio della cultura filosofica di Marx (o delle «fonti» della sua filosofia) è certamente necessario, ma come premessa allo studio, ben più importante, della sua propria filosofia, che non si esaurisce nelle «fonti» o nella «cultura» personale. Questo lavoro mostra il metodo positivistico classico seguito dal Plekhanov e la sua scarsa capacità speculativa; 2) questa tendenza ha creato la sua opposta, di collegare il marxismo col kantismo e ha quindi in ultima analisi portato alla conclusione opportunistica espressa da Otto Bauer nel suo recente volumetto Socialismo e Religione che il marxismo può essere «sostenuto» o «integrato» da una qualsiasi filosofia, quindi anche dalla cosidetta «filosofia perenne della religione».
Pongo questa come seconda tendenza, perché essa, col suo agnosticismo, abbraccia tutte le minori tendenze non «materialistiche volgari», fino a quella freudiana del De Man.
Perché il Labriola non ha avuto fortuna nella pubblicistica socialdemocratica?
Si può dire a proposito della filosofia del marxismo ciò che la Luxemburg dice a proposito dell’economia: nel periodo romantico della lotta, dello Sturm und Drang popolare, si appunta tutto l’interesse sulle armi più immediate, sui problemi di tattica politica. Ma dal momento che esiste un nuovo tipo di Stato, nasce concretamente il problema di una nuova civiltà e quindi la necessità di elaborare le concezioni più generali, le armi più raffinate e decisive. Ecco che Labriola deve essere rimesso in circolazione e la sua impostazione del problema filosofico deve essere fatta predominare. Questa è una lotta per la cultura superiore, la parte positiva della lotta per la cultura che si manifesta in forma negativa e polemica con gli a‑ privativi e gli anti‑ (anticlericalismo, ateismo ecc.). Questa è la forma moderna del laicismo tradizionale che è alla base del nuovo tipo di Stato.
La trattazione analitica e sistematica della concezione del Labriola potrebbe essere la sezione filosofica della rivista tipo «Voce» ‑ «Leonardo» («Leonardo») e potrebbe alimentare la rubrica almeno per sei mesi o un anno. Bisognerebbe inoltre compilare una bibliografia «internazionale» sul Labriola («Neue Zeit» ecc.).
Argomenti di cultura. Su Andrea Costa: raccolta dei suoi Proclami e manifesti del primo periodo di attività romagnola: raccolta critica, con annotazioni e commenti storici e politici.
Q3 §32 «Rendre la vie impossible». «Il y a deux façons de tuer: une, que l’on désigne franchement par le verbe tuer; l’autre, celle qui reste sous‑entendue d’habitude derrière cet euphémisme délicat: “rendre la vie impossible”. C’est le mode d’assassinat, lent et obscur, que consomme une foule d’invisibles complices. C’est un “auto‑da‑fé” sans “coroza” et sans flammes, perpétré par une Inquisition sans juge ni sentence...» Eugenio D’Ors, La vie de Goya, éd. Gallimard, p. 41. Altrove la chiama «Inquisizione diffusa».
Q3 §33 Alcune cause d’errore. Un governo, o un uomo politico, o un gruppo sociale applica una disposizione politica od economica. Se ne trae troppo facilmente delle conclusioni generali d’interpretazione della realtà presente e di previsione sullo sviluppo di questa realtà. Non si tiene abbastanza conto del fatto che la disposizione applicata, l’iniziativa promossa ecc. può essere dovuta a un errore di calcolo, e quindi non rappresentare nessuna «concreta attività storica». Nella vita storica come nella vita biologica, accanto ai nati vivi, ci sono gli aborti. Storia e politica sono strettamente unite, sono anzi la stessa cosa, ma pure occorre distinguere nell’apprezzamento dei fatti storici e dei fatti e atti politici.
Nella storia, data la sua larga prospettiva verso il passato e dato che i risultati stessi delle iniziative sono un documento della vitalità storica, si commettono meno errori che nell’apprezzamento dei fatti e degli atti politici in corso. Il grande politico perciò non può che essere «coltissimo», cioè deve «conoscere» il massimo di elementi della vita attuale; conoscerli non «librescamente», come «erudizione» ma in modo «vivente», come sostanza concreta di «intuizione» politica (tuttavia perché in lui diventino sostanza vivente di «intuizione» occorrerà apprenderli anche «librescamente»).
Q3 §34 Passato e presente. L’aspetto della crisi moderna che viene lamentato come «ondata di materialismo» è collegato con ciò che si chiama «crisi di autorità». Se la classe dominante ha perduto il consenso, cioè non è più «dirigente», ma unicamente «dominante», detentrice della pura forza coercitiva, ciò appunto significa che le grandi masse si sono staccate dalle ideologie tradizionali, non credono più a ciò in cui prima credevano ecc. La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati.
A questo paragrafo devono essere collegate alcune osservazioni fatte sulla così detta «quistione dei giovani» determinata dalla «crisi di autorità» delle vecchie generazioni dirigenti e dal meccanico impedimento posto a chi potrebbe dirigere di svolgere la sua missione. Il problema è questo: una rottura così grave tra masse popolari e ideologie dominanti come quella che si è verificata nel dopoguerra, può essere «guarita» col puro esercizio della forza che impedisce a nuove ideologie di imporsi? L’interregno, la crisi di cui si impedisce così la soluzione storicamente normale, si risolverà necessariamente a favore di una restaurazione del vecchio? Dato il carattere delle ideologie, ciò è da escludere, ma non in senso assoluto. Intanto la depressione fisica porterà a lungo andare a uno scetticismo diffuso e nascerà una nuova «combinazione» in cui per es. il cattolicismo diventerà ancora di più prettogesuitismo ecc. Anche da questo si può concludere che si formano le condizioni più favorevoli per un’espansione inaudita del materialismo storico. La stessa povertà iniziale che il materialismo storico non può non avere come teoria diffusa di massa, lo renderà più espansivo. La morte delle vecchie ideologie si verifica come scetticismo verso tutte le teorie e le formule generali e applicazione al puro fatto economico (guadagno ecc.) e alla politica non solo realista di fatto (come è sempre) ma cinica nella sua manifestazione immediata (ricordare la storia del Preludio al Machiavelli scritto forse sotto l’influenza del prof. Rensi che in un certo periodo – nel 21 o 22 – esaltò la schiavitù come mezzo moderno di politica economica). Ma questa riduzione all’economia e alla politica significa appunto riduzione delle superstrutture più elevate a quelle più aderenti alla struttura, cioè possibilità e necessità di formazione di una nuova cultura.
Q3 §35 Giuseppe Rensi. Occorre ricercare tutta la sua carriera politico‑intellettuale. È stato collaboratore della «Critica Sociale» (forse è stato anche fuoruscito in Isvizzera dopo il 1894 o 98). Il suo atteggiamento «moralistico» attuale (vedere i suoi articoli sulla «Nuova Rivista Storica») è da porre a confronto con le sue manifestazioni letterarie e giornalistiche del 1921‑22‑23 (articoli nel «Popolo d’Italia»). Ricordare la sua polemica col Gentile sul «Popolo d’Italia» dopo il Congresso dei filosofi tenuto a Milano nel 1926.
Q3 §36 Fatti di cultura. L’episodio Salgari, contrapposto a Giulio Verne, con l’intervento del ministro Fedele, campagne ridevoli nel «Raduno» organo del Sindacato autori e scrittori ecc., è da porre insieme alla rappresentazione della farsa Un’avventura galante ai bagni di Cernobbio data il 13 ottobre 1928 ad Alfonsine per la celebrazione del primo centenario della morte di Vincenzo Monti. Questa farsa pubblicata nel 1858 come complemento editoriale di un lavoro teatrale di Giovanni De Castro, è di un Vincenzo Monti, professore a Como in quel torno di tempo (a una semplice lettura appare l’impossibilità dell’attribuzione al Monti) ma fu «scoperta», attribuita al Monti e rappresentata ad Alfonsine, dinanzi alle autorità, in una festa ufficiale, nel centenario montiano. (Vedere, caso mai, nei giornali del tempo, l’autore della mirabile scoperta e i personaggi ufficiali che la bevettero così grossa).
Q3 §37 I nipotini di padre Bresciani. Pochissimi «scrittori» cattolici in Italia, specialmente nella poesia e nel romanzo. Gallarati Scotti (di cui ho accennato in altra nota un tratto caratteristico delle Storie dell’Amor Sacro e dell’Amor Profano, ma che tuttavia ha una sua dignità). Paolo Arcari (più noto come scrittore di saggi letterari e politici). Luciano Gennari (che ha scritto molto in lingua francese). Non è possibile fare un confronto tra gli scrittori cattolici italiani e quelli francesi (Bourget, Bazin, Mauriac, Bernanos). Il Crispolti ha scritto un romanzo Il Duello, di propaganda. In realtà, il cattolicismo italiano è sterile nel campo letterario come negli altri campi della cultura (cfr Missiroli). (Maria di Borio).
Q3 §38 I nipotini di padre Bresciani. A. Panzini: La vita di Cavour. «Uno scrittore inglese ha chiamato la storia dell’unità d’Italia la più romanzesca storia dei tempi moderni». (Il Panzini oltre a creare luoghi comuni per gli argomenti che tratta, si dà molto daffare per raccogliere tutti i luoghi comuni che sullo stesso argomento sono stati scritti da altri autori, specialmente stranieri: deve avere uno schedario speciale di luoghi comuni, per condire opportunamente tutti i suoi scritti). «Re Vittorio era nato con la spada e senza paura: due terribili baffi, un gran pizzo. Gli piacevano le belle donne e la musica del cannone. Un grande Re!»
Questo luogo comune è da unire all’altro sulla «tradizione» militare del Piemonte e della sua aristocrazia: in realtà in Piemonte è proprio mancata una «tradizione» militare cioè una «continuità» di personale militare di prim’ordine e ciò è apparso nelle guerre del Risorgimento, in cui non si è rivelata nessuna personalità, ma invece sono affiorate molte deficienze interne: in Piemonte c’era una popolazione adatta alle armi, da cui si poteva trarre un buon esercito, e apparvero di tanto in tanto delle capacità militari di primo ordine, come Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele ecc. ma mancò appunto una tradizione, una continuità nell’aristocrazia, nell’ufficialità superiore: cfr ciò che avvenne nel 48 quando non si sapeva dove metter la mano per dare un comandante all’esercito e si cascò su di un minchione qualsiasi di polacco. Le qualità guerriere di Vittorio Emanuele II consistettero solo in un certo coraggio personale, che si dovrebbe pensare essere molto raro in Italia se tanto vi si insiste su: è un po’ la stessa quistione del «galantuomismo»: in Italia si dovrebbe pensare che la stragrande maggioranza è di bricconi, se l’essere galantuomini viene elevato a titolo di distinzione. A proposito di Vittorio Emanuele II ricordare un aneddoto riferito da Ferdinando Martini nel suo libro postumo di memorie: racconta, su per giù (vedere) che Vittorio Emanuele dopo la presa di Roma disse che gli dispiaceva non ci fosse più nulla da «piè» (pigliare) e ciò a chi raccontava l’aneddoto pareva dimostrare che non ci fosse stato re più conquistatore di Vittorio Emanuele.
Si potrebbe dare dell’aneddoto tante altre spiegazioni, e non molto brillanti. Ricordare epistolario di M. D’Azeglio pubblicato dal Bollea nel «Bollettino storico subalpino»; quistioni tra Vittorio Emanuele e Quintino Sella.
Ciò che mi ha sempre stupito è che si insista tanto nelle pubblicazioni tendenti a rendere popolare la figura di Vittorio Emanuele sugli aneddoti galanti in cui alti funzionari e ufficiali andavano nelle famiglie a convincere i genitori di lasciar andare delle ragazze nel letto del re, per quattrini. A pensarci bene è stupefacente che queste cose siano pubblicate credendo di rafforzare l’amore popolare. «... il Piemonte... ha una tradizione guerriera, ha una nobiltà guerriera...». Si potrebbe osservare che Napoleone III, data la «tradizione guerriera» della sua famiglia, si occupò di scienza militare e scrisse libri che pare non fossero troppo malvagi per i suoi tempi. «Le donne? Già, le donne. Su tale argomento egli (Cavour) andava molto d’accordo col suo re, benché anche in questo ci fosse qualche differenza. Re Vittorio era di molta buona bocca come avrebbe potuto attestare la bella Rosina, che fu poi contessa di Mirafiori» e giù di questo tono fino a ricordare che i propositi galanti del re alla corte delle Tuglierì (sic) furono così audaci «che tutte le dame ne rimasero amabilmente atterrite. Quel forte, magnifico Re montanaro!». «Cavour era assai più raffinato. Cavallereschi però tutti e due e, oserei dire, romantici (!!!)». «Massimo d’Azeglio... da quel gentiluomo delicato che era...».
L’accenno del Panzini di cui parlo a p. 10 come di cosa che non si può comprendere senza aver letto il commento del «Resto del Carlino» si capisce, dopo aver riletto la seconda puntata della Vita di Cavour («Italia letteraria» del 16 giugno): questo brano: «Non ha bisogno di assumere atteggiamenti specifici. Ma in certi momenti doveva apparire meraviglioso e terribile. L’aspetto della grandezza umana è tale da indurre negli altri ubbidienza e terrore, e questa è dittatura più forte che non quella di assumere molti portafogli nei ministeri». È incredibile come una tale frase sia potuta sfuggire al Panzini ed è naturale che il «Resto del Carlino» l’abbia beccato: il Panzini nella sua lettera scrive: «Quanto a certe puntate contro la dittatura, forse fu errore fidarmi nella conoscenza storica del lettore. Cavour, nel 1859, domandò i poteri dittatori assumendo diversi portafogli, fra i quali quello della guerra, con molto scandalo della allora quasi vergine costituzionalità. Non questa materiale forma di dittatura indusse ad obbedienza, ma la dittatura dell’umana grandezza di Cavour».
«... la guerra d’Oriente, una cosa piuttosto complicata, che per chiarezza di discorso si omette». (Si afferma che Cavour è un grandissimo politico, ecc. ma l’affermazione non diventa mai rappresentazione storica concreta: per «chiarezza del discorso si omette». Il significato della spedizione nella Crimea e della capacità politica di Cavour nell’averla voluta, è omesso per «chiarezza»). Il profilo di Napoleone III è impagabile di sguaiataggine, ma non si spiega perché Napoleone abbia collaborato con Cavour. Bisognerebbe citare troppo e in fondo ne vale poco la pena. Se dovessi scrivere sull’argomento bisognerebbe però rivedere il libro (se sarà pubblicato) o l’annata della «Italia letteraria».
«Al Museo napoleonico in Roma c’è un prezioso pugnale con una lama che può passare il cuore» (non è un pugnale comune, a quanto pare!). «Può questo pugnale servire per documento? Di pugnali io non ho esperienza, ma sentii dire quello essere il pugnale carbonaro che si affidava a chi entrava nella setta tenebrosa ecc.». (Il Panzini deve sempre essere stato ossessionato dai pugnali: ricordare la «livida lama» della Lanterna di Diogene. Deve essersi trovato in Romagna per caso in qualche torbido e aver visto qualche paia d’occhi guatarlo biecamente: onde le «livide lame» che possono passare il cuore ecc.).
«E chi volesse vedere come la setta carbonara assumesse l’aspetto di Belzebù, legga il romanzo L’Ebreo di Verona di Antonio Bresciani, e si divertirà (! sic) un mondo, anche perché, a dispetto di quel che ne dicono i moderni, quel padre gesuita fu un potente narratore». (Questo brano si potrebbe porre come motto al saggio sui nipotini di padre Bresciani: è nella puntata terza della Vita di Cavour nell’«Italia letteraria» del 23 giugno 1929).
Tutta la Vita di Cavour è una beffa della storia. Se le vite romanzate sono la forma attuale della letteratura amena tipo Alessandro Dumas, Panzini è il nuovo Ponson du Terrail. Panzini vuole così ostentatamente mostrare di «saperla lunga» sul modo di procedere degli uomini, di essere un così furbissimo realista, che viene la voglia, a leggerlo, di rifugiarsi in Condorcet o in Bernardino di Saint‑Pierre, che almeno non sono così filistei. Nessun nesso storico è ricostruito nel fuoco di una personalità; la storia è un seguito di storielle divertenti senza nesso né di personalità né di altre forze sociali: è veramente una nuova forma digesuitismo, molto più accentuata di quanto io stesso avessi creduto leggendo la Vita a puntate. Si potrebbero contrapporre al luogo comune della «nobiltà guerriera e non da anticamera» i giudizi che poi si danno volta per volta sui singoli generali: La Marmora, Della Rocca, talvolta con parole di scherno incosciente. «Della Rocca è un guerriero. A Custoza, 1866, non brillerà per troppo valore, ma è un ostinato guerriero e perciò tien duro coi bollettini». (È proprio una frase da giornale umoristico tipo «Asino». Della Rocca non voleva mandare più i bollettini dello Stato Maggiore a Cavour che ne aveva notato la cattiva compilazione letteraria, alla quale collaborava il re). (Altre allusioni del genere per La Marmora e per Cialdini – anche se Cialdini non fu piemontese –, e non è detto un nome di generale piemontese che abbia brillato: altro accenno a Persano).
Non si capisce proprio cosa Panzini abbia voluto scrivere con questa Vita di Cavour; una vita di Cavour non è certamente: né una biografia di Cavour‑uomo, né una ricostruzione di Cavour politico; in verità dal libro di Panzini Cavour esce molto malconcio e molto diminuito: la sua figura non ha nessun rilievo concreto, eccetto che nelle giaculatorie che Panzini di tanto in tanto ripete: eroe, superbo, genio ecc. Ma queste giaculatorie non essendo giustificate (e perciò sono giaculatorie) sembrano talvolta prese di bavero, se non si capisse che la misura che Panzini adopera per giudicare l’eroismo, la grandezza, il genio ecc. è la sua propria misura, della genialità, grandezza, eroismo ecc. del sig. Panzini Alfredo. Ancora bisogna dire che il Panzini esagera nel trovare il dito di dio, il fato, la provvidenza in tanti avvenimenti: è, in fondo, la concezione dello stellone con parole da tragedia greca o da padre gesuita, ma che non perciò diventa meno triviale e banale. Lo stesso insistere troppo sull’elemento «provvidenziale» significa diminuire la funzione dello sforzo italiano, che pure ebbe una sua parte. Cosa significa poi in questo caso questa miracolosità della rivoluzione italiana? Significa che tra l’elemento nazionale e quello internazionale dell’evento, è l’internazionale che ha contato di più. È questo il caso? Bisognerebbe dirlo e forse la grandezza di Cavour sarebbe messa ben più in rilievo e la sua funzione personale, il suo «eroismo» apparirebbe ben più da esaltare. Ma il Panzini vuol dare colpi a molte botti con molti cerchi e non ne raccappezza qualcosa di sensato: né egli sa cosa sia una rivoluzione e quali siano i rivoluzionari. Tutti furono grandi e furono rivoluzionari ecc. ecc.
Nell’«Italia letteraria» del 2 giugno 1929 è pubblicata un’intervista di Antonio Bruers col Panzini: Come e perché Alfredo Panzini ha scritto una «Vita di Cavour»; vi si dice che egli stesso Bruers (pare che sia il Bruers che ha tradotto il Cavour di Paléologue) ha indotto Panzini a scrivere il libro, «in modo che il pubblico potesse avere finalmente un “Cavour” italiano, dopo averne avuto uno tedesco, uno inglese e uno francese». Il Panzini dice nell’intervista che la sua Vita «non è una monografia nel senso storico‑scientifico della parola; è un profilo destinato non ai dotti, agli “specialisti”, ma al vasto pubblico». Il Panzini crede che ci siano delle parti originali nel suo libro e precisamente il fatto di aver dato importanza all’attentato di Orsini per spiegare l’atteggiamento di Napoleone III: secondo il Panzini Napoleone III sarebbe stato inscritto da giovane alla Carboneria, «la quale vincolò con impegno d’onore il futuro sovrano della Francia»: Orsini, mandatario della Carboneria avrebbe ricordato a Napoleone il suo impegno e quindi ecc. (proprio un romanzo alla Ponson du Terrail: Orsini doveva essersi dimenticato della Carboneria al tempo dell’attentato già da molti anni e le sue repressioni del 48 nelle Marche erano proprio contro dei vecchi carbonari). Le ragioni dell’indulgenza di Napoleone verso Orsini (o per meglio dire alcuni suoi atteggiamenti personali, perché in ogni modo Orsini fu ghigliottinato) si spiegano forse banalmente con la paura del complice sfuggito e che poteva ritentare la prova: certo anche la grande serietà di Orsini, che non era un qualunque scalmanato, dovette imporsi. Il Panzini poi dimentica che c’era stata la guerra di Crimea e l’orientamento generale di Napoleone pro‑italiano tanto che l’attentato di Orsini sembrò spezzare la trama già ordita. Tutta la «ipotesi» del Panzini si basa poi sul famoso pugnale, che non è detto fosse della carboneria. È proprio un romanzo alla Ponson.
Q3 §39 Passato e presente. Il problema della capitale: Roma ‑ Milano. Funzione e posizione delle più grandi città: Torino ‑ Trieste ‑ Genova ‑ Bologna ‑ Firenze ‑ Napoli ‑ Palermo ‑ Bari ‑ Ancona ecc. Nella statistica industriale del 1927 e nelle pubblicazioni che ne hanno esposto i risultati, esiste una divisione di questi dati per città e per centri industriali in generale?. (L’industria tessile presenta zone industriali senza grandi città, come biellese, comasco, vicentino, ecc.). Rilievo sociale e politico della città italiana.
Questo problema è coordinato a quello delle «cento città», cioè della agglomerazione in borghi (città) della borghesia rurale, e della agglomerazione in borgate contadine di grandi masse di braccianti agricoli e di contadini senza terra dove esiste il latifondo estensivo (Puglie, Sicilia). È collegato anche al problema di quale gruppo sociale eserciti la direzione politica e intellettuale sulle grandi masse, direzione di primo grado e di secondo grado (gli intellettuali esercitano spesso una direzione di secondo grado, poiché essi stessi sono sotto l’influsso dei grandi proprietari terrieri e questi a loro volta, direttamente e indirettamente, in modo parziale o in modo totale, sono diretti dalla grande borghesia, specialmente finanziaria).
Q3 §40 Riforma e Rinascimento. Le osservazioni sparsamente fatte sulla diversa portata storica della Riforma protestante e del Rinascimento italiano, della Rivoluzione francese e del Risorgimento (la Riforma sta al Rinascimento come la Rivoluzione francese al Risorgimento) possono essere raccolte in un saggio unico con un titolo che potrebbe essere anche «Riforma e Rinascimento» e che potrebbe prendere lo spunto dalle pubblicazioni avvenute dal 20 al 25 intorno appunto a questo argomento: «della necessità che in Italia abbia luogo una riforma intellettuale e morale» legata alla critica del Risorgimento come «conquista regia» e non movimento popolare per opera di Gobetti, Missiroli e Dorso. (Ricordare l’articolo di Ansaldo nel «Lavoro» di Genova contro Dorso e contro me). Perché in questo periodo si pose questo problema? Esso scaturiva dagli avvenimenti… (Episodio comico: articoli di Mazzali in «Conscientia» di Gangale in cui si ricorreva ad Engels). Precedente storico nel saggio di Masaryk sulla Russia (nel 1925 tradotto in italiano dal Lo Gatto): il Masaryk poneva la debolezza politica del popolo russo nel fatto che in Russia non c’era stata la Riforma religiosa.
Q3 §41 I nipotini di padre Bresciani. Sarebbe certo ingiusto volere che ogni anno o anche ogni dieci anni la letteratura di un paese abbia un Promessi Sposi, o un Sepolcri ecc. ecc. Ma appunto perciò la critica che si può fare di queste epoche è una critica di «cultura», una critica di «tendenza». È vero che in certi periodi le quistioni pratiche assorbono tutte le intelligenze per la loro risoluzione (in un certo senso, tutte le forze umane vengono concentrate nel lavoro strutturale e non ancora si può parlare di superstrutture: gli americani addirittura, secondo ciò che scrive il Cambon nella prefazione alla traduzione francese dell’autobiografia di Ford, hanno creato da ciò una teoria) sicché sarebbe «poesia» cioè «creazione» solo quella economico‑pratica: ma di ciò si tratta appunto: che ci sia una creazione, in ogni caso, e d’altronde si potrebbe domandare come mai questa opera «creativa» economico‑pratica, in quanto esalta le forze vitali, le energie, le volontà, gli entusiasmi, non assuma anche forme letterarie che la celebrino. In verità ciò non avviene: le forze non sono espansive, ma puramente repressive e si badi, puramente e totalmente repressive, non solo della parte avversa, ciò che sarebbe naturale, ma della propria parte, ciò che appunto è tipico e dà a queste forze il carattere repressivo. Ogni innovazione è repressiva per i suoi avversari, ma scatena forze latenti nella società, le potenzia, le esalta, è quindi espansiva. Le restaurazioni sono universalmente repressive: creano appunto i «padri Bresciani», la letteratura allapadre Bresciani. La psicologia che ha preceduto queste innovazioni è il «panico», la paura comica di forze demoniache che non si comprendono e non si possono controllare. Il ricordo di questo «panico» perdura per lungo tempo e dirige le volontà e i sentimenti: la libertà creatrice è sparita, rimane l’astio, lo spirito di vendetta, l’accecamento balordo. Tutto diventa pratico, inconsciamente, tutto è «propaganda», è polemica, è negazione, ma in forma meschina, ristretta, gesuitica appunto.
Quando si giudica uno scrittore e si conosce solo il suo primo libro, il giudizio terrà conto dell’«età», perché giudizio di cultura: un frutto acerbo di un giovane, è un bozzacchione se di un vecchio.
Q3 §42 Passato e presente. La favola del castoro (il castoro, inseguito dai cacciatori che vogliono strappargli i testicoli da cui si estraggono dei medicinali, per salvar la vita, si strappa da se stesso i testicoli). Perché non c’è stata difesa? Scarso senso della dignità umana e della dignità politica dei partiti: ma questi elementi non sono dei dati naturali, delle deficienze proprie di un popolo in modo permanentemente caratteristico. Sono dei «fatti storici» che si spiegano con la storia passata e con le condizioni sociali presenti. Contraddizioni apparenti: dominava una concezione fatalistica e meccanica della storia (Firenze 1917, accusa di bergsonismo) e però si verificavano atteggiamenti di un volontarismo formalistico sguaiato e triviale: per es. il progetto di costituire nel 1920 un Consiglio urbano a Bologna coi soli elementi delle organizzazioni, cioè di sostituire a un organismo storico radicato nelle masse, come la Camera del Lavoro, un organismo puramente astratto e libresco. C’era almeno il fine politico di dare una egemonia all’elemento urbano, che con la costituzione del Consiglio veniva ad avere un centro proprio, dato che la Camera del Lavoro era provinciale? Questa intenzione mancava assolutamente e d’altronde il progetto non fu realizzato.
Il discorso di Treves sull’«espiazione»: questo discorso mi pare fondamentale per capire la confusione politica e il dilettantismo polemico dei leaders. Dietro a queste schermaglie c’è la paura delle responsabilità concrete, dietro a questa paura la nessuna unione con la classe rappresentata, la nessuna comprensione dei suoi bisogni fondamentali, delle sue aspirazioni, delle sue energie latenti: partito paternalistico, di piccoli borghesi che fanno le mosche cocchiere. Perché non difesa? L’idea della psicosi di guerra e che un paese civile non può «permettere» che si verifichino certe scene selvagge. Queste generalità erano anch’esse mascherature di altri motivi più profondi (d’altronde erano in contraddizione con l’affermazione ripetuta ogni volta dopo un eccidio: l’abbiamo sempre detto noi che la classe dominante è reazionaria), che sempre si incentrano nel distacco dalla classe, cioè nelle «due classi»: non si riesce a capire ciò che avverrà se la reazione trionfa, perché non si vive la lotta reale ma solo la lotta come «principio libresco».
Altra contraddizione intorno al volontarismo: se si è contro il volontarismo si dovrebbe apprezzare la «spontaneità». Invece no: ciò che era «spontaneo» era cosa inferiore, non degna di considerazione, non degna neppure di essere analizzata. In realtà, lo «spontaneo» era la prova più schiacciante dell’inettitudine del partito, perché dimostrava la scissione tra i programmi sonori e i fatti miserabili. Ma intanto i fatti «spontanei» avvenivano (1919‑1920), ledevano interessi, disturbavano posizioni acquisite, suscitavano odi terribili anche in gente pacifica, facevano uscire dalla passività strati sociali stagnanti nella putredine: creavano, appunto per la loro spontaneità e per il fatto che erano sconfessati, il «panico» generico, la «grande paura» che non potevano non concentrare le forze repressive spietate nel soffocarli.
Un documento eccezionale di questo distacco tra rappresentati e rappresentanti è costituito dal così detto patto di alleanza tra Confederazione e Partito, che può essere paragonato a un Concordato fra Stato e Chiesa. Il partito, che è in embrione una struttura statale, non può ammettere nessuna divisione dei suoi poteri politici, non può ammettere che una parte dei suoi membri si pongano come aventi eguaglianza di diritto, come alleati del «tutto», così come uno Stato non può ammettere che una parte dei suoi sudditi, oltre le leggi generali, facciano con lo Stato cui appartengono, e attraverso una potenza straniera, un contratto speciale di convivenza con lo Stato stesso. L’ammissione di una tale situazione implica la subordinazione di fatto e di diritto dello Stato e del Partito alla cosidetta «maggioranza» dei rappresentati, in realtà a un gruppo che si pone come antistato e antipartito e che finisce con l’esercitare indirettamente il potere. Nel caso del patto d’alleanza apparve chiaro che il potere non apparteneva al partito.
Al patto d’alleanza corrispondevano gli strani legami tra partito e gruppo parlamentare, anch’essi d’alleanza e di parità di diritto. Questo sistema di rapporti faceva sì che concretamente il partito non esistesse come organismo indipendente, ma solo come elemento costitutivo di un organismo più complesso che aveva tutti i caratteri di un partito del lavoro, discentrato, senza volontà unitaria ecc. Dunque i sindacati devono essere subordinati al partito? Porre così la quistione sarebbe errato. La quistione deve essere impostata così: ogni membro del partito, qualsiasi posizione o carica occupi, è sempre un membro del partito ed è subordinato alla sua direzione. Non ci può essere subordinazione tra sindacato e partito, se il sindacato ha spontaneamente scelto come suo dirigente un membro del partito: significa che il sindacato accetta liberamente le direttive del partito e quindi ne accetta liberamente (anzi ne desidera) il controllo sui suoi funzionari.
Questa quistione non fu impostata giustamente nel 1919, quantunque esistesse un grande precedente istruttivo, quello del giugno 1914: perché in realtà non esisteva una politica delle frazioni, cioè una politica del partito.
Q3 §43 Passato e presente. Un episodio piuttosto oscuro, per non dire losco, è costituito dai rapporti dei riformisti con la plutocrazia: la «Critica Sociale» amministrata da Bemporad, cioè dalla Banca Commerciale (Bemporad era anche l’editore dei libri politici di Nitti), l’entrata dell’ingegnere Omodeo nel circolo di Turati, il discorso di Turati Rifare l’Italia! sulla base dell’industria elettrica e dei bacini montani, discorso suggerito e forse scritto in collaborazione con l’Omodeo.
Q3 §44 Passato e presente. A questo saggio appartengono le osservazioni altrove scritte sui tipi «strani» che circolavano nel partito e nel movimento operaio: Ciccotti-Scozzese, Gatto‑Roissard ecc. Nessuna politica interna di partito, nessuna politica organizzativa, nessun controllo sugli uomini. Però abbondante demagogia contro gli interventisti anche se stati interventisti da giovanissimi. La mozione per cui si stabiliva che gli interventisti non potevano essere ammessi nel partito fu solo un mezzo di ricatto e di intimidazione individuale e una affermazione demagogica. Infatti non impedì a Nenni di essere ammesso nonostante il suo losco passato (così a Francesco Leonida Rèpaci)), mentre servì a falsificare la posizione politica del partito che non doveva fare dell’antinterventismo il perno della sua attività e a scatenare odio e persecuzioni personali contro determinate categorie piccolo borghesi. (Leonida Rèpaci) diventò corrispondente del giornale da Torino come Nenni ne diventò redattore, quindi non si tratta di gente entrata di straforo).
Il discorso dell’«espiazione» di Treves e la fissazione dell’interventismo sono strettamente legati: è la politica di evitare il problema fondamentale, il problema del potere, e di deviare l’attenzione e le passioni delle masse su obiettivi secondari, di nascondere ipocritamente la responsabilità storico‑politica della classe dominante, riversando le ire popolari sugli strumenti materiali e spesso inconsapevoli della politica della classe dominante: continuava, in fondo, una politica giolittiana. A questa stessa tendenza appartiene l’articolo Carabinieri reali di Italo Toscani: il cane che morde il sasso e non la mano che lo lancia. Il Toscani è finito poi scrittore cattolico di destra nel «Corriere d’Italia». Era evidente che la guerra, con l’enorme sconvolgimento economico e psicologico che aveva determinato specialmente tra i piccoli intellettuali e i piccoli borghesi, avrebbe radicalizzati questi strati. Il partito se li rese nemici gratis, invece di renderseli alleati, cioè li ributtò verso la classe dominante.
Funzione della guerra negli altri paesi per selezionare i capi del movimento operaio e per determinare la precipitazione delle tendenze di destra. In Italia questa funzione non fu svolta dalla guerra (giolittismo), ma avvenne posteriormente in modo ben più catastrofico e con fenomeni di tradimento in massa e di diserzione quali non si erano visti in nessun altro paese.
Q3 §45 Passato e presente. La debolezza teorica, la nessuna stratificazione e continuità storica della tendenza di sinistra, sono state una delle cause della catastrofe. Per indicare il livello culturale si può citare il fatto di Abbo al Congresso di Livorno: quando manca un’attività culturale del partito, i singoli si fanno la cultura come possono e aiutando il vago del concetto di sovversivo, avviene appunto che un Abbo impari a memoria le scempiaggini di un individualista.
Q3 §46 Passato e presente. Il concetto prettamente italiano di «sovversivo» può essere spiegato così: una posizione negativa e non positiva di classe: il «popolo» sente che ha dei nemici e li individua solo empiricamente nei così detti signori (nel concetto di «signore» c’è molto della vecchia avversione della campagna per la città, e il vestito è un elemento fondamentale di distinzione: c’è anche l’avversione contro la burocrazia, in cui si vede unicamente lo Stato: il contadino – anche il medio proprietario – odia il «funzionario» non lo Stato, che non capisce, e per lui è questo il «signore» anche se economicamente il contadino gli è superiore, onde l’apparente contraddizione per cui per il contadino il signore è spesso un «morto di fame»).
Questo odio «generico» è ancora di tipo «semifeudale», non moderno, e non può essere portato come documento di coscienza di classe: ne è appena il primo barlume, è solo, appunto, la posizione negativa e polemica elementare: non solo non si ha coscienza esatta della propria personalità storica, ma non si ha neanche coscienza della personalità storica e dei limiti precisi del proprio avversario. (Le classi inferiori, essendo storicamente sulla difensiva, non possono acquistare coscienza di sé che per negazioni, attraverso la coscienza della personalità e dei limiti di classe dell’avversario: ma appunto questo processo è ancora crepuscolare, almeno su scala nazionale).
Un altro elemento per comprendere il concetto di «sovversivo» è quello dello strato noto con l’espressione tipica dei «morti di fame». I «morti di fame» non sono uno strato omogeneo, e si possono commettere gravi errori nella loro identificazione astratta. Nel villaggio e nei piccoli centri urbani di certe regioni agricole esistono due strati distinti di «morti di fame»: uno è quello dei «giornalieri agricoli», l’altro quello dei piccoli intellettuali. Questi giornalieri non hanno come caratteristica fondamentale la loro situazione economica, ma la loro condizione intellettuale‑morale: essi sono ubbriaconi, incapaci di laboriosità continuata e senza spirito di risparmio e quindi spesso biologicamente tarati o per denutrizione cronica o per mezza idiozia e scimunitaggine. Il contadino tipico di queste regioni è il piccolo proprietario o il mezzadro primitivo (che paga l’affitto con la metà, il terzo o anche i due terzi del raccolto secondo la fertilità e la posizione del fondo), che possiede qualche strumento di lavoro, il giogo di buoi e la casetta che spesso si è fabbricato egli stesso nelle giornate non lavorative, e che si è procurato il capitale necessario o con qualche anno di emigrazione, o andando a lavorare in «miniera», o con qualche anno di servizio nei carabinieri ecc., o facendo qualche anno il domestico di un grande proprietario, cioè «industriandosi» e risparmiando. Il «giornaliero» invece non ha saputo o voluto industriarsi e non possiede nulla, è un «morto di fame», perché il lavoro a giornata è scarso e saltuario: è un semimendicante, che vive di ripieghi e rasenta la malavita rurale.
Il «morto di fame» piccolo borghese è originato dalla borghesia rurale, la proprietà si spezzetta in famiglie numerose e finisce con l’essere liquidata, ma gli elementi della classe non vogliono lavorare manualmente: così si forma uno strato famelico di aspiranti a piccoli impieghi municipali, di scrivani, di commissionari, ecc. ecc. Questo strato è un elemento perturbatore nella vita delle campagne, sempre avido di cambiamenti (elezioni ecc.) e dà il «sovversivo» locale e poiché è abbastanza diffuso, ha una certa importanza: esso si allea specialmente alla borghesia rurale contro i contadini, organizzando ai suoi servizi anche i «giornalieri morti di fame». In ogni regione esistono questi strati, che hanno propaggini anche nelle città, dove confluiscono con la malavita professionale e con la malavita fluttuante. Molti piccoli impiegati delle città derivano socialmente da questi strati e ne conservano la psicologia arrogante del nobile decaduto, del proprietario che è costretto a penare col lavoro. Il «sovversivismo» di questi strati ha due facce: verso sinistra e verso destra, ma il volto sinistro è un mezzo di ricatto: essi vanno sempre a destra nei momenti decisivi e il loro «coraggio» disperato preferisce sempre avere i carabinieri come alleati.
Un altro elemento da esaminare è il così detto «internazionalismo» del popolo italiano. Esso è correlativo al concetto di «sovversivismo». Si tratta in realtà di un vago «cosmopolitismo» legato a elementi storici ben precisabili: al cosmopolitismo e universalismo medioevale e cattolico, che aveva la sua sede in Italia e che si è conservato per l’assenza di una «storia politica e nazionale» italiana. Scarso spirito nazionale e statale in senso moderno. Altrove ho notato che è però esistito ed esiste un particolare sciovinismo italiano, più diffuso di quanto non pare. Le due osservazioni non sono contradditorie: in Italia l’unità politica, territoriale, nazionale ha una scarsa tradizione (o forse nessuna tradizione), perché prima del 1870 l’Italia non è mai stata un corpo unito e anche il nome Italia, che al tempo dei Romani indicava l’Italia meridionale e centrale fino alla Magra e al Rubicone, nel Medioevo perdette terreno di fronte al nome Longobardia (vedere lo studio di C. Cipolla sul nome «Italia» pubblicato negli Atti dell’Accademia di Torino). L’Italia ebbe e conservò però una tradizione culturale che non risale all’antichità classica, ma al periodo dal Trecento al Seicento e che fu ricollegata all’età classica dall’Umanesimo e dal Rinascimento. Questa unità culturale fu la base molto debole invero del Risorgimento e dell’unità per accentrare intorno alla borghesia gli strati più attivi e intelligenti della popolazione, ed è ancora il sostrato del nazionalismo popolare: per l’assenza in questo sentimento dell’elemento politico‑militare e politico‑economico, cioè degli elementi che sono alla base della psicologia nazionalista francese o tedesca o americana, avviene che molti così detti «sovversivi» e «internazionalisti» siano «sciovinisti» in questo senso, senza credere di essere in contraddizione.
Ciò che è da notarsi, per capire la virulenza che assume talvolta questo sciovinismo culturale, è questo: che in Italia una maggior fioritura scientifica, artistica, letteraria ha coinciso col periodo di decadenza politica, militare, statale (Cinquecento‑Seicento). (Spiegare questo fenomeno: cultura aulica, cortigiana, cioè quando la borghesia dei comuni era in decadenza, e la ricchezza da produttiva era diventata usuraria, con concentrazioni di «lusso», preludio alla completa decadenza economica).
I concetti di rivoluzionario e di internazionalista, nel senso moderno della parola, sono correlativi al concetto preciso di Stato e di classe: scarsa comprensione dello Stato significa scarsa coscienza di classe (comprensione dello Stato esiste non solo quando lo si difende, ma anche quando lo si attacca per rovesciarlo), quindi scarsa efficienza dei partiti ecc. Bande zingaresche, nomadismo politico non sono fatti pericolosi e così non erano pericolosi il sovversivismo e l’internazionalismo italiano.
Tutte queste osservazioni non possono essere, naturalmente, categoriche e assolute: esse servono a tentare di descrivere certi aspetti di una situazione, per valutate meglio l’attività svolta per modificarla (o la non attività, cioè la non comprensione dei propri compiti) e per dare maggior risalto ai gruppi che da questa situazione emergevano per averla capita e modificata nel loro ambito. il «sovversivismo» popolare è correlativo al «sovversivismo» dall’alto, cioè al non essere mai esistito un «dominio della legge», ma solo una politica di arbitrii e di cricca personale o di gruppo.
Q3 §47 La scienza della politica e i positivisti. La politica non è che una determinata «fenomenologia» della delinquenza, è la «delinquenza settaria»: questo mi pare il succo del libro di Scipio Sighele, Morale privata e Morale politica, Nuova edizione de La delinquenza settaria riveduta ed aumentata dall’autore, Milano, Treves, 1913 (con in appendice riprodotto l’opuscolo Contro il parlamentarismo). Può servire come «fonte» per vedere come i positivisti intendevano la «politica», sebbene sia superficiale, prolisso e sconnesso. La bibliografia è compilata senza metodo, senza precisione e senza necessità (se un autore è citato nel libro per un’affermazione incidentale, nella bibliografia è riportato il libro da cui è presa la citazione). Il libro può servire come elemento per comprendere i rapporti che sono esistiti nel decennio 1890‑1900 tra gli intellettuali socialisti e i positivisti della scuola lombrosiana, ossessionati dal problema della criminalità, tanto da farne una concezione del mondo o quasi (cadevano in una strana forma di «moralismo» astratto, poiché il bene e il male era qualcosa di trascendente e di dogmatico, che in concreto coincideva con la morale del «popolo», del «senso comune»). Il libro del Sighele deve essere stato recensito da Guglielmo Ferrero, perché nella bibliografia è citato un articolo del Ferrero Morale individuale e morale politica nella «Riforma Sociale», anno I, n. XI‑XII. Libro di Ferri: Socialismo e criminalità; di Turati: Il delitto e la questione sociale. Vedere bibliografia di Lombroso, Ferri, Garofalo (antisocialista), Ferrero, e altri da ricercare.
L’opuscolo contro il parlamentarismo è anch’esso superficialissimo e senza sugo: può essere citato come una curiosità dati i tempi in cui fu scritto: è tutto imperniato sul concetto che le grandi assemblee, i collegi sono organismi tecnicamente inferiori al comando unico o di pochi, come se questa fosse la quistione principale. E pensare che il Sighele era un democratico e che appunto per ciò si staccò a un certo punto dal movimento nazionalista. In ogni caso forse è da collegare questo opuscolo del Sighele alle concezioni «organiche» del Comte.
Q3 §48 Passato e presente. Spontaneità e direzione consapevole. Dell’espressione «spontaneità» si possono dare diverse definizioni, perché il fenomeno cui essa si riferisce è multilaterale. Intanto occorre rilevare che non esiste nella storia la «pura» spontaneità: essa coinciderebbe con la «pura» meccanicità. Nel movimento «più spontaneo» gli elementi di «direzione consapevole» sono semplicemente incontrollabili, non hanno lasciato documento accertabile. Si può dire che l’elemento della spontaneità è perciò caratteristico della «storia delle classi subalterne» e anzi degli elementi più marginali e periferici di queste classi, che non hanno raggiunto la coscienza della classe «per sé» e che perciò non sospettano neanche che la loro storia possa avere una qualsiasi importanza e che abbia un qualsiasi valore lasciarne tracce documentarie.
Esiste dunque una «molteplicità» di elementi di «direzione consapevole» in questi movimenti, ma nessuno di essi è predominante, o sorpassa il livello della «scienza popolare» di un determinato strato sociale, del «senso comune» ossia della concezione del mondo tradizionale di quel determinato strato.
È appunto questo l’elemento che il De Man, empiricamente, contrappone al marxismo, senza accorgersi (apparentemente) di cadere nella stessa posizione di coloro che avendo descritto il folklore, la stregoneria ecc. e avendo dimostrato che questi modi di vedere hanno una radice storicamente gagliarda e sono abbarbicati tenacemente alla psicologia di determinati strati popolari, credesse di aver «superato» la scienza moderna e prendesse come «scienza moderna» gli articolucci dei giornali scientifici per il popolo e le pubblicazioni a dispense; è questo un vero caso di teratologia intellettuale, di cui si hanno altri esempi: gli ammiratori del folklore appunto, che ne sostengono la conservazione, gli «stregonisti» legati al Maeterlinck che ritengono si debba riprendere il filo dell’alchimia e della stregoneria, strappato dalla violenza, per rimettere la scienza su un binario più fecondo di scoperte ecc. Tuttavia il De Man ha un merito incidentale: dimostra la necessità di studiare ed elaborare gli elementi della psicologia popolare, storicamente e non sociologicamente, attivamente (cioè per trasformarli, educandoli, in una mentalità moderna) e non descrittivamente come egli fa; ma questa necessità era per lo meno implicita (forse anche esplicitamente dichiarata) nella dottrina di Iliˇc, cosa che il De Man ignora completamente.
Che in ogni movimento «spontaneo» ci sia un elemento primitivo di direzione consapevole, di disciplina, è dimostrato indirettamente dal fatto che esistono delle correnti e dei gruppi che sostengono la spontaneità come metodo. A questo proposito occorre fare una distinzione tra elementi puramente «ideologici», ed elementi d’azione pratica, tra studiosi che sostengono la spontaneità come «metodo» immanente ed obbiettivo del divenire storico e politicanti che la sostengono come metodo «politico». Nei primi si tratta di una concezione errata, nei secondi si tratta di una contraddizione immediata e meschina che lascia vedete l’origine pratica evidente, cioè la volontà immediata di sostituire una determinata direzione a un’altra. Anche negli studiosi l’errore ha un’origine pratica, ma non immediata come nei secondi. L’apoliticismo dei sindacalisti francesi dell’anteguerra conteneva ambedue questi elementi: era un errore teorico e una contraddizione (c’era l’elemento «soreliano» e l’elemento della concorrenza tra la tendenza politica anarchico‑sindacalista e la corrente socialistica). Essa era ancora la conseguenza dei terribili fatti parigini del 71: la continuazione, con metodi nuovi e con una brillante teoria, della passività trentennale (1870‑1900) degli operai francesi. La lotta puramente «economica» non era fatta per dispiacere alla classe dominante, tutt’altro. Così dicasi del movimento catalano, che se «dispiaceva» alla classe dominante spagnola, era solo per il fatto che obbiettivamente rafforzava il separatismo repubblicano catalano, dando luogo a un vero e proprio blocco industriale repubblicano contro i latifondisti, la piccola borghesia e l’esercito monarchici.
Il movimento torinese fu accusato contemporaneamente di essere «spontaneista» e «volontarista» o bergsoniano (!). L’accusa contradditoria, analizzata, mostra la fecondità e la giustezza della direzione impressagli. Questa direzione non era «astratta», non consisteva nel ripetere meccanicamente delle formule scientifiche o teoriche: non confondeva la politica, l’azione reale con la disquisizione teoretica; essa si applicava ad uomini reali, formatisi in determinati rapporti storici, con determinati sentimenti, modi di vedere, frammenti di concezioni del mondo ecc., che risultavano dalle combinazioni «spontanee» di un dato ambiente di produzione materiale, con il «casuale» agglomerarsi in esso di elementi sociali disparati. Questo elemento di «spontaneità» non fu trascurato e tanto meno disprezzato: fu educato, fu indirizzato, fu purificato da tutto ciò che di estraneo poteva inquinarlo, per renderlo omogeneo, ma in modo vivente, storicamente efficiente, con la teoria moderna. Si parlava dagli stessi dirigenti di «spontaneità» del movimento; era giusto che se ne parlasse: questa affermazione era uno stimolante, un energetico, un elemento di unificazione in profondità, era più di tutto la negazione che si trattasse di qualcosa di arbitrario, di avventuroso, di artefatto e non di storicamente necessario. Dava alla massa una coscienza «teoretica», di creatrice di valori storici ed istituzionali, di fondatrice di Stati.
Questa unità della «spontaneità» e della «direzione consapevole», ossia della «disciplina» è appunto la azione politica reale delle classi subalterne, in quanto politica di massa e non semplice avventura di gruppi che si richiamano alla massa. Si presenta una quistione teorica fondamentale, a questo proposito: la teoria moderna può essere in opposizione con i sentimenti «spontanei» delle masse? («spontanei» nel senso che non dovuti a un’attività educatrice sistematica da parte di un gruppo dirigente già consapevole, ma formatosi attraverso l’esperienza quotidiana illuminata dal «senso comune» cioè dalla concezione tradizionale popolare del mondo, quello che molto pedestremente si chiama «istinto» e non è anch’esso che un’acquisizione storica primitiva ed elementare). Non può essere in opposizione: tra di essi c’è differenza «quantitativa», di grado, non di qualità: deve essere possibile una «riduzione», per così dire, reciproca, un passaggio dagli uni all’altra e viceversa. (Ricordare che E. Kant ci teneva a che le sue teorie filosofiche fossero d’accordo col senso comune; la stessa posizione si verifica nel Croce: ricordare l’affermazione di Marx nella Sacra famiglia che le formule della politica francese della Rivoluzione si riducono ai principii della filosofia classica tedesca).
Trascurare e peggio disprezzare i movimenti così detti «spontanei», cioè rinunziare a dar loro una direzione consapevole, ad elevarli ad un piano superiore inserendoli nella politica, può avere spesso conseguenze molto serie e gravi. Avviene quasi sempre che a un movimento «spontaneo» delle classi subalterne si accompagna un movimento reazionario della destra della classe dominante, per motivi concomitanti: una crisi economica, per esempio, determina malcontento nelle classi subalterne e movimenti spontanei di massa da una parte, e dall’altra determina complotti dei gruppi reazionari che approfittano dell’indebolimento obbiettivo del governo per tentare dei colpi di Stato. Tra le cause efficienti di questi colpi di Stato è da porre la rinunzia dei gruppi responsabili a dare una direzione consapevole ai moti spontanei e a farli diventare quindi un fattore politico positivo. Esempio dei Vespri siciliani e discussioni degli storici per accertare se si trattò di movimento spontaneo o di movimento concertato: mi pare che i due elementi si siano combinati nei Vespri siciliani, la insurrezione spontanea del popolo siciliano contro i provenzali, estesasi rapidamente tanto da dare l’impressione della simultaneità e quindi del concerto esistente, per l’oppressione diventata ormai intollerabile su tutta l’area nazionale, e l’elemento consapevole di varia importanza ed efficienza, con il prevalere della congiura di Giovanni da Procida con gli Aragonesi. Altri esempi si possono trarre da tutte le rivoluzioni passate in cui le classi subalterne erano parecchie, e gerarchizzate dalla posizione economica e dall’omogeneità. I movimenti «spontanei» degli strati popolari più vasti rendono possibile l’avvento al potere della classe subalterna più progredita per l’indebolimento obbiettivo dello Stato. Questo è ancora un esempio «progressivo», ma sono, nel mondo moderno, più frequenti gli esempi regressivi.
La concezione storico‑politica scolastica e accademica, per cui è reale e degno solo quel moto che è consapevole al cento per cento e che anzi è determinato da un piano minutamente tracciato in antecedenza o che corrisponde (ciò che è lo stesso) alla teoria astratta. Ma la realtà è ricca delle combinazioni più bizzarre ed è il teorico che deve in questa bizzarria rintracciare la riprova della sua teoria, «tradurre» in linguaggio teorico gli elementi della vita storica, e non viceversa la realtà presentarsi secondo lo schema astratto. Questo non avverrà mai e quindi questa concezione non è che una espressione di passività. (Leonardo sapeva trovare il numero in tutte le manifestazioni della vita cosmica, anche quando gli occhi profani non vedevano che arbitrio e disordine).
Q3 §49 Argomenti di cultura. Materiale ideologico. Uno studio di come è organizzata di fatto la struttura ideologica di una classe dominante: cioè l’organizzazione materiale intesa a mantenere, a difendere e a sviluppare il «fronte» teorico o ideologico. La parte più ragguardevole e più dinamica di esso è la stampa in generale: case editrici (che hanno implicito ed esplicito un programma e si appoggiano a una determinata corrente), giornali politici, riviste di ogni genere, scientifiche, letterarie, filologiche, di divulgazione ecc., periodici vari fino ai bollettini parrocchiali. Sarebbe mastodontico un tale studio se fatto su scala nazionale: perciò si potrebbe fare per una città o per una serie di città una serie di studi. Un capocronista di quotidiano dovrebbe avere questo studio come traccia generale per il suo lavoro, anzi dovrebbe rifarselo per conto proprio: quanti bellissimi capicronaca si potrebbero scrivere sull’argomento!
La stampa è la parte più dinamica di questa struttura ideologica, ma non la sola: tutto ciò che influisce o può influire sull’opinione pubblica direttamente o indirettamente le appartiene: le biblioteche, le scuole, i circoli e clubs di vario genere, fino all’architettura, alla disposizione delle vie e ai nomi di queste. Non si spiegherebbe la posizione conservata dalla Chiesa nella società moderna, se non si conoscessero gli sforzi diuturni e pazienti che essa fa per sviluppare continuamente la sua particolare sezione di questa struttura materiale dell’ideologia. Un tale studio, fatto seriamente, avrebbe una certa importanza: oltre a dare un modello storico vivente di una tale struttura, abituerebbe a un calcolo più cauto ed esatto delle forze agenti nella società. Cosa si può contrapporre, da parte di una classe innovatrice, a questo complesso formidabile di trincee e fortificazioni della classe dominante? Lo spirito di scissione, cioè il progressivo acquisto della coscienza della propria personalità storica, spirito di scissione che deve tendere ad allargarsi dalla classe protagonista alle classi alleate potenziali: tutto ciò domanda un complesso lavoro ideologico, la prima condizione del quale è l’esatta conoscenza del campo da svuotare del suo elemento di massa umana.
Q3 §50 Concordato. Il padre L. Taparelli nel suo libro Esame critico degli ordini rappresentativi così definisce i concordati: «... sono convenzioni fra due autorità governanti una medesima nazione cattolica». Quando si stabilisce una convenzione, hanno per lo meno uguale importanza giuridica le interpretazioni della convenzione stessa che ne danno le due parti.
Q3 §51 Passato e presente. Inizio del 18 brumaio di Luigi Napoleone: il detto di Hegel che nella storia ogni fatto si ripete due volte: correzione di Marx che la prima volta il fatto si verifica come tragedia, la seconda volta come farsa. Questo concetto era già stato adombrato nel Contributo alla critica della filosofia del diritto: «Gli dei greci, tragicamente feriti a morte una prima volta nel Prometeo incatenato di Eschilo, subirono una seconda morte, la morte comica, nei dialoghi di Luciano. Perché questo cammino della storia? Affinché l’umanità si separi con gioia dal suo passato». («E questo gioioso destino storico noi lo rivendichiamo per le potenze politiche della Germania», ecc.).
Q3 §52 Le pilori de la vertu. Potrebbe diventare una bellissima rubrica di cronaca (o anche di terza pagina), se fatta con garbo, con arguzia e con leggero tocco di mano. Ricollegarla alle dottrine «criminaliste» esposte da Eugenio Sue nei Misteri di Parigi, per cui alla giustizia punitiva e a tutte le sue espressioni concrete si contrappone, per completarla, una giustizia rimuneratrice. «Juste en face de l’échafaud se dresse un pavois où monte le grand homme de bien. C’est le pilori de la vertu». (Cfr La Sacra Famiglia).
Q3 §53 Passato e presente. Influsso del romanticismo francese d’appendice. Tante volte mi sono riferito a questa «fonte di cultura» per spiegare certe manifestazioni intellettuali subalterne (ricordare l’uomo dei cessi inglesi e carielli meccanici). La tesi potrebbe essere svolta con una certa compiutezza e con riferimenti più larghi. Le «proposizioni» economico‑sociali di Eugenio Sue sono legate a certe tendenze del Saint‑Simonismo, cui si collegano anche le teorie sullo Stato organico e il positivismo filosofico. il Saint‑Simonismo ha avuto una sua diffusione popolare anche in Italia, direttamente (esistono pubblicazioni in proposito che dovranno essere consultate) e indirettamente attraverso i romanzi popolari che raccoglievano opinioni più o meno legate al Saint‑Simonismo, attraverso Louis Blanc ecc. come i romanzi di Eugenio Sue.
Ciò serve anche a mostrare come la situazione politica e intellettuale del paese era così arretrata che si ponevano gli stessi problemi che nella Francia del 48 e che i rappresentanti di questi problemi erano elementi sociali molto somiglianti a quelli francesi d’allora: bohème – piccoli intellettuali venuti dalla provincia ecc. (cfr sempre la Sacra famiglia nei capitoli «Révélation des mystères d’Economie politique»). Il principe Rodolfo è nuovamente assunto a regolatore della società, ma è un principe Rodolfo venuto dal popolo, quindi ancor più romantico (Nel ms seguono due parole rese illeggibili da G.), (d’altronde non si sa se nel tempo dei tempi non ci sia una casa principesca nel suo pedigree).
Q3 §54 Emilio Bodrero. Ramo aristocratico o nazionalistico del lorianismo. Il Bodrero è professore di università, credo di materia filosofica, sebbene non sia per nulla filosofo e neppure filologo o erudito della filosofia. Apparteneva al gruppo ardigoiano. Sottosegretario all’istruzione pubblica con Fedele, cioè in una gestione della Minerva che è stata molto criticata dagli stessi elementi più spregiudicati del partito al potere. Il Bodrero è, specificamente, autore di una circolare in cui si afferma che l’educazione religiosa è il coronamento dell’istruzione pubblica, che ha servito ai clericali per muovere all’assedio sistematico dell’organismo scolastico e che è diventata per i loro pubblicisti, l’argomentazione polemica decisiva (esposizione nell’opuscolo di Ignotus, il quale però deve ipocritamente tacere che la stessa affermazione è nel concordato).
Articolo del Bodrero Itaca Italia nella «Gerarchia» del giugno 1930: stupefacente. Per il Bodrero l’Odissea è «il poema della controrivoluzione», un parallelo tra il dopo guerra troiano ‑greco e il dopoguerra 19‑20 degno di un nuovo Bertoldo. I Proci sono... gli imboscati. Penelope è... la democrazia liberale. Il fatto che i Proci saccheggiano la dispensa di Ulisse, ne stuprano le ancelle e cercano di prendergli la moglie è una... rivoluzione. Ulisse è il... combattentismo. I Feaci sono l’Olanda o la Spagna neutrali che si arricchiscono sui sacrifizi altrui ecc. Ci sono poi delle proposizioni di metodo filologico: chi ha fatto la guerra e ha conosciuto il dopoguerra non può sostenere con sicurezza che l’Iliade e l’Odissea sono di un solo autore e sono unitarie in tutta la loro struttura (anche questa è una variazione della teoria della voce del sangue come origine e mezzo della conoscenza). Si potrebbe osservare, comicamente, che proprio Ulisse è il tipo del renitente alla leva e del simulatore di pazzia!.
Q3 §55 Passato e presente. Otto Kahn. Suo viaggio in Europa nel 1924. Sue dichiarazioni a proposito del regime italiano e di quello inglese di Mac Donald. Analoghe dichiarazioni di Paul Warburg (Otto Kahn e Paul Warburg appartengono ambedue alla grande firma americana Kuhn-Loeb et C°.), di Judge Gary, dei delegati della Camera di Commercio americana e di altri grandi finanzieri. Simpatie della grande finanza internazionale per il regime inglese e italiano. Come si spiega nel quadro dell’espansionismo mondiale degli Stati Uniti. La sicurezza dei capitali americani all’estero: intanto non azioni ma obbligazioni. Altre garanzie non puramente commerciali ma politiche per il trattato sui debiti concluso da Volpi (vedere atti parlamentari, perché nei giornali certe «minuzie» non furono pubblicate) e per il prestito Morgan. Atteggiamento di Caillaux e della Francia verso i debiti e il perché del rifiuto di Caillaux di concludere l’accordo. Tuttavia anche Caillaux rappresenta la grande finanza, ma francese, che tende anch’essa all’egemonia o per lo meno a una certa posizione di superiorità (in ogni caso non vuole essere subordinata). Il libro di Caillaux, Dove va la Francia? Dove va l’Europa?, in cui è esposto chiaramente il programma politico‑sociale della grande finanza e si spiega la simpatia per il laburismo. Somiglianze reali tra regime politico degli Stati Uniti e dell’Italia, notato anche in altra nota.
Q3 §56 La concezione del centralismo organico e la casta sacerdotale. Se l’elemento costitutivo di un organismo è posto in un sistema dottrinario rigidamente e rigorosamente formulato, si ha un tipo di direzione castale e sacerdotale. Ma esiste ancora la «garanzia» dell’immutabilità? Non esiste. Le formule verranno recitate a memoria senza mutar sillaba e virgola, ma l’attività reale sarà un’altra. Non bisogna concepire l’«ideologia», la dottrina come qualcosa di artificiale e sovrapposto meccanicamente (come un vestito sulla pelle, e non come la pelle che è organicamente prodotta dall’intero organismo biologico animale), ma storicamente, come una lotta incessante. Il centralismo organico immagina di poter fabbricare un organismo una volta per sempre, già perfetto obbiettivamente. Illusione che può essere disastrosa, perché fa affogare un movimento in un pantano di dispute personali accademiche. (Tre elementi: dottrina, composizione «fisica» della società di un determinato personale storicamente determinato, movimento reale storico. Il primo e il secondo elemento cadono sotto il controllo della volontà associata e deliberante. Il terzo elemento reagisce continuamente sugli altri due e determina la lotta incessante, teorica e pratica, per elevare l’organismo a coscienze collettive sempre più elevate e raffinate). Feticismo costituzionalistico. (Storia delle Costituzioni approvate durante la Rivoluzione francese: la Costituzione votata nel 93 dalla Convenzione fu deposta in un’arca di cedro nei locali dell’assemblea, e l’applicazione ne fu sospesa fino alla fine della guerra: anche la Costituzione più radicale poteva essere sfruttata dai nemici della Rivoluzione e perciò era necessaria la dittatura, cioè un potere non limitato da leggi fisse e scritte).
Q3 § 57. I nipotini di padre Bresciani. Papini. Notare come gli scrittori della «Civiltà Cattolica» se lo tengono diletto e lo vezzeggiano e lo coccolano e lo difendono da ogni accusa di poca ortodossia. Frasi di Papini, desunte dal suo libro di S. Agostino e che mostrano la tendenza al secentismo (i gesuiti furono rappresentanti spiccati del secentismo): «quando si dibatteva per uscire dalle cantine dell’orgoglio a respirare l’aria divina dell’assoluto», «salire dal letamaio alle stelle» ecc. È evidente che Papini si è convertito non al cristianesimo, né al cattolicismo, ma propriamente al gesuitismo. (Si può dire che il gesuitismo è la fase più recente del cristianesimo cattolico).
Q3 §58 Riviste tipo. Tipo «Voce» ‑ «Leonardo». Composta da saggi originali. Reagire contro l’abitudine di riempire le riviste con traduzioni. Se collaborazione di stranieri, collaborazione originale. Ma le traduzioni di saggi scritti da stranieri hanno la loro importanza culturale, per reagire contro il provincialismo e la meschineria. Supplementi di sole traduzioni: ogni due mesi fascicoli dello stesso formato della rivista‑tipo, con altro titolo, (Supplemento ecc.) e numerazione di pagine indipendente, che contengano una scelta critico‑informativa delle pubblicazioni teoriche straniere. (Tipo «Rassegna delle riviste estere» stampata per qualche tempo dal Ministero degli Esteri).
Q3 §59 Passato e presente. L’influsso intellettuale della Francia. Ci siamo veramente liberati o lavoriamo effettivamente per liberarci dall’influsso francese? A me pare, in un certo senso, che l’influsso francese sia andato aumentando in questi ultimi anni e che esso andrà sempre più aumentando. Nell’epoca precedente, l’influsso francese giungeva in Italia disorganicamente come un fermento che metteva in ebollizione una materia ancora amorfa e primitiva: le conseguenze erano, in un certo senso, originali. Anche se la spinta al movimento era esterna, la direzione del movimento era originale, perché risultava da una componente delle forze indigene risvegliate. Ora invece, si cerca di limitare o addirittura di annullare questo influsso «disorganico», che si esercitava spontaneamente e casualmente, ma l’influsso francese è stato trasportato nel sistema stesso, nel centro delle forze motrici che vorrebbero appunto limitare e annullare. La Francia è diventata un modello negativo, ma siccome questo modello negativo è una mera apparenza, un fantoccio dell’argomentazione polemica, la Francia reale è il modello positivo. La stessa «romanità» in quanto ha qualcosa di efficiente, diventa un modello francese, poiché, come giustamente osserva il Sorel (lettere al Michels pubblicate nei «Nuovi Studi di Politica Economia Diritto»), la tradizione statale di Roma si è conservata specialmente nel centralismo monarchico francese e nello spirito nazionale statale del popolo francese. Si potrebbero trovare curiose prove linguistiche di questa imitazione: i marescialli dopo la guerra, il titolo di direttore della Banca d’Italia cambiato in governatore ecc. C’è nella lotta Francia‑Italia sottintesa una grande ammirazione per la Francia e per la sua struttura reale e da questa lotta nasce un influsso reale enormemente più grande di quello del periodo precedente. (Nazionalismo italiano copiato da nazionalismo francese ecc.: era la traccia, ben più importante che il mimetismo democratico, che questo influsso reale era già nato nel periodo precedente).
Q3 §60 Passato e presente. I morti di fame e la malavita professionale. Bohème, scapigliatura, leggera ecc. Nel libro La Scapigliatura milanese (M)lano, «Famiglia Meneghina» editrice, 1930, 16°, pp. 267, L. 15,00) Pietro Madini tenta una ricostruzione dell’ambiente generale di questo movimento letterario (antecedenti e derivazioni), compresi i rappresentanti delle scapigliature popolari, come la «Compagnia della Teppa» (verso il 1817), ritenuta una propaggine un po’ guasta della Carboneria, sciolta dall’Austria quando questa cominciò a temere l’azione patriottica del Bichinkommer. La Teppa è diventata oggi sinonimo di malavita, anzi di una speciale malavita, ma questa derivazione non è senza significato per comprendere l’atteggiamento della vecchia «Compagnia».
Ciò che Victor Hugo nell’Uomo che ride dice delle spavalderie che commettevano i giovani aristocratici inglesi era una forma di «teppa»; essa ha una traccia da per tutto, in un certo periodo storico (moscardini, Santa Vehme ecc.), ma si è conservata più a lungo in Italia; ricordare l’episodio di Terlizzi riportato dal giornale di Rerum Scriptor nel 12 o 13. Anche le così dette «burle» che tanta materia danno ai novellieri del Trecento‑Cinquecento rientrano in questo quadro: i giovani di una classe disoccupata economicamente e politicamente diventano «teppisti».
Q3 §61 Lotta di generazioni. Il fatto che la generazione anziana non riesca a guidare la generazione più giovane è in parte anche l’espressione della crisi dell’istituto famigliare e della nuova situazione dell’elemento femminile nella società. L’educazione dei figli è affidata sempre più allo Stato o a iniziative scolastiche private e ciò determina un impoverimento «sentimentale» per rispetto al passato e una meccanizzazione della vita. Il più grave è che la generazione anziana rinunzia al suo compito educativo in determinate situazioni, sulla base di teorie mal comprese o applicate in situazioni diverse da quelle di cui erano l’espressione. Si cade anche in forme statolatriche: in realtà ogni elemento sociale omogeneo è «Stato», rappresenta lo Stato, in quanto aderisce al suo programma: altrimenti si confonde lo Stato con la burocrazia statale. Ogni cittadino è «funzionario» se è attivo nella vita sociale nella direzione tracciata dallo Stato‑governo, ed è tanto più «funzionario» quanto più aderisce al programma statale e lo elabora intelligentemente.
Q3 §62 Passato e presente. L’influsso intellettuale della Francia. La fortuna, incredibile, del superficialissimo libro di Léon Daudet sullo «stupido secolo XIX»; la formula dello stupido secolo è diventata una vera giaculatoria che si ripete a casaccio, senza capirne la portata. Nel sistema ideologico dei monarchici francesi questa formula è comprensibile e giustificata: essi creano o vogliono creare il mito dell’ancien régime (sol nel passato è il vero, sol nel passato è il bello) e programmaticamente deprezzano tutta la «parentesi» tra il 1789 e il domani della restaurazione, tra l’altro anche la formazione dell’unità statale italiana. Ma per gli italiani che significato ha questa formula? Vogliono restaurare le condizioni di prima del Risorgimento? Il secolo XIX è stupido perché esso ha espresso le forze che hanno unificato l’Italia?
Ideologia di sotterfugi: c’è una corrente, molto stupida nelle sue manifestazioni, che realmente cerca di riabilitare gli antichi regimi, specialmente quello borbonico, e ciò proprio con spirito apologetico (parallelamente agli studi storici che cercano di ricostruire obbiettivamente i fatti). Ma in tutte queste espressioni mi pare sia l’imbarazzo di chi vorrebbe avere una tradizione e non può averla (una tradizione rumorosa, come potrebbe essere quella francese di Luigi XIV o di Napoleone) o è costretto a risalire troppi secoli, e nella reale tradizione del paese vede contenuta troppa quantità di argomenti polemici negativi. Appunto per questo la fortuna della frase di Daudet è un tipico esempio di sudditanza alle correnti intellettuali francesi.
La quistione, però, ha un aspetto generale molto interessante: quale deve essere l’atteggiamento di un gruppo politico innovatore verso il passato, specialmente verso il passato più prossimo? Naturalmente deve essere un atteggiamento essenzialmente «politico», determinato dalle necessità pratiche, ma la quistione consiste precisamente nella determinazione dei «limiti» di un tale atteggiamento. Una politica realistica non deve solo tener presente il successo immediato (per determinati gruppi politici, però, il successo immediato è tutto: si tratta dei movimenti puramente repressivi, per i quali si tratta specialmente di dare un gran colpo ai nemici immediati, di terrorizzare i gregari di questi e quindi acquistare il respiro necessario per riorganizzare e rafforzare con istituzioni appropriate la macchina repressiva dello Stato), ma anche salvaguardare e creare le condizioni necessarie per l’attività avvenire e tra queste condizioni è l’educazione popolare. Questo è il punto. L’atteggiamento sarà tanto più «imparziale», cioè storicamente «obbiettivo», quanto più elevato sarà il livello culturale e sviluppato lo spirito critico, il senso delle distinzioni. Si condanna in blocco il passato quando non si riesce a differenziarsene, o almeno le differenziazioni sono di carattere secondario e si esauriscono quindi nell’entusiasmo declamatorio. È certo d’altronde che nel passato si può trovare tutto quello che si vuole, manipolando le prospettive e l’ordine delle grandezze e dei valori.
Il secolo XIX ha voluto dire nell’ordine politico sistema rappresentativo e parlamentare. È vero che in Italia questo sistema è stato importato meccanicamente? Esso è stato ottenuto con una lotta, alla quale le grandi masse della popolazione non sono state chiamate a partecipare: esso si è adattato a queste condizioni assumendo forme bene specificate, italiane, inconfondibili con quelle degli altri paesi. La tradizione italiana perciò presenta diversi filoni: quello della resistenza accanita, quello della lotta, quello dell’accomodantismo e dello spirito di combinazione (che è la tradizione ufficiale). Ogni gruppo può richiamarsi a uno di questi filoni tradizionali, distinguendo tra fatti reali e ideologie, tra lotte effettive e lotte verbali ecc. ecc.; può anche sostenere di iniziare una nuova tradizione, di cui nel passato si trovano solo elementi molecolari, non già organizzati, e mettere in valore questi elementi, che per lo stesso loro carattere non sono compromettenti, cioè non possono dar luogo a una elaborazione ideologica organica che si contrapponga all’attuale, ecc.
Q3 §63 I nipotini di padre Bresciani. Letteratura popolare. Nota nella «Critica Fascista» del 1° agosto 1930 in cui si lamenta che due grandi quotidiani, uno di Roma e l’altro di Napoli, iniziano la pubblicazione in appendice di questi romanzi: Il Conte di Montecristo e Giuseppe Balsamo di A. Dumas, il Calvario di una madre di Paolo Fontenay. Scrive la «Critica»: «L’ottocento francese è stato senza dubbio un periodo aureo per il romanzo d’appendice, ma debbono avere un ben scarso concetto dei propri lettori quei giornali che ristampano romanzi di un secolo fa, come se il gusto, l’interesse, l’esperienza letteraria non fossero per niente mutate da allora ad ora. Non solo, ma ... perché non tener conto che esiste, malgrado le opinioni contrarie, un romanzo moderno italiano? E pensare che questa gente è pronta a spargere lacrime d’inchiostro sulla infelice sorte delle patrie lettere». La «Critica» confonde due quistioni: quella della letteratura artistica (così detta) e quella della letteratura popolare (poiché così si pone la quistione nella storia della cultura, sebbene evidentemente nulla impedisca, in teoria, che esista o possa esistere una letteratura popolare artistica: essa si verificherà quando ci sarà una identità di classe tra «popolo» e scrittori e artisti, cioè quando i sentimenti popolari saranno vissuti come propri dagli artisti; ma allora tutto sarà cambiato, cioè si potrà parlare di letteratura popolare solo per metafora) e non si pone il terzo problema del perché non esista una letteratura popolare artistica. I giornali non si propongono di diffondere le belle lettere: sono organismi politico‑finanziari. Il romanzo d’appendice è un mezzo per diffondersi tra le classi popolari, ciò che significa successo politico e successo commerciale. Il giornale cerca perciò il romanzo, il tipo di romanzo, che piace al popolo, che farà certamente comprare il foglio continuativamente. L’uomo del popolo compra un solo giornale, quando lo compra: la sua scelta non è puramente personale, ma di gruppo famigliare: le donne pesano molto nella scelta e insistono per il bel romanzo interessante (ciò non significa che anche gli uomini non leggano il romanzo, ma il peso maggiore è nelle donne): da ciò deriva il fatto che i giornali puramente politici o d’opinione non hanno potuto mai avere una diffusione grande: essi sono comprati dagli scapoli, uomini e donne che si interessano fortemente della politica e da un numero mediocre di famiglie, che pure non sono dell’opinione generale del giornale che leggono. (Ricordare alcuni giornali popolari che pubblicavano fino a tre romanzi d’appendice, come il «Secolo» di un certo periodo). Perché i giornali italiani del 1930, se vogliono diffondersi, devono pubblicare in appendice i romanzi d’appendice di un secolo fa? E anche i romanzi d’appendice di un determinato tipo? E perché non esiste in Italia una letteratura «nazionale» del genere?
Osservare il fatto che in molte lingue «nazionale» e «popolare» sono quasi sinonimi (in russo, in tedesco «volkisch» ha quasi un significato ancora più intimo, di razza, nelle lingue slave in genere; in francese ha il significato stesso, ma già più elaborato politicamente, legato cioè al concetto di «sovranità»; sovranità nazionale e sovranità popolare hanno valore uguale o l’hanno avuto). In Italia gli intellettuali sono lontani dal popolo, cioè dalla «nazione» e sono legati a una tradizione di casta, che non è mai stata rotta da un forte movimento politico popolare o nazionale, tradizione «libresca» e astratta.
Cfr gli articoli di Umberto Fracchia nell’«Italia Letteraria» del luglio 1930 e la Lettera a Umberto Fracchia sulla critica di Ugo Ojetti nel «Pègaso» dell’agosto 1930. I lamenti del Fracchia sono dello stesso tipo di quelli della «Critica Fascista». La letteratura «nazionale» così detta «artistica» non è popolare in Italia. Di chi la colpa? Del pubblico che non legge? Della critica che non sa presentare ed esaltare al pubblico i valori letterari? Dei giornali che invece di pubblicare in appendice il «romanzo moderno italiano» pubblicano il vecchio Conte di Montecristo? Ma perché il pubblico non legge in Italia mentre legge in altri paesi? Ed è poi vero che non legga? Non sarebbe più esatto dire: perché il pubblico italiano legge la letteratura straniera, popolare e non popolare, e non legge invece quella italiana? Lo stesso Fracchia non ha pubblicato degli ultimatum agli editori che pubblicano (e quindi vendono relativamente) opere straniere, minacciando provvedimenti governativi? E questi provvedimenti non ci sono stati in parte per opera di Michele Bianchi, sottosegretario agli interni? Cosa significa il fatto che gli italiani leggono a preferenza gli scrittori stranieri? Che esso subisce l’egemonia degli intellettuali stranieri, che esso si sente legato più agli intellettuali stranieri che a quelli nazionali: che non esiste in Italia un blocco nazionale intellettuale e morale. Gli intellettuali non escono dal popolo, non ne conoscono i bisogni, le aspirazioni, i sentimenti diffusi, ma sono qualcosa di staccato, di campato in aria, una casta cioè. La quistione deve essere estesa a tutta la cultura popolare o nazionale e non al solo romanzo o alla sola letteratura: il teatro, la letteratura scientifica in generale (scienze propriamente dette, storia ecc.): perché non ci sono in Italia dei tipi di scrittori come Flammarion? la letteratura divulgativa in generale francese. Tradotti, questi libri stranieri, sono letti e ricercati. Dunque tutta la classe colta, con la sua attività intellettuale è staccata dal popolo, dalla nazione, non perché il «popolo nazione» non abbia dimostrato e non dimostri di interessarsi a queste attività intellettuali in tutti i suoi gradi, dai più infimi (romanzacci d’appendice) ai più elevati, tanto vero che ricerca i libri stranieri, ma perché l’elemento intellettuale indigeno è più straniero degli stranieri di fronte a questo popolo‑nazione. La quistione non è d’oggi: essa si è posta fin dalla fondazione dello Stato italiano: il libro di R. Bonghi ne è documento. Anche la quistione della lingua posta dal Manzoni riflette questo problema, il problema dell’unità morale della nazione e dello Stato, ricercato nell’unità della lingua. Ma la lingua è strumento esterno e non necessario esclusivamente dell’unità: in ogni caso è effetto e non causa. Scritti di F. Martini sul teatro: tutta una letteratura.
In Italia è mancato il libro popolare, romanzo o d’altro genere. Nella poesia dei tipi come Béranger e tutti i chansonniers popolari francesi. Tuttavia ce ne sono stati, individualmente, e hanno avuto fortuna. Guerrazzi ha avuto fortuna e i suoi libri hanno continuato ad essere pubblicati fino a poco tempo fa. Carolina Invernizio è stata letta, sebbene fosse a un livello più basso dei Ponson e dei Montépin. Mastriani è stato letto. (Ricordo un articolo di Papini sulla Invernizio pubblicato nel «Resto del Carlino» durante la guerra, mi pare, verso il 1916: non so se ristampato in qualche raccolta‑libro. Mi pare che il Papini scrivesse qualcosa di interessante su questa onesta gallina della letteratura, appunto notando come la Invernizio si facesse leggere dal popolo. Si potrà vedere in qualche bibliografia di Papini la data di questo articolo o altre indicazioni: forse nella bibliografia pubblicata nel saggio del Palmieri). Il popolo legge o si interessa in altro modo alla produzione letteraria. Diffusione dei Reali di Francia e del Guerrin Meschino specialmente nell’Italia meridionale e nelle montagne. I Maggi in Toscana: gli argomenti trattati dai Maggi sono tratti dai libri e dalle novelle di carattere popolare: la Pia dei Tolomei ecc. (deve esistere qualche pubblicazione sui Maggi e una registrazione approssimativa degli argomenti che trattano).
I laici hanno fallito nella soddisfazione dei bisogni intellettuali del popolo: io credo proprio per non avere rappresentato una cultura laica, per non aver saputo creare un nuovo umanesimo, adatto ai bisogni del mondo moderno, per aver rappresentato un mondo astratto, meschino, troppo individuale ed egoista. La letteratura popolare francese che, per esempio, è diffusa anche in Italia, rappresenta in maggiore o minor grado, in modo più o meno simpatico, questo «nuovo umanesimo», questo laicismo. Guerrazzi lo rappresentava, il Mastriani ecc.
Ma se i laici hanno fallito, i cattolici non hanno avuto miglior successo. Pare che i libri ameni cattolici siano molto letti, perché hanno discrete tirature: ma il più delle volte si tratta di oggetti che vengono regalati nelle cerimonie e che non vengono letti che per castigo o per disperazione. Colpisce il fatto che nel campo del romanzo o delle narrazioni avventurose i cattolici non abbiano avuto una maggiore letteratura e una maggiore fortuna: eppure essi avrebbero una sorgente inesauribile nei viaggi e nelle vite avventurose dei missionari. Ma anche nel periodo di maggior espansione del romanzo geografico d’avventura, la letteratura cattolica in argomento è stata meschina: i libri di Ugo Mioni (credo padre gesuita) e le vicende del cardinal Massaja in Abissinia devono essere i più fortunati. Anche nella letteratura scientifica i cattolici non hanno gran che (letteratura scientifica popolare), nonostante abbiano avuto grandi astronomi come il padre Secchi (gesuita) e l’astronomia sia la scienza che più interessa il popolo. Questa letteratura cattolica è troppo impregnata di apologetica gesuitica e stucca per la sua meschinità. Questa poca fortuna della letteratura popolare cattolica indica come ci sia ormai una rottura profonda tra la religione e il popolo, che si trova in uno stato miserrimo di indifferentismo e di assenza di vita spirituale: la religione è solo una superstizione, ma non è stata sostituita da una nuova moralità laica e umanistica per l’impotenza degli intellettuali laici (la religione non è stata né sostituita, né intimamente trasformata e nazionalizzata come in altri paesi, come in America lo stessogesuitismo: l’Italia è ancora, come popolo, nelle condizioni generali create dalla Controriforma).
(La religione si è combinata col folklore pagano ed è rimasta a questo stadio. Cfr sul folklore).
Q3 §64 I nipotini di padre Bresciani. Mario Puccini, Cola o Ritratto dell’Italiano, Casa Editrice Vecchioni, Aquila, 1927. Cola è un contadino toscano, territoriale durante la guerra, con cui il Puccini vorrebbe rappresentare il «vecchio italiano» ecc.
... «il carattere di Cola, ... senza reazioni ma senza entusiasmi, capace di fare il proprio dovere e anche di compiere qualche atto di valore ma per obbedienza e per necessità e con un tenero rispetto per la propria pelle, persuaso sì e no della necessità della guerra ma senza nessun sospetto di valori eroici ... il tipo di una coscienza, se non completamente sorda, certo passiva alle esigenze ideali, tra la bacchettona e pigra, resistente a guardare oltre gli “ordini del governo” e oltre le modeste funzioni della vita individuale, contento in una parola dell’esistenza di pianura senza ambizione delle alte cime». (Dalla recensione pubblicata nella «Nuova Antologia» del 16 marzo 1928, p. 270).
Q3 §65 Massimo Lelj, Il Risorgimento dello spirito italiano (1725‑1861), L’«Esame», Edizioni di Storia Moderna, Milano 1928, L. 15,00. (Cosa è?)
Q3 §66 Lorianesimo e secentismo. Paolo Orano. Un articolo di P. Orano su Ibsen sulla « Nuova Antologia» del 1° aprile 1928. Un aforisma pregnante di vacuità: «L’autentico (! cioè il corrispettivo rinforzato del tanto screditato “vero”) sforzo moderno dell’arte drammatica è consistito nel risolvere scenicamente (!) gli assurdi (!) della vita consapevole (!). Fuori di ciò il teatro può essere un bellissimo gioco consolatore (!), un amabile passatempo, non altro». Altro aforisma come sopra: «Con lui e per lui (Ibsen) abbiamo incominciato a credere all’eternità dell’attimo, perché l’attimo è pensiero, ed al valore assoluto della personalità individuale, che è agente e giudice fuor del tempo e dello spazio, oltre i rimorsi temporali e il nulla spaziale, momento e durata inattingibili al criterio della scienza e della religione» .
Q3 §67 Gerrymandering. (Non so cosa significa mandering). Gerry, un americano, che avrebbe applicato per primo il trucco elettorale di raggruppare arbitrariamente le circoscrizioni per avere maggioranze fittizie. (Questo trucco si verifica specialmente nei collegi uninominali, costituiti in modo che pochi elettori bastano per eleggere i deputati di destra, mentre ne occorrono enormemente di più per eleggere un deputato di sinistra: cfr le elezioni francesi del 1928 e confronta il numero di voti e gli eletti del partito Marin e quelli del gruppo Cachin. Questo trucco si applica poi nei plebisciti per le quistioni nazionali, estendendo a zone più ampie di quella dove una minoranza è omogenea la circoscrizione ecc.). (Vedere chi era Gerry ecc.).
Q3 §68 Americanismo. Ricordare il libro di Guglielmo Ferrero Fra i due mondi: quanti dei luoghi comuni del Ferrero sono entrati in circolazione a proposito dell’America e continuano a essere spesi senza ricordate il conio e la zecca? (Quantità contro qualità, per esempio). Fra i due mondi è di prima della guerra, ma anche dopo il Ferrero ha insistito su questi tasti. Vedere.
Sull’americanismo vedi articolo L’America nella letteratura francese del 1927 di Étienne Fournol nella «Nuova Antologia» del 1° aprile 1928, comodo perché vi si possono trovare registrati i luoghi comuni più marchiani sull’argomento. Parla del libro di Siegfried e di quello del Romier (Qui sera le maître?) e accenna a un libro di Andrea Tardieu (Devant l’obstacle: l’Amérique et nous, Parigi, Librairie Emil Paul) e a due libri di Luc Durtain, un romanzo Hollywood dépassé e una raccolta di novelle Quarantième étage, editi dalla N.R.F. e che paiono interessanti.
A proposito del prof. Siegfried si noti questa sua contraddizione: a pag. 350 del suo libro Les États‑Unis d’aujourd’hui egli ha riconosciuto nella vita americana «l’aspetto d’una società realmente collettivistica, voluto dalle classi elette e accettato allegramente (sic) dalla moltitudine», e poi scrive la prefazione del libro del Philip sul movimento operaio americano e lo loda, sebbene non vi si dimostri precisamente questa «allegria» e che in America non ci sia lotta di classe, anzi vi si dimostra l’esistenza della più sfrenata e feroce lotta di una parte contro l’altra. Lo stesso confronto si dovrebbe fare tra il libro del Romier e quello del Philip. Perché dunque è stato accettato così facilmente in Europa (ed è stato diffuso così abilmente) questo cliché degli Stati Uniti senza lotta di classi, ecc. ecc.? Si combatte l’americanismo per i suoi elementi sovversivi della stagnante società europea, ma si crea il cliché dell’omogeneità sociale americana per uso di propaganda e come premessa ideologica di leggi eccezionali.
Q3 §69 Utopie e romanzi filosofici e loro rapporti con lo sviluppo della critica politica, ma specialmente con le aspirazioni più elementari e profonde delle moltitudini. Studiare se c’è un ritmo nell’apparizione di questi prodotti letterari: coincidono con determinati periodi, con i sintomi di profonde mutazioni storiche? Compilare un elenco i questi lavori, utopie propriamente dette, romanzi filosofici, libri che attribuiscono a paesi lontani e sconosciuti ma esistenti determinate usanze e istituzioni che si vogliono contrapporre a quelle del proprio paese. L’Utopia di T. Moro, la Nuova Atlantide di Bacone, l’Isola dei Piaceri e la Salento di Fénelon (ma anche il Telemaco), i Viaggi di Gulliver dello Swift ecc.
Q3 §70 Frate Vedremo. Questa espressione è usata da Giuseppe De Maistre in una Memoria del 6 luglio 1814 (scritta da Pietroburgo dove era ambasciatore) e pubblicata nelle (Œuvres complètes, Lione 1886, tome 1° Correspondance diplomatique. Egli scrive a proposito della politica piemontese: «Notre système, timide, neutre, suspensif, tâtonnant, est mortel dans cet état des choses... Il faut avoir l’œil bien ouvert et prendre garde à l’ennemi des grands coups, lequel s’appelle Frère‑Vedremo». (Un paragrafo su «Frate Vedremo» nella rubrica «Passato e presente»).
Q3 §71 Utopie e romanzi filosofici. In un articolo di Giuseppe Gabrieli su Federico Cesi linceo nella «Nuova Antologia» del 1° agosto 1930 si stabilisce un nesso storico‑ideologico tra la ControRiforma (che contrappone all’individualismo, acuito dall’Umanesimo e sbrigliato dal Protestantesimo, lo spirito romano di collegialità, di disciplina, di corporazione, di gerarchia per la ricostruzione della società), le Accademie (come quella dei Lincei tentata dal Cesi, cioè il lavoro collegiale degli scienziati, di tipo ben diverso da quello dei centri universitari, rimasti medioevali nei metodi e nelle forme), e le idee e le audacie delle grandi teorie, delle riforme palingenetiche o utopistiche ricostruzioni dell’umana convivenza (la Città del Sole, la Nuova Atlantide ecc.).
Mi pare che ci sia troppo di stiracchiato in questo nesso e bisogna invece vedere se queste iniziative non siano l’unica forma in cui la «modernità» poteva vivere nell’ambiente della Controriforma: la Controriforma, come tutte le Restaurazioni, non poté non essere che un compromesso e una combinazione sostanziale, se non formale, tra il vecchio e il nuovo, ecc. (Bisogna però tener conto delle scoperte scientifiche del tempo e dello spirito «scientifista» che si diffuse: di un certo «razionalismo» avant la lettre ecc.).
Q3 §72 Rubriche scientifiche. Il tipo del giornale quotidiano in Italia è determinato dall’insieme delle condizioni culturali del paese: mancanza di letteratura di divulgazione, scarsità di riviste popolari di divulgazione. Il lettore del giornale vuole trovare perciò nel suo foglio riflessi tutti gli aspetti della complessa vita sociale di una nazione moderna. È notevole il fatto che il giornale italiano, relativamente meglio fatto di quello di altri paesi, abbia sempre trascurato l’informazione scientifica, mentre aveva un corpo notevole di giornalisti‑economisti (Einaudi, Cabiati, ecc.) e di giornalisti‑letterati o di cultura generale (Borgese, Cecchi, Ojetti, Bellonci, ecc.). Anche nelle riviste importanti (come la «Nuova Antologia» e la «Rivista d’Italia») la rubrica scientifica era molto inferiore alle altre (il Bertarelli, il Dott. Ry formano un’eccezione relativa). Non ho mai visto la rivista di filosofia scientifica l’«Arduo» che si pubblicava a Bologna diretta da Sebastiano Timpanaro (Mario Pant).
Tuttavia l’informazione scientifica dovrebbe essere integrante di un giornale quotidiano in Italia, sia come notiziario scientifico‑tecnologico, sia come esposizione critica delle ipotesi e opinioni scientifiche più importanti (la parte igienica dovrebbe costituire una rubrica a parte nella rubrica generale scientifica). Un giornale popolare, più che gli altri dovrebbe avere questa sezione, per controllare e dirigere l’apprendimento dei suoi lettori e «sprovincializzare» le nozioni correnti. Difficoltà di avere specialisti che sappiano scrivere popolarmente. Si potrebbe fare lo spoglio sistematico delle riviste generali e di cultura professionale, gli atti delle Accademie e le pubblicazioni straniere e compilare estratti e riassunti in appendici speciali o nella terza pagina (come sezione speciale), scegliendo accuratamente e con intelligenza il materiale.
Q3 §73 I nipotini di padre Bresciani. Luigi Capuana. Da un articolo di Luigi Tonelli Il carattere e l’opera di Luigi Capuana nella Nuova Antologia del 1° maggio 1928: «Re Bracalone (romanzo fiabesco: il secolo XX è creato, per forza d’incanto, nello spazio di brevi giorni, nei tempi di “c’era una volta”; ma dopo averne fatta l’amara esperienza, il re lo distrugge, preferendo ritornare ai tempi primitivi) c’interessa anche sotto il riguardo ideologico; ché, in un periodo d’infatuazione (!) internazionalista socialistoide, ebbe il coraggio di bollare a fuoco (!) “le sciocche sentimentalità della pace universale, del disarmo e le non meno sciocche sentimentalità dell’uguaglianza economica e della comunità dei beni” ed esprimere l’urgenza di “tagliar corto alle agitazioni che han già creato uno Stato dentro lo Stato, un governo irresponsabile” ed affermare la necessità di una coscienza nazionale: “Ci fa difetto la dignità nazionale; bisogna creare il nobile orgoglio di essa, spingerlo fino all’eccesso. È l’unico caso in cui l’eccesso non guasta”». Il Tonelli è sciocco, ma il Capuana non scherza anche lui col suo frasario da giornaletto di provincia: bisognerebbe poi vedere cosa vale la sua ideologia del «C’era una volta» e del patriarcalismo primitivo.
Del Capuana occorrerà ricordate il teatro dialettale e le sue opinioni sulla lingua nel teatro a proposito della quistione della lingua nella letteratura italiana. Alcune commedie del Capuana (come Giacinta, Malìa, Il Cavalier Pedagna) furono scritte originariamente in italiano e poi voltate in dialetto: solo in dialetto ebbero grande successo. Il Tonelli, che non capisce nulla, scrive che il Capuana fu indotto alla forma dialettale nel teatro «non soltanto dalla convinzione che “bisogna passare pei teatri dialettali, se si vuole davvero arrivare al teatro nazionale italiano” ..., ma anche e soprattutto dal carattere particolare delle sue creazioni drammatiche: le quali sono squisitamente dialettali, e nel dialetto trovano la loro più naturale e schietta espressione». Ma cosa poi significa «creazioni squisitamente dialettali»? Il fatto è spiegato col fatto stesso, cioè non è spiegato. Vedere nel teatro di Pirandello le commedie in italiano e quelle in dialetto. La lingua non ha «storicità» di massa, non è un fatto nazionale. Liolà in italiano non vale nulla sebbene Il fu Mattia Pascal da cui è tratta sia abbastanza interessante.
Nel teatro in italiano, l’autore non si mette all’unisono col pubblico, non ha la prospettiva della storicità della lingua quando i personaggi vogliono essere «concretamente» italiani. Perché in Italia ci sono due lingue: l’italiano e il dialetto regionale e nella vita famigliare si adopera il dialetto: l’italiano, in gran parte, è un esperanto, cioè una lingua parziale ecc.
Quando si afferma la grande ricchezza espressiva dell’italiano si cade in un equivoco: si confonde la ricchezza espressiva registrata nel vocabolario o contenuta inerte nella letteratura stampata, con la ricchezza individuale che si può spendere individualmente. Quest’ultima conta, specialmente in certi casi: per misurare il grado di unità linguistica nazionale, per esempio, che non è dato dal vocabolario ma dalla vivente parlata del popolo.
Nel dialogo teatrale è evidente l’importanza di questo elemento: il dialogo dal palcoscenico deve suggerire immagini viventi, in tutta la loro concretezza storica, invece suggerisce, in gran parte, immagini libresche. Le parole della parlata famigliare si riproducono nell’ascoltatore come ricordo di parole lette nei libri o nei giornali e ricercate nel vocabolario, come sarebbe il francese in teatro ascoltato da uno che il francese ha imparato sui libri senza maestro: la parola è ossificata, senza articolazioni di sfumature, senza la comprensione del suo significato esatto che è dato da tutto il periodo ecc. Si ha l’impressione di essere goffi, o che goffi siano gli altri. Si osservi nell’italiano parlato quanti errori di pronunzia fa l’uomo del popolo: profùgo, rosèo, ecc., ciò che significa che le parole italiane le ha lette, non sentite e non sentite ripetutamente, cioè collocate in periodi diversi, ognuno dei quali abbia fatto brillare una sfaccettatura di quel poliedro che è ogni parola.
Q3 §74 Giulio Bertoni e la linguistica. Bisognerebbe scrivere una stroncatura del Bertoni come linguista, per gli atteggiamenti assunti ultimamente col suo scritto nel Manualetto di linguistica e nel volumetto pubblicato dal Petrini (vedi brano pubblicato dalla «Nuova Italia» dell’agosto 1930). Mi pare si possa dimostrare che il Bertoni né è riuscito a dare una teoria generale delle innovazioni portate dal Bartoli nella linguistica, né è riuscito a capire in che consistano queste innovazioni e quale sia la loro importanza pratica e teorica.
Del resto nell’articolo pubblicato qualche anno fa nel «Leonardo» sugli studi linguistici in Italia egli non distingue per nulla il Bartoli dalla comune schiera e anzi per il gioco dei chiaroscuri lo mette in seconda linea, a differenza del Casella che nel recente articolo sul «Marzocco» a proposito della Miscellanea Ascoli, pone in rilievo l’originalità del Bartoli: nell’articolo bertoniano del «Leonardo» è da rilevare come il Campus appaia addirittura superiore al Bartoli, quando i suoi studi sulle velari ario europee non sono che piccoli saggi in cui si applica puramente e semplicemente il metodo generale del Bartoli e furono dovuti ai suggerimenti del Bartoli stesso; è il Bartoli che disinteressatamente ha messo in valore il Campus e ha sempre cercato di metterlo in prima linea: il Bertoni, forse non senza accademica malizia, in un articolo come quello del «Leonardo» in cui occorreva quasi contare le parole dedicate a ogni studioso, per dare una giusta prospettiva, ha combinato le cose in modo che il Bartoli è messo in un cantuccio. Errore del Bartoli di aver collaborato col Bertoni nella compilazione del Manualetto, e dico errore e responsabilità scientifica. Il Bartoli è apprezzato per i suoi lavori concreti: lasciando scrivere al Bertoni la parte teorica induce in errore gli studenti e li spinge su una falsa strada: in questo caso la modestia e il disinteresse diventano una colpa.
D’altronde il Bertoni, se non ha capito il Bartoli, non ha nemmeno capito l’estetica del Croce, nel senso che dall’estetica crociana non ha saputo derivare dei canoni di ricerca e di costruzione della scienza del linguaggio, ma non ha fatto che parafrasare, esaltare, liricizzare delle impressioni: si tratta di un positivista sostanziale che si sdilinquisce di fronte all’idealismo perché questo è più di moda e permette di fare della retorica. Fa meraviglia che il Croce abbia lodato il Manualetto, senza vedere e far notare le incongruenze del Bertoni: mi pare che il Croce abbia più di tutto voluto prender atto benevolmente che in questo ramo degli studi, dove il positivismo trionfa, si cerchi di iniziare una via nuova nel senso idealistico. A me pare che tra il metodo del Bartoli e il crocismo non ci sia nessun rapporto di dipendenza immediata: il rapporto è con lo storicismo in generale, non con una particolare forma di storicismo. L’innovazione del Bartoli è appunto questa, che della linguistica, concepita grettamente come scienza naturale, ha fatto una scienza storica, le cui radici sono da cercare «nello spazio e nel tempo» e non nell’apparato vocale fisiologicamente inteso.
Bisognerebbe stroncare il Bertoni non solo in questo campo: la sua figura di studioso mi è sempre stata ripugnante intellettualmente: c’è in essa qualcosa di falso, di non sincero nel senso letterale della parola; oltre alla prolissità e alla mancanza di «prospettiva» nei valori storici e letterari.
Nella «linguistica» è crociano il Vossler, ma che rapporto esiste tra il Bartoli e il Vossler e tra il Vossler e quella che si chiama comunemente «linguistica»? Ricordare a questo proposito l’articolo del Croce Questa tavola rotonda è quadrata (nei Problemi di Estetica) dalla cui critica bisogna prendere le mosse per stabilire i concetti esatti in questa quistione.
Q3 §75 Utopie e romanzi filosofici. Articolo di Ezio Chiòrboli su Anton Francesco Doni nella Nuova Antologia del 1° maggio 1928: profilo interessante del Doni, pubblicista del Cinquecento, spiritoso, caustico, di spiriti moderni. Il Doni si occupò di infiniti problemi di ogni genere, precorrendo molte innovazioni scientifiche: scrittore popolarissimo. Materialista: accenna all’importanza dell’angolo facciale e ai segni specifici della delinquenza due secoli prima del Camper e due secoli e mezzo prima del Lavater e del Gall parlò delle funzioni dell’intelletto e delle parti del cervello a esse deputate.
Scrisse una utopia nel Mondo pazzo o savio – «immaginosa ricostruzione sociale che si pinge di molte delle iridescenze e delle ansie onde s’è arroventato il socialismo odierno» – che forse tolse dalla Utopia di Tommaso Moro. Conobbe l’Utopia: la pubblicò egli stesso nella volgarizzazione del Lando. «Pure l’immaginazione non è più la medesima, come la medesima non è di Platone nella Repubblica né d’altri quali si fossero, oscuri o ignoti; ché egli se la compì, se la rimutò, se la rifoggiò a sua posta, sì che n’ha già avvivata un’altra, sua, proprio sua, della quale tanto è preso che e nei Marmi e via via in più opere e opuscoli esce or in questo e or in quel particolare, in questo o in quel sentimento». Per la bibliografia del Doni cfr l’edizione dei Marmi curata dal Chiòrboli negli «Scrittori d’Italia» del Laterza.
Q3 §76 La quistione della lingua e le classi intellettuali italiane. Per lo sviluppo del concetto che l’Italia realizza il paradosso di un paese giovanissimo e vecchissimo nello stesso tempo (come Lao‑Tse che nasce a 80 anni).
I rapporti tra gli intellettuali e il popolo‑nazione studiati sotto l’aspetto della lingua scritta dagli intellettuali e usata nei loro rapporti e sotto l’aspetto della funzione avuta dagli intellettuali italiani nella Cosmopoli medioevale per il fatto che il Papato aveva sede in Italia (l’uso del latino come lingua dotta è legato al cosmopolitismo cattolico).
Latino letterario e latino volgare. Dal latino volgare si sviluppano i dialetti neolatini non solo in Italia ma in tutta l’area europea romanizzata: il latino letterario si cristallizza nel latino dei dotti, degli intellettuali, il così detto mediolatino (cfr articolo di Filippo Ermini sulla «Nuova Antologia» del 16 maggio 1928), che non può essere in nessun modo paragonato a una lingua parlata, nazionale, storicamente vivente, quantunque non sia neppure da confondersi con un gergo o con una lingua artificiale come l’esperanto. In ogni modo c’è una frattura tra il popolo e gli intellettuali, tra il popolo e la cultura. (Anche) i libri religiosi sono scritti in mediolatino, sicché anche le discussioni religiose sfuggono al popolo, quantunque la religione sia l’elemento culturale prevalente: della religione il popolo vede i riti e sente le prediche esortative, ma non può seguire le discussioni e gli sviluppi ideologici che sono monopolio di una casta.
I volgari sono scritti quando il popolo riprende importanza: il giuramento di Strasburgo (dopo la battaglia di Fontaneto tra i successori di Carlomagno) è rimasto perché i soldati non potevano giurare in una lingua sconosciuta, senza togliere validità al giuramento. Anche in Italia le prime tracce di volgare sono giuramenti o attestazioni di testimoni del popolo per stabilire la proprietà dei fondi di convento (Montecassino).
In ogni modo si può dire che in Italia dal 600 d. C., quando si può presumere che il popolo non comprendesse più il latino dei dotti, fino al 1250, quando incomincia la fioritura del volgare, cioè per più di 600 anni, il popolo non comprendesse i libri e non potesse partecipare al mondo della cultura. Il fiorire dei Comuni dà sviluppo ai volgari e l’egemonia intellettuale di Firenze dà una unità al volgare, cioè crea un volgare illustre. Ma cos’è questo volgare illustre? È il fiorentino elaborato dagli intellettuali della vecchia tradizione: è il fiorentino di vocabolario e anche di fonetica, ma è un latino di sintassi. D’altronde la vittoria del volgare sul latino non era facile: i dotti italiani, eccettuati i poeti e gli artisti in generale, scrivevano per l’Europa cristiana e non per l’Italia, erano una concentrazione di intellettuali cosmopoliti e non nazionali.
La caduta dei Comuni e l’avvento del principato, la creazione di una casta di governo staccata dal popolo, cristallizza questo volgare, allo stesso modo che si era cristallizzato il latino letterario. L’italiano è di nuovo una lingua scritta e non parlata, dei dotti e non della nazione. Ci sono in Italia due lingue dotte, il latino e l’italiano, e questo finisce con l’avere il sopravvento, e col trionfare completamente nel secolo XIX col distacco degli intellettuali laici da quelli ecclesiastici (gli ecclesiastici continuano anche oggi a scrivere libri in latino, ma oggi anche il Vaticano usa sempre più l’italiano quando tratta di cose italiane e così finirà col fare per gli altri paesi, coerentemente alla sua attuale politica delle nazionalità).
In ogni modo mi pare sia da fissare questo punto: che la cristallizzazione del volgare illustre non può essere staccata dalla tradizione del mediolatino e rappresenta un fenomeno analogo. Dopo una breve parentesi (libertà comunali) in cui c’è una fioritura di intellettuali usciti dalle classi popolari (borghesi) c’è un riassorbimento della funzione intellettuale nella casta tradizionale, in cui i singoli elementi sono di origine popolare, ma in cui prevale in essi il carattere di casta sull’origine. Non è cioè tutto uno strato della popolazione che arrivando al potere crea i suoi intellettuali (ciò è avvenuto nel Trecento) ma è un organismo tradizionalmente selezionato che assimila nei suoi quadri singoli individui (l’esempio tipico di ciò è dato dall’organizzazione ecclesiastica).
Di altri elementi occorre tener conto in un’analisi compiuta e credo che per molte quistioni la retorica nazionale del secolo scorso e i pregiudizi da essa incarnati non abbiano neanche spinto a fare le ricerche preliminari. Così: quale fu l’area esatta della diffusione del toscano? A Venezia, per esempio, secondo me, fu introdotto già l’italiano elaborato dai dotti sullo schema latino e non ebbe mai entratura il fiorentino originario, nel senso che i mercanti fiorentini non fecero sentire la viva voce fiorentina come a Roma e a Napoli, per esempio: la lingua di governo continuò a essere il veneziano. Così per altri centri (Genova, credo). Una storia della lingua italiana non esiste ancora in questo senso: la grammatica storica non è ancora ciò, anzi. Per la lingua francese esistono di queste storie (quella del Brunot – e del Littré – mi pare sia del tipo che io penso, ma non ricordo). Mi pare che, intesa la lingua come elemento della cultura e quindi della storia generale e come manifestazione precipita della «nazionalità» e «popolarità» degli intellettuali, questo studio non sia ozioso e puramente erudito.
Nel suo articolo, interessante come informazione dell’importanza che ha assunto lo studio del mediolatino (questa espressione, che dovrebbe significare latino medioevale, credo, mi pare abbastanza impropria e possibile causa di errori tra i non specialisti) e a cui potrò rifarmi per una prima bibliografia, oltre che ad altri scritti dell’Ermini che è un mediolatinista, l’Ermini afferma che in base alle ricerche, «alla teoria dei due mondi separati, del latino, che è in mano dei soli dotti e si spegne, e del neolatino, che sorge e s’avviva, bisogna sostituire la teoria dell’unità latina e della continuità perenne della tradizione classica». Ciò può significare solo che la nuova cultura neolatina sentiva fortemente gli influssi della precedente cultura, non che ci sia stata una unità «popolare‑nazionale» di cultura.
Ma forse per l’Ermini mediolatino ha proprio il significato letterale, del latino che sta in mezzo tra quello classico e quello umanistico, che indubbiamente segna un ritorno al classico, mentre il mediolatino ha caratteri propri, inconfondibili: l’Ermini fa incominciare il mediolatino verso la metà del secolo IV, quando avviene l’alleanza tra la cultura (!) classica e la religione cristiana, quando «una nobile pleiade di scrittori, uscendo dalle scuole di retorica e di poetica, sente vivo il desiderio di congiungere la fede nuova alla bellezza (!) antica e così dar vita alla prima poesia cristiana». (Mi pare giusto far risalire il mediolatino al primo rigoglio di letteratura cristiana latina, ma il modo di esporne la genesi mi pare vago e arbitrario – cfr la storia della letteratura latina del Marchesi per questo punto –).
Il mediolatino sarebbe quindi compreso tra la metà del sec. IV e la fine del secolo XIV, tra l’inizio dell’ispirazione cristiana e il diffondersi dell’umanesimo. Questi mille anni sono dall’Ermini suddivisi così: prima età delle origini, dalla morte di Costantino alla caduta dell’Impero d’Occidente (337‑476); seconda età, della letteratura barbarica, dal 476 al 799, cioè fino alla restaurazione dell’impero per opera di Carlo Magno, vero tempo di transizione nel continuo e progressivo latinizzarsi dei barbari (esagerato: del formarsi uno strato di intellettuali germanici che scrivono in latino); una terza età: del Risorgimento carolino, dal 799 all’888, alla morte di Carlo il Grosso; una quarta, della letteratura feudale, dall’888 al 1000, fino al pontificato di Silvestro II, quando il feudalesimo, lenta trasformazione di ordinamenti preesistenti, apre un’era nuova; una quinta, della letteratura scolastica, che corre sino alla fine del secolo XII, quando il sapere si raccoglie nelle grandi scuole e il pensiero e il metodo filosofico feconda tutte le scienze, e una sesta, della letteratura erudita, dal principio del XIII al termine del XIV e che accenna già alla decadenza.
Q3 §77 Il clero, la proprietà ecclesiastica e le forme affini di proprietà terriera o mobiliare. Il clero come tipo di stratificazione sociale deve essere tenuto sempre presente nell’analizzare la composizione delle classi possidenti e dirigenti. Il liberalismo nazionale ha distrutto in una serie di paesi la proprietà ecclesiastica, ma è stato impotente a impedire che tipi affini si riformassero e ancora più parassitari, perché i rappresentanti di esso non svolgevano e non svolgono neppure quelle funzioni sociali che svolgeva il clero: beneficenza, cultura popolare, assistenza pubblica ecc. Il costo di questi servizi era certamente enorme, tuttavia essi non erano completamente passivi. Le nuove stratificazioni sono ancor più passive, perché non si può dire che sia normale una funzione di questo genere: per effettuare un risparmio di 1000 lire l’anno una famiglia di «produttori di risparmio» ne consuma 10 000 costringendo alla denutrizione una decina di famiglie di contadini ai quali estorce la rendita fondiaria e altri profitti usurari. Sarebbe da vedere se queste 11 000 lire immesse nella terra non permetterebbero un’accumulazione maggiore di risparmio, oltre all’elevato tenore di vita nei contadini e quindi a un loro sviluppo intellettuale e produttivo‑tecnico.
In che misura negli Stati Uniti si sta formando una proprietà ecclesiastica propriamente detta, oltre alla formazione di proprietà del tipo ecclesiastico? e ciò nonostante le nuove forme di risparmio e di accumulazione rese possibili dalla nuova struttura industriale.
Q3 §78 I nipotini di padre Bresciani. I romanzi popolari d’appendice. Diversità di questi romanzi: tipo Victor Hugo ‑ Sue (Miserabili‑Misteri di Parigi) a carattere spiccatamente ideologico‑politico di tendenza democratica, legato alle ideologie quarantottesche; il tipo sentimentale‑popolare (Richebourg‑Decourcelle, ecc.); il puro intrigo con contenuto ideologico conservatore (Montépin). Il romanzo storico. Dumas ‑ Ponson du Terrail ecc. Il romanzo poliziesco col suo pendant (Lecocq ‑ Rocambole ‑ Sherlock Holmes ‑ Arsenio Lupin). Il romanzo misterioso (fantasmi ecc. ‑ Radcliffe ecc.). il romanzo scientifico d’avventura o semplicemente d’intrigo (Verne‑Boussenard).
Ognuna di queste categorie ha molte varietà, secondo i paesi (in America il romanzo d’avventura è il romanzo dei pionieri ecc.). Si può vedere come nella produzione d’insieme di un paese sia implicito un sentimento nazionale, ma non retorico, abilmente insinuato nel racconto (nel Verne e nei francesi il sentimento antinglese, legato alla perdita delle colonie e al bruciore per le sconfitte marittime ecc.).
In Italia nessuno di questi tipi ha avuto dei rappresentanti di qualche valore (non valore letterario, ma valore commerciale, di invenzione, di costruzione pratica di intrighi macchinosi ma elaborati con una certa razionalità). Neanche il romanzo poliziesco, che è diventato internazionale, ha dei rappresentanti in Italia.
Il curioso è che molti romanzi, specialmente storici, hanno preso l’argomento in Italia. Così Venezia, col suo Consiglio dei dieci, con la sua organizzazione tribunalizia‑poliziesca, ha dato e continua a dare argomento di romanzi popolari. Lo stesso si dica per i briganti, se ne togli i libercoli popolari pietosissimi.
L’ultimo tipo di libro popolare è la Vita romanzata, che in ogni modo rappresenta un qualcosa di superiore al Dumas: anche questa letteratura non ha in Italia rappresentanti (il Mazzucchelli? Non ho letto nulla), o almeno non sono paragonabili per numero, fecondità, e anche dati di piacevolezza letteraria ai francesi, ai tedeschi, agli inglesi. Il letterato italiano non scriverebbe una biografia romanzata di Masaniello o di Cola di Rienzo senza inzepparla di stucchevoli pezze d’appoggio retoriche, perché non si creda... non si pensi... ecc. ecc. Così avverrà che queste vite saranno scritte da stranieri (vedi Bianca Capello). È vero che in questi ultimi tempi sono state iniziate molte collane biografiche, ma si tratta di libri che stanno alle vite romanzate come la Monaca di Monza sta al Conte di Montecristo. È sempre il vecchio schema biografico che può trovare qualche migliaio di lettori nel caso migliore, ma non diventare popolare.
È da notare che alcuni tipi di questo romanzo popolare hanno il tipo corrispondente nel teatro e nel cinematografo. Nel teatro devo aver notato altrove come il Niccodemi abbia saputo trovare spunti popolari: Scampolo, l’Aigrette, la Volata ecc., onde il suo grande successo. Anche il Forzano deve aver dato qualcosa del genere, nel campo storico: episodi della Rivoluzione francese, ecc. ma con più pedanteria e provincialismo. In questo reparto del teatro si potrebbe notare come Ibsen, in alcuni drammi, come Casa di bambola piaccia molto al pubblico popolare in quanto i sentimenti rappresentati e la tendenza trovano risonanza nella psicologia popolare: cosa dovrebbe essere poi il così detto teatro di idee se non questo, la rappresentazione di passioni legate ai costumi moderni con soluzioni che rappresentano lo sviluppo storico ecc. solo che queste passioni e queste soluzioni devono essere rappresentate e non essere una tesi, un discorso di propaganda, cioè l’autore deve vivere nel mondo reale moderno e non assorbire sentimenti libreschi.
Q3 §79 La quistione della lingua. Ettore Veo, in un articolo della Nuova Antologia, del 16 giugno 1928, Roma nei suoi fogli dialettali, nota come il romanesco rimanesse a lungo costretto nell’ambito del volgo, schiacciato dal latino. «Ma già in movimenti rivoluzionari il volgo, come succede, cerca di passare – o lo si fa passare – in primo piano». Il Sacco di Roma trova scrittori in dialetto, ma specialmente la Rivoluzione francese. (Di qui comincia di fatto la fortuna «scritta» del romanesco e la fioritura dialettale che culmina nel periodo liberale di Pio IX fino alla caduta della Repubblica Romana). Nel 47‑49 il dialetto è arma dei liberali, dopo il 70 dei clericali.
Q3 §80 Il particolare chauvinisme italiano trova una sua manifestazione nella letteratura che rivendica le invenzioni, le scoperte scientifiche. Parlo dello «spirito» con cui queste rivendicazioni sono fatte, non del fenomeno in sé: non si tratta, insomma, di contributi... alla storia della tecnica e della scienza, ma di «pezzi» giornalistici di colore sciovinistico. Penso che molte rivendicazioni sono... oziose, nel senso che non basta aver avuto uno spunto, ma occorre saperne trarre tutte le conseguenze e applicazioni pratiche. Altrimenti si arriverebbe alla conclusione che non è stato mai inventato nulla, perché... i cinesi conoscevano già tutto. Per molte rivendicazioni questi specialisti (come il Savorgnan di Brazzà) di glorie nazionali non s’accorgono di far fare all’Italia la funzione della Cina.
A questo spunto si può riunire tutta la letteratura sulla patria di Cristoforo Colombo. A me pare che si tratti di una letteratura completamente inutile e oziosa. La quistione dovrebbe essere posta così: perché nessuno Stato italiano aiutò Cristoforo Colombo o perché Colombo non si rivolse a nessuno Stato italiano? In che consiste dunque l’elemento «nazionale» della scoperta dell’America? La nascita di Cristoforo Colombo in un punto dell’Europa piuttosto che in un altro ha un valore episodico e casuale, poiché egli stesso non si sentiva legato a uno Stato italiano. La quistione, secondo me, dovrebbe essere definita storicamente fissando che l’Italia ebbe per molti secoli una funzione internazionale‑europea. Gli intellettuali e gli specialisti italiani erano cosmopoliti e non italiani, non nazionali. Uomini di Stato, capitani, ammiragli, scienziati, navigatori italiani non avevano un carattere nazionale ma cosmopolita. Non so perché questo debba diminuire la loro grandezza o menomare la storia italiana, che è stata quello che è stata e non la fantasia dei poeti o la retorica dei declamatori: avere una funzione europea, ecco il carattere del «genio» italiano dal Quattrocento alla rivoluzione francese.
Q3 §81 Federico Confalonieri. Per capire l’impressione penosa che produceva tra gli esuli italiani l’atteggiamento di inerzia del Confalonieri durante la sua dimora all’estero dopo la liberazione dallo Spielberg occorre tener presente un brano della lettera scritta da Mazzini a Filippo Ugoni il 15 novembre 38 e pubblicata da Ugo Da Como nella «Nuova Antologia» del 16 giugno 1928 (Lettera inedita di Giuseppe Mazzini): «Mi sorprende che Confalonieri rientri. Quando tu mi parli della guerra che susciterebbe nel mio cuore il pensiero di mia madre, di mio padre, della sorella che mi rimane, dici il vero; ma Confalonieri da che affetto prepotente è egli richiamato in Italia? dopo la morte di Teresa sua moglie? Non capisco la vita se non consacrata al dovere, o all’amore ch’è anch’esso un dovere. Intendo, senza approvare o disapprovare, l’individuo che rinunzia alla lotta pel vero e pel bene a fronte della felicità o infelicità di persone care e sacre; non intendo chi vi rinunzia per vivere, come si dice, quieto; otto o dieci anni di vita d’individualismo, di sensazioni che passano e non producono cosa alcuna per altri, conchiusi dalla morte, mi paiono cosa spregevole per chi non ha credenza di vita futura, più che spregevole rea forse per chi ne ha. Confalonieri, solo, in età già inoltrata, senza forti doveri che lo leghino a una famiglia di esseri amati, dovrebbe, secondo me, aver tutto a noia fuorché la idea di contribuire all’emancipazione del suo paese e alla crociata contro l’Austria».
Il Da Como nella sua introduzione‑commento alla lettera del Mazzini, così scrive: «E per questo è pure nella nostra lettera un accorato pensiero per Federico Confalonieri. Egli era passato da Londra, un anno prima, diretto in Francia: Mazzini aveva saputo che era mesto e silenzioso, ma i patimenti, secondo lui, non dovevano mutare il fondo dell’anima. Lo seguiva con trepidazione perché voleva che fosse sempre un’alta diritta figura, un esempio. Pensava che se egli stesso fosse uscito dallo Spielberg, trovandosi un deserto d’intorno, non avrebbe ad altro inteso che al modo di ritentare qualche cosa a prò dell’antica idea e finirvi. Non voleva che supplicasse, che volesse e ottenesse il ritorno chi aveva sofferto quindici anni senza avvilirsi, senza indizi di cangiamento. Voleva che fosse sempre un nuovo Farinata degli Uberti, come lo raffigurò Gabriele Rosa, affettuoso e costante esaltatore, sino all’ultimo, del suo compagno di prigionia». Il Da Como è completamente fuori strada e le parole del Mazzini, altro che accorate, sono aspre e dure. L’agiografia impedisce di vedere la storia.
(Nell’epistolario del Mazzini ci sono altri accenni al Confalonieri? E nelle lettere di altri esuli? Il giudizio reale bisogna appunto cercarlo in queste lettere private, perché difficilmente i fuorusciti avranno in scritti dedicati al pubblico voluto gettare ombre sul Confalonieri. Un’altra ricerca interessante è da farsi negli scritti degli agenti provocatori dell’Austria).
Q3 §82 Cultura storica italiana e francese. La cultura storica e la cultura generale francese ha potuto svilupparsi e diventare «popolare‑nazionale» per la stessa complessità e varietà della storia politica francese negli ultimi 150 anni. La tendenza dinastica si è dissolta per il succedersi di tre dinastie antagoniste tra loro in modo radicale: legittimista, liberale‑conservatrice, militare‑plebiscitaria e per il succedersi di governi repubblicani anch’essi differenziati fortemente: il giacobino, il radicale socialista e l’attuale. È impossibile una «agiografia» nazionale unilineare: ogni tentativo di questo genere appare subito settario, sforzato, utopistico, antinazionale perché è costretto a tagliare via o a sottovalutare pagine incancellabili della storia nazionale (vedi l’attuale tendenza Maurras e la misera storia di Francia del Bainville). Per questa ragione il protagonista della storia francese è diventato l’elemento permanente di queste variazioni politiche, il popolo‑nazione; quindi un tipo di nazionalismo politico e culturale che sfugge ai limiti dei partiti propriamente nazionalistici e che impregna tutta la cultura, quindi una dipendenza e un collegamento stretto tra popolo‑nazione e intellettuali.
Niente di simile in Italia, in cui nel passato occorre ricercare col lanternino il sentimento nazionale, facendo distinzioni, interpretando, tacendo ecc., in cui se si esalta Ferrucci occorre spiegare Maramaldo, se si esalta Firenze occorre giustificare Clemente VII e il papato, se si esalta Milano e la Lega occorre spiegare Como e le città favorevoli al Barbarossa, se si esalta Venezia occorre spiegare Giulio II ecc. Il preconcetto che l’Italia sia sempre stata una nazione complica tutta la storia e domanda acrobazie intellettuali antistoriche. Perciò nella storia del secolo XIX non ci poteva essere unità nazionale, mancando l’elemento permanente, il popolo‑nazione. La tendenza dinastica da una parte doveva prevalere dato l’apporto che le dava l’apparato statale e le tendenze politiche più opposte non potevano avere un minimo comune di obbiettività: la storia era propaganda politica, tendeva a creare l’unità nazionale, cioè la nazione, dall’esterno contro la tradizione, basandosi sulla letteratura, era un voler essere, non un dover essere perché esistono già le condizioni di fatto. Per questa loro stessa posizione, gli intellettuali dovevano distinguersi dal popolo, mettersene fuori, creare tra di loro o rafforzare lo spirito di casta, e nel loro fondo diffidare del popolo, sentirlo estraneo, averne paura, perché in realtà era qualcosa di sconosciuto, una misteriosa idra dalle innumerevoli teste.
Mi pareva che attualmente ci fosse qualche condizione per superare questo stato di cose, ma essa non è stata sfruttata a dovere e la retorica ha ripreso il sopravvento (l’atteggiamento incerto nell’interpretare Caporetto offre un esempio di questo attuale stato di cose, così la polemica sul Risorgimento e ultimamente sul Concordato). Non bisogna negare che molti passi in avanti sono stati compiuti in tutti i sensi, però: sarebbe un cadere in una retorica opposta. Anzi, specialmente prima della guerra, molti movimenti intellettuali erano rivolti a svecchiare e sretorizzare la cultura e ad avvicinarla al popolo, cioè a nazionalizzarla. (Nazione-popolo e nazione‑retorica si potrebbero dire le due tendenze).
(Su questo ultimo argomento cfr Volpe, L’Italia in cammino, dove molte inesattezze di fatto e di proporzioni e dove si osserva il nascere di una nuova retorica; il libro di Croce, La Storia d’Italia, dove difetti di altro genere ma non meno pericolosi, perché la storia viene vanificata nell’astrazione dei concetti; e i libri di Prezzolini sulla cultura italiana).
Q3 §83 Passato e presente. Scuola di giornalismo di Ermanno Amicucci, nella «Nuova Antologia» del 10 luglio 1928. Credo che l’articolo sia poi stato raccolto con altri in un volume.
L’articolo è interessante per le informazioni e gli spunti che dà. La quistione in Italia è più complessa di quanto non paia leggendo l’Amicucci e io credo che i risultati delle iniziative scolastiche non saranno molto grandi. Ma il principio di insegnare il giornalismo e di non lasciare che il giornalista si formi da sé attraverso la pratica è vitale e si andrà sempre più imponendo, a mano a mano che il giornalismo diventa un’industria complessa e un organismo più responsabile.
La quistione in Italia trova i suoi limiti nel fatto che non esistono grandi concentrazioni giornalistiche, per il decentramento della vita nazionale, e che i giornali sono pochi. Il personale giornalistico è scarso e quindi si alimenta normalmente attraverso le sue stesse gradazioni di importanza: i giornali meno importanti servono da scuola per i giornali più importanti e reciprocamente. Un redattore di secondo ordine del «Corriere» diventa direttore o redattore capo di un giornale di provincia; un redattore di primo ordine di un giornale di provincia diventa redattore di secondo ordine di un grande giornale ecc. Non esistono in Italia centri come Parigi, Londra, Berlino ecc., che accolgono migliaia di giornalisti, costituenti una vera categoria professionale economicamente importante, e le retribuzioni in Italia, come media, sono molto basse: in Germania poi il numero dei giornali che si pubblicano in tutto il paese è imponente e alla concentrazione di Berlino corrisponde un’ampia stratificazione nazionale.
Mi pare che, per certi tipi di giornale, il problema deve essere risolto nella stessa redazione, trasformando le riunioni periodiche redazionali in scuola organica di giornalismo, ad assistere alle cui lezioni dovrebbero essere invitati estranei: giovani e studenti, fino ad assumere il carattere di vere scuole politico‑giornalistiche, con lezioni generali (di storia, di economia, di diritto costituzionale ecc.) affidati a estranei competenti ma che sappiano investirsi dei bisogni del giornale. Ogni redattore del giornale, fino ai reporters, dovrebbe essere messo in grado di fare tutte le parti del giornale, così come, subito, ogni redattore dovrebbe diventare un reporter, cioè dare tutta la sua vita al giornale, ecc.
Q3 §84 La morte di Vittorio Emanuele II. In una lettera di Guido Baccelli a Paulo Fambri, del 12 agosto (forse 1880, manca l’anno e 1880 è un’ipotesi del Guidi) pubblicata da Angelo Flavio Guidi (L’Archivio inedito di Paulo Fambri, «Nuova Antologia» del 16 giugno 1928) è scritto: «Il cuore di tutta Italia sanguina ancora al ricordo della morte del glorioso Vittorio Emanuele: quella immensa sciagura però poteva essere cento volte più grande se non si fossero guadagnate colla aspirazione dell’ossigeno parecchie ore di vita». (Seguono puntini, dell’editore Guidi, perché completano tutta la riga, non sono cioè i soliti puntini di sospensione). Cosa significa?
Q3 §85 Arturo Graf. Se occorrerà di scrivere di Giovanni Cena e del suo programma sociale, bisognerà ricordare il Graf e la sua crisi spirituale che lo riportò alla religione o per lo meno al teismo. (Cfr O. M. Barbano, Per una fede, Da lettere inedite di Arturo Graf, nella Nuova Antologia del 16 luglio 1928. Il Barbano era un allievo e amico del Graf e pubblica i brani delle lettere dal Graf scrittegli intorno alla sua crisi e al suo volumetto Per una fede che ebbe ripercussioni scarse all’infuori dei famigliari). In queste lettere sono interessanti alcuni accenni ai rapporti tra il Graf e il modernismo (conosciuto attraverso la rivista «Il Rinnovamento») per cui si potrebbe forse dire che la crisi del Graf è legata alla crisi generale del tempo, manifestatasi in certi gruppi intellettuali, scontenti della «scienza», ma scontenti anche della religione ufficiale.
Q3 §86 Lorianismo. Alfredo Trombetti. Per molti aspetti può esser fatto rientrare nel lorianismo, sempre con l’avvertenza che ciò non significa un giudizio complessivo su tutta la sua opera ma un semplice giudizio di squilibrio tra la «logicità» e il contenuto concreto dei suoi studi. Il Trombetti era un formidabile poliglotta, ma non è un glottologo, o almeno il suo glottologismo non si identificava con il suo poliglottismo: la conoscenza materiale di innumerevoli lingue gli prende la mano sul metodo scientifico.
Inoltre egli era un illuminato: la teoria della monogenesi del linguaggio era la prova della monogenesi dell’umanità, con Adamo ed Eva a capostipiti. Perciò i cattolici lo applaudirono ed egli diventò popolare, cioè fu «legato» alla sua teoria da un punto d’onore non scientifico ma ideologico. Negli ultimi tempi ebbe riconoscimenti ufficiali e fu esaltato dai giornali quotidiani come una gloria nazionale, specialmente per l’annunzio dato a un Congresso Internazionale di Linguistica (dell’Aja, ai primi del 28) della decifrazione dell’Etrusco. Mi pare però che l’Etrusco continui a essere indecifrato come prima e che tutto si riduca a un ennesimo tentativo fallito.
Nella Nuova Antologia del 16 luglio 1928, è pubblicato un articolo di Pericle Ducati, Il Primo Congresso Internazionale Etrusco 27 aprile ‑ 3 maggio 1928 in cui si parla in modo molto strano, ma up to date, della «scoperta» del Trombetti. A p. 199 si parla di «conseguita decifrazione» dell’etrusco, «mercè soprattutto gli sforzi di un Italiano, di Alfredo Trombetti». A p. 204 la «conseguita decifrazione» è invece ridotta a «un passo gigantesco nella interpretazione dell’etrusco». La tesi del Trombetti è questa, già fissata da lui nel Convegno Nazionale Etrusco del 1926: l’etrusco è una lingua intermedia, insieme ad altri idiomi dell’Asia Minore e pre‑ellenici, tra il gruppo caucasico e il gruppo arioeuropeo con maggiori affinità con quest’ultimo; perciò il lemnio, quale appare dalle due iscrizioni della stele famosa, e l’etrusco quasi s’identificano. Questa tesi rientra nel sistema generale del Trombetti che presuppone provata la monogenesi e quindi ha una base molto fragile. E ancora, presuppone certa l’origine transmarina degli Etruschi, mentre questa opinione, se è la più diffusa, non è universale: Gaetano De Sanctis e Luigi Pareti sostengono invece l’origine transalpina e non sono due studiosi da disprezzare.
Al Congresso Internazionale Etrusco il Trombetti è passato alla più precisa determinazione della grammatica ed alla ermeneutica dei testi, saggio del suo libro La lingua etrusca uscito poco dopo. Ebbe grande successo. Contraddittori, non tra gli stranieri, nota il Ducati, ma tra i nazionali, pur «garbatamente e facendo onore alla eccezionale valentia del Trombetti». «Un giovane ed ormai valoroso glottologo, Giacomo Devoto, si è preoccupato del metodo, ché il rigore del metodo gli è sembrato intaccato dalle investigazioni e dai risultati del Trombetti». Qui il Ducati fa una serie di considerazioni veramente strabilianti sul metodo della glottologia e contro il Devoto, concludendo: «Guardiamo pertanto ai risultati del Trombetti e non sottilizziamo». Si è visto poi cosa voleva dire non sottilizzare.
Nelle scienze in generale il metodo è la cosa più importante: in certe scienze poi, che necessariamente devono basarsi su un corredo ristretto di dati positivi, ristretto e non omogeneo, le quistioni di metodo sono ancor più importanti, se non sono addirittura tutto. Non è difficile con un po’ di fantasia costruire ipotesi su ipotesi e dare un’apparenza brillante di logicità a una dottrina: ma la critica di queste ipotesi rovescia tutto il castello di carta e trova il vuoto sotto il brillante.
Ha il Trombetti trovato un nuovo metodo? Questa è la quistione. Questo nuovo metodo fa progredire la scienza più del vecchio, interpreta meglio ecc.? Niente di tutto ciò. Anche qui appare come il nazionalismo introduca deviazioni dannose nella valutazione scientifica e quindi nelle condizioni pratiche del lavoro scientifico. Il Bartoli ha trovato un nuovo metodo, ma esso non può far chiasso interpretando l’etrusco: il Trombetti invece afferma di aver decifrato l’etrusco, quindi risolto uno dei più grandi e appassionanti enigmi della storia: applausi, popolarità, aiuti economici ecc. Il Ducati ripete, approvando, ciò che gli disse al Congresso un glottologo «assai egregio»: «il Trombetti è un’eccezione: si eleva egli assai al disopra di noi e ciò che a noi non sembra lecito di tentare, a lui è possibile di compiere», e aggiunge le opinioni molto profonde del paleontologo Ugo Antonielli. Per l’Antonielli il Trombetti è un: «gigante buono che addita una diritta e sicura via». E se, come argutamente (!) aggiunge lo stesso Antonielli, il nostro italianissimo Trombetti, «per la supina sensibilità di taluni, si fosse chiamato Von Trombetting ovvero Trombetty...»
Poiché la quistione si poneva così, bisogna convenire che il Devoto e gli altri oppositori furono degli eroi e che c’è qualcosa di sano nella scienza italiana. Il Ducati appoggia questa tendenza nazionalistica nella scienza, senza accorgersi delle contraddizioni in cui cade: se il Trombetti additasse una via diritta e sicura, avrebbe appunto rinnovato o sviluppato e perfezionato il metodo e allora sarebbe lecito tentare a tutti gli studiosi ciò che egli ha fatto. O l’uno o l’altro: o il Trombetti è al di sopra della scienza per sue particolari doti di intuizione o addita una via per tutti. «Caso curioso! Tra i glottologi raccolti a Firenze il Trombetti ha raccolto il plauso più incondizionato tra gli stranieri». E allora perché il Ducati riporta il «Von Trombetting»? O non indica ciò piuttosto che la glottologia italiana è più seria e progredita di quella straniera? Può capitare proprio questo bel caso al nazionalismo scientifico: di non accorgersi delle vere «glorie» nazionali e di essere proprio esso, lo schiavo, il supino servo degli stranieri!
Q3 §87 Per la formazione delle classi intellettuali italiane nell’alto Medioevo bisogna tener conto oltre che della lingua (quistione del Mediolatino) anche e specialmente del diritto. Caduta del diritto romano dopo le invasioni barbariche e sua riduzione a diritto personale e consuetudinario in confronto del diritto longobardo; emersione del diritto canonico che da diritto particolare, di gruppo, assurge a diritto statale; rinascita del diritto romano e sua espansione per mezzo delle Università. Questi fenomeni non avvengono di colpo e simultaneamente ma sono legati allo sviluppo storico generale (fusione dei barbari con le popolazioni locali ecc.). Lo sviluppo del diritto canonico e l’importanza che esso assume nell’economia giuridica delle nuove formazioni statali, il formarsi della mentalità imperiale‑cosmopolita medioevale, lo sviluppo del diritto romano adattato e interpretato per le nuove forme di vita danno luogo al nascere e allo stratificarsi degli intellettuali italiani cosmopoliti.
C’è un periodo, quello dell’egemonia del diritto germanico, in cui però il legame tra il vecchio e il nuovo rimane quasi unicamente la lingua, il Mediolatino. Il problema di questa interruzione ha interessato la scienza e cosa importante ha interessato anche intellettuali come il Manzoni (vedi suoi scritti sui rapporti tra romani e longobardi a proposito dell’Adelchi): cioè ha interessato nel principio del secolo XIX quelli che si preoccupavano della continuità della tradizione italiana dall’antica Roma in poi per costituire la nuova coscienza nazionale.
Sull’argomento generale dell’oscuramento del diritto romano e sua rinascita e dell’emergere del diritto canonico cfr I «due diritti» e il loro odierno insegnamento in Italia di Francesco Brandileone (Nuova Antologia del 16 luglio 1928) per avere alcune idee generali, ma vedere, naturalmente le grandi storie del diritto.
Schema estratto dal saggio del Brandileone:
Nelle scuole dell’Impero Romano a Roma, a Costantinopoli, a Berito, si insegnava solo il diritto romano nelle due positiones di jus publicum e di jus privatum; nel jus publicum era compreso il jus sacrum pagano, finché il paganesimo fu religione tanto dei sudditi che dello Stato. Comparso il Cristianesimo e ordinatosi, nei secoli delle persecuzioni e delle tolleranze, come società a sé, diversa dalla società politica, esso dié luogo a un jus sacrum nuovo. Dopo che il Cristianesimo fu prima riconosciuto e poi elevato dallo Stato a fede unica dell’Impero, il nuovo jus sacrum ebbe bensì appoggi e riconoscimenti da parte del legislatore laico, ma non fu però considerato come l’antico. Poiché il Cristianesimo si era separato dalla vita sociale politica, si era staccato anche dal jus publicum e le scuole non si occupavano del suo ordinamento; il nuovo jus sacrum formò la speciale occupazione delle scuole tutte proprie della società religiosa (questo fatto è molto importante nella storia dello Stato romano ed è ricco di gravi conseguenze, perché inizia un dualismo di potestà che avrà lo sviluppo nel Medio Evo: ma il Brandileone non lo spiega: lo pone come una conseguenza logica dell’originario distacco del Cristianesimo dalla società politica. Benissimo, ma perché diventato il Cristianesimo religione dello Stato come lo era stato il paganesimo, non si ricostituì l’unità formale politico‑religiosa? Questo è il problema).
Durante i secoli dell’alto Medio Evo il nuovo jus sacrum, detto anche jus canonicum o jus ecclesiasticum e il jus romanum furono insegnati in scuole diverse e in scuole di diversa importanza numerica, di diffusione, di attività. Speciali scuole romanistiche, sia che continuassero le antiche scuole sia che fossero sorte allora, in Occidente, si incontrano solo in Italia; se anche fuori d’Italia vi furono le Scholae liberalium artium e se in esse (così come nelle corrispondenti italiane) si impartirono nozioni elementari di diritto laico, specialmente romano, l’attività spiegata fu povera cosa come è attestato dalla scarsa, frammentaria, intermittente e di solito maldestra produzione da esse uscita e giunta sino a noi. Invece le scuole ecclesiastiche, dedicate allo studio e all’insegnamento dei dogmi della fede e insieme del diritto canonico, furono una vera moltitudine, né solo in Italia, ma in tutti i paesi diventati cristiani e cattolici. Ogni monastero e ogni chiesa cattedrale di qualche importanza ebbe la propria scuola: testimonianza di questa attività la ricchezza di collezioni canoniche senza interruzione dal vi all’XI secolo, in Italia, in Africa, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda. La spiegazione di questo rigoglio del diritto canonico in confronto di quello romano è legata al fatto che mentre il diritto romano, in quanto continuava a ricevere applicazione in Occidente e in Italia, era degradato a diritto personale, ciò non avveniva per il canonico.
Per il diritto romano, l’essere diventato diritto personale volle dire essere messo in una posizione inferiore a quella spettante alle leggi popolari o Volksrechte, vigenti nel territorio dell’Impero d’Occidente, la cui conservazione e modificazione spettavano non già al potere sovrano, regio o imperiale, o per lo meno non ad esso solo, ma anche e principalmente alle assemblee dei popoli ai quali appartenevano. Invece i sudditi romani dei regni germanici, e poi dell’Impero, non furono considerati come un’unità a sé, ma come singoli individui, e quindi non ebbero una particolare assemblea, autorizzata a manifestare la sua volontà collettiva circa la conservazione e modificazione del proprio diritto nazionale. Sicché fu ridotto il diritto romano a un puro diritto consuetudinario.
Nell’Italia longobarda principi e istituti romani furono accettati dai vincitori ma la posizione del diritto romano non mutò.
La rinnovazione dell’Impero con Carlo Magno non tolse il diritto romano dalla sua posizione d’inferiorità: essa fu migliorata, ma solo tardi e per il concorso di altre cause: in complesso continuò in Italia a rimanere diritto personale fino al secolo XI. Le nuove leggi fatte dai nuovi imperatori, fino a tutto il secolo XI, non furono aggiunte al Corpus giustinianeo, ma all’Editto longobardo, e quindi non furono riguardate come diritto generale obbligatorio per tutti, ma come diritto personale proprio dei viventi a legge longobarda.
Per il diritto canonico invece la riduzione a diritto personale non avvenne, essendo il diritto di una società diversa e distinta dalla società politica, l’appartenenza alla quale non era basata sulla nazionalità: esso possedeva nei concilii e nei papi il suo proprio potere legislativo. Esso però aveva una sfera di obbligatorietà ristretta. Diventa obbligatorio o perché viene accettato spontaneamente o perché fu accolto fra le leggi dello Stato.
La posizione del diritto romano si venne modificando radicalmente in Italia a mano a mano che dopo l’avvento degli Ottoni l’impero fu concepito più chiaramente ed esplicitamente come la continuazione dell’antico. Fu la scuola pavese che si rese interprete di un tal fatto e proclamò la legge romana omnium generalis, preparando l’ambiente in cui poté sorgere e fiorire la scuola di Bologna e gli imperatori svevi riguardarono il Corpus giustinianeo come il codice loro, al quale fecero delle aggiunte. Questo riaffermarsi del diritto romano non è dovuto a fattori personali: esso è legato al rifiorire dopo il mille della vita economica, dell’industria, del commercio, del traffico marittimo. Il diritto germanico non si prestava a regolare giuridicamente la nuova materia e i nuovi rapporti.
Anche il diritto canonico subisce dopo il mille un cambiamento.
Coi Carolingi alleati al papato viene concepita la monarchia universale abbracciante tutta l’umanità, diretta concordemente dall’Imperatore nel temporale e dal Papa nello spirituale. Ma questa concezione non poteva delimitare a priori il campo soggetto a ciascuna potestà e lasciava all’Imperatore una larga via d’intervento nelle faccende ecclesiastiche. Quando i fini dell’Impero, già sotto gli stessi Carolingi e poi sempre più in seguito, si mostrarono discordanti da quelli della Chiesa e lo Stato mostrò di tendere all’assorbimento della gerarchia ecclesiastica nello Stato, incominciò la lotta che si chiuse al principio del secolo XII colla vittoria del Papato. Fu proclamata la primazia dello spirituale (sole-luna) e la Chiesa riacquistò la libertà della sua azione legislativa ecc. ecc. Questa concezione teocratica fu combattuta teoricamente e praticamente, ma tuttavia essa, nella sua forma genuina o attenuata, rimase dominatrice per secoli e secoli. Così si ebbero due tribunali, il sacramentale e il non sacramentale, e così i due diritti furono accoppiati, utrumque ius, ecc.
Q3 §88 La ricerca della formazione storica degli intellettuali italiani porta così a risalire fino ai tempi dell’Impero romano, quando l’Italia, per avere nel suo territorio Roma, diventa il crogiolo delle classi colte di tutti i territori imperiali. Il personale dirigente diventa sempre più imperiale e sempre meno latino, diventa cosmopolita: anche gli imperatori non sono latini ecc.
C’è dunque una linea unitaria nello sviluppo delle classi intellettuali italiane (operanti nel territorio italiano) ma questa linea di sviluppo è tutt’altro che nazionale: il fatto porta a uno squilibrio interno nella composizione della popolazione che vive in Italia ecc.
Il problema di ciò che sono gli intellettuali può essere mostrato in tutta la sua complessità attraverso questa ricerca.
Q3 §89 Lorianismo. A questa corrente occorre collegare la famosa controversia sui libri perduti di Tito Livio che sarebbero stati ritrovati a Napoli qualche anno fa da un professore che acquistò così qualche istante di celebrità forse non desiderata. Secondo me le cause di questo scandaloso episodio sono da ricercare negli intrighi del prof. Francesco Ribezzo e nella abulia del professore in parola di cui non ricordo il nome. Questo professore pubblicava una rivista, il prof. Ribezzo un’altra rivista concorrente, ambedue inutili o quasi (ho visto la rivista del Ribezzo per molti anni e ho conosciuto il Ribezzo per quello che vale): i due si contendevano una cattedra all’Università di Napoli. Fu il Ribezzo a pubblicare nella sua rivista l’annunzio della scoperta fatta (!) dal collega, che così si trovò fatto centro della curiosità dei giornali e del pubblico e fu liquidato scientificamente e moralmente. Il Ribezzo non ha nessuna capacità scientifica: quando lo conobbi io, nel 1910‑11 aveva dimenticato il greco e il latino quasi completamente ed era uno «specialista» di linguistica comparata arioeuropea. Questa sua ignoranza risaltava così manifesta che il Ribezzo ebbe frequenti conflitti violenti con gli allievi. Al Liceo di Palermo fu implicato nello scandalo dell’uccisione di un professore da parte di uno studente (mi pare nel 1908 o nel 1909). Mandato a Cagliari in punizione entrò in conflitto con gli studenti, conflitto che nel 1912 diventò acuto, con polemiche nei giornali, minacce di morte al Ribezzo ecc. che fu dovuto trasferire a Napoli. Il Ribezzo doveva essere fortemente sostenuto dalla camorra universitaria napoletana (Cocchia e C.). Partecipò al concorso per la cattedra di glottologia dell’Università di Torino: poiché fu nominato il Bartoli, fece una pubblicazione ridevole ecc.
Q3 §90 Storia delle classi subalterne (cfr a pp. 10 e 12). La unificazione storica delle classi dirigenti è nello Stato e la loro storia è essenzialmente la storia degli Stati e dei gruppi di Stati. Questa unità deve essere concreta, quindi il risultato dei rapporti tra Stato e «società civile». Per le classi subalterne l’unificazione non avviene: la loro storia è intrecciata a quella della «società civile», è una frazione disgregata di essa. Bisogna studiare: 1) il formarsi obbiettivo per lo sviluppo e i rivolgimenti, avvenuti nel mondo economico, la loro diffusione quantitativa e l’origine da altre classi precedenti; 2) il loro aderire alle formazioni politiche dominanti passivamente o attivamente, cioè tentando di influire sui programmi di queste formazioni con rivendicazioni proprie; 3) nascita di partiti nuovi della classe dominante per mantenere il controllo delle classi subalterne; 4) formazioni proprie delle classi subalterne di carattere ristretto e parziale; 5) formazioni politiche che affermano l’autonomia di esse ma nel quadro vecchio; 6) formazioni politiche che affermano l’autonomia integrale, ecc. La lista di queste fasi può essere ancora precisata con fasi intermedie o con combinazioni di più fasi. Lo storico nota la linea di sviluppo verso l’autonomia integrale, dalle fasi più primitive. Perciò, anche la storia di un Partito di queste classi è molto complessa, in quanto deve includere tutte le ripercussioni della sua attività per tutta l’area delle classi subalterne nel loro complesso: tra queste una eserciterà già una egemonia, e ciò occorre fissare studiando gli sviluppi anche di tutti gli altri partiti in quanto includono elementi di questa classe egemone o delle altre classi subalterne che subiscono questa egemonia.
Un canone di ricerca storica si potrebbe costruire studiando la storia della borghesia in questo modo (queste osservazioni si collegano alle sul Risorgimento): la borghesia ha preso il potere lottando contro determinate forze sociali aiutata da determinate altre forze; per unificarsi nello Stato doveva eliminare le une e avere il consenso attivo o passivo delle altre. Lo studio del suo sviluppo di classe subalterna deve dunque ricercare le fasi attraverso cui ha conquistato un’autonomia in confronto dei nemici futuri da abbattere e ha conquistato l’adesione di quelle forze che l’hanno aiutata attivamente o passivamente in quanto senza questa adesione non avrebbe potuto unificarsi nello Stato. Il grado di coscienza cui era arrivata la borghesia nelle varie fasi si misura appunto con questi due metri e non solo con quello del suo distacco dalla classe che la dominava; di solito appunto si ricorre solo a questo e si ha una storia unilaterale o talvolta non si capisce nulla, come nel caso della storia italiana dai Comuni in poi: la borghesia italiana non seppe unificare il popolo, ecco una causa delle sue sconfitte e delle interruzioni del suo sviluppo: anche nel Risorgimento questo «egoismo» ristretto impedì una rivoluzione rapida e vigorosa come quella francese.
Ecco una delle quistioni più importanti e delle cause di difficoltà nel fare la storia delle classi subalterne.
Q3 §91 I nipotini di Padre Bresciani. La fiera del libro. Poiché
il popolo non va al libro, il libro andrà al popolo. Questa
iniziativa è dovuta alla «Fiera Letteraria» e al suo direttore
d’allora, Umberto Fracchia, che la lanciò e attuò nel 1927 a
Milano. L’iniziativa in sé non è cattiva e può dare qualche
piccolo risultato. La questione però rimane sempre la stessa:
che il libro deve diventare intimamente nazionale‑popolare per
andare al popolo e non solo andare al popolo «materialmente» con
le bancarelle e gli strilloni ecc.
Q3 §92 Federico Confalonieri. Il Confalonieri prima di andare allo Spielberg e dopo la liberazione prima di andare nel carcere di Gradisca per essere poi deportato, andò a Vienna. Vedere se anche in questo secondo soggiorno a Vienna, fatto per ragioni di salute, ebbe contatti con uomini politici austriaci.
Q3 §93 Giovanni Cena. Sull’attività svolta dal Cena per le scuole dei contadini dell’Agro Romano cfr le pubblicazioni di Alessandro Marcucci.
Q3 §94 I nipotini di padre Bresciani. Polifilo (Luca Beltrami). Per rintracciare gli scritti brescianeschi del Beltrami (I popolari di Casate Olona ecc. pubblicati nel «Romanzo Mensile», nella «Lettura», ecc.) vedere la Bibliografia degli scritti di Luca Beltrami dal marzo 1881 al marzo 1930, curata da Fortunato Pintor, bibliotecario onorario del Senato, e con prefazione di Guido Mazzoni. Da un cenno bibliografico pubblicato nel «Marzocco» dell’11 maggio 1930 appare che gli scritti sull’ipotetico «Casate Olona» del Beltrami sono stati ben trentacinque (io ne ho letto solo tre o quattro). Il Beltrami ha postillato questa sua Bibliografia e a proposito di «Casate Olona» il «Marzocco» scrive: «... la bibliografia dei trentacinque scritti sull’ipotetico “Casate Olona” gli suggerisce l’idea di ricomporre in unità quelle sue dichiarazioni proposte e polemiche d’indole politicosociale che, male intonate a un regime democratico‑parlamentare, sotto un certo aspetto debbono considerarsi un’anticipazione di cui altri – non il Beltrami – avrebbe potuto menar vanto di antiveggente precursore (!?)». Poiché anche il «Marzocco» si abbandona a queste scurrilità sarebbe interessante ricordare l’atteggiamento assunto dal foglio fiorentino a proposito della fucilazione di F. Ferrer.
Q3 §95 I nipotini di padre Bresciani. Romanzi d’appendice e teatro popolare (dramma da arena, drammone da arena ecc.). (Perché si chiama, precisamente, d’arena, il dramma popolare? Dal fatto delle Arene popolari come l’Arena del Sole di Bologna? Vedere ciò che scrisse Edoardo Boutet sugli spettacoli per le lavandaie che la Compagnia Stabile di Roma diretta dal Boutet dava all’Arena del Sole di Bologna il lunedì – giorno delle lavandaie –. Questo capitolo dei ricordi teatrali del Boutet lo lessi nel «Viandante» di Monicelli, che usciva a Milano nel 1908‑9.
Nel «Marzocco» del 17 novembre 1929 è pubblicata una nota di Gaio (Adolfo Orvieto) molto significativa: «Danton», il melodramma e il «romanzo nella vita». Comincia così: «Una Compagnia drammatica di recente “formazione” che ha messo insieme un repertorio di grandi spettacoli popolari – dal Conte di Montecristo alle Due Orfanelle – con la speranza legittima di richiamare un po’ di gente a teatro, ha visto i suoi voti esauditi – a Firenze – con un novissimo dramma di autore ungherese e di soggetto franco‑rivoluzionario: Danton». Il dramma è di De Pekar ed è «pura favola patetica con particolari fantastici di estrema libertà» (– per es. Robespierre e Saint‑Just assistono al processo di Danton e altercano con lui ecc. –). «Ma è favola, tagliata alla brava, che si vale dei vecchi metodi infallibili del teatro popolare, senza pericolose deviazioni modernistiche. Tutto è elementare, limitato, di taglio netto. Le tinte fortissime e i clamori si alternano alle opportune smorzature e il pubblico respira e consente. Mostra di appassionarsi e si diverte. Che sia questa la strada migliore per riportarlo al teatro di prosa?»
La conclusione dell’Orvieto è significativa. Così nel 1929 per aver pubblico a teatro bisogna rappresentare il Conte di Monte Cristo e le Due Orfanelle e nel 1930 per far leggere i giornali bisogna pubblicare in appendice il Conte di Monte Cristo e Giuseppe Balsamo.
Q3 §96 I nipotini di padre Bresciani. Romanzi popolari. Ricerche statistiche: quanti romanzi italiani hanno pubblicato i periodici popolari più diffusi? Il «Romanzo Mensile», la «Domenica del Corriere», la «Tribuna Illustrata», il «Mattino Illustrato»? La «Domenica del Corriere» forse nessuno in tutta la sua vita (32° anno nel 1930) su circa 80 o 90 romanzi che avrà pubblicato. Credo che la «Tribuna Illustrata» ne abbia pubblicato qualcuno: ma occorre notare che la «Tribuna Illustrata» è enormemente meno popolare della «Domenica» e ha un tipo suo di romanzo. Sarebbe poi interessante vedere la nazionalità degli autori e il tipo dei romanzi d’avventura pubblicati. Il «Romanzo Mensile» e la «Domenica» pubblicano molti romanzi inglesi e di tipo poliziesco (hanno pubblicato Sherlok Holmes) ma anche tedeschi, ungheresi (la baronessa Orczy, che mi pare ungherese, è diventata molto popolare e i suoi romanzi sulla Rivoluzione francese hanno avuto varie edizioni nel «Romanzo Mensile» che pure deve avere una tiratura rispettabile – mi pare sia giunto a 25 000 esemplari) e persino australiani (di Guido Boothby che ha avuto pure diverse edizioni). Così nel «Romanzo Mensile» e nella «Domenica» deve prevalere il tipo d’avventura poliziesca. Sarebbe interessante sapere chi al «Corriere» era incaricato di scegliere questi romanzi e da quali criteri partiva.
Il «Mattino Illustrato», sebbene esca a Napoli, pubblica romanzi di tipo «Domenica», ciò che significa che c’è un gusto diffuso. Relativamente e forse anche in modo assoluto l’amministrazione del «Corriere della Sera» è la maggiore diffonditrice di questi romanzi popolari: ne pubblica almeno 15 all’anno e con tirature altissime. Deve venire poi la Casa Sonzogno (forse qualche anno fa la Sonzogno pubblicava molto di più che il «Corriere»). Un confronto nel tempo dell’attività editoriale della Sonzogno darebbe un quadro delle variazioni avvenute nel gusto del pubblico popolare: sarebbe interessante farlo, ma di una certa difficoltà, perché la Sonzogno non pubblica l’anno di stampa e non numera il più delle volte le edizioni. Uno studio dei Cataloghi darebbe forse dei risultati. Il confronto tra il catalogo di 40 anni o 50 anni fa e quello odierno sarebbe già interessante: tutto il romanzo lacrimoso‑sentimentale deve essere caduto nel dimenticatoio eccetto qualche «capolavoro» del genere che deve resistere ancora (come la Capinera del mulino mi pare del Richebourg). Così è interessante seguire le pubblicazioni di questi romanzi a dispense.
Un certo numero di romanzi popolari italiani devono aver pubblicato il Perino e recentemente il Nerbini, tutti a fondo anticlericale, dipendenti dal guerrazzismo. Anche una lista delle case editrici di questa merce sarebbe interessante.
Q3 §97 Il Concordato. Allegata alla legge delle Guarantigie fu una disposizione in cui si fissava che se nei prossimi 5 anni dopo la promulgazione della legge stessa il Vaticano rifiutava di accettare l’indennità stabilita, il diritto all’indennità sarebbe venuto a cadere. Appare invece che nei bilanci fino al 1928 era sempre impostata la voce dell’indennità al Papa: come mai? fu forse modificata la disposizione del 1871 allegata alle Guarantigie e quando e per quali ragioni? La quistione è molto importante.
Q3 §98 Spartaco. Una osservazione casuale di Cesare (Bell. Gall., I, 40,5) rivela il fatto che i prigionieri di guerra cimbri furono il nucleo della rivolta di schiavi sotto Spartaco. Questi rivoltosi furono annientati. (Cfr Tenney Frank, Storia economica di Roma, trad. it., Ed. Vallecchi, p. 153). (Vedi nel Frank, in questo stesso capitolo, le osservazioni e le congetture sulla diversa sorte delle varie nazionalità di schiavi e sulla loro sopravvivenza probabile in quanto furono distrutti o si assimilarono alla popolazione indigena o addirittura la sostituirono).
99 La legge del numero (base psicologica delle manifestazioni pubbliche: processioni, assemblee popolari ecc.). A Roma gli schiavi non potevano essere riconosciuti come tali. Quando un senatore propose una volta che agli schiavi fosse dato un abito che li distinguesse, il Senato fu contrario al provvedimento, per timore che gli schiavi divenissero pericolosi qualora potessero rendersi conto del loro grande numero. Seneca, De clem., I, 24. Cfr Tacito, Annali, 4, 27.
Q3 §100 I nipotini di padre Bresciani. Letteratura popolare. La collezione «Tolle et lege» della Casa ed. «Pia Società S. Paolo» Alba-Roma, su 111 numeri del 1928 ne aveva 65 di libri scritti dal gesuita Ugo Mioni. Eppure non devono essere tutti i libri di questo scrittore, che d’altronde non ha scritto solo romanzi d’avventura o di apologetica cristiana: ha scritto anche un grosso trattato di «Missionologia» per esempio.
Q3 §101 I nipotini di padre Bresciani. Carattere antipopolare o apopolare‑nazionale della letteratura italiana. Vedere se su tale argomento ha scritto qualche letterato moderno. Qualcosa deve aver scritto Adriano Tilgher e anche Gino Saviotti. Del Saviotti trovo citato nell’«Italia letteraria» del 24 agosto 1930 questo brano da un articolo sul Parini pubblicato nell’«Ambrosiano» del 15 agosto: «Buon Parini, si capisce perché avete sollevato la poesia italiana, ai vostri tempi. Le avete dato la serietà che le mancava, avete trasfuso nelle sue aride vene il vostro buon sangue popolano. Vi sieno rese grazie anche in questo giorno dopo centotrentun’anni dalla vostra morte. Ci vorrebbe un altro uomo come voi, oggi, nella nostra cosidetta poesia!».
Q3 §102 Passato e presente. Scuola di giornalismo (cfr pp. 48 bis ‑ 49). Il numero dei giornalisti italiani. Nelle «Notizie sindacali» pubblicate dall’«Italia Letteraria» del 24 agosto 1930 si riportano i dati di un censimento eseguito dalla Segreteria del Sindacato Nazionale dei giornalisti: al 30 giugno, 1960 giornalisti inscritti dei quali 800 inscritti al partito fascista, così ripartiti: Sindacato di Bari 30 e 26; Bologna 108 e 10; Firenze 108 e 43; Genova 113 e 39; Milano 348 e 143; Napoli 106 e 45; Palermo 50 e 17; Roma 716 e 259; Torino 144 e 59; Trieste 90 e 62; Venezia 147 e 59.
Q3 §103 Il Risorgimento e le classi rivoluzionarie. Nell’edizione Laterza delle «Memorie storiche dei regno di Napoli dal 1790 al 1815» di Francesco Pignatelli Principe di Strongoli (Nino Cortese, Memorie di un generale della Repubblica e dell’Impero, 2 voll. in 8° di pp. 136‑CCCCXXV, 312, L. 60), il Cortese premette un’introduzione, «Stato e ideali politici nell’Italia meridionale nel settecento e l’esperienza di una rivoluzione», in cui affronta il problema: come mai, nel Mezzogiorno d’Italia, la nobiltà apparisca dalla parte dei rivoluzionari e sia poi ferocemente perseguitata dalla reazione, mentre in Francia nobiltà e monarchia sono unite davanti al pericolo rivoluzionario. Il Cortese risale ai tempi di Carlo di Borbone per trovare il punto di contatto tra la concezione degli innovatori aristocratici e quella dei borghesi; per i primi la libertà e le necessarie riforme devono essere garantite soprattutto da un parlamento aristocratico, mentre sono disposti ad accettare la collaborazione dei migliori della borghesia; per questa il controllo deve essere esercitato e la garanzia della libertà affidata all’aristocrazia dell’intelligenza, del sapere, della capacità ecc. da qualsiasi parte venga. Per ambedue lo Stato deve essere governato dal re, circondato, illuminato e controllato da una aristocrazia. Nel 1799, dopo la fuga del re, si ha prima il tentativo di una repubblica aristocratica da parte dei nobili e poi quello degli innovatori borghesi nella successiva repubblica napoletana.
Mi pare che i fatti napoletani non possano essere contrapposti a quelli francesi: anche in Francia ci fu una rottura fra nobili e monarchia e un’alleanza tra monarchia, nobili e alta borghesia. Solo che in Francia la rivoluzione ebbe la forza motrice anche nelle classi popolari che le impedirono di fermarsi ai primi stadi, ciò che mancò invece nell’Italia meridionale e successivamente in tutto il Risorgimento. Il libro del Cortese è da vedere.
Q3 §104 Letteratura popolare. Antologia degli scrittori operai americani pubblicata nel 1930 dalle edizioni Les Revues (Poèmes d’ouvriers américains traduits par N. Guterman e P. Morhange, 9 franchi: hanno avuto molto successo nella critica francese come si vede dagli estratti pubblicati nel prospetto dell’editore).
Nel 1925 alle «Editions Aujourd’hui» è stata pubblicata una Anthologie des écrivains ouvriers raccolta da Gaston Depresle, con prefazione di Barbusse: doveva essere in due volumi, ma è stato pubblicato solo il primo volume. (Pubblica scritti, tra gli altri, di Marguerite Andoux, Pierre Hamp ecc.).
La Librairie Valois – place du Panthéon (V°) 7 – ha pubblicato nel 1930: Henry Poulaille, Nouvel âge littéraire, nel cui prospetto di pubblicità sono elencati i nomi di Charles Louis Philippe, Carlo Peguy, Giorgio Sorel, L. et M. Bonneff, Marcel Martinet, Carlo Vildrac ecc. (Non appare se sia un’antologia o una raccolta di articoli critici del Poulaille: pubblicata da Valois, con nomi tipici come Sorel ecc.).
Q3 §105 Lorianesimo. Le noccioline americane e il petrolio. In una nota sul lorianesimo ho accennato alla proposta di un colonnello di coltivare ad arachidi 50 000 Km2 per avere il fabbisogno italiano in olii combustibili. Si tratta del colonnello del Genio navale ingegnere Barberis, che ne parlò in una comunicazione Il Combustibile liquido e il suo avvenire al Congresso delle Scienze tenuto in Perugia nell’ottobre 1927. (Cfr Manfredi Gravina, Olii, petroli e benzina, nella «Nuova Antologia» del 1° gennaio 1928, nota a p. 71).
Q3 §106 Il Prof. H. de Vries de Heekelingen insegna(va?) paleografia e diplomatica nella Università cattolica di Nimega (Olanda). Ha fondato a Losanna nel 1927 il Centro Internazionale di Studi sul Fascismo. Ha collaborato alla «Critica fascista». (Sull’organizzazione di questo Centro cfr le notizie pubblicate nella Nuova Antologia del 16 gennaio 1928). Il Centro fa un servizio di informazione per chiunque su ogni argomento che possa avere rapporto col fascismo.
Q3 §107 Le classi sociali nel Risorgimento. Vedere il volume di Niccolò Rodolico, Il popolo agli inizi del Risorgimento, Firenze, Le Monnier, 8°, pp. 312. Nello statuto della Società Esperia fondata dai fratelli Bandiera si diceva: «Non si facciano, se non con sommo riguardo, affiliazioni tra la plebe, perché dessa quasi sempre per natura è imprudente e per bisogno corrotta. È da rivolgersi a preferenza ai ricchi, ai forti e ai dotti, negligendo i poveri, i deboli, gli ignoranti». Bisogna raccogliere tutte le osservazioni che nel primo periodo del Risorgimento (prima del 48) si riferiscono a questo argomento e vedere donde è originata questa diffidenza: processi del 21 in Piemonte, differenza nell’atteggiamento dei soldati e degli ufficiali – i soldati o tradirono o si mostrarono molto deboli nell’istruzione dei processi –. Atteggiamento di Mazzini prima del 1853 e dopo: vedere le sue istruzioni a Crispi per la fondazione di sezioni del Partito d'Azione in Portogallo, con la raccomandazione di mettere operai nei Comitati.
Q3 §108 L’equazione personale. I calcoli dei movimenti stellari Sono turbati da quella che gli scienziati chiamano l’«equazione personale» che bisogna correggere. Vedere esattamente come si calcola questo errore e come esso si verifica e con quali criteri. In ogni modo la nozione di «equazione personale» può essere utile anche in altri campi.
Q3 §109 I nipotini di Padre Bresciani. Italo Svevo e i letterati italiani. Italo Svevo fu «rivelato» da James Joyce. Commemorando lo Svevo la «Fiera Letteraria» sostenne che prima di questa rivelazione c’era stata la «scoperta» italiana: «In questi giorni parte della stampa italiana ha ripetuto l’errore della “scoperta francese”; anche i maggiori giornali par che ignorino ciò che pure è stato detto e ripetuto a tempo debito. È dunque necessario scrivere ancora una volta che gli italiani colti furono per i primi informati dell’opera dello Svevo; e che per merito di Eugenio Montale, il quale ne scrisse sulle riviste l’“Esame” e il “Quindicinale”, lo scrittore triestino ebbe in Italia il primo e legittimo riconoscimento. Con ciò non si vuol togliere agli stranieri nulla di quanto spetta loro; soltanto, ci par giusto che nessuna ombra offuschi la sincerità e, diciamo pure, la fierezza (!!) del nostro omaggio all’amico scomparso» («Fiera Letteraria» del 23 settembre 1928 – lo Svevo morì il 15 settembre – in un articoletto editoriale introduttivo a un articolo del Montale, Ultimo addio, e a uno di Giovanni Comisso, Colloquio).
Questa prosetta untuosa e gesuitesca è in contraddizione con ciò che afferma Carlo Linati, nella «Nuova Antologia» del 1° febbraio 1928 (Italo Svevo, romanziere). Il Linati scrive: «Due anni fa, trovandomi a prender parte alla serata di un club intellettuale milanese, ricordo che ad un certo punto entrò un giovane scrittore tornato allora allora da Parigi, il quale dopo aver discorso a lungo con noi di un pranzo del Pen Club offerto a Pirandello dai letterati parigini, aggiunse che alla fine di esso, il celebre romanziere irlandese James Joyce, chiacchierando con lui della letteratura italiana moderna, gli aveva detto: – Ma voialtri italiani avete un grande prosatore e forse neanche lo sapete. – Quale? – Italo Svevo, triestino». Il Linati dice che nessuno conosceva quel nome, come non lo conosceva il giovane letterato che aveva parlato col Joyce. Il Montale riuscì finalmente a «scoprire» una copia di Senilità e ne scrisse sull’«Esame». Ecco come i letterati italiani hanno «scoperto» Svevo. È questo un caso? Non mi pare. Per la «Fiera Letteraria» ricordare altri due casi: quello del romanzo di Moravia e quello del Malagigi di Nino Savarese di cui parlò solo dopo che ebbe un premio in un concorso o qualcosa di simile, mentre il romanzo era apparso nella Nuova Antologia del 1928. In realtà questa gente si infischia della letteratura, della cultura ecc. Essa esercita la professione di sacrestano letterario e nulla più.
(Onorevolmente bisogna invece ricordare nel campo della letteratura per i ragazzi «Il Giornalino della Domenica» di Vamba con tutte le sue iniziative e le sue organizzazioni e la collaborazione di padre Pistelli; cfr l’articolo di Lea Nissim, Omero Redi e le «Pistole» nella Nuova Antologia del 1° febbraio 1928).
Q3 §110 L’attrezzamento nazionale. Nella ricerca sulle condizioni economiche e sulla struttura dell’economia italiana, inquadrare nel concetto di «attrezzamento nazionale». Fissare questo concetto esattamente ecc.
Q3 §111 Lorianismo. Sulle interpretazioni settarie della Commedia di Dante e del dolce stil nuovo da parte di Luigi Valli cfr per un’informazione rapida Una nuova interpretazione delle rime di Dante e del «dolce stil novo» di Benedetto Migliore nella Nuova Antologia del 16 febbraio 1928.
Q3 §112 Corrado Barbagallo. Il suo libro L’oro e il fuoco deve essere esaminato con molta attenzione, tenendo conto del partito preso dell’autore di trovare nell’antichità ciò che è essenzialmente moderno, come il capitalismo e le manifestazioni che al capitalismo sono collegate. Bisogna specialmente esaminare le sue ricerche e le sue conclusioni a proposito delle associazioni professionali e delle loro funzioni, ponendole a confronto con le opinioni degli studiosi del mondo classico e medioevale. Cfr per l’opposizione del Mommsen e del Marquardt a proposito dei collegia opificum et artificum: per il Marquardt essi erano istituzioni erariali che servivano all’economia e alla finanza dello Stato e poco o punto istituzioni sociali (cfr il mir russo). A parte l’osservazione che in ogni caso il sindacalismo moderno dovrebbe trovare corrispondenza in istituzioni proprie degli schiavi del mondo classico. Ciò che caratterizza il mondo moderno è che al disotto degli operai non c’è altra classe priva di organizzazione, ciò che non è mai avvenuto neanche nelle corporazioni medioevali. (Anche l’artigiano romano poteva servirsi degli schiavi come lavoranti ed essi non appartenevano ai collegia, a parte il dubbio che nello stesso popolo ci fossero categorie escluse dai collegia anche se non servili).
Q3 §113 Utopie. La Tempesta di Shakespeare. (L’opposizione di Calibano e Prospero ecc.; ma il carattere utopistico dei discorsi di Gonzalo è più evidente). Cfr A. Loria, Pensieri e soggetti economici in Shakespeare («Nuova Antologia» del 1° agosto 1928) che può essere utilizzato per il capitolo del Lorianismo. A proposito della Tempesta vedere di Renan il Calibano e l’Eau de Jouvence. Questo articolo di Loria è però interessante come antologia dei brani shakespeariani di carattere sociale: può servire come documento indiretto del modo di pensare dei popolani del suo tempo.
Q3 §114 Passato e presente. «Quando i bricconi ricchi hanno bisogno dei bricconi poveri, questi possono imporre ai primi il maggior prezzo che vogliono». Shakespeare (nel Timone di Atene) (?).
Q3 §115 Ufficio internazionale delle classi colte italiane. Forse si potrebbe far coincidere il tramonto della funzione cosmopolitica degli intellettuali italiani con il fiorire degli avventurieri del Settecento: l’Italia a un certo punto non dà più tecnici all’Europa, o perché le altre nazioni hanno già elaborato una classe colta propria o perché l’Italia non produce più capacità a mano a mano che ci allontaniamo dal Cinquecento; e le vie tradizionali di «far fortuna» all’estero sono ormai percorse da imbroglioni che sfruttano la tradizione. Da vedere e da porre in termini esatti.
Q3 §116 Ufficio internazionale delle classi colte italiane. Nella guerra delle Fiandre combattuta dagli Spagnoli verso la fine del Cinquecento, una gran parte dell’elemento tecnico militare e del genio era costituita da italiani. Capitani di gran fama come Alessandro Farnese, duca di Parma, Ranuccio Farnese, Ambrogio Spinola, Paciotto da Urbino, Giorgio Basta, Giambattista del Monte, Pompeo Giustiniano, Cristoforo Mondragone e molti altri minori. La città di Namur era stata fortificata da due ingegneri italiani: Gabrio Serbelloni e Scipione Campi ecc. Cfr Un generale di cavalleria italo‑albanese: Giorgio Basta di Eugenio Barbarich nella «Nuova Antologia» del 16 agosto 1928.
In questa ricerca sulla funzione cosmopolitica delle classi colte italiane è specialmente da tener conto dell’apporto di tecnici militari, per il valore più strettamente «nazionale» che sempre ha avuto il servizio militare. La quistione si collega ad altre ricerche: come si erano formate queste capacità militari? La borghesia dei Comuni aveva avuto anche un’origine militare, nel senso che la sua organizzazione di classe fu originariamente anche militare e che attraverso la sua funzione militare riuscì a prendere il potere. Questa tradizione militare si spezzò dopo l’avvento al potere, dopo che il Comune aristocratico divenne Comune borghese. Come, perché? Come si formarono le compagnie di ventura, e per quale origine necessaria? Di che condizione sociale furono i condottieri in maggioranza? Mi pare piccoli nobili, ma di che nobiltà? Di quella feudale o di quella mercantile? Ecc. Questi capi militari della fine del Cinquecento e dei secoli successivi come si erano formati? ecc.
Naturalmente che gli italiani abbiano così validamente partecipato alle guerre della Controriforma ha un significato particolare, ma parteciparono anche alla difesa dei protestanti? Né bisogna confondere questo apporto di tecnici militari con la funzione che ebbero gli Svizzeri, per esempio, quali mercenari internazionali, o i cavalieri tedeschi in Francia (reîtres) o gli arcieri scozzesi nella stessa Francia: appunto perché gli italiani non dettero solo tecnici militari, ma tecnici del genio (ingegneri), della politica, della diplomazia ecc.
Il Barbarich (credo che adesso sia generale) termina il suo articolo sul Basta con questo periodo: «La lunga pratica di quarant’anni di campagne nelle guerre aspre di Fiandra, di Francia e di Transilvania, hanno procurato a Giorgio Basta una ben straordinaria sanzione pratica alla lucida e chiara sua teoria, che sarà ripresa dal Montecuccoli. Ricordare oggidì l’una e l’altra è opera di rivendicazione storica doverosa, di buona propaganda sollecita delle tradizioni nostre, le quali affermano la indiscussa e luminosa priorità dell’arte militare italica nei grandi eserciti moderni». Ma si può parlare in questo caso di arte militare italica? Dal punto di vista della storia della cultura può essere interessante sapere che il Farnese era italiano o Napoleone corso o Rothschild ebreo, ma storicamente la loro attività individuale è stata incorporata nello Stato al cui servizio essi sono stati assunti o nella società in cui hanno operato. L’esempio degli ebrei può dare un elemento di orientazione per giudicare l’attività di questi italiani, ma solo fino ad un certo punto: in realtà gli ebrei hanno avuto un maggior carattere nazionale di questi italiani, nel senso che nel loro operare c’era una preoccupazione di carattere nazionale che in questi italiani non c’era. Si può parlare di tradizione nazionale quando la genialità individuale è incorporata attivamente, cioè politicamente e socialmente, nella nazione da cui l’individuo è uscito (gli studi sull’ebraismo e la sua funzione internazionale possono dare molti elementi di carattere teorico per questa ricerca), quando essa trasforma il proprio popolo, gli imprime un movimento che appunto forma la tradizione. Dove esiste una continuità in questa materia tra il Farnese e oggi? Le trasformazioni, gli aggiornamenti, le innovazioni portate da questi tecnici militari nella loro arte si sono incorporate nella tradizione francese o spagnola o austriaca: in Italia sono diventate numeri di scheda bibliografica.
Q3 §117 L’emigrazione italiana e la funzione cosmopolita delle classi colte italiane. Prima della rivoluzione francese, prima cioè che si costituisse organicamente una classe dirigente nazionale, c’era una emigrazione di elementi italiani rappresentanti la tecnica e la capacità direttiva, elementi che hanno arricchito gli Stati europei col loro contributo. Dopo la formazione di una borghesia nazionale e dopo l’avvento del capitalismo si è iniziata l’emigrazione del popolo lavoratore, che è andato ad aumentare il plusvalore dei capitalismi stranieri: la debolezza nazionale della classe dirigente ha così sempre operato negativamente. Essa non ha dato la disciplina nazionale al popolo, non l’ha fatto uscire dal municipalismo per una unità superiore, non ha creato una situazione economica che riassorbisse le forze di lavoro emigrate in modo che questi elementi sono andati perduti in grandissima parte, incorporandosi nelle nazionalità straniere in funzione subalterna.
Q3 §118 Storia nazionale e storia della cultura (europea o mondiale). L’attività degli elementi dirigenti che hanno operato all’estero, come l’attività della moderna emigrazione, non può essere incorporata nella storia nazionale, come invece deve essere, per esempio, l’attività di elementi simili in altre condizioni. Una classe di un paese può servire in un altro paese, mantenendo i suoi legami nazionali e statali originari, cioè come espressione dell’influenza politica del paese d’origine. Per un certo tempo i missionari o il clero nei paesi d’oriente esprimevano l’influenza francese anche se questo clero solo parzialmente era costituito di cittadini francesi, per i legami statali tra Francia e Vaticano. Uno stato maggiore organizza le forze armate di un altro paese, incaricando del lavoro tecnici militari del suo gruppo che non perdono la nazionalità, tutt’altro. Gli intellettuali di un paese influenzano la cultura di un altro paese e la dirigono ecc. Un’emigrazione di lavoratori colonizza un paese sotto la direzione diretta o indiretta della sua propria classe dirigente economica e politica. La forza espansiva, l’influsso storico di una nazione non può essere misurato dall’intervento individuale di singoli, ma dal fatto che questi singoli esprimono consapevolmente e organicamente un blocco sociale nazionale. Se così non è, si deve parlare solo di fenomeni di una certa portata culturale appartenenti a fenomeni storici più complessi: come avvenne in Italia per tanti secoli, di essere l’origine «territoriale» di elementi dirigenti cosmopoliti e di continuare in parte ad esserlo per il fatto che l’alta gerarchia cattolica è in gran parte italiana. Storicamente questa funzione internazionale è stata la causa di debolezza nazionale e statale: lo sviluppo delle capacità non è avvenuto per i bisogni nazionali, ma per quelli internazionali, il processo di specializzazione tecnica degli intellettuali ha seguito perciò delle vie anormali dal punto di vista nazionale, perché ha servito a creare l’equilibrio di attività e di branche di attività non di una comunità nazionale ma di una comunità più vasta che voleva «integrare» i suoi quadri nazionali, ecc. (Questo punto deve essere bene sviluppato con precisione ed esattezza).
Q3 §119 Passato e presente. Agitazione e propaganda. La debolezza dei partiti politici italiani in tutto il loro periodo di attività, dal Risorgimento in poi (eccettuato in parte il partito nazionalista) è consistita in quello che si potrebbe chiamare uno squilibrio tra l’agitazione e la propaganda, e che in altri termini si chiama mancanza di principii, opportunismo, mancanza di continuità organica, squilibrio tra tattica e strategia ecc. La causa principale di questo modo di essere dei partiti è da ricercare nella deliquescenza delle classi economiche, nella gelatinosa struttura economica e sociale del paese, ma questa spiegazione è alquanto fatalistica: infatti se è vero che i partiti non sono la nomenclatura delle classi, è anche vero che i partiti non sono solo una espressione meccanica e passiva delle classi stesse, ma reagiscono energicamente su di esse per svilupparle, assodarle, universalizzarle. Questo appunto non è avvenuto in Italia, e la manifestazione di questa «omissione» è appunto questa agitazione e propaganda o come altrimenti si voglia dire.
Lo Stato-Governo ha una certa responsabilità in questo stato di cose (si può chiamare responsabilità in quanto ha impedito il rafforzamento dello Stato stesso, cioè ha dimostrato che lo Stato‑governo non era un fattore nazionale): il governo ha infatti operato come un «partito», si è posto al disopra dei partiti non per armonizzarne gli interessi e l’attività nei quadri permanenti della vita e degli interessi statali nazionali, ma per disgregarli, per staccarli dalle grandi masse e avere «una forza di senza partito legati al governo con vincoli paternalistici di tipo bonapartistico‑cesareo»: così occorre analizzare le così dette dittature di Depretis, Crispi, Giolitti e il fenomeno parlamentare del trasformismo. Le classi esprimono i partiti, i partiti elaborano gli uomini di Stato e di governo, i dirigenti della società civile e della società politica. Ci deve essere un certo rapporto utile e fruttuoso in queste manifestazioni e in queste funzioni. Non può esserci elaborazione di dirigenti dove manca l’attività teorica, dottrinaria dei partiti, dove non sono sistematicamente ricercate e studiate le ragioni di essere e di sviluppo della classe rappresentata. Quindi scarsità di uomini di Stato, di governo, miseria della vita parlamentare, facilità di disgregare i partiti, corrompendone, assorbendone i pochi uomini indispensabili. Quindi miseria della vita culturale e angustia meschina dell’alta cultura: invece della storia politica, la erudizione scarnita, invece della religione la superstizione, invece dei libri e delle grandi riviste, il giornale quotidiano e il libello. Il giorno per giorno, con le sue faziosità e i suoi urti personalistici, invece della politica seria. Le università, tutte le istituzioni che elaboravano le capacità intellettuali e tecniche, non permeate dalla vita dei partiti, dal realismo vivente della vita nazionale, formavano quadri nazionali apolitici, con formazione mentale puramente rettorica, non nazionale. La burocrazia così si estraniava dal paese, e attraverso le posizioni amministrative, diventava un vero partito politico, il peggiore di tutti, perché la gerarchia burocratica sostituiva la gerarchia intellettuale e politica: la burocrazia diventava appunto il partito statale‑bonapartistico.
Vedere i libri che dopo il 19 criticarono un «simile» (ma molto più ricco nella vita della «società civile») stato di cose nella Germania guglielmina, per esempio il libro di Max Weber, Parlamento e Governo nel nuovo ordinamento della Germania. Critica politica della burocrazia e della vita dei partiti. Traduzione e prefazione di Enrico Ruta, pp. XVI-200, L. 10,00. (La traduzione è molto imperfetta e imprecisa).
Q3 §120 Antonio Fradeletto. Antico radicale massone, convertito al cattolicismo. Pubblicista retorico sentimentale, oratore delle grandi occasioni. È un tipo della cultura italiana che ormai tende a sparire. Scrittore di cose letterarie, artistiche e «patriottiche». Mi pare che in ciò consista il «tipo»: nel fatto che il «patriottismo» non era un sentimento diffuso, lo stato d’animo di uno strato nazionale, ma specialità di una serie di scrittori (così Cian, per esempio), qualifica professionale, per così dire. (Non confondere con i nazionalisti sebbene Corradini appartenga a questo tipo, e si differenzi in ciò da Coppola e Federzoni: neanche D’Annunzio rientra in questa categoria: in Francia questo tipo esisteva forse in Barrès, ma non identicamente).
Q3 §121 I nipotini di padre Bresciani. Arturo Calza scrive nella Nuova Antologia del 16 ottobre 1928: «Bisogna cioè riconoscere che – dal 1914 in qua – la letteratura ha perduto non solo il pubblico che le forniva gli alimenti, ma anche quello che le forniva gli argomenti. Voglio dire che in questa nostra società europea, la quale traversa ora uno di quei momenti più acuti e più turbinosi di crisi morale e spirituale che preparano le grandi rinnovazioni, il filosofo, e dunque anche, necessariamente, il poeta, il romanziere e il drammaturgo – vedono intorno a sé piuttosto una società “in divenire” che una società assestata e assodata in uno schema definitivo (!) di vita morale e intellettuale; piuttosto vaghe e sempre mutevoli parvenze di costumi e di vita che non vita e costumi saldamente stabiliti e organizzati; piuttosto semi e germogli, che non fiori sbocciati e frutti maturati. Ond’è che – come scriveva in questi giorni egregiamente il Direttore della “Tribuna” (Roberto Forges Davanzati), e hanno ripetuto poi, e anzi “intensificato” altri giornali ‑ “noi viviamo nella maggiore assurdità artistica, fra tutti gli stili e tutti i tentativi, senza più capacità d’essere un’epoca”». Quante chiacchiere tra il Calza e il Forges Davanzati. Forse che solo in questo periodo c’è stata una crisi sociale? E non è anzi vero che proprio nei periodi di crisi sociale le passioni e gli interessi e i sentimenti diventano più intensi e si ha nella letteratura il romanticismo? Gli argomenti zoppicano alquanto e poi si rivoltano contro l’argomentatore: come mai il Forges Davanzati non si accorge che «il non avere capacità di essere un’epoca» non può limitarsi all’arte ma investe tutta la vita?
Q3 §122 La diplomazia italiana. Costantino Nigra e il trattato di Uccialli. Nella Nuova Antologia del 16 novembre 1928 in un articolo di Carlo Richelmy, Lettere inedite di Costantino Nigra, è pubblicata una lettera (o estratti di una lettera) del 28 agosto 1896 del Nigra a un «caro amico» che il Richelmy crede di poter identificare col marchese Visconti‑Venosta perché con lo stesso, in quei giorni, il Nigra scambiò alcuni telegrammi sul medesimo argomento. Nigra informa che il principe Lobanov (forse ambasciatore russo a Vienna, dove il Nigra era ambasciatore) lo ha informato di alcune pratiche che il Negus Menelik ha fatto presso lo Zar. Il Negus aveva fatto sapere allo Zar di essere disposto ad accettare la mediazione della Russia per la conclusione della pace coll’Italia ecc. Il Nigra conchiude: «Per me è evidente una cosa. Dopo l’affare del trattato di Uccialli, il Negus è diffidente verso di noi, sospettando sempre che dal nostro plenipotenziario gli si cangino le clausole pattuite. Questa diffidenza, che è invincibile, ha consigliato il Negus di chiedere di trattare per mezzo della Russia al fine di avere un testimone idoneo e potente. La cosa è dura per il nostro amor proprio, ma ormai il nostro paese deve persuadersi che quando si adoperano diplomatici come Antonelli, generali come Baratieri, e ministri come Mocenni, non si possono avere pretese soverchie». («Mani vuote, ma sporche» – machiavellismo da rigattieri ecc.).
Q3 §123 L’italiano meschino. «Il latino si studia obbligatoriamente in tutte le scuole superiori del Nord‑America. La storia romana è insegnata in tutti gli istituti, e tale insegnamento rivaleggia, se non supera quello che vien fatto nei ginnasi e nei licei italiani, perché nelle scuole americane la classica storia di Roma antica è tradotta fedelmente da Tacito e da Cesare, da Sallustio e da Tito Livio, mentre in Italia si ricorre troppo spesso e troppo supinamente alle deformate (sic) traduzioni di Lipsia». Filippo Virgilii, L’espansione della cultura italiana, Nuova Antologia, 1° dicembre1928 (il brano è a p. 346); (né può essere errore di stampa, dato il senso di tutto il periodo! E il Virgilii è professore di Università e ha fatto le scuole classiche!)
Q3 §124 Emigrazione. Il viaggio di Enrico Ferri nell’America meridionale avvenne nel 1908‑9 (ma il suo discorso in Parlamento mi pare proprio che sia del 1911). Nel 1911 si recò nel Brasile una commissione di rappresentanti delle organizzazioni operaie di cooperazione e di resistenza per farvi una inchiesta sulle condizioni economico‑sociali: pubblicò a Bologna nel 1912 una relazione (Emigrazione agricola al Brasile, Relazione della Commissione, Bologna 1912). (Questi dati molto imprecisi sono nell’articolo del Virgilii citato nella nota precedente). Della commissione faceva parte il prof. Gaetano Pieraccini che pare sia stato l’estensore della relazione.
A proposito delle concezioni di Enrico Corradini sulla nazione proletaria e sull’emigrazione, sarebbe interessante sapere se non abbia influito su di lui il libro di Ferruccio Macola, L’Europa alla conquista dell’America latina, Venezia, 1894, di cui il Virgilii cita questo brano: «È necessario che la vecchia Europa pensi che le colonie fondate dal suo proletariato nel continente nuovo devono considerarsi, non più come strumento di produzione a beneficio dei rapaci e viziosi discendenti di avventurieri spagnoli e portoghesi, ma come le avanguardie della sua occupazione». (Il libro del Macola deve essere molto voluminoso, perché la citazione è presa da p. 421, e deve essere molto divertente e sintomatico dello stato d’animo di molti crispini).
Q3 §125 Luigi Castellazzo, il processo di Mantova e gli altri processi sotto l’Austria. Per mostrare un tratto caratteristico della vita italiana nella seconda metà del secolo scorso (ma più esattamente dopo il 1876 cioè dopo l’avvento della sinistra al potere) è interessante esaminare la campagna fatta dai moderati (con Alessandro Luzio alla testa) contro Luigi Castellazzo per il suo atteggiamento e le sue confessioni al processo di Mantova che portò all’impiccagione di don Tazzoli, di Carlo Poma, di Tiro Speri, di Montanari e del Frattini. La campagna era puramente politica, perché le accuse fatte al Castellazzo non furono fatte ad altri che nei processi si comportarono come o anche peggio del Castellazzo: ma il Castellazzo era repubblicano, massone e aveva persino avuto delle simpatie per la Comune di Parigi. Il Castellazzo si comportò peggio di Giorgio Pallavicino al processo Confalonieri? Va bene che il processo di Mantova finì con esecuzioni capitali, mentre ciò non avvenne per il Confalonieri e compagni, ma queste esecuzioni furono dovute alle confessioni del Castellazzo o non furono la fulminea risposta per l’insurrezione del 3 febbraio 1853? E non contribuì la vigliaccheria dei nobili milanesi che strisciarono ai piedi di Francesco Giuseppe alla vigilia dell’esecuzione? Vedere come il Luzio se la cava personalmente con questi quesiti.
Certo i moderati cercarono di attenuare la responsabilità di questi nobili in forma sconcia (cfr i libri del Bonfadini). Vedere come il Luzio se la cava nella quistione dei Costituti Confalonieri e nella quistione dell’atteggiamento del Confalonieri dopo la sua liberazione. Sulla quistione Castellazzo cfr Luzio: I martiri di Belfiore nelle diverse edizioni (la 4a è del 1924); I processi politici di Milano e di Mantova restituiti dall’Austria, Milano, Cogliati, 1919 (questo libretto deve parlare dei Costituti Confalonieri che il sen. Salata aveva «scoperto» negli archivi viennesi); La Massoneria e il Risorgimento Italiano, 2 voll., Bocca (pare che questa opera sia giunta alla 4a edizione in pochissimo tempo, ciò che sarebbe veramente maraviglioso); cfr P. L. Rambaldi, Luci ed ombre nei processi di Mantova, «Archivio Storico Italiano», v. XLIII, pp. 257‑331; e Giuseppe Fatini, Le elezioni di Grosseto e la Massoneria, Nuova Antologia del 16 dicembre 1928 (parla dell’elezione a deputato del Castellazzo nel settembre 1883 e della campagna che si scatenò: il Carducci sosteneva il Castellazzo e parla della campagna contro di lui come di un «accanimento fariseo moderato»).
Cosa si proponevano e si propongono gli storici e i pubblicisti moderati con questo loro indefesso, accortissimo e molto bene organizzato (talvolta pare che ci sia un centro direttivo per questo lavoro, una massoneria moderata, tanto è grande lo spirito di sistema) lavoro di propaganda? «Dimostrare» che l’unità italiana è stata opera precipua dei moderati, cioè della dinastia, e legittimare storicamente il monopolio del potere: attraverso questa «dimostrazione» disgregare ideologicamente la democrazia, assorbirne gli elementi individualmente e educare le nuove generazioni intorno a loro, con le loro parole d’ordine, coi loro programmi. Nella loro propaganda essi sono senza scrupoli, mentre il Partito d’azione è pieno di scrupoli patriottici, nazionali ecc. I moderati non riconoscono una forza collettiva agente nel Risorgimento all’infuori della dinastia e dei moderati: riconoscono solo individualità singole, che vengono esaltate per catturarle o diffamate per spezzare il vincolo collettivo. In realtà il Partito d’azione non seppe contrapporre nulla di efficace a questa propaganda: lamentazioni o sfoghi così apertamente settarii che non potevano impressionare l’uomo della strada, cioè convincere le nuove generazioni. Così il Partito d’azione fu disgregato e la democrazia borghese non riuscì ad avere mai una base nazionale. In un certo periodo, tutte le forze della democrazia si allearono e la Massoneria divenne il perno di questa alleanza: è questo un periodo ben determinato nella storia della Massoneria che finì con lo svilupparsi delle forze operaie. La Massoneria divenne il bersaglio dei moderati, che evidentemente speravano di conquistare così una parte delle forze cattoliche specialmente giovanili: in realtà i moderati valorizzarono le forze cattoliche controllate dal Vaticano e la formazione dello Stato italiano e della coscienza laica nazionale ne subì fieri contraccolpi come si vide in seguito. (Studiare bene questa serie di osservazioni).
Q3 §126 La formazione delle classi colte italiane e la loro funzione cosmopolita. Studiare l’origine, la formazione, lo sviluppo, la ragion d’essere ecc. della così detta «lingua franca» nell’oriente mediterraneo.
Q3 §127 Il Risorgimento. L’immagine dell’Italia come di un carciofo di cui le foglie si mangiano una a una, che viene attribuita a Vittorio Emanuele II (e d’altronde l’attribuzione non sarebbe contraria al suo carattere), secondo Amerigo Scarlatti («L’Italia che scrive», febbraio 1928) è di Vittorio Amedeo II come risulta dal Voyage d’Italie del Misson, stampato all’Aia nel 1703. (Ricordare la frase di Vittorio Emanuele II citata dal Martini).
Q3 §128 Machiavelli ed Emanuele Filiberto. Nel volume miscellaneo su Emanuele Filiberto pubblicato nel 1928 dal Lattes, Torino (pp. 477 in 8°) l’attività militare di Emanuele Filiberto come stratega e come organizzatore dell’esercito piemontese è studiata dai generali Maravigna e Brancaccio.
Q3 §129 Diplomazia italiana. Per tutto un lungo periodo dovette esistere una specie di censura preventiva o un impegno di non scrivere le proprie memorie da parte dei diplomatici e in genere degli uomini di Stato italiani, tanto poca è la letteratura in proposito. Dal 1919 in poi abbiamo una certa abbondanza, relativa, ma la qualità è molto scadente. (Le memorie di Salandra sono «inconcepibili» in quella forma pacchiana). Il libro di Alessandro De Bosdari, Delle guerre balcaniche e della grande guerra e di alcuni fatti precedenti ad esse (Milano, Mondadori, 1927, pp. 225, L. 15), secondo una breve nota di P. Silva nell’«Italia che scrive» dell’aprile 1928, è privo d’importanza per il fatto che l’autore insiste specialmente sui fatterelli personali e non sa organicamente rappresentare la propria attività in una esposizione degli avvenimenti che getti su di essi una qualche luce utile. (Su un capitolo di questo libro, pubblicato dalla Nuova Antologia ho scritto una nota a proposito dei giudizi del Bosdari sulla diplomazia italiana).
Q3 §130 Cultura italiana. Vedere l’attività culturale delle «Edizioni Doxa» di Roma: mi pare sia di tendenze protestanti. Così l’attività di «Bilychnis». Così bisognerà farsi una nozione esatta dell’attività intellettuale degli ebrei italiani in quanto organizzata e centralizzata: periodici come il «Vessillo Israelitico» e «Israel», pubblicazioni di case editrici specializzate, ecc.: centri di cultura più importanti. In che cosa il nuovo movimento sionista nato dopo la dichiarazione Balfour ha influito sugli ebrei italiani?
Q3 §131 Diplomazia italiana. Nella recensione del libro di Salandra La neutralità italiana di Giuseppe A. Andriulli pubblicata nell’ICS del maggio 1928 si accenna al fatto che già prima che Sonnino andasse agli Esteri, il ministro di San Giuliano aveva intavolato trattative con l’Intesa e che i collaboratori di San Giuliano affermavano che queste trattative erano impostate in modo ben diverso che da Sonnino, specialmente rispetto alla parte coloniale. Perché queste trattative furono troncate da Sonnino e si aprirono invece le trattative con l’Austria? Salandra ancora non spiega le ragioni dell’accordo con la Germania del maggio 15 per le proprietà private (accordo fatto subito divulgare dai tedeschi per mezzo del «Bund», giornale svizzero) e le ragioni della ritardata dichiarazione di guerra alla Germania (cosa che creò diffidenza verso l’Italia da parte dell’Intesa, di cui si giovò Sisto di Borbone).
Q3 §132 Lorianismo. Paolo Orano. A proposito dei rapporti tra gli intellettuali sindacalisti italiani e Sorel occorre fare un confronto tra i giudizi che su di essi il Sorel ha pubblicato recensendone i libri (nel «Mouvement socialiste» e altrove) e quelli espressi nelle sue lettere al Croce. Questi ultimi illuminano i primi di una luce spesso ironica o reticente: cfr il giudizio su Cristo e Quirino di P. Orano pubblicato nel «Mouvement socialiste» dell’aprile 1908 e quello nella lettera al Croce in data 29 dicembre 1907: evidentemente il giudizio pubblico era ironico e reticente, ma l’Orano lo riporta nella edizione Campitelli, Foligno, 1928, come se fosse di lode.
Q3 §133 Carlo Flumiani, I gruppi sociali. Fondamenti di scienza politica, Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1928, pp. 126, L. 20. (Procurarsi il catalogo di questa casa che ha stampato altri libri di scienza politica).
Q3 §134 Piero Pieri, Il Regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806, Napoli, Ricciardi, 1928, pp. 314, L. 25. Studia la politica borbonica dopo la prima restaurazione e le cause del suo crollo nel 1806, avvenuto pur non essendoci all’interno nessuna forza contraria attiva e mentre l’esercito francese era ancora lontano. Studia il difficile regime delle classi nel Mezzogiorno e il nascere del pensiero liberale che sostituiva il vecchio giacobinismo del 1799. Deve essere molto interessante.
Per capire l’orientamento delle classi nel Mezzogiorno deve essere interessante anche il libro di A. Zazo, L’istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767‑1860), Città di Castello, «Il Solco», 1927, pp. 328, L. 15. (Lo squilibrio tra istruzione pubblica e privata si è determinato dopo il 1821: le scuole private fioriscono, mentre l’opera statale decade: si forma così un’aristocrazia della cultura in un deserto popolare, il distacco tra classe colta e popolo aumenta. Questo argomento mi pare da svolgere).
Q3 §135 Storia e Antistoria. Dalla recensione di Mario Missiroli (ics, gennaio 1929) del libro di Tilgher Saggi di Etica e di Filosofia del Diritto, Torino, Bocca, 1928, in 8°, pp. XIV‑218, appare che la tesi fondamentale dell’opuscoletto Storia e Antistoria ha una grande portata nel sistema (!) filosofico del Tilgher. Scrive il Missiroli: «Si è detto, e non a torto, che l’idealismo italiano, che fa capo al Croce ed a Gentile, si risolve in un puro fenomenismo. Non v’è posto per la personalità. Contro questa tendenza reagisce vivacemente Adriano Tilgher con questo volume. Risalendo alla tradizione della filosofia classica, particolarmente a Fichte, Tilgher ribadisce con grande vigore la dottrina della libertà e del “dover essere”. Dove non c’è libertà di scelta, c’è “natura”. Impossibile sottrarsi al fatalismo. La vita e la storia perdono ogni senso e nessuna risposta ottengono gli eterni interrogativi della coscienza. Senza riferirsi ad un quid che trascenda la realtà empirica, non si può parlare di moralità, di bene e di male. Vecchia tesi. L’originalità di Tilgher consiste nell’aver esteso per primo questa esigenza alla logica. Il “dover essere” è necessario alla logica non meno che alla morale. Di qui l’indissolubilità della logica e della morale che i vecchi trattatisti amavano tenere distinte. Posta la libertà come una premessa necessaria, ne consegue una teoria del libero arbitrio come assoluta possibilità di scelta fra il bene e il male. Così la pena (acutissime le pagine su il diritto penale) trova il suo fondamento non soltanto nella responsabilità (scuola classica) ma nel fatto puro e semplice che l’individuo può fare il male conoscendolo come tale. La causalità può tenere le veci della responsabilità. Il determinismo di chi delinque equivale al determinismo di chi punisce. Tutto bene. Ma questo energico richiamo al “dover essere”, all’antistoria, che crea la storia, non restaura, logicamente, il dualismo e la trascendenza? Non si può riguardare la trascendenza come un “momento” senza ricadere nell’immanentismo. Non si viene a patti con Platone».
Q3 §136 I nipotini di Padre Bresciani. Per gli scrittori «tecnicamente» gesuiti da includere in questa rubrica cfr Monsignor Giovanni Casati, Scrittori Cattolici Italiani viventi. Dizionario bio‑bibliografico ed indice analitico delle opere con prefazione di F. Meda, pp. VIII‑112, in 8°.
Q3 §137 La formazione della classe intellettuale italiana. Efficacia avuta dal movimento operaio socialista per creare importanti settori della classe dominante. La differenza tra il fenomeno italiano e quello di altri paesi consiste obbiettivamente in questo: che negli altri paesi il movimento operaio e socialista elaborò singole personalità politiche, in Italia invece elaborò interi gruppi di intellettuali che come gruppi passarono all’altra classe. Mi pare che la causa italiana sia da ricercare in ciò: scarsa aderenza delle classi alte al popolo: nella lotta delle generazioni, i giovani si avvicinano al popolo; nelle crisi di svolta questi giovani ritornano alla loro classe (così è avvenuto per i sindacalisti‑nazionalisti e per i fascisti). È in fondo lo stesso fenomeno generale del trasformismo, in diverse condizioni. Il trasformismo «classico» fu il fenomeno per cui si unificarono i partiti del Risorgimento; questo trasformismo mette in chiaro il contrasto tra civiltà, ideologia ecc. e la forza di classe. La borghesia non riesce a educare i suoi giovani (lotta di generazione): i giovani si lasciano attrarre culturalmente dagli operai e addirittura se ne fanno o cercano di farsene i capi («inconscio» desiderio di realizzare essi l’egemonia della loro propria classe sul popolo), ma nelle crisi storiche ritornano all’ovile. Questo fenomeno di «gruppi» non si sarà certo verificato solo in Italia: anche nei paesi dove la situazione è analoga, si sono avuti fenomeni analoghi: i socialismi nazionali dei paesi slavi (o socialrivoluzionari o narodniki ecc.).
Q3 §138 I nipotini di Padre Bresciani. Alfredo Panzini. Ho già osservato in altra nota come F. Palazzi, nella sua recensione del libro di Panzini I giorni del sole e del grano, osservi come lo spirito del Panzini sia piuttosto quello del negriero che non quello di un disinteressato e candido georgico. Questa acuta osservazione si può applicare non solo al Panzini, che è il tipo di un’epoca. Ma un’altra osservazione di costume fa il Palazzi che è strettamente legata al Panzini e che si ricollega ad altre osservazioni da me fatte (a proposito dell’ossessione del Panzini per la «livida lama» ecc.). Scrive il Palazzi (ics, giugno 1929): «Quando (il Panzini) vi fa l’elogio, a mezza bocca, del frugale pasto consumato sulle zolle, a guardarlo bene vi accorgerete che la sua bocca fa le smorfie di disgusto e nell’intimo pensa come mai si possa vivere di cipolle e di brodo nero spartano, quando Dio ha messo sotto la terra il tartufo e in fondo al mare le ostriche. .... “Una volta – egli confesserà – mi è venuto anche da piangere”. Ma quel pianto non sgorga dai suoi occhi, come da quelli di Leone Tolstoi, per le miserie che sono sotto i suoi occhi, per la bellezza intravista di certi umili atteggiamenti, per la simpatia viva verso gli umili e gli afflitti che pur non mancano tra i coltivatori rudi dei campi. Oh, no! egli piange perché a sentir ricordati certi dimenticati nomi di masserizie, si ricorda di quando sua madre li chiamava pure così e si rivede bambino e ripensa alla brevità ineluttabile della vita, alla rapidità della morte che ci è sopra. “Signor arciprete, mi raccomando: poca terra sopra la bara”. Il Panzini insomma piange perché si fa pena. Piange di sé e della morte e non per gli altri. Egli passa accanto all’anima del contadino senza vederla. Vede le apparenze esteriori, ode quel che esce appena dalla sua bocca e si domanda se pel contadino la proprietà non sia per caso sinonimo di “rubare”».
Q3 §139 Passato e presente. Per compilare questa rubrica rileggere prima i Ricordi politici e civili di Francesco Guicciardini. Sono ricchissimi di spunti morali sarcastici, ma appropriati. Es.: «Pregate Dio sempre di trovarvi dove si vince, perché vi è data laude di quelle cose ancora di che non avete parte alcuna come per il contrario chi si trova dove si perde, è imputato di infinite cose delle quali è inculpabilissimo».
Ricordare un’affermazione di Arturo Labriola (ait latro...) come sia rivoltante moralmente sentire rimproverare le masse dai loro antichi capi che hanno mutato bandiera per aver fatto ciò che questi stessi capi avevano comandato di fare.
Per i Ricordi del Guicciardini vedere l’edizione della Soc. Editrice «Rinascimento del Libro», 1929, con prefazione di Pietro Pancrazi.
Q3 §140 Cattolicismo e laicismo. Religione e scienza, ecc. Leggere il libretto di Edmondo Cione, Il dramma religioso dello spirito moderno e la Rinascenza, Napoli, Mazzoni, 1929, pp. 132. Svolge questo concetto: «la Chiesa, forte della sua autorità, ma sentendo il vuoto aleggiarle nella testa, priva di scienza e di filosofia; il Pensiero, forte della sua potenza, ma anelante invano alla popolarità ed all’autorità della tradizione». Perché «invano?» Intanto non è esatta la contrapposizione di Chiesa e di Pensiero, o almeno nell’imprecisione del linguaggio si annida tutto un modo errato di pensare e di agire, specialmente. Il Pensiero può essere contrapposto alla Religione di cui la Chiesa è l’organizzazione militante. I nostri idealisti, laicisti, immanentisti ecc. hanno fatto del Pensiero una pura astrazione, che la Chiesa ha bellamente preso sottogamba assicurandosi le leggi dello Stato e il controllo dell’educazione. Perché il «Pensiero» sia una forza (e solo come tale potrà farsi una tradizione) deve creare una organizzazione, che non può essere lo Stato, perché lo Stato ha rinunziato in un modo o nell’altro a questa funzione etica quantunque la proclami ad altissima voce, e deve perciò nascere nella società civile. Questa gente, che è stata antimassonica, finirà col riconoscere la necessità della massoneria. Problema «Riforma e Rinascimento» altre volte accennato. Posizione del Croce (il Cione è un crociano) che non sa (e non può) popolarizzarsi, cioè «nuovo Rinascimento» ecc.
Q3 §141 La funzione internazionale degli intellettuali italiani. Nell’ics dell’ottobre 1929 Dino Provenzal, nella rubrica «Libri da fare» propone: Una storia degli Italiani fuori d’Italia, e scrive: «L’invocava Cesare Balbo tanti anni fa, come ricorda il Croce nella sua recente Storia della età barocca in Italia. Chi raccogliesse notizie ampie, sicure, documentate, intorno all’opera di nostri connazionali esuli, o semplicemente emigrati, mostrerebbe un lato ancora ignoto dell’attitudine che gli Italiani hanno sempre posseduto a diffondere idee e costruire opere in ogni parte del mondo. Il Croce, nel ricordare il disegno del Balbo, dice che questa non sarebbe storia d’Italia. Secondo come s’intende: storia del pensiero e del lavoro italiano sì».
Né il Croce né il Provenzal intendono ciò che potrebbe essere questa ricerca. Vedere e studiare questa parte del Croce, che vede il fenomeno, mi pare, troppo legato (o esclusivamente legato) alla Controriforma e alle condizioni dell’Italia nel Seicento. Ora è certo invece che proprio la Controriforma doveva automaticamente accentuare il carattere cosmopolitico degli intellettuali italiani e il loro distacco dalla vita nazionale. Botero, Campanella ecc. sono politici «europei» ecc.
Q3 §142 I limiti dell’attività dello Stato. Vedere la discussione avvenuta in questi anni a questo proposito: è la discussione più importante di dottrina politica e serve a segnare i confini tra liberali e non liberali. Può servire di punto di riferimento il volumetto di Carlo Alberto Biggini, Il fondamento dei limiti all’attività dello Stato, Città di Castello, Casa Ed. «Il Solco», pp. 150, L. 10. L’affermazione del Biggini che si ha tirannia solo se si vuol regnare fuor «delle regole costitutive della struttura sociale» può avere ampliamenti ben diversi da quelli che il Biggini suppone, purché per «regole costitutive» non si intendano gli articoli delle Costituzioni, come pare non intenda neanche il Biggini (prendo lo spunto da una recensione dell’ics dell’ottobre 1929 scritta da Alfredo Poggi). (In quanto lo Stato è la stessa società ordinata, è sovrano. Non può avere limite giuridico: non può avere limite nei diritti pubblici soggettivi, né può dirsi che si autolimiti. Il diritto positivo non può essere limite allo Stato perché può essere dallo Stato ad ogni momento modificato in nome di nuove esigenze sociali, ecc.).
A questo risponde il Poggi che sta bene e che ciò è già implicito nella dottrina del limite giuridico cioè finché un ordinamento giuridico è, lo Stato vi è costretto; se lo vuol modificare, lo sostituirà con un altro ordinamento, cioè lo Stato non può agire che per via giuridica (ma siccome tutto ciò che fa lo Stato, è per ciò stesso giuridico, si può continuare all’infinito). Veder quanto delle concezioni del Biggini è marxismo camuffato e reso astratto.
Per lo svolgimento storico di queste due concezioni dello Stato mi pare debba essere interessante il libretto di Widar Cesarini Sforza, «Jus» et «directum». sull’origine storica dell’idea di diritto, in 8° pp. 90, Bologna, Stab. tipogr. riuniti, 1930. I romani foggiarono la parola jus per esprimere il diritto come potere della volontà e intesero l’ordine giuridico come un sistema di poteri non contenuti nella loro sfera reciproca da norme oggettive e razionali: tutte le espressioni da essi usate di aequitas, justitia, recta o naturalis ratio devono intendersi nei limiti di questo significato fondamentale. Il Cristianesimo più che il concetto di jus ha elaborato il concetto di directum nella sua tendenza a subordinare la volontà alla norma, a trasformare il potere in dovere. Il concetto di diritto come potenza è riferito solo a Dio, la cui volontà diventa norma di condotta inspirata al principio dell’eguaglianza. La justitia non si distingue ormai dall’aequitas ed entrambe implicano la rectitudo che è qualità soggettiva del volere di conformarsi a ciò che è retto e giusto. Traggo questi spunti da una recensione (nel «Leonardo» dell’agosto 1930) di G. Solari che fa rapide obbiezioni al Cesarini Sforza .
Q3 §143 1914. Sugli avvenimenti del giugno 1914 ricordare l’interessantissimo saggio di Papini in «Lacerba» (questo saggio deve essere ricordato anche per altre ragioni) e gli scritti di Rerum Scriptor.
Q3 §144 Rinascimento. Come si spiega che il Rinascimento Italiano ha trovato studiosi e divulgatori numerosissimi all’estero e che non esista un libro d’insieme scritto da un italiano. Mi pare che il Rinascimento sia la fase culminante moderna della «funzione internazionale degli intellettuali italiani», e che perciò esso non abbia avuto rispondenza nella coscienza nazionale che è stata dominata e continua ad essere dominata dalla Controriforma. Il Rinascimento è vivo nelle coscienze dove ha creato correnti nuove di cultura e di vita, dove è stato operante in profondità, non dove è stato soffocato senza residuo altro che retorico e verbale e dove quindi è diventato oggetto di «mera erudizione», di curiosità estrinseca cioè.
Q3 §145 Cultura italiana e francese e Accademie. Un confronto delle culture italiana e francese può essere fatto confrontando l’Accademia della Crusca e l’Accademia degli Immortali. Lo studio della lingua è alla base di ambedue: ma il punto di vista della Crusca è quello del «linguaiolo», dell’uomo che si guarda continuamente la lingua. Il punto di vista francese è quello della «lingua» come concezione del mondo, come base elementare – popolare‑nazionale – dell’unità della civiltà francese. Perciò l’Accademia Francese ha una funzione nazionale di organizzazione dell’alta cultura, mentre la Crusca... (qual è l’attuale posizione della Crusca? Essa ha certamente cambiato carattere: pubblica testi critici ecc., ma il Dizionario in che posizione si trova nei suoi lavori?)
Q3 §146 Kipling. Potrebbe, l’opera di Kipling, servire per criticare una certa società che pretenda di essere qualcosa senza avere elaborato in sé la morale civica corrispondente, anzi avendo un modo di essere contradditorio coi fini che verbalmente si pone. D’altronde la morale di Kipling è imperialista solo in quanto è legata strettamente a una ben determinata realtà storica: ma si possono estrarre da essa immagini di potente immediatezza per ogni gruppo sociale che lotti per la potenza politica. La «capacità di bruciar dentro di sé il proprio fumo stando a bocca chiusa», ha un valore non solo per gli imperialisti inglesi, ecc.
Q3 §147 Intellettuali italiani. Carducci. La signora Foscarina Trabaudi Foscarini De Ferrari ha compilato due volumi, Il Pensiero del Carducci (Zanichelli, Bologna), di tutta la materia contenuta nei venti volumi delle opere del Carducci in forma di indice analitico‑sistematico dei nomi e concetti trattati. È indispensabile per una ricerca delle opinioni generali del Carducci e della sua concezione della vita. (Cfr l’articolo di Guido Mazzoni, Il pensiero del Carducci attraverso gli indici delle sue opere nel «Marzocco» del 3 novembre 1929).
Q3 §148 Carattere popolare‑nazionale negativo della letteratura italiana. Nel «Marzocco» dell’11 novembre 1928 è contenuto un articolo di Adolfo Faggi, Fede e dramma, in cui sono spunti che interessano questo argomento. Il Faggi dà gli elementi per istituire un confronto tra la concezione del mondo di Tolstoi e del Manzoni, sebbene affermi arbitrariamente che i «Promessi Sposi corrispondono perfettamente al suo (del Tolstoi) concetto dell’arte religiosa» esposto nello studio critico sullo Shakespeare: «L’arte in generale e in particolare l’arte drammatica fu sempre religiosa, ebbe cioè sempre per iscopo di chiarire agli uomini i loro rapporti con Dio, secondo la comprensione che di questi rapporti s’erano fatta in ogni età gli uomini più eminenti e destinati perciò a guidare gli altri... Ci fu poi una deviazione nell’arte che l’asservì al passatempo e al divertimento; deviazione che ha avuto luogo anche nell’arte cristiana». Nota il Faggi che in Guerra e Pace i due personaggi che hanno la maggiore importanza religiosa sono Platone Karatajev e Pietro Biezuchov: il primo è uomo del popolo, e il suo pensiero ingenuo ed istintivo ha molta efficacia sulla concezione della vita di Pietro Biezuchov. Nel Tolstoi è caratteristico appunto che la sapienza ingenua e istintiva del popolo, enunciata anche con una parola casuale, faccia la luce e determini una crisi nella coscienza dell’uomo colto. Questo anzi è caratteristico della religione di Tolstoi che intende l’evangelo «democraticamente», cioè secondo il suo spirito originario e originale. Il Manzoni invece ha subito la Controriforma, il suo cristianesimo ègesuitismo. E il Faggi nota che «nei Promessi Sposi sono gli spiriti superiori come il padre Cristoforo e il Card. Borromeo che agiscono sugli inferiori e sanno sempre trovare per loro la parola che illumina e guida». Bisognerebbe ancora notare che nei Promessi Sposi non c’è personaggio di condizione inferiore che non sia «preso in giro»: da don Abbondio, a fra Galdino, al sarto, a Gervasio, ad Agnese, a Renzo, a Lucia: per lo meno essi sono rappresentati come esseri meschini, senza vita interiore. Vita interiore hanno solo i signori: fra Cristoforo, il Borromeo, l’Innominato. Perpetua, secondo Don Abbondio, aveva detto presso a poco ciò che dice il card. Borromeo, ma è notevole come questo spunto sia oggetto di comico. In realtà anche nel Manzoni si potrebbero trovare voli tracce di Brescianismo (così il fatto che il parere di Renzo sul valore del voto di verginità di Lucia coincide col parere di padre Cristoforo, o l’importanza che ha la frase di Lucia nel turbare l’Innominato e nel determinarne la crisi morale, sono di carattere ben diverso da quello che ha in Tolstoi l’apporto del popolo come sorgente di vita morale e religiosa).
Q3 §149 Letteratura popolare. Verne e letteratura di avventure meravigliose. Nelle avventure di Verne non c’è niente di completamente impossibile: le «possibilità» di cui dispongono gli eroi di Verne sono superiori a quelle realmente esistenti nel tempo, ma non troppo superiori e specialmente non «fuori» della linea di sviluppo delle conquiste scientifiche del tempo. La immaginazione non è del tutto «arbitraria». Diverso è il caso del Wells e del Poe, in cui appunto domina in gran parte l’«arbitrario», anche se il punto di partenza può essere logico e innestato a una realtà scientifica concreta. Questo carattere limita la fortuna e la popolarità di Verne (a parte il valore artistico scarso): la scienza ha superato Verne e i suoi libri non sono più «eccitanti» psicologici. Lo stesso si può dire delle avventure poliziesche, per es. di Conan Doyle: per «il tempo erano eccitanti», oggi sempre meno, per varie ragioni: perché il mondo delle lotte poliziesche è più noto, mentre Conan Doyle in gran parte lo rivelava ecc. e anche perché la tecnica è più avanzata. Interessa ancora l’apporto individuale dell’eroe, la macchina psichica del ricercatore, ma allora Poe è più interessante e Chesterton ancor più ecc.
Nel «Marzocco» del 19 febbraio 1928, Adolfo Faggi (Impressioni da Giulio Verne) scrive che il carattere antinglese di molti romanzi di Verne è da riportare a quel periodo di rivalità fra la Francia e l’Inghilterra che culminò nell’episodio di Fashoda. L’affermazione è errata e credo anche anacronistica: in realtà l’antibritannicismo è un elemento fondamentale della psicologia popolare francese, forse più profondo che l’antitedeschismo, perché ha ben altra tradizione storica: l’antitedeschismo è relativamente recente, non va, in realtà, oltre la Rivoluzione Francese, ma è specialmente legato al 70, ed alla sconfitta e alla dolorosa impressione che la Francia non era più la più forte nazione militare e politica dell’Europa occidentale, perché la Germania, da sola, non in coalizione, aveva vinto la Francia. L’antinglesismo invece risale almeno alla guerra dei cento anni, è legato all’immagine popolare di Giovanna d’Arco ed è stato rinforzato modernamente dalla Rivoluzione Francese e magari da Fashoda. Questo elemento non è specifico del Verne, ma di tutta la letteratura popolare francese (cfr la Sand, ecc.) recente e non recente.
Q3 §150 Letteratura popolare. Emilio De Marchi. Perché il De Marchi non è molto letto? Eppure nei suoi libri ci sono molti elementi di «popolarità». Bisognerebbe rileggerlo e analizzare questi elementi, specialmente in Demetrio Pianelli e in Giacomo l’idealista.
Q3 §151 Carattere popolare‑nazionale negativo della letteratura italiana. (Cfr nota precedente dallo stesso titolo, due pagine avanti). In un articolo del «Marzocco» del 9 settembre 1928, Adolfo Faggi (Tolstoi e Skakespeare) esamina l’opuscolo di Tolstoi su Shakespeare al quale accenna nell’articolo su Tolstoi e Manzoni già esaminato. (Leo N. Tolstoi, Skakespeare, eine kritische Studie, Hannover, 1906: il volumetto contiene anche un articolo di Ernest Crosby su L’atteggiamento dello Shakespeare davanti alle classi lavoratrici e una breve lettera di Bernard Shaw sulla filosofia dello Shakespeare). Tolstoi demolisce Shakespeare partendo dal punto di vista della sua ideologia cristiana: ne fa una critica non artistica, ma morale e religiosa. L’articolo del Crosby, da cui prese le mosse, dimostra, contrariamente all’opinione di molti illustri inglesi, che non c’è in tutta l’opera di Shakespeare quasi alcuna parola di simpatia per il popolo e le turbe lavoratrici. Lo Shakespeare, conforme alle tendenze del suo tempo, parteggia manifestamente per le classi elevate della società: il suo dramma è essenzialmente aristocratico. Quasi tutte le volte ch’egli introduce sulla scena dei borghesi o dei popolani, li presenta in maniera sprezzante o repugnante, e li fa materia o argomento di riso. (Cfr ciò che fa Manzoni, in misura minore, ma sempre con eguale tendenza, manifestata dall’adesione a un cristianesimo aristocratico). La lettera dello Shaw è rivolta contro Shakespeare «pensatore», non contro Shakespeare artista. Secondo Shaw nella letteratura si deve dare il primo posto a quegli autori che hanno superato la morale del loro tempo e intravedute le nuove esigenze dell’avvenire: Shakespeare non fu «moralmente» superiore al suo tempo, ecc.
Nella mia trattazione dovrò evitare di apparire impeciato di tendenze moralistiche di tipo Tolstoi e anche di tipo Shaw. Per me si tratta di una ricerca di storia della cultura, non di critica artistica, altro che indirettamente (dimostrare che non io domando un contenuto morale «estrinseco», ma gli autori esaminati introducono un contenuto morale estrinseco, cioè fanno della propaganda e non dell’arte): fissare non perché un libro è «bello», ma perché esso è «letto», è «popolare», «ricercato».
Q3 §152 «Spectator» = Mario Missiroli. Che «Spectator», autore di alcuni articoli nella «Nuova Antologia» e nel «Resto del Carlino» sia Mario Missiroli è provato oltre che da prove interne (stile, modo di impostare i problemi, riferimenti a Sorel e a lettere inedite di Sorel, ecc.) anche dal fatto che alcune recensioni anonime pubblicate dalla Nuova Antologia nel 1929 sono apparse, per es. nell’«Italia letteraria», con la firma di Missiroli.
Q3 §153 Letteratura popolare. sul romanzo poliziesco. Il romanzo poliziesco è nato ai margini della letteratura delle «Cause Celebri» (che a sua volta è collegata ai romanzi tipo Conte di Montecristo ecc.: non si tratta anche qui di «cause celebri» tipiche, che riassumono cioè l’ideologia popolare intorno alla amministrazione della giustizia, specialmente se ad essa s’intreccia la passione politica? E Rodin dell’Ebreo Errante non è anch’esso un tipo di «organizzatore» di intrighi scellerati, e il principe Rodolfo l’organizzatore di «amicizie del popolo»? Il passaggio da questi romanzi a quelli d’avventura segue un processo di «fissazione» dello schema dell’intrigo, ma specialmente segna una depurazione dall’elemento ideologico piccolo borghese e democratico: non più lotta tra il popolo buono e generoso ecc. e le forze misteriose della tirannide‑gesuiti ecc. –, ma tra delinquente e poliziotto sulla base della legge scritta).
Le «Cause Celebri», nella celebre collezione francese, avevano il corrispettivo in Inghilterra e in Germania (e in Italia? Fu tradotta, credo, la collezione francese, almeno in parte, per i processi di fama mondiale). Nasce una letteratura di carattere «giudiziario»: il grande delinquente viene rappresentato come superiore alla giustizia (all’apparato giudiziario); romanticismo = Masnadieri di Schiller. Racconti di Hoffmann, Anna Radcliffe, Balzac, Vautrin. Lo Javert di Victor Hugo inizia una riabilitazione del poliziotto; non che Javert sia presentato simpaticamente, ma appare come un «uomo di carattere», «la legge personificata». Rocambole e Ponson du Terrail. Gaboriati riabilita il poliziotto: Lecocq apre la strada a Sherlock Holmes. (Non è vero che gli Anglosassoni rappresentino in questa letteratura la «difesa della legge», mentre i Francesi rappresentano l’esaltazione del delinquente: negli Stati Uniti prevale forse la rappresentazione del grande delinquente ecc.). In questa letteratura un aspetto «meccanico» e un aspetto «artistico». Poe e Chesterton l’aspetto artistico.
Q3 §154 Aspetto nazionale‑popolare negativo della letteratura italiana. Su Bruno Cicognani, scrive Alfredo Gargiulo nell’«Italia Letteraria» del 24 agosto 1930 (cap. XIX di 1900‑1930): «L’uomo e l’artista fanno nel Cicognani una cosa sola: nondimeno si sente il bisogno di dichiarar subito, quasi in separata sede (!), la simpatia che ispira l’uomo. L’umanissimo Cicognani! Qualche sconfinamento, lieve del resto, nell’umanitarismo di tipo romantico o slavo: che importa? Ognuno sarà disposto a perdonarglielo, in omaggio a quell’autentica (!) fondamentale umanità». Dal seguito non si capisce bene ciò che il Gargiulo voglia dire: è caso «mostruoso» che l’uomo e l’artista facciano una cosa sola? E cosa significa «l’autentica fondamentale umanità»: «autentico» sostituisce il «vero» di una volta, troppo screditato. Bisognerebbe, come detto altrove, leggere tutta l’esposizione del Gargiulo: per me «umanità» autentica, fondamentale ecc. può significare una cosa sola: «storicità», cioè carattere «nazionale-popolare» dello scrittore, sia pure in senso largo, «socialità» dello scrittore, anche in senso «aristocratico», purché il gruppo sociale che esso esprime sia vivo storicamente e il «collegamento» sociale non sia di carattere «pratico‑politico» cioè predicatorio moralistico, ma «storico morale».
Q3 §155 L’architettura nuova. Speciale carattere obbiettivo dell’architettura. Realmente l’«opera d’arte» è il «progetto» (l’insieme dei disegni e dei piani e dei calcoli, coi quali persone diverse dall’architetto «artista‑progettista» possono realizzare l’edifizio, ecc.): un architetto può essere giudicato grande artista dai suoi piani, anche senza aver edificato materialmente nulla. Il progetto sta all’edifizio materiale come il «manoscritto» sta al libro stampato: l’edifizio è l’estrinsecazione sociale dell’arte, la sua «diffusione», la possibilità data al pubblico di partecipare alla bellezza (quando è tale), così come il libro stampato.
Cade l’obbiezione del Tilgher al Croce a proposito della «memoria» come causa dell’estrinsecazione artistica: l’architetto non ha bisogno dell’edifizio per «ricordare» ma del progetto. Ciò sia detto anche solo considerando la «memoria» crociana come approssimazione relativa nel problema del perché il pittore dipinge, lo scrittore scrive ecc. e non si accontenta di costruire fantasmi per solo suo uso e consumo: e tenendo conto che ogni progetto architettonico ha un carattere di «approssimazione» maggiore che il manoscritto, la pittura ecc. Anche lo scrittore introduce innovazioni per ogni edizione del libro (o corregge le bozze modificando ecc., cfr Manzoni): nell’architettura la quistione è più complessa, perché l’edifizio è compiuto mai in sé completamente, ma deve avere degli adattamenti anche in rapporto al «panorama» in cui viene inserito ecc. (e non si possono fare di esso delle seconde edizioni così facilmente come di un libro ecc.). Ma il punto più importante da osservare oggi è questo: che in una civiltà a rapido sviluppo, in cui il «panorama» urbano deve essere molto «elastico», non può nascere una grande arte architettonica, perché è più difficile pensare edifizi fatti per l’«eternità». In America si calcola che un grattacielo debba durare non più di 25 anni, perché si suppone che in 25 anni l’intera città «possa» mutare fisionomia, ecc. ecc. Secondo me, una grande arte architettonica può nascere solo dopo una fase transitoria di carattere «pratico», in cui cioè si cerchi solo di raggiungere la massima soddisfazione ai bisogni elementari del popolo col massimo di convenienze: ciò inteso in senso largo, non cioè solo per quanto riguarda il singolo edifizio, la singola abitazione o il singolo luogo di riunione per grandi masse, ma in quanto riguarda un complesso architettonico, con strade, piazze, giardini, parchi, ecc.
Q3 §156 Lorianismo. Trombetti e la monogenesi del linguaggio. La Nuova Antologia, che in un articolo di Pericle Ducati (già da me notato precedentemente) aveva esaltato l’opera del Trombetti per l’interpretazione dell’etrusco, nel numero del 1° marzo 1929 pubblica una nota di V. Pisani, Divagazioni etrusche, completamente stroncatoria. Il Pisani ricorda contro il Trombetti alcuni canoni elementari per lo studio critico della scienza delle lingue:
1°. Il metodo puramente etimologico è privo di consistenza scientifica: la lingua non è il puro lessico, errore volgare e diffusissimo: le singole parole astrattamente prese, anche somigliantissime in una determinata fase storica, possono: a) essere nate indipendentemente l’una dall’altra; esempio classico mysterion greco ed ebraico, con lo stesso significato: ma in greco il significato è dato da myst-, ed ‑erion è suffisso per gli astratti, mentre in ebraico è il contrario: ‑erion (o terion) è la radicale fondamentale e myst- (o mys‑) è il prefisso generico; così haben tedesco non ha la stessa origine di habere latino, né to call inglese di xaléo greco o di calãre latino (chiamare), né ähnlich tedesco può unirsi ad anàlogos greco ecc. Il Littmann pubblicò, nella Zeitschrift der Deutschen Morgenl. Gesellschaft, LXXVI, pp. 270 sgg., una lista di queste apparenti concordanze per dimostrare l’assurdità dell’etimologia antiscientifica; b) possono essere state importate da una lingua all’altra in epoche relativamente preistoriche: per esempio: l’America è stata «scoperta» da Cristoforo Colombo «solo» dal punto di vista della civiltà europea nel complesso, cioè Cristoforo Colombo ha fatto entrare l’America nella zona d’influsso della civiltà europea, della storia europea; ma ciò non esclude, tutt’altro, che elementi europei, o di altri continenti, possano essere andati in America anche in gruppi relativamente considerevoli e avervi lasciato delle «parole», delle forme lessicali più o meno considerevoli; ciò può ripetersi per l’Australia e per ogni altra parte del mondo; come si può allora affermare, come fa il Trombetti, su numeri relativamente scarsi di forme lessicali (30‑40), che tali forme siano documento della monogenesi?
2°. Le forme lessicali e i loro significati devono essere confrontate per fasi storiche omogenee delle lingue rispettive, per ogni forma occorre perciò «fare» oltre la storia fonologica anche la storia semantica e confrontare i significati più antichi. Il Trombetti non rispetta nessuno di questi canoni elementari: a) si accontenta, nei confronti, di significati generici affini, anche non troppo affini (qualche volta stiracchiati in modo ridicolo: ricordo un caso curiosissimo di un verbo di moto arioeuropeo confrontato con una parola di un dialetto asiatico che significa «ombelico» o giù di lì, che dovrebbero corrispondere, secondo il Trombetti, per il fatto che l’ombelico si «muove» continuamente per la respirazione!); b) basta per lui che nelle parole messe a confronto si verifichi la successione di due suoni consonantici rassomigliantisi come, per esempio, t, th, d, dh, s, ecc., oppure p, ph, f, b, bh, v, w, ecc.; si sbarazza delle altre consonanti eventuali considerandole come prefissi, suffissi o infissi.
3°. La parentela di due lingue non può essere dimostrata dalla comparazione, anche fondata, di un numero anche grandissimo di parole, se mancano gli argomenti grammaticali di indole fonetica e morfologica (e anche sintattica, sebbene in minor grado). Esempio: l’inglese che è lingua germanica anche se il lessico è molto neolatino; il rumeno che è neolatino anche se ha molte parole slave; l’albanese che è illirico anche se il lessico è greco, latino, slavo, turco, italiano; l’armeno che contiene molto iranico: persiano arabizzato ma sempre arioeuropeo ecc.
Perché il Trombetti ha avuto tanta fama? 1°. Naturalmente ha dei meriti, primo fra tutti di essere un grande poliglotta. 2°. Perché la tesi della monogenesi è sostenuta dai cattolici, che vedono nel Trombetti «un grande scienziato d’accordo colla Bibbia» e quindi lo portano sugli scudi. 3°. La boria delle nazioni. Però il Trombetti è più apprezzato dai profani che dai suoi colleghi nella sua scienza. Certo la monogenesi non può essere esclusa a priori, ma non può neanche essere provata, o almeno il Trombetti non l’ha provata. Ricordare gli epigrammi del Voltaire contro l’etimologista famigerato Ménage (Gilles, 1633‑1692) sull’etimologia di alfana > equa per esempio.
Il metodo acritico del Trombetti applicato all’etrusco non poteva dare risultati certi, evidentemente. La sua interpretazione può essere messa in serie con le tante che ne sono state date: «per caso» potrebbe essere vera, ma di questa verità non può essere data la dimostrazione. (Vedere in che consiste il metodo che il Trombetti chiama «combinatorio»: non ho materiale: pare che significhi questo: il raccostamento di un termine etrusco ignoto con un termine noto di altra lingua riputata affine deve essere controllato coi termini noti di altre lingue affini che somigliano come suono ma non coincidono tra loro nei significati ecc.: ma forse non è questo).
Q3 §157 Distacco tra dirigenti e diretti. Assume aspetti diversi a seconda delle circostanze e delle condizioni generali. Diffidenza reciproca: il dirigente dubita che il «diretto» lo inganni, esagerando i dati positivi e favorevoli all’azione e perciò nei suoi calcoli deve tener conto di questa incognita che complica l’equazione. Il «diretto» dubita dell’energia e dello spirito di risolutezza del dirigente e perciò è tratto anche inconsciamente a esagerare i dati positivi e a nascondere o sminuire i dati negativi. C’è un inganno reciproco, origine di nuove esitazioni, di diffidenze, di quistioni personali ecc. Quando ciò avviene, significa che: 1) c’è crisi di comando; 2) l’organizzazione, il blocco sociale del gruppo in parola, non ha ancora avuto il tempo di saldarsi, creando l’affiatamento reciproco, la reciproca lealtà; 3) ma c’è un terzo elemento: l’incapacità del «diretto» a svolgere il suo compito che significa poi incapacità del «dirigente» a scegliere, a controllare, a dirigere il suo personale.
Esempi pratici: un ambasciatore può ingannare il suo governo: 1) perché vuole ingannarlo per interesse personale; caso di slealtà per tradimento di carattere nazionale o statale: l’ambasciatore è o diventa l’agente di un governo diverso da quello che rappresenta; 2) perché vuole ingannarlo, essendo avversario della politica del governo e favorevole alla politica di altro partito governativo del suo stesso paese, quindi perché vuole che nel suo paese al governo vada un partito piuttosto che un altro: caso di slealtà che in ultima analisi può diventare altrettanto grave che il precedente, sebbene possa essere accompagnato da circostanze attenuanti, come sarebbe il caso che il governo non faccia una politica nazionale e l’ambasciatore ne abbia le prove perentorie: sarebbe allora slealtà verso uomini transitori per poter essere leali verso lo Stato immanente: quistione terribile perché questa giustificazione ha servito a uomini indegni moralmente (Fouché, Talleyrand e, meno, i marescialli di Napoleone); 3) perché non sa d’ingannarlo, per incapacità o incompetenza o per scorrettezza (trascura il servizio) ecc. In questo caso la responsabilità del governo deve essere graduata: 1) se avendo possibilità di scelta adeguate ha scelto male per ragioni estrinseche al servizio (nepotismo, corruzione, limitazioni di spese per servizio importante per cui invece di capaci si scelgono i «ricchi» per la diplomazia o i «nobili» ecc.); 2) se non ha possibilità di scelta (Stato nuovo, come l’Italia nel 1861‑70) e non crea le condizioni generali per sanare la deficienza e procurarsi la possibilità di scelta.
Q3 §158 Il nodo storico 1848‑49. Vedete e analizzare minutamente il succedersi dei governi e delle combinazioni di partiti al governo piemontese dalla preparazione della guerra fino al proclama di Moncalieri, da Cesare Balbo a Massimo D’Azeglio. Funzione di Gioberti e di Rattazzi. In che consistette precisamente il connubio Cavour‑Rattazzi? Fu il primo passo della disgregazione democratica? Ma fino a che punto Rattazzi poteva dirsi un democratico?
Q3 §159 Risorgimento. La storia come «biografia» nazionale. Questa forma di storia comincia col nascere del sentimento nazionale. Si presuppone che ciò che si desidera sia sempre esistito e non abbia potuto affermarsi per l’intervento di forze estranee o per l’addormentarsi delle virtù intime. È storia oleografica: l’Italia è veramente pensata come qualcosa di astratto, come la bella donna dei quadri ecc. di cui gli italiani sono i «figli» ecc. Si fa la sua biografia contrapponendola ai figli degeneri, o deviati ecc. ecc. Si capisce che questa storia è nata per ragioni pratiche, di propaganda. Ma perché continuare in questa tradizione. Oggi essa è doppiamente antistorica: perché è in contraddizione con la realtà e perché impedisce di valutare adeguatamente lo sforzo del Risorgimento, sminuendo la figura e l’originalità dei suoi protagonisti.
Q3 §160 Struttura economica italiana. Giuseppe Paratore in un articolo della Nuova Antologia del 1° marzo 1929 La Economia, la Finanza, il Denaro d’Italia scrive che l’Italia ha «una doppia costituzione economica (industriale capitalistica al nord, agraria di risparmio al sud)» e nota come tale situazione abbia reso difficile nel 26‑27 la stabilizzazione della lira. Il metodo più semplice e diretto di consolidare rapidamente la svalutazione monetaria, creando subito una nuova parità – secondo le prescrizioni di Kemmerer, Keynes, Cassel ecc. – non era consigliabile ecc.
Sarebbe interessante sapere quale fattore risultò, in ultima analisi, meglio difeso: se l’economia del Nord o quella del Sud, e ciò perché, in realtà, la stabilizzazione fu compiuta dopo molte esitazioni e sotto il panico di un crollo fulmineo (corso del dollaro nel 1928: gennaio 477,93, febbraio 479,93, marzo 480,03, aprile 479,63, maggio 500,28, giugno 527,72, luglio 575,41); bisogna inoltre tener conto che il Sud era più omogeneo rispetto al Nord nelle sue rivendicazioni e aveva la solidarietà di tutti i risparmiatori nazionali; nel Nord i capitalisti divisi, esportatori favorevoli inflazione, per il mercato interno ecc. ecc. Inoltre: la bassa stabilizzazione avrebbe provocato una crisi sociale-politica e non solo puramente economica, perché avrebbe mutato la posizione sociale di milioni di cittadini.
Q3 §161 Leone XIII. Per la sua personalità, abbastanza limitata e meschina, cfr Piero Misciatelli, Un libro di ricordi e di preghiere del papa Leone XIII, Nuova Antologia, 1° marzo 1929.
Q3 §162 Il nodo storico 1848‑49. Articolo nella «Nuova Antologia» del 1° marzo 1929: Carlo Pagani, Dopo Custoza e Volta nel 1848. Riporta alcuni documenti inediti tratti dall’Archivio Casati di Milano, non essenziali, ma significativi per vedere la crisi politica di quel momento, crisi politica che fu uno degli elementi principali della disfatta militare: mancanza di unità politica, di un indirizzo politico ben stabilito, esitazioni, azione irresponsabile delle cricche reazionarie, poca attenzione per i bisogni dell’esercito inteso come massa umana ecc.
Appare che l’Inghilterra era contraria all’intervento militare della Francia a favore del Piemonte – Palmerston dichiarò che l’intervento francese avrebbe scatenato una guerra europea perché l’Inghilterra non l’avrebbe tollerato – mentre solo mollemente appoggiava il Piemonte in via diplomatica per evitare una disfatta rovinosa e mutamenti territoriali troppo favorevoli all’Austria.
L’articolo è da rivedere in caso di ricostruzione degli avvenimenti del 48‑49 per trovare elementi di concordanza con altri documenti, e di sussidio. Per la bibliografia dell’argomento: per le vicende del ministero Casati‑Gioberti (luglio‑agosto 1848) cfr la lettera dello stesso Gioberti a Giuseppe Massari pubblicata dal sen. Matteo Mazziotti (con proemio) nella Nuova Antologia del 16 giugno 1918; per la missione di Carlo d’Adda in Francia e Inghilterra svolta per incarico del governo provvisorio di Milano cfr Pagani, Resoconto del Congresso Storico di Trento, 1926 (discorso Il Governo provvisorio di Milano nel 1848 e il Trentino, pronunziato dal Pagani al Congresso); Carlo Pagani, Uomini e cose in Milano dal marzo all’agosto del 1848, Editore Cogliati, Milano (con documenti tratti dal Museo storico del Risorgimento Italiano di Milano, e specialmente dagli Archivi Casati, d’Adda, Arese, Giulini‑Crivelli, Restelli).
Q3 §163 La «storia» del Risorgimento di Alessandro Luzio. È da notare come il modo di scrivere la storia del Risorgimento di A. Luzio sia stato lodato dai gesuiti della «Civiltà Cattolica». Non sempre immagino, ma più spesso di quanto si creda, l’accordo tra il Luzio e i gesuiti è possibile. Cfr nella «Civiltà Cattolica» del 4 agosto 1928, pp. 216‑17, nell’articolo Processo politico e condanna dell’abbate Gioberti nell’anno 1833. Il Luzio deve difendere la politica di Carlo Alberto (nel libro Mazzini carbonaro, p. 498) e non esita a giudicare aspramente l’atteggiamento del Gioberti nel processo per i fatti del 31, d’accordo coi gesuiti (è da notare che dagli articoli pubblicati dalla «Civiltà Cattolica» nel 1928 su questo processo del Gioberti risulta dai documenti degli Archivi Vaticani che il papa aveva già dato preventivamente – in forma loiolesca – il suo placet alla condanna a morte e all’esecuzione del Gioberti, mentre nel 21 la condanna a morte di un ecclesiastico in Piemonte era stata trasformata nell’ergastolo per intervento vaticano).
Q3 §164 sul movimento religioso. La redazione della «Civiltà Cattolica». Gli articoli della «Civiltà Cattolica» sono scritti tutti da padri della Compagnia di Gesù e ordinariamente non sono firmati. Qualche volta si può sapere chi siano gli autori, perché negli estratti il loro nome è pubblicato (non sempre però). Così, per es., la rubrica sulle quistioni operaie è fatta dal padre Angelo Brucculeri, che deve essere anche il rappresentante italiano nel Centro internazionale di Malines che ha compilato il Codice sociale.
Bisognerebbe procurarsi il catalogo delle pubblicazioni vendibili presso la «Civiltà Cattolica» per vedere di quali quistioni sono messi in vendita gli estratti: è un indice dell’importanza data alle quistioni stesse. Ricordare che nel 1929 (o ai primi del 30) l’«Amico delle Famiglie» pubblicò che il padre Rosa aveva lasciato la direzione della «Civiltà Cattolica» ed era stato inviato dal papa in Ispagna per una missione, dopo essergli stata donata una medaglia d’oro in riconoscimento dei servizi resi al Vaticano. L’«Amico delle Famiglie» è un settimanale cattolico di Genova e deve aver riprodotto la notizia dalla stampa quotidiana cattolica e non cattolica. Perché? Di fatto il padre Rosa andò in Ispagna ed ebbe la medaglia, ma continuò a dirigere la «Civiltà Cattolica». Evidentemente l’allontanamento del padre Rosa era desiderato, per l’atteggiamento preso sull’applicazione del Concordato, talvolta abbastanza aspro: ma il papa non credette di esaudire il pio desiderio, perché la linea del padre Rosa era quella del Vaticano e il papa teneva a farlo sapere.
La «Civiltà Cattolica» pubblica ogni tanto degli indici analitici delle sue annate: l’ultimo è quello delle annate 1911‑1925 compilato dal Cav. Giuseppe Del Chiaro, segretario di redazione. Su tutte le quistioni importanti bisognerà vedere questi indici, perché le pubblicazioni e i commenti dei gesuiti hanno una certa importanza e possono dare degli spunti: specialmente sulle quistioni di storia del Risorgimento. Ricordare la quistione dei Costituti di Federico Confalonieri. Così sulla quistione del brigantaggio dal 60 al 70: ricordare la quistione dei fratelli La Gala imbarcatisi a Civitavecchia su battello francese e arrestati a Genova dai Piemontesi, con conseguente protesta diplomatica del papa e della Francia, restituzione dei La Gala e loro estradizione ecc. Importanti sono gli articoli storici della «Civiltà Cattolica» sui movimenti cattolico‑liberali e l’odio dei gesuiti contro Gioberti che ancora oggi è vituperato banalmente ad ogni occasione.
Movimenti pancristiani. Nathan Söderblom, arcivescovo luterano di Upsala in Svezia, propugna un cattolicismo evangelico, consistente in una adesione diretta a Cristo (prof. Federico Heiler, già cattolico romano, autore del libro Der Katholizismus, seine Idee und seine Erscheinung, Monaco, 1923, della stessa tendenza, ciò che significa che i pancristiani qualche successo l’hanno avuto).
Cattolicismo nell’India. Upadhyaya Brahmabandhav, celebre Sannyasi (?) cattolico, che voleva convertire l’India al Cattolicismo, per mezzo degli stessi indù, cristianizzando le parti dell’induismo passibili di essere assorbite; fu disapprovato dal Vaticano per eccessi di nazionalismo. (Quando avvenne questa predicazione di Upadhyaya? Mi pare che oggi il Vaticano sarebbe più tollerante). Per la quistione del Cristianesimo in India vedere il fenomeno del Sadhu Sundar Sing: cfr «Civiltà Cattolica», 7 e 21 luglio 1928.
Q3 §165 Italo Toscani. Nel 1928 è uscita una Vita di S. Luigi Gonzaga di Italo Toscani, Roma, Libreria Fr. Ferrari, in 16°, pp. 254, L. 5,50, lodata dalla «Civiltà Cattolica» del 21 luglio 1928. Il Toscani già nel 26 scriveva nel «Corriere d’Italia». Ricordare le sue avventure durante la guerra. Il suo contegno al fronte (furono pubblicate dal Comando militare cartoline illustrate con suoi versi d’occasione). Suoi articoli nel 1919, specialmente contro i carabinieri: uomo repellente da ogni punto di vista. Condannato a 6 o 7 anni nel 1917 dal Tribunale di Roma per antimilitarismo, la condanna gli fu condonata per le poesie scritte al fronte; autolesionista: si «curava» gli occhi in modo così sfacciato che faceva maraviglia come al reggimento gliela passassero liscia. «Stranezze» della vita militare durante la guerra. Come mai al Toscani, abbastanza noto, si davano tanti permessi di dormire fuori della caserma? (aveva una stanza mobiliata ai Canelli; episodio tragicomico del falso Calabresi).
Q3 §166 Passato e presente. Per la compilazione esatta di questa rubrica, per avere degli spunti e per aiuto alla memoria, occorrerà esaminare accuratamente alcune collezioni di riviste: per esempio, dell’«Italia che Scrive» di Formiggini, che in determinate rubriche dà un quadro del movimento pratico della vita intellettuale – fondazione di nuove riviste, concorsi, associazioni culturali ecc. (Rubrica delle rubriche) –; della «Civiltà Cattolica» per coglierne certi atteggiamenti e per le iniziative e le affermazioni di enti religiosi (per es. nel 20 l’episcopato lombardo si pronunziò sulle crisi economiche, affermando che i capitalisti e non gli operai devono essere i primi a subirne le conseguenze). La «Civiltà Cattolica» pubblica qualche articolo sul marxismo molto interessante e sintomatico.
QUADERNO 4
APPUNTI DI FILOSOFIA. MATERIALISMO E IDEALISMO
Prima serie
Q4 §1 Se si vuole studiare una concezione del mondo che non è stata mai dall’autore‑pensatore esposta sistematicamente, occorre fare un lavoro minuzioso e condotto col massimo scrupolo di esattezza e di onestà scientifica. Occorre seguire, prima di tutto, il processo di sviluppo intellettuale del pensatore, per ricostruirlo secondo gli elementi divenuti stabili e permanenti, cioè che sono stati realmente assunti dall’autore come pensiero proprio, diverso e superiore al «materiale» precedentemente studiato e per il quale egli può aver avuto, in certi momenti, simpatia, fino ad averlo accettato provvisoriamente ed essersene servito per il suo lavoro critico o di ricostruzione storica o scientifica. Questa avvertenza è essenziale appunto quando si tratta di un pensatore non sistematico, quando si tratta di una personalità nella quale l’attività teorica e l’attività pratica sono intrecciate indissolubilmente, di un intelletto pertanto in continua creazione e in perpetuo movimento. Quindi: 1° biografia, molto minuziosa con 2° esposizione di tutte le opere, anche le più trascurabili, in ordine cronologico, divise secondo i vari periodi: di formazione intellettuale, di maturità, di possesso e applicazione serena del nuovo modo di pensare. La ricerca del leit‑motiv, del ritmo del pensiero, più importante delle singole citazioni staccate.
Questa ricerca originale deve essere il fondamento del lavoro. Inoltre, fra le opere dello stesso autore, bisogna distinguere quelle che egli ha condotto a termine e ha pubblicato, da quelle inedite, perché non compiute. Il contenuto di queste deve essere assunto con molta discrezione e cautela: esso deve essere ritenuto non definitivo, per lo meno in quella data forma; esso deve essere ritenuto materiale ancora in elaborazione, ancora provvisorio.
Nel caso di Marx l’opera letteraria può essere distinta in queste categorie: 1) opere pubblicate sotto la responsabilità diretta dell’autore: tra queste devono essere considerate, in linea generale, non solo quelle materialmente date alle stampe, ma anche gli scritti destinati ad operare immediatamente, anche se non stampati, come le lettere, le circolari, i manifesti, ecc. (esempio tipico: le Glosse al programma di Gotha e l’epistolario); 2) le opere non stampate sotto la responsabilità diretta dell’autore, ma da altri dopo la sua morte: intanto di queste sarebbe bene avere un testo diplomatico, non ancora cioè rielaborato dal compilatore, o per lo meno una minuziosa descrizione del testo originale fatta con criteri diplomatici.
L’una e l’altra categoria devono essere sezionate per periodi cronologico‑critici in modo da poter stabilire confronti validi e non puramente meccanici ed arbitrari.
Anche il lavoro di elaborazione fatto dall’autore del materiale delle opere poi da lui stampate, dovrebbe essere studiato e analizzato: per lo meno darebbe, questo studio, degli indizi per valutare criticamente l’attendibilità delle redazioni compilate da altri delle opere inedite. Quanto più il materiale preparatorio delle opere edite si allontana dal testo definitivo redatto dallo stesso autore, e tanto meno è attendibile la redazione di altro scrittore di un materiale dello stesso tipo. Infatti un’opera non può mai essere identificata col materiale bruto raccolto per la sua compilazione: la scelta, la disposizione degli elementi, il peso maggiore o minore dato a questo o a quello degli elementi raccolti nel periodo preparatorio, sono appunto ciò che costituisce l’opera effettiva.
Anche lo studio dell’epistolario deve esser fatto con certe cautele: un’affermazione recisa fatta in una lettera non sarebbe forse ripetuta in un libro. La vivacità stilistica delle lettere, se spesso è artisticamente più efficace dello stile più misurato e ponderato di un libro, qualche volta porta a deficienze di dimostrazione: nelle lettere, come nei discorsi, come nelle conversazioni si verificano più spesso errori logici; la rapidità del pensiero è a scapito della sua solidità.
Solo in seconda linea, nello studio di un pensiero originale e personale, viene il contributo di altre persone alla sua documentazione. Per Marx: Engels. Naturalmente non bisogna sottovalutare il contributo di Engels, ma non bisogna neanche identificare Engels con Marx, non bisogna pensare che tutto ciò che Engels attribuisce a Marx sia autentico in senso assoluto. È certo che Engels ha dato la prova di un disinteresse e di un’assenza di vanità personale unica nella storia della letteratura: non è menomamente da porre in dubbio la sua assoluta lealtà personale. Ma il fatto è che Engels non è Marx e che se si vuole conoscere Marx bisogna specialmente cercarlo nelle sue opere autentiche, pubblicate sotto la sua diretta personalità.
Conseguono da ciò parecchie avvertenze di metodo e alcune indicazioni per ricerche collaterali. Che valore ha il libro di Mondolfo sul Materialismo storico di Federico Engels? Il Sorel (in una sua lettera a B. Croce) pone il dubbio che si possa studiare un argomento di tal fatta, data la scarsa capacità di pensiero originale dell’Engels. A parte la quistione di merito accennata dal Sorel, mi pare che per il fatto stesso che si suppone una scarsa capacità teoretica in Engels (per lo meno una sua posizione subalterna in confronto a Marx), sia indispensabile ricercare le differenze tra il Marx che dirò autentico e l’Engels, per essere in grado di vedere ciò che non è marxistico nelle esposizioni che l’Engels fa del pensiero del suo amico: in realtà nel mondo della cultura questa distinzione non è mai fatta e le esposizioni di Engels, relativamente sistematiche (specialmente Antidühring), sono assunte come fonte autentica e spesso come sola fonte autentica. Il libro del Mondolfo mi pare perciò molto utile, a parte il suo valore intrinseco che ora non ricordo, come indicazione di una via da seguire.
Q4 §2 Il libro del De Man. Annunzio di B. Croce nella «Critica» del 1928; recensione di G. De Ruggiero nella «Critica» del 1929; recensione nella «Civiltà Cattolica» e nel «Leonardo» del 1929; accenno di G. Zibordi nel libro su Prampolini; annunzio librario dell’editore Laterza; articoli nei «Problemi del Lavoro» con riproduzione delle tesi non riportate nella traduzione Schiavi; prefazione Schiavi. L’«Italia letteraria» dell’11 agosto 1929 ne pubblicò una recensione di Umberto Barbaro. Dice il Barbaro: «... una critica del marxismo che, se si vale delle precedenti “revisioni” di carattere economico, in massima è fondata su di una quistione tattica (sic) relativa alla psicologia delle masse operaie». «Dei molti tentativi di andare “au de là” del marxismo (il traduttore, il noto avvocato Alessandro Schiavi, modifica un po’ il titolo, in “superamento” in senso crociano e assai giustificatamente (!) per altro, poiché il De Man stesso considera la sua come una posizione in antitesi necessaria per una sintesi superiore) questo non è certamente dei più poderosi e tanto meno dei più sistematici; anche perché la critica si basa prevalentemente appunto su quella misteriosa e fuggevole, benché certo affascinante pseudoscienza che è la psicologia. Nei riguardi del “movimento” questo libro è piuttosto disfattista e talvolta fornisce addirittura argomenti alle tendenze che vuol combattere: al fascismo per un gruppo di osservazioni sugli stati affettivi e sui “complessi” (in senso freudiano) degli operai da cui derivano idee di “gioia del lavoro” e di “artigianato” ed a comunismo e fascismo insieme per la scarsa efficacia degli argomenti in difesa della democrazia e del riformismo».
Q4 §3 Due aspetti del marxismo. Il marxismo è stato un momento della cultura moderna: in una certa misura ne ha determinato e fecondato alcune correnti. Lo studio di questo fenomeno molto importante e significativo è stato trascurato o è addirittura ignorato dai marxisti «ufficiali» per questa ragione: che esso ha avuto per tramite la filosofia idealista, ciò che ai marxisti legati essenzialmente alla particolare corrente di cultura dell’ultimo quarto del secolo scorso (positivismo, scientismo) pare un controsenso. Per questo mi pare da rivalutare la posizione di Antonio Labriola. Perché? Il marxismo ha subito una doppia revisione, cioè ha dato luogo a una doppia combinazione. Da un lato alcuni suoi elementi, esplicitamente o implicitamente, sono stati assorbiti da alcune correnti idealistiche (Croce, Sorel, Bergson ecc., i pragmatisti ecc.); dall’altra i marxisti «ufficiali», preoccupati di trovare una «filosofia» che contenesse il marxismo, l’hanno trovata nelle derivazioni moderne del materialismo filosofico volgare o anche in correnti idealistiche come il Kantismo (Max Adler). Il Labriola si distingue dagli uni e dagli altri con la sua affermazione che il marxismo stesso è una filosofia indipendente e originale. In questa direzione occorre lavorare, continuando e sviluppando la posizione del Labriola. Il lavoro è molto complesso e delicato. Perché il marxismo ha avuto questa sorte, di apparire assimilabile, in alcuni suoi elementi, tanto agli idealisti che ai materialisti volgari? Bisognerebbe ricercare i documenti di questa affermazione, ciò che significa fare la storia della cultura moderna dopo Marx e Engels.
Per gli idealisti: vedere quali elementi del marxismo sono stati assorbiti «esplicitamente», cioè confessatamente. Per esempio, il materialismo storico come canone empirico di ricerca storica del Croce, che ha introdotto questo suo concetto nella cultura moderna, anche fra i cattolici (cfr Olgiati) in Italia e all’estero, il valore delle ideologie ecc.; ma la parte più difficile e delicata è la ricerca degli assorbimenti «impliciti», non confessati, avvenuti perché appunto il marxismo è stato un momento della cultura, una atmosfera diffusa, che ha modificato i vecchi modi di pensare per azioni e reazioni non apparenti o non immediate. Lo studio del Sorel può dare molti indizi a questo proposito. Bisognerebbe però studiare specialmente la filosofia del Bergson e il pragmatismo per vedere in quanto certe loro posizioni sarebbero inconcepibili senza l’anello storico del marxismo; così per il Croce e Gentile ecc.
Un altro aspetto della quistione è l’insegnamento pratico che il marxismo ha dato agli stessi partiti che lo combattono per principio, così come i gesuiti combattevano Machiavelli pur applicandone i principii (in una «Opinione» pubblicata dal Missiroli nella «Stampa» del 1925 o 26 su per giù si dice: «Sarebbe da vedere se nell’intimo della loro coscienza, gli industriali più intelligenti non siano persuasi che Marx abbia visto molto bene nelle cose loro» o qualcosa di simile). Ciò è naturale, perché se Marx ha esattamente analizzato la realtà, egli non ha fatto che sistemare razionalmente ciò che gli agenti storici di questa realtà sentono confusamente e istintivamente.
L’altro aspetto della quistione è ancor più interessante. Perché anche i marxisti ufficiali hanno «combinato» il marxismo con una filosofia non marxista? Cfr R. Luxemburg in volumetto su Marx. Nel campo filosofico mi pare che la ragione storica sia da ricercare nel fatto che il marxismo ha dovuto allearsi con tendenze estranee per combattere i residui del mondo precapitalistico nelle masse popolari, specialmente nel terreno religioso. Osservazione di Sorel a proposito di Clemenceau e il marxismo nella lettera a Missiroli. Il marxismo aveva due compiti: combattere le ideologie moderne nella loro forma più raffinata e rischiarare le masse popolari, la cui cultura era medioevale. Questo secondo compito, che era fondamentale, ha assorbito tutte le forze, non solo «quantitativamente», ma «qualitativamente»; per ragioni «didattiche» il marxismo si è confuso con una forma di cultura un po’ superiore alla mentalità popolare, ma inadeguata per combattere le altre ideologie delle classi colte, mentre il marxismo originario era proprio il superamento della più alta manifestazione culturale del suo tempo, la filosofia classica tedesca. Ne è nato un «marxismo» in «combinazione» buono per la letteratura di cui parla il Sorel, ma insufficiente per creare un vasto movimento culturale che abbracci tutto l’uomo, in tutte le sue età e in tutte le sue condizioni sociali, unificando moralmente la società.
Questo fenomeno si può osservare in tutte le culture moderne, nel senso che la filosofia moderna non riesce a elaborare un programma scolastico secondo la sua visione del mondo e non riesce a elaborare una cultura popolare, ma rimane la cultura di una aristocrazia intellettuale. Questa quistione è legata alla quistione della così detta «riforma» nei paesi non protestanti. Nel volume Storia dell’età barocca in Italia, a p. 11, il Croce scrive: «Il movimento della Rinascita era rimasto aristocratico, di circoli eletti, e nella stessa Italia, che ne fu madre e nutrice, non uscì dai circoli di corte, non penetrò fino al popolo, non divenne costume o “pregiudizio”, ossia collettiva persuasione e fede. La Riforma, invece, ebbe bensì questa efficacia di penetrazione popolare, ma la pagò con un ritardo nel suo intrinseco sviluppo, con la lenta e più volte interrotta maturazione del suo germe vitale». A p. 8: «E Lutero, come quegli umanisti, depreca la tristezza e celebra la letizia, condanna l’ozio e comanda il lavoro; ma, d’altra parte, è condotto a diffidenza e ostilità contro le lettere e gli studi, sicché Erasmo poté dire: ubicumque regnat lutheranismus, ibi literarum est interitus; e certo, se non proprio per solo effetto di quella avversione in cui era entrato il suo fondatore, il protestantesimo tedesco fu per un paio di secoli pressoché sterile negli studi, nella critica, nella filosofia. I riformatori italiani, segnatamente quelli del circolo di Giovanni de Valdés e i loro amici, riunirono invece senza sforzo l’umanismo al misticismo, il culto degli studi all’austerità morale. Il calvinismo, con la sua dura concezione della grazia e la dura disciplina, neppur esso favorì la libera ricerca e il culto della bellezza; ma gli accadde, interpretando e svolgendo e adattando il concetto della grazia e quello della vocazione, di venire a promuovere energicamente la vita economica, la produzione e l’accrescimento della ricchezza». La riforma luterana e il calvinismo crearono una cultura popolare, e solo in periodi successivi una cultura superiore; i riformatori italiani furono sterili di grandi successi storici.
La filosofia moderna continua la Rinascita e la Riforma nella sua fase superiore, ma coi metodi della Rinascita, senza l’incubazione popolare della Riforma che ha creato le basi solide dello Stato moderno nelle nazioni protestantiche. Per questo suo sviluppo popolare la Riforma poté resistere all’assalto armato della coalizione cattolica e così fu fondata la nazione germanica. A questo movimento può essere paragonato l’illuminismo «politico» francese che precedé e accompagnò la Rivoluzione dell’89: anch’esso fu una riforma intellettuale e morale del popolo francese e anch’esso non fu accompagnato da una cultura superiore. (Ricordare anche qui la riduzione di Marx dei termini politici francesi «fraternité, ecc.» al linguaggio della filosofia tedesca nella Sacra Famiglia). Rinascita‑Riforma ‑ Filosofia tedesca ‑ Rivoluzione francese ‑ laicismo liberalismo ‑ storicismo ‑ filosofia moderna ‑ materialismo storico.
Il materialismo storico è il coronamento di tutto questo movimento di riforma intellettuale e morale, nella sua dialettica cultura popolare ‑ alta cultura. Corrisponde alla Riforma + Rivoluzione francese, universalità + politica; attraversa ancora la fase popolare, è diventato anche «pregiudizio» e «superstizione». Il materialismo storico, così com’è, è l’aspetto popolare dello storicismo moderno.
Nella storia della cultura, che è più larga della storia della filosofia, ogni volta che la cultura popolare è affiorata, perché si attraversava una fase di rivolgimenti sociali e dalla ganga popolare si selezionava il metallo di una nuova classe, si è avuta una fioritura di «materialismo»; viceversa le classi tradizionali si aggrappavano allo spiritualismo. Hegel, a cavallo della Rivoluzione francese e della Restaurazione, ha dialettizzato i due momenti della vita filosofica, materialismo e spiritualismo. I continuatori di Hegel hanno distrutto quest’unità, e si è ritornati al vecchio materialismo con Feuerbach e allo spiritualismo della destra hegeliana. Marx nella sua giovinezza ha rivissuto tutta questa esperienza: hegeliano, materialista feuerbacchiano, marxista, cioè ha rifatto l’unità distrutta in una nuova costruzione filosofica: già nelle tesi su Feuerbach appare nettamente questa sua nuova costruzione, questa sua nuova filosofia. Molti materialisti storici hanno rifatto per Marx ciò che era stato fatto per Hegel, cioè dall’unità dialettica sono ritornati al materialismo crudo, mentre, come detto, l’alta cultura moderna, idealista volgare, ha cercato di incorporare ciò che del marxismo le era indispensabile, anche perché questa filosofia moderna, a suo modo, ha cercato di dialettizzare anch’essa materialismo e spiritualismo, come aveva tentato Hegel e realmente fatto Marx. «Politicamente», il materialismo è vicino al popolo, alle credenze e ai pregiudizi e anche alle superstizioni popolari (cfr stregonerie degli spiritisti, Maeterlinck, ecc.). Ciò si vede nel cattolicismo e nell’ortodossia orientale. La religione popolare è crassamente materialista e la religione ufficiale cerca di non allontanarsene troppo, per non staccarsi dalle masse, per non diventare la ideologia di ristretti gruppi. I neoscolastici moderni tentano appunto di incorporare il positivismo nel cattolicismo (scuola di Lovanio ecc.).
Molti tentativi ereticali sono tentativi di riforme puramente spiritualiste della religione: ma il dualismo natura‑spirito serve molto bene alla chiesa per mantenersi legata al popolo e nello stesso tempo permettere una certa selezione aristocratica (platonismo e aristotelismo nella religione cattolica).
Nella storia degli sviluppi culturali, bisogna tener molto conto dell’organizzazione della cultura e del personale che la esprime. Cfr atteggiamento di Erasmo verso la Riforma (vedi articolo di De Ruggiero in «Nuova Italia» e suo libro sulla Riforma) e di altri intellettuali: essi piegano dinanzi alle persecuzioni e ai roghi: il portatore storico della Riforma è il popolo tedesco, non gli intellettuali. Ma questa «vigliaccheria» degli intellettuali spiega la «sterilità» della Riforma nell’alta cultura, finché dalle classi popolari riformate non si seleziona lentamente un nuovo gruppo di intellettuali ed ecco la filosofia tedesca del 700‑800. Qualcosa di simile avviene anche per il marxismo: non crea un’alta cultura perché i grandi intellettuali che si formano sul suo terreno non sono selezionati dalle classi popolari, ma dalle classi tradizionali, alle quali ritornano nelle «svolte» storiche o se rimangono con esse, è per impedirne lo sviluppo autonomo. L’affermazione che il marxismo è una filosofia nuova, indipendente, è l’affermazione della indipendenza e originalità di una nuova cultura in incubazione, che si svilupperà con lo svilupparsi delle relazioni sociali. Ciò che esiste è «combinazione» di vecchio e nuovo, equilibrio momentaneo corrispondente all’equilibrio dei rapporti sociali. Solo quando si crea uno Stato, è veramente necessario creare un’alta cultura. In ogni modo l’atteggiamento deve essere sempre critico e mai dogmatico, dev’essere un atteggiamento in certo senso romantico, ma di un romanticismo che consapevolmente ricerca la sua serena classicità.
Q4 §4 Machiavellismo e marxismo. Duplice interpretazione del Machiavelli: da parte degli uomini di Stato tirannici che vogliono conservare e aumentare il loro dominio e da parte delle tendenze liberali che vogliono modificare le forme di governo. Questa seconda tendenza ha la sua espressione nei versi del Foscolo: «che, temprando lo scettro ai regnatori, gli allor ne sfronda ed alle genti svela ecc.». Il Croce scrive che ciò dimostra la validità obbiettiva delle posizioni del Machiavelli e ciò è giustissimo.
Q4 §5 Materialismo storico e criteri o canoni pratici di interpretazione della storia e della politica cfr p. 50 bis. Confronto con ciò che per il metodo storico ha fatto il Bernheim. Il libro del Bernheim non è un trattato della filosofia dello storicismo, cioè della filosofia moderna, tuttavia implicitamente le è legato. La «sociologia marxista» (cfr il Saggio popolare) dovrebbe stare al marxismo, come il libro del Bernheim sta allo storicismo: una raccolta sistematica di criteri pratici di ricerca e di interpretazione, uno degli aspetti del «metodo filologico» generale. Sotto alcuni punti di vista si dovrebbe fare, di alcune tendenze del materialismo storico (e, per avventura, le più diffuse) la stessa critica che lo storicismo ha fatto del vecchio metodo storico e della vecchia filologia, che avevano portato a nuove forme ingenue di dogmatismo e sostituivano l’interpretazione con la descrizione esteriore, più o meno accurata dei fenomeni e specialmente col ripetere sempre: «noi siamo seguaci del metodo storico!»
Letteratura. Il rapporto artistico, anche nel materialismo storico, mostra con evidenza maggiore, le ingenuità dei pappagalli. Due scrittori rappresentano lo stesso momento sociale, ma uno è artista, l’altro no. Esaurire la quistione descrivendo ciò che rappresentano, cioè riassumendo più o meno bene le caratteristiche di un determinato ambiente sociale significa non sfiorare la quistione artistica. Questo può anche essere utile, lo è anzi certamente, ma in un campo diverso: rientra nella critica del costume, nella lotta per distruggere certe correnti di sentimenti e credenze e punti di vista, per crearne e suscitarne delle altre: ma non è critica artistica e non si può presentare come tale. È lotta per una nuova cultura. In un certo senso quindi è anche critica artistica, perché dalla nuova cultura nascerà una nuova arte e forse in questo senso, nella storia italiana, bisogna intendere il rapporto De Sanctis ‑ Croce e le polemiche sul contenuto e sulla forma. La critica del De Sanctis è militante, non è frigidamente estetica: è propria di un periodo di lotta culturale; le analisi del contenuto, la critica della «struttura» delle opere, cioè anche della coerenza logica e storica‑attuale delle masse di sentimenti rappresentati sono legate a questa lotta culturale: in ciò mi pare consista la profonda umanità e l’umanesimo del De Sanctis che lo rende simpatico anche oggi; piace sentire in lui il fervore appassionato dell’uomo di parte, che ha saldi convincimenti morali e politici e non li nasconde e non tenta neanche di nasconderli. Il Croce riesce, data la sua molteplice attività, a distinguere questi diversi aspetti che nel De Sanctis erano uniti e fusi. Nel Croce si sente la stessa cultura del De Sanctis, ma nel periodo della sua espansione e del suo trionfo: è lotta per un raffinamento della cultura, non per il suo diritto di vivere; la passione e il fervore romantici si sono composti nella serenità superiore e nell’indulgenza piena di bonomia. Ma anche nel Croce questa posizione non è permanente: subentra una fase in cui la serenità e l’indulgenza si incrinano e affiora l’acrimonia e la collera repressa: è difensiva, non aggressiva e fervida, quindi questa fase non può essere confrontata con quella del De Sanctis.
Insomma il tipo di critica letteraria propria del materialismo storico è offerto dal De Sanctis, non dal Croce o da chiunque altro (meno che mai dal Carducci): lotta per la cultura, cioè, nuovo umanesimo, critica del costume e dei sentimenti, fervore appassionato, sia pure sotto forma di sarcasmo.
Alla fase De Sanctis ha corrisposto nel periodo più recente la fase della «Voce»: si capisce su un piano subalterno. Il De Sanctis lottava per la creazione, ex‑nuovo in Italia, di una alta cultura nazionale, in opposizione ai vecchiumi di vario genere, retorica egesuitismo: la «Voce» lottava piuttosto per la divulgazione in uno strato intermedio di quella stessa cultura, lottava contro il provincialismo, ecc. ecc. Tuttavia ebbe una funzione; lavorò nella sostanza e suscitò degli artisti (naturalmente nella misura in cui gli artisti si suscitano: aiutò qualcuno a ritrovare se stesso, a svilupparsi, suscitò bisogno di interiorità e di espressione di essa ecc.). Questo problema trova un riscontro per assurdo nell’articolo di Alfredo Gargiulo Dalla cultura alla letteratura nell’«Italia Letteraria» del 6 aprile 1930 (sesto capitolo di uno studio intitolato 1900‑1930 che occorrerà tener presente per «I nipotini delpadre Bresciani»). Il Gargiulo in questa serie di articoli mostra il suo completo esaurimento intellettuale (un altro giovane senza «maturità»); egli si è completamente incanagliato con la banda dell’«Italia Letteraria» e nel capitolo in parola assume come proprio questo principio di G. B. Angioletti nella prefazione all’antologia Scrittori Nuovi compilata da Falqui e Vittorini: «Gli scrittori di questa Antologia sono dunque nuovi non perché abbiano trovato nuove forme o cantato nuovi soggetti, tutt’altro; lo sono perché hanno dell’arte un’idea diversa da quella degli scrittori che li precedettero. O, per venir subito all’essenziale, perché credono all’arte, mentre quelli credevano a molte altre cose che con l’arte nulla avevano a che vedere. Tale novità, perciò, può consentire la forma tradizionale e il contenuto antico; ma non può consentire deviamenti dall’idea essenziale dell’arte. Quale possa essere questa idea, non è qui il luogo di ripetere. Ma mi sia consentito ricordare che gli scrittori nuovi, compiendo una rivoluzione (!) che per essere stata silenziosa (!) non sarà meno memorabile (!), intendono di essere soprattutto artisti, laddove i loro predecessori si compiacevano di essere moralisti, predicatori, estetizzanti, psicologisti, edonisti, ecc.». Questo discorso non è molto chiaro e ordinato, ma se qualcosa di reale c’è in esso è un secentismo programmatico, nient’altro. Questa concezione dell’artista è un nuovo «guardarsi la lingua» nel parlare, è un nuovo «concettare». E puri costruttori di concettini, non di immagini, sono alcuni dei poeti esaltati dalla «banda», per esempio G. Ungaretti (che tra l’altro scrive una lingua sufficientemente impropria e infranciosata). Il movimento della «Voce» non poteva creare artisti, è evidente; ma lottando per una nuova cultura, si possono creare anche degli artisti. Si trattava cioè di un movimento vitale, e nella vita c’è anche l’arte. La «rivoluzione silenziosa» di cui parla Angioletti è stata solo una serie di confabulazioni da caffè e di mediocri articoli di giornale standardizzato e di rivistucola provinciale: ha prodotto sufficienza e mutria, non ha mutato idee: vedremo dei nuovi «sacerdoti dell’arte» in regime di concordato e di monopolio. (Questo paragrafo deve essere fuso nei «Nipotini del Padre Bresciani» che può diventare una scorribanda nel territorio della letteratura, in cui possono essere incastrati i motivi «teorici» sul materialismo storico nel campo artistico).
Q4 §6 Roberto Ardigò, Scritti vari raccolti e ordinati da Giovanni Marchesini, Firenze, Le Monnier, 1922. Raccoglie una parte di scritti vari che l’Ardigò aveva egli stesso ordinato e disposto per la pubblicazione. Sono interessanti per la biografia dell’Ardigò e per stabilire le sue tendenze politiche. Sono paccotiglia senza valore, se presi in sé e per sé, e anche scritti molto male. Il libro è diviso in varie sezioni. Tra le polemiche (I sezione) è notevole quella contro la massoneria del 1903. Tra le lettere (IV sezione) la lettera di Ardigò alla «Gazzetta di Mantova» per il pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele (del 29 novembre 1883). Ardigò aveva accettato di far parte di un comitato promotore di un pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele a Roma. «Il pellegrinaggio però non andava ai versi a molti scalmanati rivoluzionari, che si erano immaginati che io la pensassi come loro e quindi sconfessassi la mia fede politico‑sociale colla suddetta adesione. E così si espressero privatamente e pubblicamente colle più fiere invettive al mio indirizzo». Le lettere dell’Ardigò sono altisonanti ed enfatiche. In quella del 29 novembre 1883 si legge: «Ieri, perché tornava loro conto di farmi passare per uno dei loro, che non sono mai stato (e lo sanno o devono saperlo), mi proclamarono, con lodi che mi facevano schifo, il loro maestro; e ciò senza intendermi o intendendomi a rovescio. Oggi, perché non mi trovano pronto a prostituirmi alle loro mire parricide, vogliono pigliarmi per un orecchio perché ascolti e impari la lezione che (molto ingenuamente) si arrogano di recitarmi. Oh! quanto ho ragione di dire con Orazio: Odi profanum vulgus et arceo!». In una successiva lettera del 4 dicembre 1883 al «Bacchiglione», giornale democratico di Padova, scrive: «Come sapete fui amico di Alberto Mario; ne venero la memoria e caldeggio con tutta l’anima quelle idee e quei sentimenti che ebbi comuni con lui. E conseguentemente avverso senza esitazione le basse fazioni anarchiche antisociali... Tale mia avversione l’ho sempre espressa recisissimamente. Alcuni anni fa in un’adunanza della Società della Eguaglianza sociale di Mantova ho parlato così: La sintesi delle vostre tendenze è l’odio, la sintesi delle mie è l’amore; perciò io non sono con voi... Ma si continuava a voler far credere alla mia solidarietà col socialismo antisociale di Mantova. Sicché sentii il dovere di protestare, ecc.». La lettera fu ristampata nella «Gazzetta di Mantova» (diretta dal Luzio) (del 10 dicembre 1883) con altra coda violentissima perché gli avversari gli avevano ricordato il canonicato ecc.
L’Ardigò era un tiepido democratico e nel luglio 1884 scriveva al Luzio che «nulla mi impedirebbe di assentire» alla proposta fattagli di entrare nella lista moderata per le elezioni comunali di Mantova. Scrive anche di credere il Luzio «più radicale di molti sedicenti democratici... Molti si chiamano democratici e non sono che arruffoni sciocchi...». Nel giugno‑agosto 1883 si serviva però del giornale socialista di Imola «Il Moto» per rispondere a una serie di articoli anonimi della liberale «Gazzetta dell’Emilia» di Bologna in cui si sosteneva che l’Ardigò era un liberale di fresca data e lo si sfotteva abbastanza brillantemente se pure con molta malafede polemica. «Il Moto» naturalmente difende l’Ardigò a spada tratta e lo esalta, senza che l’Ardigò cerchi di distinguersi.
Tra i pensieri, abbastanza triti e banali, spicca quello sul Materialismo storico (p. 271) che senz’altro è da mettere nella serie delle «loriate». Lo riproduco: «Colla Concezione materialistica della Storia si vuole spiegare una formazione naturale (!), che ne (sic) dipende solo in parte e solo indirettamente, trascurando altri essenziali coefficienti. E mi spiego.
L’animale non vive, se non ha il suo nutrimento. E può procurarselo, perché in lui nasce il sentimento della fame, che lo porta a cercare il cibo. Ma in un animale, oltre il sentimento della fame, si producono molti altri sentimenti, relativi ad altre operazioni, i quali, pur essi, agiscono a muoverlo. Egli è che, col nutrimento si mantiene un dato organismo, che ha attitudini speciali, quali in una specie, quali in un’altra. Una caduta d’acqua fa muovere un mulino a produrre la farina e un telajo a produrre un drappo. Sicché pel mulino, oltre la caduta dell’acqua, occorre il grano da macinare e pel telajo occorrono i fili da comporre insieme. Mantenendosi col movimento un organismo, l’ambiente, colle sue importazioni d’altro genere (?), determina, come dicemmo, molti funzionamenti, che non dipendono direttamente dal nutrimento, ma dalla struttura speciale dell’apparecchio funzionante, da una parte, e dalla azione, ossia importazione nuova dell’ambiente dall’altra. Un uomo quindi, per esempio, è incitato in più sensi. E in tutti irresistibilmente. È incitato dal sentimento della fame, è incitato da altri sentimenti, prodotti in ragione della struttura sua speciale, e delle sensazioni e delle idee fatte nascere in lui per l’azione esterna, e per l’ammaestramento ricevuto, ecc. ecc. (sic). Deve ubbidire al primo, ma deve ubbidire anche agli altri; voglia o non voglia. E gli equilibrj che si formano tra l’impulso del primo e di questi altri, per la risultante dell’azione, riescono diversissimi, secondo una infinità di circostanze, che fanno giocare più l’uno che l’altro dei sentimenti incitanti. In una mandra di porci il sopravvento rimane al sentimento della fame, in una popolazione di uomini, ben diversamente, poiché hanno anche altre cure all’infuori di quella d’ingrassare. Nell’uomo stesso l’equilibrio si diversifica secondo le disposizioni che poterono farsi in lui, e quindi, col sentimento della fame, il ladro ruba e il galantuomo invece lavora: avendo quanto gli occorre per soddisfare alla fame, l’avaro cerca anche il non necessario, e il filosofo se ne contenta e dedica la sua opera alla scienza. L’antagonismo poi può esser tale, che riescano in prevalenza i sentimenti che sono diversi da quelli della fame, fino a farli tacere affatto, fino a sopportare di morire, ecc. ecc. ecc. (sic).
La forza, onde è, e agisce l’animale, è quella della natura, che lo investe e lo sforza ad agire in sensi moltiformi, trasformandosi variamente nel suo organismo. Poniamo che sia la luce del sole, alla quale si dovrebbe ridurre la concezione materialistica della storia, anziché alla ragione economica. Alla luce del sole, intesa in modo, che anche ad essa si possa riferire il fatto della idealità impulsiva dell’uomo». (Fine).
Il brano pare sia stato pubblicato nel «Giornale d’Italia», numero unico a beneficio della Croce Rossa, gennaio 1915; è interessante non solo come documento che l’Ardigò non conosceva neanche gli elementi primi del materialismo storico e non aveva letto che qualche articolo di giornale di provincia, stranamente capito, ma perché serve a rintracciare l’origine e la genesi di certe opinioni diffuse, come quella del «ventre». Ma perché solo in Italia si è avuta questa strana interpretazione? Il movimento alle origini è stato legato alla fame, è evidente, e l’accusa di ventraiolismo è una accusa più umiliante per chi ha lasciato un paese in tali condizioni ecc. ecc. In ogni modo il «pezzo» starà molto bene nel campionario loriano: nonostante tutto, Ardigò non era il primo venuto.
Q4 §7 Le superstrutture e la scienza. Porre la scienza a base della vita, fare della scienza una concezione del mondo significa ricadere nel concetto che il materialismo storico abbia bisogno di un altro sostegno all’infuori di se stesso. La scienza è anch’essa una superstruttura. Ma nello studio delle superstrutture la scienza occupa un posto a sé, per il fatto che la sua reazione sulla struttura ha un carattere di maggiore estensione e continuità di sviluppo, specialmente a partire dal 700, da quando fu fatto alla scienza un posto a parte nell’apprezzamento generale. Che la scienza sia una superstruttura è dimostrato dal fatto che essa ha avuto periodi interi di eclisse, scacciata da un’ideologia dominante, la religione soprattutto: la scienza e la tecnica degli arabi apparivano come stregoneria ai cristiani. La scienza non si presenta come nuda nozione obbiettiva mai; essa appare sempre rivestita da una ideologia e concretamente è scienza l’unione del fatto obbiettivo e dell’ipotesi o di un sistema di ipotesi che superano il mero fatto obbiettivo. In questo campo però è diventato relativamente facile scindere la nozione obbiettiva dal sistema di ipotesi, con un processo di astrazione che è insito nella stessa metodologia scientifica e appropriarsi l’una respingendo l’altro. In tal modo una classe può appropriarsi la scienza di un’altra classe senza accettarne l’ideologia (l’ideologia del progresso è stata creata dal progresso scientifico) e le osservazioni in proposito del Sorel (e del Missiroli) cadono.
Q4 §8 Machiavelli e Marx. Charles Benoist nella prefazione a Le Machiavélisme, Prima parte: Avant Machiavel, Parigi, Plon, 1907, scrive: «C’è machiavellismo e machiavellismo: c’è un machiavellismo vero e un machiavellismo falso: vi è un machiavellismo che è di Machiavelli e un machiavellismo che è qualche volta dei discepoli, più spesso dei nemici di Machiavelli; sono già due, anzi tre machiavellismi, quello di Machiavelli, quello dei machiavellisti, e quello degli antimachiavellisti; ma eccone un quarto: quello di coloro che non han mai letto una riga di Machiavelli e che si servono a sproposito dei verbi, dei sostantivi e degli aggettivi derivati dal suo nome. Machiavelli perciò non dovrebbe essere tenuto responsabile di quel che dopo di lui il primo o l’ultimo venuto si sono compiaciuti di fargli dire».
La innovazione fondamentale introdotta da Marx nella scienza politica e storica in confronto del Machiavelli è la dimostrazione che non esiste una «natura umana» fissa e immutabile e che pertanto la scienza politica deve essere concepita nel suo contenuto concreto (e anche nella sua formulazione logica?) come un organismo storicamente in isviluppo. Nel Machiavelli sono da vedere due elementi fondamentali: 1) l’affermazione che la politica è un’attività indipendente e autonoma che ha suoi principi e sue leggi diversi da quelli della morale e della religione in generale (questa posizione del Machiavelli ha una grande portata filosofica, perché implicitamente innova la concezione della morale e della religione, cioè innova tutta la concezione del mondo); 2) contenuto pratico e immediato dell’arte politica studiato e affermato con obbiettività realistica, in dipendenza della prima affermazione.
L’importanza storica e intellettuale delle scoperte del Machiavelli si può misurare dal fatto che esse sono ancora discusse e contraddette ancora al giorno d’oggi: ciò significa che la rivoluzione intellettuale e morale contenuta in nuce nelle dottrine del Machiavelli non si è ancora realizzata «manifestamente» come forma «pubblica» della cultura nazionale. Non che la dottrina del Machiavelli sia rimasta o fosse anche al tempo suo una cosa puramente «libresca», il patrimonio di qualche solitario pensatore. Se così fosse, il Machiavelli sarebbe stato un utopista, un puro raziocinizzatore. Come disse il Foscolo, il «Machiavelli ha svelato» qualcosa di reale, ha teorizzato una pratica. Come questo è avvenuto? Non sarebbe stato il Machiavelli un politico poco machiavellico, poiché le sue norme «si applicano, ma non si dicono»? L’affermazione del Foscolo implica quindi un giudizio storico‑politico, che non si limita solo al fatto costatato dal Croce (e in sé giustissimo) che il machiavellismo, essendo una scienza, serviva tanto ai reazionari quanto ai democratici. Il Machiavelli stesso nota che le cose che egli scrive sono applicate e sono state sempre applicate: egli quindi non vuol suggerire a chi già sa, né è da pensare in lui una pura «attività scientifica» che in questa materia sarebbe stata miracolosa al tempo suo, se oggi stesso trova non poco contrasto. Il Machiavelli quindi pensa «a chi non sa», a chi non è nato nella tradizione degli uomini di governo, in cui tutto il complesso dell’educazione di fatto, unita con l’interesse di famiglia (dinastico e patrimoniale) porta a dare il carattere del politico realistico. E chi non sa? La classe rivoluzionaria del tempo, il «popolo» e la «nazione» italiana, la democrazia che esprime dal suo seno dei «Pier Soderini» e non dei «Valentini». Il Machiavelli vuol fare l’educazione di questa classe, da cui deve nascere un «capo» che sappia quello che si fa e un popolo che sa che ciò che il capo fa è anche suo interesse, nonostante che queste azioni possono essere in contrasto con l’ideologia diffusa (la morale e la religione). Questa posizione del Machiavelli si ripete per Marx: anche la dottrina di Marx è servita oltre che alla classe alla quale Marx esplicitamente si rivolgeva (in ciò diverso e superiore al Machiavelli) anche alle classi conservatrici, il cui personale dirigente in buona parte ha fatto il suo tirocinio politico nel marxismo.
Q4 §9 Un repertorio del marxismo cfr p. 45 bis. Sarebbe utilissimo un «inventario» critico di tutte le quistioni che sono state sollevate dal marxismo: materiale, ipotesi, tentativi di soluzione ecc. Il materiale è talmente esteso, disparato, di diversissimo valore che una compilazione di questo genere avrebbe una importanza non trascurabile nel campo scolastico e propedeutico e sarebbe uno strumento di primo ordine per la diffusione degli studi sul marxismo e per il loro consolidamento in disciplina scientifica e non più in imparaticcio e dilettantismo giornalistico.
Q4 §10 Marx e Machiavelli. Questo argomento può dar luogo a un duplice lavoro: uno studio sui rapporti reali tra i due in quanto teorici della politica militante, dell’azione, e un libro che traesse dalle dottrine marxiste un sistema ordinato di politica attuale del tipo Principe. L’argomento sarebbe il partito politico, nei suoi rapporti con le classi e con lo Stato: non il partito come categoria sociologica, ma il partito che vuole fondare lo Stato. In realtà, se bene si osserva, la funzione tradizionale dell’istituto della corona è, negli Stati dittatoriali, assolta dai partiti: sono essi che pur rappresentando una classe e una sola classe, tuttavia mantengono un equilibrio con le altre classi, non avversarie ma alleate e procurano che lo sviluppo della classe rappresentata avvenga col consenso e con l’aiuto delle classi alleate. Ma il protagonista di questo «nuovo principe» non dovrebbe essere il partito in astratto, una classe in astratto, uno Stato in astratto, ma un determinato partito storico, che opera in un ambiente storico preciso, con una determinata tradizione, in una combinazione di forze sociali caratteristica e bene individuata. Si tratterebbe insomma, non di compilare un repertorio organico di massime politiche, ma di scrivere un libro «drammatico» in un certo senso, un dramma storico in atto, in cui le massime politiche fossero presentate come necessità individualizzata e non come principi di scienza.
Q4 §11 Problemi fondamentali del marxismo. Si fa (di solito) una confusione tra la cultura filosofica personale di Marx, cioè tra le correnti filosofiche e i grandi filosofi che Marx ha studiato e le origini o le parti costitutive del materialismo storico, e si cade nell’errore di ridurre la filosofia che sarebbe alla base del materialismo storico a questo o quel sistema. Certamente è interessante e necessario ricercare e approfondire gli elementi della cultura filosofica di Marx, ma tenendo presente che parte essenziale del materialismo storico non è né lo spinozismo, né lo hegelismo né il materialismo francese, ma precisamente ciò che non era contenuto se non in germe in tutte queste correnti e che Marx ha sviluppato, o di cui ha lasciato gli elementi di sviluppo; la parte essenziale del marxismo è nel superamento delle vecchie filosofie e anche nel modo di concepire la filosofia, ed è ciò che bisogna dimostrare e sviluppare sistematicamente. In sede teorica, il marxismo non si confonde e non si riduce a nessun’altra filosofia: esso non è solo originale in quanto supera le filosofie precedenti, ma è originale specialmente in quanto apre una strada completamente nuova, cioè rinnova da cima a fondo il modo di concepire la filosofia. In sede di ricerca storica si dovrà studiare da quali elementi Marx ha preso occasione per il suo filosofare, quali elementi ha incorporato rendendoli omogenei ecc.: allora si dovrà riconoscere che di questi elementi «originari» l’hegelismo è il più importante relativamente, specialmente per il suo tentativo di superare le concezioni tradizionali di «idealismo» e di «materialismo». Quando si dice che Marx adopera l’espressione «immanenza» in senso metaforico, non si dice nulla: in realtà Marx dà al termine «immanenza» un significato proprio, egli cioè non è un «panteista» nel senso metafisico tradizionale, ma è un «marxista» o un «materialista storico». Di questa espressione «materialismo storico» si è dato il maggior peso al primo membro, mentre dovrebbe essere dato al secondo: Marx è essenzialmente uno «storicista» ecc.
Q4 §12 Struttura e superstruttura. Bisogna fissar bene il significato del concetto di struttura e di superstruttura, così come il significato di «strumento tecnico» ecc. o si cade in confusioni disastrose e risibili. La complessità della quistione si vede da ciò: le biblioteche sono struttura o superstruttura? I gabinetti sperimentali degli scienziati? Gli strumenti musicali di un’orchestra? ecc. Si confonde struttura con «struttura materiale» in genere e «strumento tecnico» con ogni strumento materiale ecc., fino a sostenere che una determinata arte si è sviluppata perché si sono sviluppati gli strumenti specifici per cui le espressioni artistiche complete diventano di dominio pubblico, possono essere riprodotte. Non si può negare una certa relazione, ma non diretta e immediata. In realtà certe forme di strumento tecnico hanno una doppia fenomenologia: sono struttura e sono superstruttura: l’industria tipografica stessa, che ha assunto in questa particolare sezione dello «strumento tecnico», una importanza inaudita, partecipa di questa doppia natura. Essa è oggetto di proprietà, quindi di divisione di classe e di lotta, ma è anche elemento inscindibile di un fatto ideologico, o di più fatti ideologici: la scienza, la letteratura, la religione, la politica ecc. Ci sono delle superstrutture che hanno una «struttura materiale»: ma il loro carattere rimane quello di superstrutture: il loro sviluppo non è «immanente» nella loro particolare «struttura materiale» ma nella «struttura materiale» della società. Una classe si forma sulla base della sua funzione nel mondo produttivo: lo sviluppo e la lotta per il potere e per la conservazione del potere crea le superstrutture che determinano la formazione di una «speciale struttura materiale» per la loro diffusione ecc. Il pensiero scientifico è una superstruttura che crea «gli strumenti scientifici»; la musica è una superstruttura che crea gli strumenti musicali. Logicamente e anche cronologicamente si ha: struttura sociale ‑ superstruttura ‑ struttura materiale della superstruttura.
Q4 §13 e osservazioni critiche sul «Saggio popolare». La prima osservazione da farsi è che il titolo non corrisponde al contenuto del libro. Teoria del materialismo storico dovrebbe significare sistemazione logica dei concetti filosofici che sono noti sotto il nome di materialismo storico. Il primo capitolo, o un’introduzione generale, dovrebbero aver trattato la quistione: che cos’è la filosofia? una concezione del mondo è una filosofia? come è stata finora concepita la filosofia? il materialismo storico rinnova questa concezione? quali rapporti esistono tra le ideologie, le concezioni del mondo, le filosofie? La risposta a questa serie di domande costituisce la «teoria» del materialismo storico. Nel Saggio popolare non è giustificata la premessa implicita nell’esposizione (sebbene non sempre logicamente coerente con molte affermazioni) ed esplicitamente accennata qua e là che la filosofia del materialismo storico è il materialismo filosofico: cosa significa realmente questa affermazione? Se essa fosse vera, la teoria del materialismo storico sarebbe il materialismo filosofico; ma, in tal caso, cosa sarebbe il materialismo storico stesso? Anche la risposta a queste domande non si ha.
Non è neanche giustificato il nesso tra il titolo generale Teoria ecc. e il sottotitolo Saggio popolare di sociologia marxista; il sottotitolo è più esatto se si dà del termine «sociologia» una definizione circoscritta. Infatti si presenta la quistione: che cosa è stata e che cosa è la «sociologia»? Non è essa un embrione di filosofia non sviluppata? La «sociologia» non ha cercato di fare qualcosa di simile al «materialismo storico»? Solo che bisogna intendersi: il materialismo storico è nato sotto forma di criteri pratici (in grandissima parte, almeno) per un puro caso, perché Marx ha dedicato le sue forze intellettuali ad altri problemi; ma in questi criteri pratici è implicita tutta una concezione del mondo, una filosofia. La sociologia è il tentativo di creare una metodologia storico‑politica in dipendenza da un sistema filosofico già elaborato, sul quale la sociologia ha reagito, ma solo parzialmente. La sociologia è quindi diventata una tendenza a sé, è diventata la filosofia dei non filosofi; un tentativo di classificare e descrivere schematicamente i fatti storici e politici, secondo dei criteri costruiti sul modello delle scienze, di determinate scienze. In ogni caso ogni sociologia presuppone una filosofia, una concezione del mondo; essa stessa è di queste un frammento subordinato. Né bisogna confondere con la «teoria» generale, con la «filosofia», la particolare «logica» interna delle diverse sociologie, per cui esse acquistano una meccanica coerenza.
Tutti questi problemi sono problemi «teorici», non quelli che l’autore del saggio pone come tali. Le quistioni che egli pone sono quistioni di ordine immediato, politico, ideologico, intesa l’«ideologia» come una fase intermedia tra la teoria generale e la pratica immediata o politica. Sono riflessioni su fatti singoli storico‑politici, slegati e casuali. Una quistione «teorica» si presenta all’autore fin dall’inizio, quando parla di quella tendenza che nega la possibilità di costruire una «sociologia» marxista e sostiene che il marxismo può esprimersi solo in lavori storici concreti. L’obbiezione, che è importantissima, non è risolta dall’autore che con parole1. Certo il marxismo si realizza nello studio concreto della storia passata e nell’attività attuale di creazione di nuova storia. Ma si può sempre fare la teoria della storia passata e della politica attuale, dato che se i fatti sono individui e sempre mutevoli nel flutto del movimento storico, i concetti possono essere teorizzati.
Il non aver posto la quistione della «teoria» impedisce anche una giusta posizione della quistione: che cosa è la religione, e un apprezzamento delle filosofie passate che diventano tutte delirio e follia. Si cade nel dogmatismo, ecc. ecc. (Studiare bene la quistione della «sociologia» e dei suoi rapporti col marxismo). Cfr p. 58.
Q4 §14 Il concetto di «ortodossia». Da quanto si è detto sopra, il concetto di «ortodossia» deve essere rinnovato e riportato alle sue origini autentiche. L’ortodossia non deve essere ricercata in questo o quello dei discepoli di Marx, in quella o questa tendenza legata a correnti estranee al marxismo, ma nel concetto che il marxismo basta a se stesso, contiene in sé tutti gli elementi fondamentali, non solo per costruire una totale concezione del mondo, una totale filosofia, ma per vivificare una totale organizzazione pratica della società, cioè per diventare una integrale, totale civiltà. Questo concetto così rinnovato di ortodossia, serve a precisare meglio l’attributo di «rivoluzionaria» attribuito a una concezione del mondo, a una teoria. Il cristianesimo fu rivoluzionario in confronto del paganesimo perché fu un elemento di scissione completa tra i sostenitori del vecchio e del nuovo mondo. Una teoria è rivoluzionaria in quanto è appunto elemento di separazione completa in due campi, in quanto è vertice inaccessibile agli avversari. Ritenere che il materialismo storico non sia una struttura di pensiero completamente autonoma significa in realtà non avere completamente tagliato i legami col vecchio mondo. In realtà, il materialismo storico non ha bisogno di sostegni eterogenei: esso stesso è così robusto, che il vecchio mondo vi ricorre per fornire il suo arsenale di qualche arma più efficace. Ciò significa che mentre il materialismo storico non subisce egemonie, incomincia esso stesso ad esercitare una egemonia sul vecchio mondo intellettuale. Ciò avviene in forme reciproche naturalmente, ma è appunto ciò che bisogna sventare. Il vecchio mondo, rendendo omaggio al materialismo storico cerca di ridurlo a un corpo di criteri subordinati, di secondo grado, da incorporare nella sua teoria generale, idealistica o materialistica: chi riduce a un ruolo simile il materialismo storico nel campo proprio di questa teoria, capitola implicitamente dinanzi agli avversari.
Q4 §15 Croce e Marx. Gli accenni che Croce fa a Marx debbono essere studiati nei diversi periodi della sua attività di studioso e di uomo pratico. Egli si avvicina a Marx da giovane, quando volle mettere d’accordo «le tendenze democratiche ... state sempre naturali al suo animo» col suo odio contro il positivismo. «Il mio stomaco si ricusò di digerirla (la democrazia), finché essa non prese qualche condimento dal socialismo marxistico, il quale, cosa ormai notissima, è imbevuto di filosofia classica tedesca» (cfr Cultura e vita morale, seconda ediz., p. 45). Se ne allontana nei periodi di democrazia fino al 14. Vi ritorna durante la guerra (cfr specialmente la prefazione del 1917 al Materialismo storico ed economia marxistica; e cfr il suo giudizio riferito dal De Ruggiero che la guerra era la guerra del materialismo storico) ma se ne allontana nel primo e specialmente nel secondo dopo guerra, quando una gran parte della sua attività critico-pratica è rivolta a scalzare il materialismo storico poiché sente e prevede che esso dovrà riaffermarsi con estremo vigore dopo l’ubbriacatura di astrazioni ampollose delle filosofie ufficiali ed ufficiale ma specialmente come conseguenza delle condizioni pratiche e dell’intervenzionismo statale (cfr per questa preoccupazione le lettere del Croce stampate nella «Nuova Rivista Storica» negli anni 1928‑29 a proposito della storia etico‑politica) .
Il punto che più interessa di esaminare è quello delle «ideologie» e del loro valore: rilevare le contraddizioni in cui il Croce cade a questo proposito. Nel volumetto Elementi di politica il Croce scrive che per Marx le «superstrutture» sono apparenza e illusione e di ciò fa un torto a Marx (cfr bene il punto di quistione). Ma è vero ciò? La teoria di Croce sulle ideologie, ripetuta recentemente nella recensione apparsa sulla «Critica» del volumetto del Malagodi è di evidente origine marxista: le ideologie sono costruzioni pratiche, sono strumenti di direzione politica, sebbene essa non riproduca della dottrina marxista che una parte, la parte critico‑distruttiva. Per Marx le «ideologie» sono tutt’altro che illusioni e apparenza; sono una realtà oggettiva ed operante, ma non sono la molla della storia, ecco tutto. Non sono le ideologie che creano la realtà sociale, ma è la realtà sociale, nella sua struttura produttiva, che crea le ideologie. Come Marx potrebbe aver pensato che le superstrutture sono apparenza ed illusione? Anche le sue dottrine sono una superstruttura. Marx afferma esplicitamente che gli uomini prendono coscienza dei loro compiti nel terreno ideologico, delle superstrutture, il che non è piccola affermazione di «realtà»: la sua teoria vuole appunto anch’essa «far prendere coscienza» dei propri compiti, della propria forza, del proprio divenire a un determinato gruppo sociale. Ma egli distrugge le «ideologie» dei gruppi sociali avversi, che appunto sono strumenti pratici di dominio politico sulla restante società: egli dimostra come esse siano prive di senso, perché in contraddizione con la realtà effettuale. Il Croce si trova intellettualmente a mal partito. Egli che nella prefazione del 1917 al Materialismo storico ecc. scrisse: «gli serberemo (al Marx) ... altresì la nostra gratitudine, per aver conferito a renderci insensibili alle alcinesche seduzioni ... della Dea Giustizia e della Dea Umanità», deve ora fare molti passi a ritroso e dare apparenza di florida giovinezza a un’altra decrepita maga sdentata, il liberalismo più o meno deificato.
Questo argomento del valore concreto delle superstrutture in Marx dovrebbe essere bene studiato. Ricordare il concetto di Sorel del «blocco storico». Se gli uomini prendono coscienza del loro compito nel terreno delle superstrutture, ciò significa che tra struttura e superstrutture c’è un nesso necessario e vitale, così come nel corpo umano tra la pelle e lo scheletro: si direbbe uno sproposito se si affermasse che l’uomo si mantiene eretto sulla pelle e non sullo scheletro, e tuttavia ciò non significa che la pelle sia una cosa apparente e illusoria, tanto vero che non è molto gradevole la situazione dell’uomo scorticato. Così sarebbe uno sproposito dire che il colore delle guance sia la causa della salute e non viceversa ecc. (Il paragone del corpo umano può servire per rendere popolari questi concetti, come metafora appropriata). Non ci si innamora di una donna per la forma dello scheletro e tuttavia anche questa forma contribuendo all’armonia generale delle forme esterne e persino alla disposizione della pelle, è un elemento di attrazione sessuale. Semplice metafora perché mentre la storia registra mutamenti radicali di strutture sociali, nel regno animale si può parlare solo, caso mai, di lentissime evoluzioni.
Q4 §16 La teleologia nel «Saggio popolare». Un’osservazione generale: le dottrine filosofiche sono tutte presentate su uno stesso piano di trivialità e di banalità, così che pare al lettore che tutta la cultura precedente sia stata una fantasmagoria di baccanti in delirio. Il metodo è riprovevole da molti punti di vista: un lettore serio, che poi amplii le sue cognizioni e approfondisca i suoi studi, crede di essere stato preso in giro e rigetta tutto il sistema. È facile parere di aver superato una posizione abbassandola, ma si tratta di un puro sofisma di parole: il superamento è avvenuto solo sulla carta e lo studioso si ritrova la difficoltà dinanzi in forma paurosa. La superficialità non è un buon metodo pedagogico. Presentare così le quistioni può avere significato in un Voltaire, ma non è Voltaire chiunque voglia, cioè non è un grande artista.
La quistione della teleologia: il Saggio popolare presenta la teleologia nelle sue forme più esagerate e infantili e dimentica la soluzione datane dal Kant; si potrebbe dimostrare perciò quante soluzioni sono «teleologiche» nel Saggio inconsapevolmente: per esempio, mi pare che il capitolo sull’«Equilibrio tra la natura e la società» sia appunto concepito secondo la teleologia kantiana. (Vedere bene questo argomento. In generale ricordare che tutte queste sono provvisorie e scritte a penna corrente: esse sono da rivedere e da controllare minutamente, perché certamente contengono inesattezze, anacronismi, falsi accostamenti ecc. che non importano danno perché le hanno solo l’ufficio di promemoria rapido).
Q4 §17 L’immanenza e il «Saggio popolare». Ciò che si è detto della «teleologia» si può ripetere dell’«immanenza». Nel Saggio popolare si nota che Marx adopera l’espressione «immanenza», «immanente», e si dice che evidentemente quest’uso è «metaforico». Benissimo. Ma si è così spiegato il significato che l’espressione «immanenza» ha metaforicamente in Marx? Perché Marx continua a usare questa espressione? Solo per l’orrore di creare termini nuovi? Quando da una concezione si passa ad un’altra, il linguaggio precedente rimane, ma viene usato metaforicamente. Tutto il linguaggio è diventato una metafora e la storia della semantica è anche un aspetto della storia della cultura: il linguaggio è una cosa vivente e nello stesso tempo è un museo di fossili della vita passata. Quando io adopero la parola «disastro» nessuno può imputarmi di credenze astrologiche, o quando dico «per Bacco» nessuno può credere che io sia un adoratore delle divinità pagane, tuttavia quelle espressioni sono una prova che la civiltà moderna è anche uno sviluppo del paganesimo e dell’astrologia. L’espressione «immanenza» in Marx ha un preciso significato e questo occorreva definire: in realtà questa definizione sarebbe stata veramente «teoria». Marx continua la filosofia dell’immanenza, ma la depura da tutto il suo apparato metafisico e la conduce nel terreno concreto della storia. L’uso è metaforico solo nel senso che la concezione è stata superata, è stata sviluppata ecc. D’altronde l’immanenza di Marx è completamente una cosa nuova? O non se ne trovano tracce nella filosofia precedente? In Giordano Bruno, per esempio, credo si trovino tracce di una tale concezione. Conosceva Marx il Bruno? O questi elementi dal Bruno passarono nella filosofia classica tedesca? Tutti problemi da vedere concretamente.
Q4 §18 La tecnica del pensare. Cfr F. Engels: Prefazione all’Antidühring (3a edizione, Stuttgart, 1894, p. XIX): che «l’arte di operare coi concetti non è alcunché d’innato o di dato nella coscienza comune, ma è un lavoro tecnico del pensiero, che ha una lunga storia, né più né meno della ricerca sperimentale delle scienze naturali» (citato dal Croce, Materialismo storico ed economia marxistica, 1921iv, p. 31). Questo concetto di Engels è richiamato da me in varie . Vedere il testo originale di Engels, parafrasato dal Croce, il quale nota tra parentesi che questo concetto non è «peregrino», cioè era diventato di senso comune già prima di Engels. Per me non si tratta del fatto della maggiore o minore originalità dell’affermazione di Engels, ma della sua importanza e del posto che occupa nel materialismo storico. Mi pare che ad essa occorra richiamarsi per intendere ciò che vuol dire Engels quando scrive che dopo Marx della vecchia filosofia rimane, tra l’altro, la logica formale, affermazione che il Croce riporta nel suo saggio sullo Hegel con un punto esclamativo. Lo stupore del Croce quanto alla «riabilitazione» della logica formale implicita nell’affermazione di Engels, deve essere collegato alla sua dottrina della tecnica nell’arte per esempio, ma il paragone in questo caso sarebbe fallacissimo. Se può esistere un artista che non conosce nulla dell’elaborazione tecnica precedente, non si può dire lo stesso nella sfera della scienza e del pensiero, in cui esiste progresso e deve esistere progresso metodico e di tecnica proprio come nelle scienze sperimentali. La quistione che sorge sarà del posto che questa tecnica deve occupare nel quadro della scienza del pensiero: se si prende l’esempio della dialettica, l’importanza di questo posto apparirà subito. La dialettica è anche una tecnica ed è proprio come tale che trova difficoltà presso molti filosofi ad essere accettata; ma è anche un nuovo pensiero, una nuova filosofia. Si può staccare il fatto tecnico dal fatto filosofico? Nella «Critica» del Croce sono state pubblicate molte recensioni che dimostrano questa incomprensione della tecnica dialettica e della nuova maniera di pensare.
Mi pare di aver notato altrove l’importanza che ha la tecnica del pensiero nella costruzione di un programma didattico: anche qui non si può fare il paragone tra la tecnica del pensiero e le vecchie retoriche. Queste né creavano artisti, né creavano il gusto, né davano criteri per apprezzare la bellezza: erano inutili in sé e se avevano risultati era per l’opera vivente del maestro. La tecnica del pensiero non creerà certamente grandi filosofi, ma darà criteri di giudizio e correggerà le storture del modo di pensare del senso comune. Sarebbe interessante un paragone tra la tecnica del senso comune, della filosofia dell’uomo della strada, e la tecnica del pensiero moderno più sviluppato. Anche in questo riguardo vale l’osservazione del Macaulay sulle debolezze logiche della cultura formatasi per via oratoria e declamatoria. Tutto questo argomento deve essere ben studiato, dopo aver raccolto tutto il materiale possibile in proposito. (Vedere anche le dottrine dei pragmatisti sul linguaggio come causa di errore – il libretto del Prezzolini – e le quistioni poste dal Pareto sullo stesso argomento). Si tratta in parte di una propedeutica (ma non solo di ciò, perché l’immagine di «strumento» tecnico può trarre in errore e tra «tecnica» e «pensiero in atto» esistono più identità che non esistano nelle scienze tra «strumenti materiali» e scienza propriamente detta): un astronomo che non sappia servirsi dei suoi strumenti non sarebbe un astronomo, quantunque tra «strumenti astronomici» e astronomia i rapporti siano esteriori e meccanici. Un poeta può non saper leggere e scrivere: in un certo senso anche un pensatore può farsi leggere e scrivere tutto ciò che lo interessa degli altri ed egli ha pensato. Il leggere e scrivere si riferiscono alla memoria, sono un aiuto della memoria. La tecnica del pensiero non può essere paragonata a queste cose, per cui si possa dire che importa insegnare questa tecnica come importa insegnare a leggere e a scrivere senza che ciò interessi la filosofia come il leggere e scrivere non interessa il poeta come tale.
Q4 §19 Lo «strumento tecnico» nel «Saggio popolare». Ho già fatto qualche appunto su questo argomento precedentemente. Bisogna però vedere non solo le affermazioni più evidentemente errate (come quella dello strumento tecnico e la musica) ma la concezione generale dello «strumento tecnico» che è sbagliata nel suo complesso. Nel suo saggio sul Loria il Croce nota come sia appunto stato il fiero Achille a sostituire arbitrariamente all’espressione marxista «forze materiali di produzione» l’altra di «strumento tecnico» (a pp. 39‑40 del Materialismo storico ed economia marxistica c’è un confronto tra il brano della prefazione alla Critica dell’economia politica in cui si svolgono i principi del materialismo storico e un brano del libro di Loria La terra e il sistema sociale, prolusione – Verona, Drucker, 1892 – in cui la sostituzione è stata fatta in modo ridevole). Questo metodo loriano ha poi trovato il suo coronamento nell’articolo sull’Influenza sociale dell’aeroplano che mi pare incominci proprio con la ripetizione di queste parole generali sull’importanza fondamentale dello strumento tecnico.
Il Croce nota che Marx ha spesso messo in rilievo l’importanza storica delle invenzioni tecniche e invocato una storia della tecnica (Das Kapital, I, 143 n., 335‑6 n., non si dice di quale edizione ma dev’essere quella di Kautsky) ma non si è mai sognato di fare dello «strumento tecnico» la causa unica e suprema dello svolgimento economico. Il brano della Critica dell’economia politica contiene le espressioni «grado di sviluppo delle materiali forze di produzione», «modo di produzione della vita materiale», «condizioni economiche della produzione» e simili, le quali affermano bensì che lo svolgimento economico è determinato da condizioni materiali, ma non le riducono tutte alla sola «metamorfosi dello strumento tecnico». Il Croce aggiunge poi che il Marx non si è mai proposto questa indagine intorno alla causa ultima della vita economica. «La sua filosofia non era così a buon mercato. Non aveva “civettato” invano con la dialettica dello Hegel, per andar poi a cercare le “cause ultime”». (Tutta una serie di argomenti da studiare).
Q4 §20 Croce e Marx. Il valore delle ideologie (vedi precedenti). Nel volume Materialismo storico ed economia marxistica, a p. 93: «Simile concezione (diritto di natura, stato di natura ecc. del sec. XVIII) è colpita, in verità, solo di sbieco dalla critica del Marx, il quale, analizzando il concetto di natura, mostrava come esso fosse il complemento ideologico dello svolgimento storico della borghesia, un’arma potentissima di cui questa si valse contro i privilegi e le oppressioni, che mirava ad abbattere. Quel concetto potrebbe essere sorto come strumento per un fine pratico e occasionale ed essere nondimeno intrinsecamente vero» ecc.
Appare qui lo stesso pregiudizio contro il valore intrinseco delle ideologie o il pregiudizio che Marx negasse questo valore: in realtà l’intrinseco di questa ideologia era il suo carattere storico di utilità di classe, quindi molto reale e di molto valore (rivedere nel caso questo passo del Croce).
Q4 §21 La tecnica del pensare. «Gli strumenti mentali e morali di cui l’uomo dispone sono sempre i medesimi: l’osservazione, l’esperimento, il ragionamento induttivo e deduttivo, l’abilità manuale e la fantasia inventiva. A seconda del metodo con cui questi mezzi sono usati si ha un indirizzo empirico o scientifico dell’attività umana, con questa differenza fra i due: che il secondo è molto più rapido ed ha un rendimento molto maggiore» (Mario Camis, L’aeronautica e le scienze biologiche, in Nuova Antologia del 16 marzo 1928).
Ragionare semplicisticamente. Esempi di questo ragionamento che, secondo l’opinione comune, è il modo di ragionare della grande maggioranza degli uomini (il sentimento o l’interesse immediato turbano il processo logico). Esempio del ragionamento di Babbitt sulle organizzazioni sindacali: «Una buona associazione operaia è una buona cosa perché impedisce i sindacati rivoluzionari che distruggerebbero la proprietà. Però nessuno dovrebbe essere costretto a entrare in una associazione. Tutti gli agitatori laburisti che tentano di costringere degli individui a entrare in una associazione dovrebbero essere impiccati. In breve, sia detto tra noi, bisognerebbe non permettere nessuna associazione; e poiché questa è la maniera migliore di combatterle ogni uomo d’affari dovrebbe appartenere a una associazione di imprenditori e alla Camera di Commercio. L’unione fa la forza Perciò ogni solitario egoista che non fa parte della Camera di Commercio dovrebbe essere costretto ad affiliarsi». (Cfr Babbitt di Sinclair Lewis, ediz. Stock, 1930).
Il ragionamento di Don Ferrante è impeccabile formalmente, ma errato nelle premesse di fatto e nella presunzione del ragionatore, onde nasce il senso umoristico.
Il modo di ragionare di Iliic nella novella di Tolstoi: La morte di Iliic (Gli uomini sono mortali, Caio è uomo, Caio è mortale, ma io non sono Caio ecc.).
Q4 §22 Croce e Marx. Il valore delle ideologie. I fenomeni della attuale decomposizione del parlamentarismo possono dare un esempio per la discussione sul valore delle soprastrutture e della morfologia sociale (quistione della crisi d’autorità ecc.: vedi sparse).
Q4 §23 Il «Saggio popolare» e le leggi sociologiche. Le così dette leggi sociologiche, assunte come causa, non hanno invece nessuna portata causativa: esse non sono che un duplicato del fatto stesso osservato. Si descrive il fatto o una serie di fatti, si estrae con un processo di generalizzazione astratta un rapporto di somiglianza, lo si chiama legge e poi si assume questa così detta legge alla funzione di causa. Ma in realtà cosa si è trovato di nuovo? Assolutamente nulla: si tratta solo di dare nomi nuovi a cose vecchie, ma il nome non è una causa.
Q4 §24 La restaurazione e lo storicismo. Il periodo della Restaurazione elabora lo «storicismo» secondo due linee di sviluppo: nella realtà effettuale e ideologicamente. Nella realtà effettuale in quanto «conserva» una gran parte delle conquiste del periodo precedente, cioè riconosce il predominio della grande borghesia e ne attua il programma «civile»; ideologicamente in quanto, per questa stessa ragione, deve sviluppare una sua filosofia politica, che giustifichi la sua posizione, criticando il programma «piccolo borghese» della rivoluzione, cioè quell’insieme di «strumenti pratici» attraverso i quali era stato possibile ottenere l’unità popolare intorno alla borghesia stessa (cioè quell’insieme di principii ideologici che formano la parte più caratteristica del razionalismo politico francese e dei così detti principii dell’89). Alla gerarchia politico‑sociale per cui gli intellettuali piccolo borghesi sono all’apice del governo popolare, si sostituisce un’altra gerarchia in cui il governo è in mano all’aristocrazia e agli intellettuali assimilati: al consenso diretto delle classi popolari si sostituisce il consenso indiretto, ossia la passività politica (suffragio universale ‑ suffragio censitario). La lotta ideologica su questo terreno genera la concezione storicistica: i teorici dell’ancien régime sono ben piazzati per vedere il carattere astratto, antistorico delle ideologie piccolo‑borghesi; ma essi generano il loro contrario, uno storicismo «popolare» che critica e l’ideologia piccolo‑borghese e l’ideologia «aristocratica», spiegando ambedue e spiegando «se stesso» ciò che rappresenta il massimo «storicismo», la liberazione totale da ogni «ideologismo», la reale conquista del mondo storico, cioè l’inizio di una nuova civiltà originale. Bisogna studiare tutte queste correnti di pensiero nelle loro concrete manifestazioni: 1) come corrente filosofica, 2) come corrente storiografica, 3) come corrente politica. Nella corrente filosofica bisogna intendere non solo i filosofi sistematici, ma tutti gli scrittori che per una o per altra branca delle scienze affermano lo «storicismo» esplicitamente o implicitamente: oltre che nella storiologia, nell’economia, nella morale, nella scienza della politica ecc. Nella corrente storiografica, gli storici che nei loro studi concreti sono «storicisti». Nella corrente politica (certamente la più complessa, perché tutti i grandi politici in atto sono stati implicitamente «storicisti» anche quando hanno giustificato le loro imprese secondo le ideologie diffuse nel loro tempo) tutte le affermazioni di «storicismo» e il loro contraddirsi con le ideologie diffuse e i tentativi di spiegarle con queste.
Q4 §25 sul «Saggio popolare». Cosa intende per «materia» il Saggio popolare? In un saggio popolare ancor più che in un libro per i «dotti», occorre definire con esattezza non solo i concetti fondamentali, ma tutta la terminologia, per evitare le cause di errore date dalle accezioni popolari e volgari delle parole. È evidente che per il materialismo storico, la «materia» non deve essere intesa né nel suo significato quale risulta dalle scienze naturali (fisica, chimica, meccanica ecc.: vedere questi significati e loro sviluppo storico) né nel suo significato quale risulta dalle diverse metafisiche materialistiche. Le proprietà fisiche (chimiche, meccaniche ecc.) della materia sono considerate, certamente, ma solo in quanto diventano «elemento economico» della produzione. La materia non è quindi considerata come tale, ma come socialmente e storicamente organizzata per la produzione, come rapporto umano. Il materialismo storico non studia una macchina per stabilirne la struttura fisico‑chimico‑meccanica dei suo componenti naturali, ma in quanto è oggetto di produzione e di proprietà, in quanto in essa è cristallizzato un rapporto sociale e questo corrisponde a un determinato periodo storico. L’insieme delle forze materiali di produzione è l’elemento meno variabile nello sviluppo storico, è quello che volta per volta può essere misurato con esattezza matematica, che può dar luogo pertanto a una scienza sperimentale della storia, nel senso ben preciso in cui si può parlare di «sperimentale» nella storia. La variabilità dell’insieme delle forze materiali di produzione è anch’essa misurabile e si può stabilire con una certa precisione quando il suo sviluppo da quantitativo diventa qualitativo. L’insieme delle forze materiali di produzione è nello stesso tempo «tutta la storia passata cristallizzata» e la base della storia presente e avvenire, è un documento e una forza attiva attuale. Ma il concetto di attività di queste forze materiali non può essere confuso con quello di attività nel senso fisico o metafisico. L’elettricità è storicamente attiva, non come pura forza naturale, ma come elemento di produzione dominato dall’uomo e incorporato nell’insieme delle forze materiali di produzione, oggetto di proprietà. Come forza naturale l’elettricità esisteva anche prima della sua riduzione a forza di produzione ma non operava nella storia, non era elemento storico, della storia umana (non della storia naturale e quindi in misura determinata anche della storia umana, in quanto la storia umana è una parte della storia naturale).
Queste osservazioni servono a far capire come l’elemento causale preso dalle scienze naturali per spiegare la storia sia un ritorno alla vecchia storiografia ideologica (idealistica o materialistica): quando si dice, come nel Saggio popolare, che la nuova teoria atomica distrugge l’individualismo (le robinsonate), si cade appunto in questa deviazione. Cosa significa infatti questo accostamento della politica alla scienza naturale? Che la scienza spiega la storia? Che le leggi di una determinata scienza naturale sono identiche alle leggi della storia? Oppure significa che, essendo tutto il complesso delle idee scientifiche una unità, si può ridurre una scienza all’altra? Ma in questo caso perché questo determinato elemento della fisica e non un altro deve essere quello riducibile all’unità della concezione del mondo?
Ma in realtà, questo è solo uno dei tanti elementi del Saggio popolare che dimostrano la superficiale impostazione del problema del materialismo storico, il non aver saputo dare a questa concezione la sua autonomia scientifica e la posizione che le spetta di fronte alle scienze naturali o, peggio a quel vago concetto di «scienza» in generale che è proprio della concezione volgare del popolo. La teoria atomistica moderna è una teoria «definitiva», stabilita una volta per sempre? O non è anch’essa semplicemente una ipotesi scientifica che potrà essere superata, cioè assorbita in una teoria più vasta e comprensiva? Perché dunque il riferimento a questa teoria dovrebbe essere definitivo e porre fine alle quistioni dell’individualismo e delle robinsonate? (A parte il fatto che le robinsonate sono puri schemi pratici costruiti per indicare una tendenza o per una dimostrazione per assurdo). Ma ci sono altre quistioni: se la teoria dell’atomo fosse quello che il Saggio popolare pretende, dato che la società ha mutato durante il suo sviluppo, a quale periodo si riferisce la spiegazione legata a questa teoria? A tutti i periodi indistintamente? Ma allora la storia sarebbe sempre stata uguale e gli uomini avrebbero sempre avuto uno stesso raggruppamento. Oppure questa teoria giustifica una legge di tendenza? Ma cosa significherebbe ciò? Per ciò che riguarda il suo oggetto, gli atomi, la teoria degli atomi è buona per tutti i tempi e per tutti i luoghi, ma nella storia è uguale per tutti i tempi e per tutti i luoghi una teoria estratta da quella degli atomi? O non si potrebbe pensare invece il contrario, che cioè la teoria degli atomi sia stata essa influenzata dalla storia umana, che cioè si tratti di una superstruttura?
Q4 §26 Il «Saggio popolare» e la «causa ultima». Errata interpretazione del materialismo storico che viene dogmatizzato e la cui ricerca viene identificata con la ricerca della causa ultima o unica ecc. Storia di questo problema nello sviluppo della cultura: il problema delle cause ultime è appunto vanificato dalla dialettica. Contro questo dogmatismo aveva posto in guardia Engels in alcuni scritti dei suoi ultimi anni (cfr le due lettere di Engels sul materialismo storico tradotte in italiano).
Q4 §27 Teleologia. Dalle Xenie di Goethe: «Il teleologo. ‑ Il Creatore buono adoriamo del mondo, che, quando ‑ il sughero creò, inventò insieme il tappo» (trad. di B. Croce).
Il Croce – nel suo volume, Goethe, p. 262 – annota: «Contro il finalismo estrinseco, generalmente accolto nel secolo decimottavo, e che il Kant aveva di recente criticato surrogandolo con un più profondo concetto della finalità» .
Q4 §28 Antonino Lovecchio, Filosofia della prassi e filosofia dello spirito, Palmi, Zappone, 1928, pp. 112, L. 7. Dalla recensione fattane nell’ics da Giuseppe Tarozzi (giugno 1928) traggo queste informazioni: il libro consta di due parti, una sul materialismo storico, l’altra sul pensiero di B. Croce, che sono connesse tra loro dato il contributo del Croce alla critica del marxismo: la parte conclusiva è intitolata «Marx e Croce». Discute le tesi sul marxismo specialmente di Antonio Labriola, Croce, Gentile, Rodolfo Mondolfo, Adelchi Baratono, Alfredo Poggi. È un crociano. Il libretto è un abbozzo, ricco di molti e non lievi difetti di forma. Vedere di procurarselo.
Q4 §29 Machiavelli. In una recensione di Giuseppe Tarozzi del 1° volume sulla Costituzione russa di Mario Sertoli (Firenze, Le Monnier, 1928, in 8°, pp. 435, L. 50) trovo citato un libro del Vorländer Von Machiavelli bis Lenin, senz’altra indicazione. Non so chi sia il Vorländer e che valore abbia il suo libro (cfr la rassegna sul Machiavelli pubblicata nel 1929 dai «Nuovi Studi»).
Q4 §30 Il libro del De Man. Recensione di Paolo Milano nell’ics del settembre 1929. Distingue nell’opera del De Man due apporti: 1° la massa di osservazioni psicologiche sulle fasi di sviluppo, le deviazioni, le reazioni contradditorie del movimento operaio e socialistico negli anni recenti, una sagace collezione di dati e documenti sociali, insomma; l’analisi dell’evoluzione riformistica delle masse operaie da un lato e dei gruppi padronali dall’altro, secondo il Milano, è ricca e soddisfacente; 2° e la discussione teorica da cui dovrebbe risultare il «superamento del marxismo» (esattamente per il De Man il «ripudio» del marxismo). Per il De Man la concezione del materialismo storico, nel suo fondo meccanicistica e razionalistica, è superata dalle indagini più recenti, che hanno assegnato alla concatenazione razionale soltanto un posto e neppure il più ragguardevole, nella serie dei moventi degli atti umani. Alla reazione meccanica (!) della dialettica marxistica la scienza moderna (!) ha vittoriosamente (!) sostituito una reazione psicologica, la cui intensità non è proporzionale alla causa agente. Per il Milano: «È ormai chiaro che qualunque critica alla concezione marxistica della Storia porta automaticamente ad impostare il contrasto tra interpretazione materialistica e interpretazione idealistica del mondo e ad assegnare in sostanza una priorità all’essere o al conoscere». Il De Man è sfuggito a questo problema o meglio si è fermato a mezza strada, dichiarandosi per una concezione dei fatti umani come generati da «moventi psicologici» e da «complessi» sociali, cioè il De Man è influenzato dalla psicologia freudiana, soprattutto attraverso le applicazioni alle dottrine sociali, tentatane dall’Adler (Max Adler? in quali scritti?). Osserva il Milano: «Si sa d’altronde che labile terreno sia la psicologia nelle indagini storiche: tanto più equivoco in ricerche del tipo di questa, di cui si parla. I fenomeni psicologici infatti si prestano ad essere volta a volta indicati come tendenze volitive o come fatti materiali: tra queste opposte interpretazioni oscilla anche il De Man, ed evita quindi una presa di posizione sul punto cruciale del contrasto. Davvero psicologica piuttosto un lettore accorto giudicherà che sia l’origine dell’opera del De Man: nata da una crisi di sfiducia e dalla costatazione dell’insufficienza delle dottrine marxistiche integrali a spiegare i fenomeni, che all’osservazione dell’autore si erano offerti durante lo spicciolo lavoro politico. Nonostante le ottime intenzioni, il tenore del libro non supera questa documentata e mossa constatazione né riesce ad una confutazione teorica sul piano adeguato e col vigore necessario». E conclude: «La riprova ne dà l’ultimo capitolo, in cui la trattazione vorrebbe conchiudersi col raccomandare un pratico contegno politico. Il De Man, egualmente evitando i due estremi di una tattica di presa del potere e di un apostolato esclusivamente idealistico, consiglia una generica educazione delle masse e con ciò si pone fuori di quel socialismo, di cui pure per tutta l’opera si era dichiarato fedele e illuminato seguace». La recensione è notevole e acuta, dato il carattere dello scrittore, piuttosto letterato, per quanto mi consta.
Q4 §31 Di Giorgio Sorel vedi p. 78. La «Nuova Antologia» del 1° dicembre 1928 pubblica un lungo articolo (da p. 289 a p. 307) intitolandolo Ultime meditazioni (Scritto postumo inedito). Si tratta di un saggio, scritto nel 1920, che doveva servire di prefazione ad una raccolta di articoli pubblicati dal 1910 al 1920 in giornali italiani e che ancora non è stata pubblicata (nel 1929 sembrava imminente la pubblicazione presso la Casa Ed. «Corbaccio» di Milano di questa raccolta, a cura di Mario Missiroli, ma fino ad oggi – settembre 1930 – niente se ne è fatto e probabilmente non se ne farà più niente, perché in Italia la rinomanza del Sorel – fondata su una serie di equivoci più o meno disinteressati – è molto scaduta ed esiste già una letteratura antisorelliana).
Il saggio riassume tutti i pregi e tutti i difetti del Sorel: è tortuoso, saltellante, incoerente, superficiale, profondo ecc.: ma dà o suggerisce punti di vista originali, trova nessi impensati, obbliga a pensare e ad approfondire. Qual è il significato esatto della conclusione del saggio del Sorel? Esso appare chiaramente da tutto l’articolo e fa ridere la noticina introduttiva della Nuova Antologia che conclude con queste parole: «... uno scrittore, che assegnò all’Italia del dopo guerra il primato intellettuale e politico in Europa». A quale Italia? Potrebbe dire qualcosa in proposito esplicitamente il Missiroli o si potrebbe trovare qualcosa nelle lettere private del Sorel a Missiroli (che dovrebbero essere pubblicate, secondo gli annunzi dati, ma non lo saranno o lo saranno non integre).
Toglierò da questo saggio del Sorel solo qualche spunto, notandone, pro memoria, la grande importanza per comprendere il Sorel e il suo atteggiamento nel dopo guerra. (Mi pare che non si può comprendere il Sorel come figura di «intellettuale rivoluzionario» se non si pensa alla Francia di dopo il 70: il 70‑71 videro in Francia due terribili disfatte: quella nazionale, che pesò sugli intellettuali borghesi e sugli uomini politici, creando dei tipi come Clemenceau, quintessenza del giacobinismo francese, e la disfatta del popolo parigino della Comune, che pesò sugli intellettuali rivoluzionari e creò l’antigiacobino Sorel: il curioso antigiacobinismo del Sorel, settario, meschino, antistorico è un portato del salasso popolare del 71, è anti‑thiersismo. Il 71 distrusse il cordone ombelicale tra il nuovo popolo e la tradizione del 93: Sorel avrebbe voluto essere il rappresentante di questa tendenza, ma non ci riuscì ecc.).
1°. Bernstein ha sostenuto (Socialismo teorico e socialdemocrazia pratica, trad. franc., pp. 53‑54) che un rispetto superstizioso per la dialettica hegeliana ha condotto Marx a preferire alle costruzioni degli utopisti tesi rivoluzionarie assai prossime a quelle della tradizione giacobina babeuvista o blanquista: non si comprende allora, però, come mai nel Manifesto non si parli della letteratura babeuvista che Marx indubbiamente conosceva. L’Andler è del parere (vol. II del Manifesto, p. 191) che Marx faccia un’allusione piena di disprezzo per la congiura degli Uguali, quando parla dell’ascetismo universale e grossolano che si riscontra nelle più antiche rivendicazioni proletarie dopo la Rivoluzione francese.
2°. Pare che Marx non si sia mai potuto liberare completamente dall’idea hegeliana della storia, secondo la quale diverse ere si succedono nell’umanità, seguendo l’ordine di sviluppo dello spirito, che cerca di raggiungere la perfetta realizzazione della ragione universale. Alla dottrina del suo maestro egli aggiunge quella della lotta di classe: sebbene gli uomini non conoscano che le guerre sociali, nelle quali sono spinti dai loro antagonismi economici, essi cooperano inconsciamente a un’opera che il solo metafisico suppone. Questa ipotesi del Sorel è molto azzardata ed egli non la giustifica: ma evidentemente gli sta molto a cuore, sia per la sua esaltazione della Russia, sia per la sua previsione della funzione civile dell’Italia (è da segnalare, a proposito di questo avvicinamento Russia‑Italia, l’atteggiamento di D’Annunzio in un tempo quasi coincidente: la pubblicazione – ma mi pare che non si tratti di una pubblicazione ma solo di manoscritto fatto circolare – è proprio della primavera del 1920: conobbe il Sorel questo atteggiamento del D’Annunzio? Il Missiroli solo potrebbe dare una risposta): secondo il Sorel, «Marx aveva una così grande fiducia nella subordinazione della storia alle leggi dello sviluppo dello spirito, che ha insegnato che, dopo la caduta del capitalismo, l’evoluzione verso il comunismo perfetto si produrrebbe, senza essere provocata da una lotta di classi (Lettera sul programma di Gotha). Sembra che Marx abbia creduto, come Hegel, che i diversi momenti dell’evoluzione si manifestino in paesi diversi, ciascuno dei quali è specialmente adatto a ciascuno di quei momenti. (Vedere la prefazione del 21 gennaio 1882 a una traduzione russa del Manifesto). Egli non ha mai fatta un’esposizione esplicita della sua dottrina; così molti marxisti sono persuasi che tutte le fasi dell’evoluzione capitalista devono prodursi nella stessa forma presso tutti i popoli moderni. Questi marxisti sono troppo poco hegeliani».
3°. La quistione prima o dopo il 48? Il Sorel non intende l’importanza di questo problema e accenna al «curioso» cambiamento che si produsse nello spirito di Marx alla fine del 1850: nel marzo egli aveva firmato un manifesto dei rivoluzionari, che sostituisce il termine «comunisti» adoprato nel testo di Sorel citato da G. rifugiati a Londra, nel quale era tracciato il programma di una agitazione rivoluzionaria da intraprendersi in vista di un nuovo prossimo sconvolgimento sociale, che Bernstein trova degno del primo venuto dei rivoluzionari da club (Socialismo teorico ecc., p. 51), mentre poi egli si convinse che la rivoluzione nata dalla crisi del 47, finiva con quella crisi. Ora gli anni dopo il 48 furono di una prosperità senza eguale: mancava dunque per la rivoluzione progettata la prima delle condizioni necessarie, un proletariato ridotto all’ozio e disposto a combattere (cfr Andler, Manifesto, I, pp. 55‑56; ma di quale edizione?) Così sarebbe nata nei marxisti la concezione della miseria crescente, che avrebbe dovuto servire a spaventare gli operai e indurli a combattere in vista di un peggioramento probabile anche in una situazione prospera (– spiegazione infantile e contraddetta dai fatti anche se è vero che della teoria della miseria crescente si fece uno strumento di questo genere: ma arbitrariamente? non mi pare).
4°. Su Proudhon: «Proudhon apparteneva a quella parte della borghesia che era più vicina al proletariato: per questo i marxisti hanno potuto accusarlo di essere un borghese, mentre gli scrittori più sagaci lo considerano come un ammirevole prototipo dei nostri (francesi) contadini e dei nostri artigiani (cfr Daniele Halévy nei “Débats” del 3 gennaio 1913)». Mi pare si possa accettare. Da questo punto di vista Sorel spiega anche il «giurismo» di Proudhon: «In ragione della modicità delle loro risorse, i contadini, i proprietari delle più piccole fabbriche, i piccoli commercianti sono obbligati a difendere aspramente i loro interessi davanti ai tribunali. Un socialismo che si proponga di proteggere i ceti posti sui gradini più bassi dell’economia, è naturalmente destinato a dare una grande importanza alla sicurezza del diritto; e una tendenza siffatta è particolarmente forte presso quegli scrittori che, come Proudhon, hanno la testa piena di ricordi della vita campagnola». E dà ancora altri spunti per rinforzare questa analisi. Lo strano è che il Sorel, avendo una simile convinzione della tendenza sociale del Proudhon, lo esalti e lo proponga come modello o fonte di principi per il proletariato moderno. Data questa origine delle tendenze giuridiche del Proudhon, perché gli operai dovrebbero occuparsi della quistione? Si ha, a questo punto, l’impressione che il saggio del Sorel sia mutilato e che manchi precisamente una parte, riguardante il movimento italiano delle fabbriche: dato il pubblicato, è possibile immaginare che Sorel abbia trovato nel movimento delle commissioni interne intorno ai regolamenti di fabbrica e in generale intorno alla «legislazione» interna di fabbrica, che dipende unicamente dalla volontà sovrana e incontrollata dell’imprenditore, il corrispettivo della esigenza che Proudhon rifletteva per i contadini. Il saggio, così com’è pubblicato, è incoerente e incompleto; la sua conclusione riguardante l’Italia («Molte ragioni mi avevano condotto, da gran tempo, a supporre, che quello che un hegeliano chiamerebbe il Weltgeist, spetta oggi all’Italia. Grazie all’Italia la luce dei tempi nuovi non si spegnerà») non ha nessuna dimostrazione, sia pure per accenni, al modo di Sorel. Nell’ultima nota c’è un accenno ai consigli degli operai e dei contadini in Germania, «che io consideravo conformi allo spirito proudhoniano» e un rimando ai Materiali di una teoria del proletariato (pp. 164 e 394). Sarebbe interessante sapere se veramente il saggio è stato mutilato e da chi: se direttamente dal Missiroli o da altri.
Gli scritti del Sorel del dopoguerra hanno una particolare importanza per la storia della cultura occidentale: il Sorel ascrive al pensiero di Proudhon tutta una serie di istituzioni e di atteggiamenti ideologici di questo periodo. Perché il Sorel ha potuto far questo? È assolutamente arbitrario questo suo modo di giudicare? E data la acutezza del Sorel come storico delle idee, che esclude, almeno in grande parte, una tale arbitrarietà, da quali esperienze culturali è partito il Sorel, e non è tutto ciò molto importante per un giudizio complessivo dell’opera soreliana? Da questo punto di vista occorre accostare al Sorel il De Man, ma quale differenza fra i due! Il De Man si imbroglia assurdamente nella storia delle idee, e si lascia abbagliare dalle superficiali apparenze: se un rimprovero si può fare invece al Sorel è proprio in senso contrario, di analizzare troppo minutamente il sostanziale delle idee e di perdere il senso delle proporzioni. Il Sorel trova che i «fatti» del dopoguerra sono di carattere proudhoniano; il Croce trova che il De Man segna un ritorno al Proudhon, ma il De Man tipicamente non capisce i «fatti» del dopoguerra indicati dal Sorel. Per il Sorel è «proudhoniano» ciò che è «spontanea» creazione del popolo, è «marxista ortodosso» ciò che è burocratico, perché egli ha dinanzi sempre, ossessionante, l’esempio della Germania da una parte e del giacobinismo letterario dall’altra, il fenomeno del centralismo-burocrazia. Il De Man in realtà rimane un esemplare pedantesco della burocrazia laburista belga: tutto è pedantesco in lui, anche l’entusiasmo: crede di aver fatto delle scoperte grandiose, perché ripete come formula scientifica la descrizione di fatti empirici: caso tipico di positivismo che raddoppia il fatto, descrivendolo e formulandolo sinteticamente e poi fa della formulazione del fatto la legge del fatto. Per il Sorel, come appare da questo saggio, ciò che conta in Proudhon, è l’orientamento psicologico, non già il concreto atteggiamento pratico, sul quale in verità non si pronunzia esplicitamente: questo orientamento psicologico consiste nel «confondersi» coi sentimenti popolari che concretamente pullulano dalla situazione reale fatta al popolo dalla disposizione del mondo economico, nel «calarsi» in essi per comprenderli ed esprimerli in forma giuridica, razionale; questa o quella interpretazione, o anche l’insieme di esse possono essere errate, o cervellotiche o addirittura ridicole, ma l’atteggiamento generale è il più produttivo di conseguenze buone. L’atteggiamento del De Man non è questo: è invece quello «scientifista»: egli si china verso il popolo non per comprenderlo disinteressatamente, ma per «teorizzarne» i sentimenti, per costruirvi degli schemi pseudo‑scientifici, non per mettersi all’unisono ed estrarre principi giuridico‑educativi (leggi «scientifiche» in De Man – espressioni «giuridiche» in Proudhon). cfr p. 78.
Q4 §32 Il «Saggio popolare». Nel Saggio popolare si dice (e
scrivo «si dice» perché l’affermazione non è giustificata, non è
valutata, non esprime un concetto fecondo, ma è casuale, senza
nessi con antecedenti e conseguenti) che ogni società è qualcosa
di più che la mera somma dei suoi componenti. L’osservazione
avrebbe dovuto essere collegata con l’altra di Engels che la
quantità diventa qualità e avrebbe dovuto dar luogo a una
analisi concreta di un aspetto caratteristico del materialismo
storico. Se ogni aggregato sociale, infatti, è qualcosa di più
che la somma dei suoi componenti, ciò significa che la legge che
spiega gli aggregati sociali non è una «legge fisica», intesa
nel senso stretto della parola: nella fisica non si esce dal
dominio della quantità altro che per metafora. Nel materialismo
storico la qualità è però strettamente connessa alla quantità e
anzi in questa connessione è la sua parte originale e feconda.
L’idealismo ipostatizza questo «qualcosa», ne fa un ente a sé,
lo spirito, come la religione ne aveva fatto la divinità. Ma se
è «ipostasi» quella della religione e dell’idealismo, cioè
astrazione arbitraria non procedimento di distinzione analitica
praticamente comodo per ragioni pedagogiche, è anche «ipostasi»
quella del materialismo volgare che «divinizza» la materia ecc.
Cfr questo modo di vedere nella concezione dello Stato così come
è esposta dagli idealisti attuali; lo Stato finisce con l’essere
proprio «questo qualcosa» di superiore agli individui: un uomo
di buon senso, chiamato alla leva, per es. potrebbe rispondere
che prendano di lui la parte di «qualcosa» con cui contribuisce
a creare il «totale qualcosa» che è lo Stato, e gli lascino la
persona fisica concreta e materiale. Ricordare la novella del
Saladino che dirime la vertenza tra il rosticciere che vuole
pagato l’uso del fumo aromatico delle sue vivande e il
mendicante che non vuol pagare: il Saladino fa suonare una
moneta e dice al rosticciere di intascare il suono così come il
mendicante ha mangiato il fumo.
Q4 §33 Passaggio dal sapere al comprendere al sentire e viceversa dal sentire al comprendere al sapere. L’elemento popolare «sente», ma non comprende né sa; l’elemento intellettuale «sa» ma non comprende e specialmente non sente. I due estremi sono dunque la pedanteria e il filisteismo da una parte e la passione cieca e il settarismo dall’altra. Non che il pedante non possa essere appassionato, tutt’altro: la pedanteria appassionata è altrettanto ridicola e pericolosa che il settarismo o la demagogia appassionata. L’errore dell’intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere e specialmente senza sentire ed essere appassionato, cioè che l’intellettuale possa esser tale se distinto e staccato dal popolo: non si fa storia‑politica senza passione, cioè senza essere sentimentalmente uniti al popolo, cioè senza sentire le passioni elementari del popolo, comprendendole, cioè spiegandole e giustificandole nella determinata situazione storica e collegandole dialetticamente alle leggi della storia, cioè a una superiore concezione del mondo, scientificamente elaborata, il «sapere». Se l’intellettuale non comprende e non sente, i suoi rapporti col popolo‑massa sono o si riducono a puramente burocratici, formali: gli intellettuali diventano una casta o un sacerdozio (centralismo organico): se il rapporto tra intellettuali e popolo‑massa, tra dirigenti e diretti, tra governanti e governati, è dato da una adesione organica in cui il sentimento passione diventa comprensione e quindi sapere (non meccanicamente, ma in modo vivente), allora solo il rapporto è di rappresentanza, e avviene lo scambio di elementi individuali tra governati e governanti, tra diretti e dirigenti, cioè si realizza la vita d’insieme che sola è la forza sociale, si crea il «blocco storico». Il De Man studia i sentimenti popolari, non «con‑sente» con essi per guidarli e condurli a una catarsi di civiltà moderna: la sua posizione è quella dello studioso di folklore che ha continuamente paura che la modernità gli distrugga l’oggetto della sua scienza. D’altronde c’è nel suo libro il riflesso pedantesco di una esigenza reale: che i sentimenti popolari siano conosciuti, non ritenuti qualcosa di trascurabile e di inerte nel movimento storico.
Q4 §34 A proposito del nome di «materialismo storico». Nel «Marzocco» del 2 ottobre 1927, nel capitolo XI dei Bonaparte a Roma di Diego Angeli dedicato alla principessa Carlotta Napoleone (figlia di Re Giuseppe e moglie di Napoleone Luigi, il fratello di Napoleone III, morto nell’insurrezione di Romagna del 31) è riportata una lettera di Pietro Giordani alla principessa Carlotta in cui il Giordani scrive i suoi ricordi personali su Napoleone I. Napoleone a Bologna si era recato nel 1805 a visitare l’«Istituto» (Accademia di Bologna) e conversò a lungo con quegli scienziati (fra cui Volta). Fra l’altro disse: «... Io credo che quando nelle scienze si trova qualche cosa veramente nuova, bisogna appropriargli un vocabolo affatto nuovo, acciocché l’idea rimanga precisa e distinta. Se date nuovo significato a un vecchio vocabolo, per quanto professiate che l’antica idea attaccata a quella parola non ha niente di comune coll’idea attribuitagli nuovamente, le menti umane non possono mai ritenersi affatto che non concepiscano qualche somiglianza e connessione fra l’antica e la nuova idea; e ciò imbroglia la scienza e produce poi inutili dispute». Secondo l’Angeli la lettera del Giordani, senza data, si può ritenere che risalga alla primavera del 1831 (quindi è da pensare che il Giordani ricordasse il contenuto della conversazione con Napoleone, ma non la forma esatta). Vedere se il Giordani espone nei suoi libri sulla lingua suoi concetti su questo argomento.
Q4 §35 Sull’origine del concetto di «ideologia». «Ideologia» è un aspetto del «sensismo» ossia del materialismo francese del XVIII secolo. Significava «scienza delle idee» e, poiché l’analisi era il solo metodo riconosciuto e applicato dalla scienza, «analisi delle idee», cioè ancora «ricerca della origine delle idee». Le idee devono essere scomposte nei loro «elementi» originari e questi non potevano essere altro che le «sensazioni»: le idee derivano dalle sensazioni. Ma il sensismo poteva associarsi senza troppa difficoltà colla fede più alta nella potenza dello spirito e nei suoi «destini immortali», e così avviene che il Manzoni, anche dopo la sua conversione o ritorno al cattolicismo, anche quando scriveva gli Inni Sacri, mantenne la sua adesione di massima al sensismo finché non conobbe la filosofia del Rosmini.
Come propagatore letterario dell’ideologia Destutt de Tracy (1754‑1836) dei più illustri e popolari per la facilità della sua esposizione; Cabanis (oltre Condillac, Helvétius che sono più strettamente filosofi) col suo Rapports du Physique et du Moral. Legame tra cattolicismo e Ideologia: Manzoni‑Cabanis‑Bourget‑Taine (Taine è caposcuola per Maurras e altri di indirizzo cattolico), «romanzo psicologico» (Stendhal e de Tracy ecc.). Di Destutt de Tracy Eléments d’Idéologie (Parigi, 1817‑18), più completi nella traduzione italiana Elementi di Ideologia del conte Destutt de Tracy, tradotti dal Compagnoni, Milano, Stamperia di Giambattista Sonzogno, 1819.
Come «ideologia» da «scienza delle idee», da studio sull’origine delle idee, è passata a significare un «sistema di idee»? Logicamente il processo è facile da comprendere, ma come è avvenuto storicamente?
Vedere se il De Man (e Freud) non sia l’ultimo degli «ideologi» e come pertanto sia ancora più strano l’«entusiasmo» per lui di Croce e dei crociani, se non ci fosse una giustificazione «politica». Vedere come il Saggio popolare sia rimasto ancora impigliato nell’Ideologia, mentre il Materialismo storico ne rappresenta un netto superamento e storicamente si contrapponga appunto all’Ideologia. Del resto, lo stesso significato che Marx ha dato al termine «ideologia» contiene implicito un giudizio di valore ed esclude che, per Marx, l’origine delle idee fosse da ricercare nelle sensazioni e quindi, in ultima analisi, nella fisiologia: questa stessa «ideologia» è da analizzare storicamente, come soprastruttura.
Q4 §36 Criteri di giudizio «letterario». Un lavoro può essere pregevole: 1°) perché espone una nuova scoperta che fa progredire una determinata attività scientifica. Ma non solo l’«originalità» assoluta è un pregio. Può avvenire inoltre: 2°) che fatti ed argomenti già noti siano scelti e disposti secondo un criterio più adeguato di quelli precedenti. La struttura (l’ordine) di un lavoro scientifico può essere «originale». 3°) I fatti e gli argomenti già noti possono aver dato luogo a «nuove» considerazioni, subordinate ma tuttavia importanti.
Ancora, il giudizio deve adeguarsi ai fini che un’opera si propone: di creazione e riorganizzazione scientifica, o di divulgazione dei fatti ed argomenti noti in un determinato gruppo culturale, di un determinato livello culturale ecc.: esiste una «tecnica» della divulgazione e se non esiste occorre crearla; la divulgazione è un fatto strettamente pratico, in cui bisogna giudicare la conformità al fine dei mezzi (tecnica nel senso più generale) adoperati.
Ma anche la ricerca e il giudizio del fatto o dell’argomentazione «originale», ossia dell’«originalità» dei fatti (concetti ‑ nessi di pensiero) e degli argomenti è molto difficile e complicata e domanda le più ampie cognizioni storiche. Cfr il capitolo del Materialismo storico di Croce dedicato a Loria. Dice il Croce: «Altro è metter fuori un’osservazione incidentale, che si lascia poi cadere senza svolgerla, ed altro stabilire un principio di cui si sono scorte le feconde conseguenze; altro enunciare un pensiero generico ed astratto ed altro pensarlo realmente e in concreto; altro, finalmente, inventare, ed altro ripetere di seconda o di terza mano».
Si presentano i casi estremi: chi non trova che ci sia mai nulla di nuovo sotto il sole e che tutto il mondo è paese anche nel mondo delle idee e chi invece trova «originalità» a tutto spiano e pretende sia originale una rimasticatura per via della nuova saliva.
Q4 §37 Idealismo‑positivismo. «Obbiettività» della conoscenza. Per i cattolici: «... tutta la teoria idealista riposa sulla negazione dell’obbiettività di ogni nostra conoscenza e sul monismo idealista dello “Spirito” (equivalente, in quanto monismo, a quello positivista della “Materia”) per cui il fondamento stesso della religione, Dio, non esiste obbiettivamente fuori di noi, ma è una creazione dell’intelletto. Pertanto l’idealismo, non meno del materialismo, è radicalmente contrario alla religione» (padre Mario Barbera, nella «Civiltà Cattolica» del 1°‑VI‑I929).
Per la quistione della «obbiettività» della conoscenza secondo il materialismo storico, il punto di partenza deve essere l’affermazione di Marx(nell’introduzione alla Critica dell’economia politica, brano famoso sul materialismo storico) che «gli uomini diventano consapevoli (di questo conflitto) nel terreno ideologico» delle forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche. Ma questa consapevolezza è solo limitata al conflitto tra le forze materiali di produzione e i rapporti di produzione – come materialmente dice il testo marxista – o si riferisce a ogni consapevolezza, cioè a ogni conoscenza? Questo è il problema: che può essere risolto con tutto l’insieme della dottrina filosofica del valore delle superstrutture ideologiche. Come dovrà essere concepito un «monismo» in queste condizioni? Né il monismo materialista né quello idealista, né «Materia» né «Spirito» evidentemente, ma «materialismo storico», cioè attività dell’uomo (storia) in concreto, cioè applicata a una certa «materia» organizzata (forze materiali di produzione), alla «natura» trasformata dall’uomo. Filosofia dell’atto (praxis), ma non dell’«atto puro», ma proprio dell’atto «impuro», cioè reale nel senso profano della parola.
Q4 §38 Rapporti tra struttura e superstrutture. Questo problema mi pare il problema cruciale del materialismo storico. Elementi per orientarsi: 1°) il principio che «nessuna società si pone dei compiti per la cui soluzione non esistano già le condizioni necessarie e sufficienti» o esse non siano in corso di sviluppo e di apparizione, e 2°) che «nessuna società cade se prima non ha svolto tutte le forme di vita che sono implicite nei suoi rapporti» (vedere l’esatta enunciazione di questi principii). Da questi principii si possono trarre alcuni canoni di metodologia storica. Nello studio di una struttura occorre distinguere ciò che è permanente da ciò che è occasionale. Ciò che è occasionale dà luogo alla critica politica, ciò che è permanente dà luogo alla critica storico‑sociale; ciò che è occasionale serve a giudicare i gruppi e le personalità politiche, ciò che è permanente a giudicare i grandi raggruppamenti sociali. Nello studiare un periodo storico appare la grande importanza di questa distinzione: esiste una crisi, che si prolunga talvolta per decine di anni. Ciò significa che nella struttura si sono rivelate contraddizioni insanabili, che le forze politiche operanti positivamente alla conservazione della struttura stessa si sforzano tuttavia di sanare entro certi limiti; questi sforzi incessanti e perseveranti (poiché nessuna forma sociale vorrà mai confessare di essere superata) formano il terreno dell’«occasionale» sul quale si organizzano le forze che «cercano» dimostrare (coi fatti in ultima analisi, cioè col proprio trionfo, ma immediatamente con la polemica ideologica, religiosa, filosofica, politica, giuridica ecc.) che «esistono già le condizioni necessarie e sufficienti perché determinati compiti possano e quindi debbano essere risolti storicamente».
L’errore in cui si cade spesso nella analisi storica consiste nel non saper trovare il rapporto tra il «permanente» e «l’occasionale», cadendo così o nell’esposizione di cause remote come se fossero quelle immediate, o nell’affermazione che le cause immediate sono le sole cause efficienti. Da un lato si ha l’eccesso di «economismo», dall’altro l’eccesso di «ideologismo»; da una parte si sopravalutano le cause meccaniche, dall’altra l’elemento «volontario» e individuale. Il nesso dialettico tra i due ordini di ricerche non viene stabilito esattamente. Naturalmente se l’errore è grave nella storiografia, ancor più grave diventa nella pubblicistica, quando si tratta non di ricostruire la storia passata ma di costruire quella presente e avvenire. I propri desideri sostituiscono l’analisi imparziale e ciò avviene non come «mezzo» per stimolare, ma come autoinganno: la biscia morde il ciarlatano, ossia il demagogo è la prima vittima della sua demagogia.
Questi criteri metodologici possono acquistare tutta la loro importanza solo se applicati all’esame di studi storici concreti. Si potrebbe farlo utilmente per gli avvenimenti che si svolsero in Francia dal 1789 al 1870. Mi pare che per maggior chiarezza dell’esposizione sia proprio necessario abbracciare tutto questo periodo. Infatti, solo nel 1870‑71, col tentativo comunalistico, si esauriscono storicamente tutti i germi nati nel 1789: cioè non solo la nuova classe che lotta per il potere sconfigge i rappresentanti della vecchia società che non vuole confessarsi decisamente superata, ma sconfigge anche i rappresentanti dei gruppi nuovissimi che sostengono superata la nuova struttura sorta dal rivolgimento dell’89 e dimostra così di essere vitale e in confronto al vecchio e in confronto al nuovissimo.
D’altronde gli storici non sono molto concordi (ed è impossibile che lo siano) nel fissare i limiti di ciò che si suole chiamare «rivoluzione francese». Per alcuni (per es. il Salvemini) la Rivoluzione è compiuta a Valmy: la Francia ha creato un nuovo Stato e ha trovato la forza politico‑militare che ne afferma e ne difende la sovranità territoriale. Per altri la Rivoluzione continua fino al Termidoro, anzi bisogna parlare di più rivoluzioni (il 10 agosto sarebbe una rivoluzione a sé ecc.): così il Mathiez nel suo compendio pubblicato nella Collezione Colin. Per altri però anche Napoleone deve essere incluso nella Rivoluzione, deve essere considerato un protagonista della Rivoluzione e così si può arrivare al 30, al 48, al 70. In tutti questi modi di vedere c’è una parte di verità. Realmente le contraddizioni interne della struttura sociale francese che si sviluppa dopo il 1789 trovano la loro relativa composizione solo con la terza repubblica e la Francia ha 60 anni di vita politica equilibrata dopo 80 anni di rivolgimenti a ondate sempre più lunghe: 89‑94, 94‑1815, 1815‑1830, 1830‑1848, 48‑70. È appunto lo studio accurato di queste «ondate» a oscillazioni più o meno lunghe che permette di fissare i rapporti tra struttura e superstrutture da una parte e dall’altra tra gli elementi che si possono chiamare permanenti e quelli «occasionali» della struttura. Si può dire intanto che la mediazione dialettica tra i due principii del materialismo storico riportati in principio di questa nota è il concetto di rivoluzione permanente.
Un altro aspetto di questo stesso problema è la quistione così detta dei rapporti delle forze. Si legge spesso in queste narrazioni storiche l’espressione generica: «rapporto delle forze» favorevole o sfavorevole. Così, astrattamente, questa espressione non spiega nulla o quasi nulla: di solito si ripete il fatto che si deve spiegare, si fa una tautologia: l’errore teorico consiste nel dare un canone di ricerca e di interpretazione come «causa storica». Intanto nell’espressione «rapporto delle forze» occorre distinguere diversi momenti o gradi: mi pare se ne possano distinguere tre fondamentali:
1°) c’è un rapporto delle forze sociali strettamente legato alla struttura; questo è un rapporto obbiettivo, è un dato «naturalistico» che può essere misurato coi sistemi delle scienze esatte o matematiche. Sulla base del grado di sviluppo delle forze materiali di produzione avvengono i diversi raggruppamenti sociali, ognuno di essi rappresentando una funzione e una posizione nella produzione stessa.
Questo schieramento fondamentale dà la possibilità di studiare se nella società esistono le condizioni sufficienti e necessarie per una sua trasformazione; dà la possibilità di controllare il grado di realismo e di attuabilità delle diverse ideologie che sono nate nel suo stesso terreno, nel terreno delle contraddizioni che esso ha generato durante il suo sviluppo.
2°) un momento successivo è il «rapporto delle forze» politiche, cioè la valutazione del grado di omogeneità e di autocoscienza raggiunto dai vari raggruppamenti sociali. Questo «momento» a sua volta può essere scisso in diversi momenti, che corrispondono ai diversi gradi della coscienza politica, così come si sono finora manifestati nella storia. Il primo momento, il più elementare, è quello economico primitivo: un commerciante sente di essere solidale con un altro commerciante, un fabbricante con un altro fabbricante ecc., ma il commerciante non si sente ancora solidale col fabbricante; si sente cioè l’unità omogenea del gruppo professionale, ma non ancora del raggruppamento sociale. Un secondo momento è quello in cui si raggiunge la coscienza della solidarietà d’interessi tra tutti i membri del raggruppamento sociale, ma ancora nel campo puramente economico. In questa fase economico‑politica, si pone la quistione dello Stato, ma sul terreno dell’eguaglianza politica elementare, poiché si rivendica il diritto di partecipare all’amministrazione e alla legislazione e di modificarle, di riformarle, nei quadri generali esistenti. Un terzo momento è quello in cui si raggiunge la coscienza che i proprii interessi «corporativi», nel loro sviluppo attuale e avvenire, superano la cerchia «corporativa», di raggruppamento economico cioè, e possono e debbono divenire gli interessi di altri raggruppamenti subordinati; questa è la fase più schiettamente «politica» che segna il netto passaggio dalla pura struttura alle superstrutture complesse, è la fase in cui le ideologie germinate precedentemente vengono a contatto ed entrano in contrasto fino a che una sola di esse, o almeno una sola combinazione di esse, tende a prevalere, a imporsi, a diffondersi su tutta l’area, determinando oltre che l’unità economica e politica anche l’unità intellettuale e morale, su un piano non corporativo, ma universale, di egemonia di un raggruppamento sociale fondamentale su i raggruppamenti subordinati. Lo Stato‑governo è concepito sì come organismo proprio di un raggruppamento, per creare il terreno favorevole alla massima espansione di questo raggruppamento stesso, ma anche questo sviluppo e questa espansione sono visti concretamente come universali, cioè collegati agli interessi dei raggruppamenti subordinati come uno sviluppo di equilibri instabili tra gli interessi del gruppo fondamentale e quelli dei gruppi subordinati in cui gli interessi del gruppo fondamentale prevalgono ma fino a un certo punto, non cioè almeno fino all’egoismo economico‑corporativo. Nella storia reale questi momenti si complicano tra loro, orizzontalmente e verticalmente, cioè per attività economica (orizzontale) e per territorio (verticalmente), combinandosi e scindendosi variamente, e ognuna di queste combinazioni può essere rappresentata da una propria espressione organizzata economica e politica. Ancora bisogna tener presente che a questi rapporti interni di uno Stato‑nazione si intrecciano i rapporti internazionali, creando a loro volta combinazioni originali e storicamente concrete. Un’ideologia, nata in un paese più sviluppato, si diffonde in un paese meno sviluppato, incidendo nel gioco locale delle combinazioni (la religione, per esempio, è sempre stata una fonte di tali combinazioni ideologico‑politiche nazionali‑internazionali, e con la religione le altre formazioni internazionali, fra cui gli «intellettuali» in genere, la Massoneria, il Rotary Club, gli ebrei, la diplomazia internazionale che si suggerisce espedienti politici o li impone in determinati paesi ecc.; la religione, la Massoneria, il Rotary, gli ebrei possono rientrare nella stessa categoria generale degli «intellettuali», la cui funzione principale, su scala internazionale, è stata quella di mediare gli estremi, di trovare dei compromessi intermedi tra le soluzioni più estreme); questo rapporto tra forze internazionali e forze nazionali è ancora complicato nell’interno di ogni nazione dal fatto frequente dell’esistenza di parecchie sezioni territoriali nazionali di diversa struttura e di diverso rapporto di forze in tutti i gradi (così la Vandea in Francia era alleata con le forze internazionali reazionarie e le rappresentava nel seno dell’unità territoriale francese; così Lione rappresentava un nodo di rapporti particolari ecc.).
3°) il terzo momento è quello del «rapporto delle forze militari» che è quello immediatamente decisivo volta per volta. Lo sviluppo storico oscilla continuamente tra il primo e il terzo momento, con la mediazione del secondo. Ma anche questo terzo momento del rapporto delle forze non è qualcosa di indistinto e di identificabile immediatamente in forma schematica. Mi pare si possano distinguere in esso due momenti: il momento «militare» nel senso stretto, tecnico della parola, e il momento che si può chiamare «politico‑militare». Nello sviluppo della storia mondiale ed europea questi due momenti si sono presentati in un numero vario di combinazioni. Un esempio tipico, che può servire come mezzo di dimostrazione limite, è quello del rapporto di oppressione militare nazionale, cioè di uno Stato, militarmente bene organizzato, che opprime territori di altra nazionalità, subordinando agli interessi del suo raggruppamento sociale dominante i raggruppamenti della stessa specie di queste nazionalità che opprime. Anche in questo caso il rapporto non è puramente militare ma politico‑militare e le forze delle nazionalità oppresse non devono essere puramente militari, per la lotta d’indipendenza, ma militari e politico-militari. Molte osservazioni a questo proposito si trovano nelle scritte sul Risorgimento italiano. Intanto: nel caso di oppressione nazionale, se la nazione oppressa, per iniziare la lotta d’indipendenza, dovesse attendere che lo Stato egemone le permetta di organizzare una propria forza militare nel senso stretto e tecnico della parola, avrebbe da attendere un pezzo. La nazione oppressa dunque opporrà inizialmente alla forza militare egemone una forza solo «politico‑militare», cioè elementi di azione politica che abbiano riflessi militari nel senso: 1° che abbiano efficacia disgregatrice interna nell’efficienza bellica della nazione egemone; 2° che costringano la forza militare egemone a diluirsi in un grande territorio, annullandone così gran parte dell’efficienza bellica. Nelle sul Risorgimento appunto è stata notata l’assenza di una direzione politico‑militare specialmente nel Partito d'Azione (per congenita incapacità) ma anche nel partito piemontese sia prima che dopo il 48, non per congenita incapacità, ma per «neomaltusianismo politico‑economico», perché cioè non si volle neanche accennare alla possibilità di una riforma agraria e perché non si voleva la convocazione di una assemblea nazionale costituente, ma si voleva che la monarchia piemontese, senza condizioni o limitazioni di origine popolare, si estendesse a tutta l’Italia, con la pura sanzione dei plebisciti regionali.
Un’altra quistione legata al problema trattato in questa rubrica è questa: se i fatti storici fondamentali sono determinati dal malessere o dal benessere economico. Un esame della storia mondiale ed europea mi pare obblighi ad escludere ogni risposta tassativa in questo senso e a procedere per approssimazioni a una risposta piuttosto generica in un piano non economico immediato, ma piuttosto d’ordine politico e intellettuale. Nel suo compendio di storia della Rivoluzione Francese, il Mathiez, opponendosi alla storia volgare tradizionale, afferma che verso il 1789 la situazione economica era piuttosto buona immediatamente, per cui non si può dire che la rottura dell’equilibrio esistente sia dovuta a una crisi di immiserimento (vedere esattamente le affermazioni del Mathiez). Naturalmente bisogna distinguere: lo Stato era in preda a una gravissima crisi finanziaria e la quistione si poneva così: quale dei tre stati doveva fare dei sacrifizi per rimettere in sesto le finanze statali e regali? Inoltre: se la situazione della borghesia era florida, certamente non buona era la situazione dei ceti artigiani e operai e specialmente quella dei contadini servi della gleba o sottoposti ad altre angherie e gravami di carattere feudale. In ogni caso la rottura dell’equilibrio non avvenne per causa di un immiserimento del gruppo sociale che aveva interesse a rompere l’equilibrio e di fatto lo ruppe, ma avvenne per un conflitto di carattere superiore, per «prestigio» di gruppo, in un certo senso, per esasperazione del sentimento di indipendenza del proprio gruppo ecc. Insomma la quistione particolare del malessere o benessere come causa di rotture essenziali nell’equilibrio storico è un aspetto parziale della quistione dei «rapporti di forza» nei vari gradi. Può avvenire rottura sia perché una situazione di benessere è minacciata come perché il malessere è diventato intollerabile e non si vede nella vecchia società nessuna forza che sia capace di mitigarlo; per cui si può dire che questi elementi appartengono alle «fluttuazioni occasionali» delle situazioni, nel cui terreno il rapporto sociale di forze diventa rapporto politico di forza per culminare nel rapporto militare decisivo. Se manca questo processo di sviluppo da un momento all’altro nel rapporto di forze, la situazione rimane inoperosa e possono darsi conclusioni varie: la vittoria della vecchia società che si assicura un periodo di «respiro» distruggendo fisicamente l’élite avversaria e terrorizzando la riserva, oppure anche la distruzione reciproca delle forze in conflitto con l’instaurazione della pace dei cimiteri sotto la custodia di una sentinella straniera.
Legata a questa quistione generale è la quistione del così detto «economismo» che assume diverse forme e ha diverse manifestazioni concrete. Rientra nella categoria dell’economismo tanto il movimento teorico del libero scambio come il sindacalismo teorico. Il significato di queste due tendenze è molto diverso. Il primo è proprio di un raggruppamento dominante, il secondo di un raggruppamento subalterno. Nel primo caso si specula incoscientemente (per un errore teorico di cui non è difficile identificare il sofisma) sulla distinzione tra società politica e società civile e si afferma che l’attività economica è propria della società civile e la società politica non deve intervenire nella sua regolamentazione. Ma in realtà questa distinzione è puramente metodica, non organica e nella concreta vita storica società politica e società civile sono una stessa cosa. D’altronde anche il liberismo deve essere introdotto per legge, per intervento cioè del potere politico: è un fatto di volontà, non l’espressione spontanea, automatica del fatto economico. Diverso è il caso del sindacalismo teorico, in quanto esso si riferisce a un raggruppamento subalterno, al quale con questa teorica si impedisce di diventare mai dominante, di uscire dalla fase economico-corporativa per elevarsi alla fase di egemonia politico-intellettuale nella società civile e diventare dominante nella società politica. Nel caso del liberismo teorico si ha il caso di una frazione del raggruppamento dominante che vuole modificare la società politica, che vuole riformare la legislazione esistente nella parte di politica commerciale e indirettamente industriale (è innegabile che il protezionismo, specialmente nei paesi a mercato povero e ristretto, limita, almeno parzialmente, la libertà di iniziativa industriale e favorisce morbosamente il nascere dei monopoli); la quistione è di rotazione al potere governativo di una frazione invece che di un’altra del raggruppamento dominante, non di fondazione e organizzazione di una nuova società politica e tanto meno di un nuovo tipo di società civile.
Nel caso del sindacalismo teorico la cosa è più complessa: è innegabile che in esso la indipendenza e l’autonomia del raggruppamento subalterno che si dice di esprimere, è invece sacrificata all’egemonia intellettuale del raggruppamento dominante, poiché il sindacalismo teorico è un aspetto del liberismo economico giustificato con alcune affermazioni del materialismo storico. Perché e come avviene questo «sacrifizio»? Perché si esclude la trasformazione del raggruppamento subordinato in dominante, o non ponendosi affatto il problema (fabianesimo, De Man, parte notevole del laburismo), o lo si pone in forma incongrua e inefficiente (socialdemocrazia) o si afferma il salto immediato dal regime dei raggruppamenti a quello della perfetta eguaglianza (sindacalismo teorico in senso stretto). È per lo meno strano l’atteggiamento dell’economismo verso la volontà, l’azione e l’iniziativa politica, come se esse non fossero espressione dell’economia e anzi l’espressione efficiente dell’economia; come è strano che impostare concretamente la quistione dell’egemonia sia interpretato come fatto che subordina il raggruppamento egemone. Evidentemente il fatto dell’egemonia presuppone che si tenga conto degli interessi e delle tendenze dei raggruppamenti su cui l’egemonia verrà esercitata, che si formi un certo equilibrio, che cioè il raggruppamento egemone faccia dei sacrifizi di ordine economico‑corporativo, ma questi sacrifizi non possono riguardare l’essenziale, poiché l’egemonia è politica, ma anche e specialmente economica, ha la sua base materiale nella funzione decisiva che il raggruppamento egemone esercita sul nucleo decisivo dell’attività economica.
L’economismo si presenta sotto molte altre forme oltre che il liberismo teorico e il sindacalismo teorico. Appartengono all’economismo tutte le forme di astensionismo elettorale (esempio l’astensionismo dei clericali italiani dal 1870 al 1919, divenuto dopo il 1900 sempre più parziale fino a sparire del tutto) che possono essere svariatissime, nel senso che ci può essere semi‑astensionismo, un quarto ecc. Non sempre l’economismo è contrario all’azione politica e al partito politico, che viene però considerato come organismo educativo di tipo sindacale. La così detta «intransigenza» è una forma di economismo: così la «formula tanto peggio tanto meglio» ecc.
Un altro punto di riferimento per comprendere i rapporti tra struttura e superstrutture è contenuto nella Miseria della Filosofia, là dove si dice che fase importante nello sviluppo di un raggruppamento sociale nato sul terreno dell’industria è quella in cui i singoli membri di una organizzazione economico‑corporativa non lottano solo più per i loro interessi economici corporativi, ma per lo sviluppo dell’organizzazione presa a sé, come tale (vedere esattamente l’affermazione contenuta nella Miseria della Filosofia, in cui sono contenute affermazioni essenziali dal punto di vista del rapporto della struttura e delle superstrutture e del concetto di dialettica proprio del materialismo storico; dal punto di vista teorico, la Miseria della Filosofia può essere considerata in parte come l’applicazione e lo svolgimento delle Tesi su Feuerbach mentre la Santa Famiglia è una fase intermedia ancora indistinta, come si vede dai brani riferentesi a Proudhon e specialmente al materialismo francese. Del resto il brano sul materialismo francese è più uno spunto di storia della cultura, che un brano teoretico, come spesso si suole intenderlo e come «storia della cultura» è ammirevole e definitivo). È da ricordare insieme l’affermazione di Engels che l’economia è «in ultima analisi» la molla della storia (nelle due lettere sul materialismo storico pubblicate anche in italiano), direttamente collegata al brano famoso della prefazione alla Critica dell’Economia Politica dove si dice che gli uomini «diventano consapevoli» del conflitto tra forma e contenuto del mondo produttivo sul terreno delle ideologie. Questo nodo è da ricordare a proposito della tesi prospettata in diverse dei vari quaderni che nel periodo moderno della storia il materialismo storico è più diffuso di quanto non sembri; esso però si presenta sotto l’aspetto di «economismo storico» (il nuovo nome usato dal Loria per indicare le sue nebulose concezioni da questo punto di vista è esatto e si può dire che il materialismo storico che io ritengo più diffuso di quanto si creda, è d’interpretazione loriana e non è l’originale marxista).
Questa interpretazione è legata all’errore di metodo, da me indicato più sopra, di non distinguere nell’analisi delle situazioni economiche e delle strutture sociali ciò che è «relativamente permanente» da ciò che è «fluttuazione occasionale»; distinzione che entro certi limiti corrisponde a quella di Stato e Governo, di strategia e tattica. Aspetti parziali dell’«economismo storico» sono: 1) la dottrina per cui lo svolgimento economico viene ridotto ai cangiamenti degli strumenti tecnici, mentre Marx parla sempre di «forze materiali di produzione» in generale e in queste forze include anche la «forza fisica» degli uomini (Loria ha dato un’esposizione brillantissima di questa dottrina nell’articolo sull’influenza sociale dell’aeroplano nella «Rassegna contemporanea» del 1912); 2) la dottrina per cui lo svolgimento economico e storico viene fatto dipendere immediatamente dai mutamenti di un qualche fattore importante della produzione, dovuto all’introduzione di un nuovo combustibile che porta con sé l’applicazione di nuovi metodi nella costruzione e nell’azionamento degli strumenti meccanici (per esempio il petrolio: cfr a questo proposito l’articolo sul petrolio di Antonino Laviosa nella Nuova Antologia del 1929 che nota i mutamenti nella costruzione dei mezzi di trasporto e specialmente militari portati dalla diffusione del petrolio e della benzina e ne trae delle conseguenze politiche esagerate: parla di un’era del petrolio che si contrappone a un’era del carbone ecc.; qualche altro avrà scritto lo stesso per l’elettricità ecc. Ora, anche queste scoperte di nuovi combustibili e di nuove energie motrici hanno importanza storica, perché possono mutare la statura relativa delle nazioni, ma non sono determinanti del moto storico). Spesso avviene che si combatte l’economismo storico credendo di combattere il materialismo storico. È questo il caso, per esempio, di un articolo dell’«Avenir» di Parigi del 10 ottobre 1930 (riportato nella «Rassegna settimanale della stampa estera» del 21 ottobre 1930, pp. 2303-4: «Ci si dice da molto tempo, ma soprattutto dopo la guerra, che le quistioni d’interesse dominano i popoli e portano avanti il mondo. Sono i marxisti che hanno inventato questa tesi sotto l’appellativo un po’ dottrinario di “materialismo storico”. Nel marxismo puro, gli uomini presi in massa non obbediscono alle passioni, ma alle necessità economiche. La politica è una passione. La Patria è una passione. Queste due idee esigenti non godono nella storia che una funzione di apparenza perché in realtà la vita dei popoli, nel corso dei secoli, si spiega con un gioco cangiante e sempre rinnovato di cause di ordine materiale. L’economia è tutto. Molti filosofi ed economisti “borghesi” hanno ripreso questo ritornello. Essi assumono una certa aria da spiegarci col corso del grano, dei petroli o del caucciù, la grande politica internazionale. Essi si ingegnano a dimostrarci che tutta la diplomazia è comandata da questioni di tariffe doganali e di prezzi di costo. Queste spiegazioni sono molto in auge. Esse hanno una piccola apparenza scientifica e procedono da una specie di scetticismo superiore che vorrebbe passare per una eleganza suprema. La passione in politica estera? Il sentimento in materia nazionale? Suvvia! Questa roba è buona per la gente comune. I grandi spiriti, gli iniziati sanno che tutto è dominato dal dare e dall’avere. Ora questa è una pseudo-verità assoluta. È completamente falso che i popoli non si lasciano guidare che da considerazioni di interesse ed è completamente vero che essi obbediscono più che mai al sentimento. Il materialismo storico è una buona scemenza. Le nazioni obbediscono soprattutto a delle condizioni dettate da un desiderio e da una fede ardente di prestigio. Chi non comprende questo non comprende nulla». La continuazione dell’articolo (intitolato La mania del prestigio) esemplifica con la politica tedesca e italiana, che sarebbe di «prestigio» e non dettata da interessi materiali. Il brano è interessante e andrebbe analizzato minutamente in caso di compilazione di un saggio; esso è contro l’«economismo storico» esagerato, di tipo loriano. L’autore non conosce la filosofia moderna e non capisce, d’altronde, che le «passioni», appunto, sono fatti economici.
Degenerato in economismo storico, il materialismo storico perde una gran parte della sua espansività culturale tra le persone intelligenti, per quanta ne acquista tra gli intellettuali pigri, tra quelli che vogliono apparire sempre furbissimi ecc.; esso, come scrisse Engels, fa credere a molti di poter avere, a poco prezzo e con nessuna fatica, in saccoccia tutta la storia, e tutta la sapienza politica. Avendo dimenticato che la tesi di Marx – che gli uomini acquistano coscienza dei conflitti fondamentali nel terreno delle ideologie – ha un valore organico, è una tesi gnoseologica e non psicologica o morale, si è creata la forma mentis di considerare la politica e quindi tutta la storia come un marché de dupes, un gioco di illusionismi e di prestidigitazioni. Tutta l’attività culturale è ridotta così a «svelare» trucchi, a suscitare scandali, a fare i conti in tasca agli uomini politici. Naturalmente gli errori di interpretazione sono stati talvolta grossolani e hanno così reagito negativamente sul prestigio della dottrina originaria. Perciò occorre combattere contro l’economismo non solo nella teoria della storiografia, ma anche nella teoria e nella pratica politica. In questo campo la reazione deve essere condotta sul terreno del concetto di egemonia, così come è stata condotta praticamente nello sviluppo della teoria del partito politico e nello sviluppo pratico della vita di determinati partiti politici.
Si potrebbe fare una ricerca storica sui giudizi emessi sullo sviluppo di certi movimenti politici, prendendo come archetipo quello detto boulangismo (dal 1886 al 1890 circa) ma forse addirittura il colpo di stato del 2 dicembre di Napoleone III. Si può trovare che il ragionamento stereotipato dell’economismo storico di solito è molto semplicistico: a chi giova immediatamente? A una certa frazione del raggruppamento dominante, che per non sbagliare si sceglie in quella frazione che evidentemente ha una funzione progressiva secondo una teoria generale. Come giudizio storico è quasi infallibile, poiché realmente se quel movimento politico andrà al potere la frazione progressiva del raggruppamento dominante in ultima analisi finirà col controllarlo e col farsene uno strumento per rivolgere a proprio beneficio l’apparato statale. Dico quasi infallibile a ragion veduta, perché l’interpretazione è solo un’ipotesi storica possibile e magari probabile che nel giudizio politico assume però una tinta moralistica. In ciò consiste l’errore teorico e pratico. Quando un tale movimento si forma l’analisi dovrebbe essere condotta secondo questa linea: 1°) contenuto sociale del movimento; 2°) rivendicazioni che i dirigenti pongono e che trovano consenso in determinati strati sociali; 3°) le esigenze obbiettive che tali rivendicazioni riflettono; 4°) esame della conformità dei mezzi adoperati al fine proposto; e 5°) solo in ultima analisi e presentata in forma politica e non in forma moralistica, presentazione dell’ipotesi che tale movimento necessariamente sarà snaturato e servirà a ben altri fini da quelli che le moltitudini seguaci credono. Invece quest’ipotesi viene affermata preventivamente, quando nessun elemento concreto (dico che appaia tale con evidenza e non per un’analisi «scientifica» esoterica) esiste ancora per suffragarla, così che essa appare come un’accusa morale di doppiezza e di malafede ecc. o di poca furberia, di stupidaggine. La politica diventa una serie di fatti personali. Naturalmente finché questi movimenti non hanno raggiunto il potere, si può sempre pensare che essi falliscano e alcuni infatti sono falliti (il boulangismo stesso – Valois‑Gayda): la ricerca allora deve dirigersi alla ricerca degli elementi di forza e degli elementi di debolezza che essi contengono nel loro intimo: l’ipotesi «economistica» afferma un elemento di forza, la disponibilità di un certo aiuto finanziario diretto o indiretto (un giornale che appoggi il movimento è un aiuto finanziario indiretto) e basta. Troppo poco. La ricerca quindi, come ho detto, dev’essere fatta nella sfera del concetto di egemonia.
Questo concetto, data l’affermazione fatta più sopra, che l’affermazione di Marx che gli uomini prendono coscienza dei conflitti economici nel terreno delle ideologie ha un valore gnoseologico e non psicologico e morale, avrebbe anch’esso pertanto un valore gnoseologico e sarebbe da ritenere perciò l’apporto massimo di Iliíč alla filosofia marxista, al materialismo storico, apporto originale e creatore. Da questo punto di vista Iliíč avrebbe fatto progredire il marxismo non solo nella teoria politica e nella economia, ma anche nella filosofia (cioè avendo fatto progredire la dottrina politica avrebbe fatto progredire anche la filosofia).
Q4 §39 Sul «Saggio popolare». Una trattazione sistematica del materialismo storico non può trascurare nessuna delle parti costitutive del marxismo. Ma in che senso ciò deve essere inteso? Essa deve trattare tutta la parte generale filosofica e in più deve essere: una teoria della storia, una teoria della politica, una teoria dell’economia. Ciò come schema generale che deve concretamente assumere una forma vivente, non schematica. Si dirà, ma il materialismo storico non è specificamente una teoria della storia? È giusto, ma dalla storia appunto non possono staccarsi la politica e l’economia, anche nelle fasi specializzate di scienza ‑ arte della politica e di scienza‑economica. Cioè: dopo avere svolto il compito principale nella parte filosofica generale, che è il vero e proprio materialismo storico, in cui i concetti generali della storia, della politica e dell’economia si annodano in unità organica, è utile, in un saggio popolare, dare le nozioni generali di ogni parte costitutiva in quanto scienza indipendente e distinta. Ciò vorrebbe dire che dopo aver studiato la filosofia generale cioè il nesso organico di storia‑politica‑economica si studia: come la storia e la politica si riflettano nell’economia, come l’economia e la politica si riflettano nella storia, come la storia e l’economia si riflettano nella politica.
Q4 §40 Filosofia e ideologia. Come filosofia il materialismo storico afferma teoricamente che ogni «verità» creduta eterna e assoluta ha origini pratiche e ha rappresentato o rappresenta un valore provvisorio. Ma il difficile è far comprendere «praticamente» questa interpretazione per ciò che riguarda il materialismo storico stesso. Questa interpretazione è adombrata da Engels dove parla di passaggio dal regno della necessità al regno della libertà. L’idealismo assoluto, o almeno certi suoi aspetti, sarebbero una utopia filosofica durante il regno della necessità, ma potrebbero diventare «verità» dopo il passaggio da un regno all’altro. Non si può parlare di «Spirito» quando la Società è raggruppata senza necessariamente concludere che si tratti dello «spirito» di un particolare raggruppamento (cosa implicitamente riconosciuta quando, come fa il Gentile – nel volume sul modernismo –, si dice sulle tracce di Schopenhauer che la religione è la filosofia della moltitudine mentre la filosofia è la religione degli uomini più eletti – cioè dei grandi intellettuali –), ma se ne potrà parlare quando la Società sarà unitaria.
Praticamente, dicevo, anche il materialismo storico tende a diventare una ideologia nel senso deteriore, cioè una verità assoluta ed eterna. Ciò avviene specialmente quando, come nel Saggio popolare, esso è confuso col materialismo volgare, con la metafisica della «materia» che non può non essere eterna e assoluta.
Bisognerà, su questa traccia, elaborare l’affermazione di Engels sul passaggio dalla necessità alla libertà: evidentemente questo passaggio avviene negli uomini, non nella natura (sebbene avrà delle conseguenze sull’intuizione della natura, sulle opinioni scientifiche), per cui solo per metafora si può parlare di storia naturale dell’umanità e paragonare i fatti umani ai fatti naturali.
Q4 §41 La scienza. Definizioni della scienza: 1°) Studio dei fenomeni e delle loro leggi di somiglianza (regolarità), di coesistenza (coordinazione), di successione (causalità). 2°) Un’altra tendenza, tenendo conto dell’ordinamento più comodo che la scienza stabilisce tra i fenomeni, in modo da poterli meglio far padroneggiare dal pensiero e dominarli per i fini dell’azione, definisce la scienza come la descrizione più economica della realtà.
La quistione più importante riguardo alla scienza è quella della esistenza obbiettiva della realtà. Per il senso comune la quistione non esiste neppure: ma da che cosa è data questa certezza del senso comune? Essenzialmente dalla religione (almeno dalle religioni occidentali, specialmente dal cristianesimo): essa è quindi una ideologia, l’ideologia più diffusa e radicata. Mi pare che sia un errore domandare alla scienza come tale la prova dell’obbiettività del reale: questa è una concezione del mondo, una filosofia, non un dato scientifico. Cosa può dare la scienza in questa direzione? La scienza fa una selezione tra le sensazioni, tra gli elementi primordiali della conoscenza: considera certe sensazioni come transitorie, come apparenti, come fallaci perché dipendono unicamente da speciali condizioni individuali e certe altre come durature, come permanenti, come superiori alle condizioni speciali individuali. Il lavoro scientifico ha due aspetti: uno che instancabilmente rettifica il metodo della conoscenza, e rettifica o rafforza gli organi delle sensazioni e l’altro che applica questo metodo e questi organi sempre più perfetti a stabilire ciò che di necessario esiste nelle sensazioni da ciò che è arbitrario e transitorio. Si stabilisce così ciò che è comune a tutti gli uomini, ciò che tutti gli uomini possono vedere e sentire nello stesso modo, purché essi abbiano osservato le condizioni scientifiche di accertamento. In quanto si stabilisce questa oggettività, la si afferma: si afferma l’essere in sé, l’essere permanente, l’essere comune a tutti gli uomini, l’essere indipendente da ogni punto di vista che sia meramente particolare. Ma anche questa è una concezione del mondo, è un’ideologia.
Il materialismo storico accetta questo punto di vista, non quello che pure è uguale materialmente, del senso comune. Il senso comune afferma l’oggettività del reale in quanto questa oggettività è stata creata da Dio, è quindi un’espressione della concezione del mondo religiosa: d’altronde nel descrivere questa oggettività cade nei più grossolani errori, in gran parte è ancora all’astronomia tolemaica, non sa stabilire i nessi reali di causa ed effetto ecc., cioè in realtà non è realmente «oggettivo», perché non sa concepire il «vero» oggettivo; per il senso comune è «vero» che la terra è ferma e il sole con tutto il firmamento le gira intorno ecc. Eppure fa l’affermazione filosofica della oggettività del reale. Ma tutto ciò che la scienza afferma è «oggettivamente vero»? In modo definitivo? Non si tratta invece di una lotta per la conoscenza dell’oggettività del reale, per una rettificazione sempre più perfetta dei metodi d’indagine e degli organi di osservazione, e degli strumenti logici di selezione e di discriminazione? Se è così, ciò che più importa non è dunque l’oggettività del reale come tale ma l’uomo che elabora questi metodi, questi strumenti materiali che rettificano gli organi sensori, questi strumenti logici di discriminazione, cioè la cultura, cioè la concezione del mondo, cioè il rapporto tra l’uomo e la realtà. Cercare la realtà fuori dell’uomo appare quindi un paradosso, così come per la religione è un paradosso peccato cercarla fuori di Dio.
Ricordo una affermazione di Bertrando Russell: si può immaginare sulla terra, anche senza l’uomo, non Glasgow e Londra, ma due punti della superficie della terra uno più a Nord e uno più a Sud (o qualcosa di simile: è contenuta in un libretto filosofico di Russell tradotto in una collezioncina Sonzogno di carattere scientifico). Ma senza l’uomo come significherebbe Nord e Sud, e «punto», e «superficie» e «terra»? Non sono queste espressioni necessariamente legate all’uomo, ai suoi bisogni, alla sua vita, alla sua attività? Senza l’attività dell’uomo, creatrice di tutti i valori anche scientifici, cosa sarebbe l’«oggettività»? Un caos, cioè niente, il vuoto, se pure così si può dire, perché realmente se si immagina che non esista l’uomo, non si può immaginare la lingua e il pensiero. Per il materialismo storico non si può staccare il pensare dall’essere, l’uomo dalla natura, l’attività (storia) dalla materia, il soggetto dall’oggetto: se si fa questo distacco si cade nel chiacchericcio, nell’astrazione senza senso.
Q4 §42 Giovanni Vailati e il linguaggio scientifico. Ho citato parecchie volte il brano in cui Marx, nella Sacra Famiglia, dimostra come il linguaggio politico francese, adoperato da Proudhon, corrisponda e possa tradursi nel linguaggio della filosofia classica tedesca. Questa affermazione mi pareva molto importante per comprendere l’intimo valore del materialismo storico e per trovare la via di risoluzione di molte apparenti contraddizioni dello sviluppo storico e per rispondere ad alcune superficiali obbiezioni contro questa teoria della storiografia. Nel fascicolo di settembre‑ottobre 1930 dei «Nuovi Studi di Diritto, Economia, Politica» in una lettera aperta di Luigi Einaudi a Rodolfo Benini («Se esista, storicamente, la pretesa repugnanza degli economisti verso il concetto dello Stato produttore») in una nota a p. 303 si legge: «Se io possedessi la meravigliosa facoltà che in sommo grado aveva il compianto amico Vailati di tradurre una qualunque teoria dal linguaggio geometrico in quello algebrico, da quello edonista in quello della morale kantiana, dalla terminologia economica pura normativa in quella applicata precettistica, potrei tentare di ritradurre la pagina dello Spirito nella formulistica tua, ossia economistica classica. Sarebbe un esercizio fecondo, simile a quelli di cui racconta Loria, da lui intrapresi in gioventù: di esporre successivamente una data dimostrazione economica prima in linguaggio di Adamo Smith e poi di Ricardo e quindi di Marx, di Stuart Mill e di Cairnes. Ma sono esercizi che vanno, come faceva Loria, dopo fatti, riposti nel cassetto. Giovano ad insegnare la umiltà ad ognuno di noi, quando per un momento ci illudiamo di aver visto qualcosa di nuovo. Perché se questa novità poteva essere stata detta con le loro parole e inquadrarsi nel pensiero dei vecchi, segno è che quel qualcosa era contenuto in quel pensiero. Ma non possono né devono impedire che ogni generazione usi quel linguaggio che meglio si adatta al modo suo di pensare e d’intendere il mondo. Si riscrive la storia; perché non si dovrebbe riscrivere la scienza economica, prima in termini di costo di produzione e poi di utilità e quindi di equilibrio statico e poi di equilibrio dinamico?»
Le intenzioni «metodologiche» dell’Enaudi sono molto più circoscritte di quelle che sono implicite nell’affermazione di Marx, ma appartengono alla stessa serie. L’Einaudi si riattacca alla corrente rappresentata dai pragmatisti italiani e da Vilfredo Pareto, tendenza che trovò una certa espressione nel libretto di Prezzolini: Il linguaggio come causa di errore. L’Einaudi vuole dare una lezione di modestia allo Spirito, nel quale molto spesso, la novità delle idee, dei metodi, dell’impostazione dei problemi, è puramente e semplicemente una quistione di terminologia, di parole. Ma, come dicevo, è questo il primo grado del problema che è implicito, in tutta la sua vastità, nel brano di Marx. Come due individui, prodotti dalla stessa fondamentale cultura, credono di sostenere cose differenti solo perché adoperano una terminologia diversa, così nel campo internazionale, due culture, espressioni di due civiltà fondamentalmente simili, credono di essere antagonistiche, diverse, una superiore all’altra, perché adoperano diverse espressioni ideologiche, filosofiche, o perché una ha carattere più strettamente pratico, politico (Francia) mentre l’altra ha carattere più filosofico, dottrinario, teorico. In realtà, per lo storico, esse sono intercambiabili, sono riducibili una all’altra, sono traducibili scambievolmente.
Questa «traducibilità» non è perfetta, certamente, in tutti i particolari (anche importanti); ma lo è nel «fondo» essenziale. Una è realmente superiore all’altra, ma non sempre in ciò che i loro rappresentanti e i loro fanatici chierici pretendono; se così non fosse non ci sarebbe progresso reale, che avviene anche per spinte «nazionali».
La filosofia gentiliana è, nel mondo contemporaneo, quella che più fa quistioni di «parole», di «terminologia», che dà per «creazione» nuova ogni mutamento grammaticale dell’espressione: perciò la breve nota dell’Einaudi è una freccia avvelenatissima contro lo Spirito e su di essa si aggira esasperatamente la breve nota dello stesso Spirito. (Ma della quistione di merito della polemica non voglio occuparmi in questa nota). Voglio solo notare la necessità di studiare questo aspetto del pragmatismo italiano (specialmente nel Vailati) e del Pareto sulla quistione del linguaggio scientifico.
Q4 §43 L’«obbiettività del reale» e il Prof. Lukacz (cfr nota antecedente La scienza a p. 75). È da studiare la posizione del prof. Lukacz verso il materialismo storico. Il Lukacz (conosco le sue teorie molto vagamente) credo affermi che si può parlare di dialettica solo per la storia degli uomini e non per la natura. Può aver torto e può aver ragione. Se la sua affermazione presuppone un dualismo tra l’uomo e la natura egli ha torto perché cade in una concezione della natura propria della religione e anche propria dell’idealismo, che realmente non riesce a unificare e mettere in rapporto l’uomo e la natura altro che verbalmente. Ma se la storia umana è anche storia della natura, attraverso la storia della scienza, come la dialettica può essere staccata dalla natura? Penso che il Lukacz, scontento delle teorie del Saggio popolare, sia caduto nell’errore opposto: ogni conversione e identificazione del materialismo storico nel materialismo volgare non può che determinare l’errore opposto, la conversione del materialismo storico nell’idealismo o addirittura nella religione.
Q4 §44 Sorel. In un articolo su Clemenceau pubblicato nella «Nuova Antologia» del 16 dicembre 1929 e in un altro pubblicato nell’«Italia Letteraria» del 15 dicembre (il primo firmato «Spectator», il secondo firmato con nome e cognome) Mario Missiroli pubblica due brani importanti di lettere inviategli da Giorgio Sorel e riguardanti Clemenceau: «Egli (Clemenceau) giudica la filosofia di Marx, che costituisce l’ossatura del socialismo contemporaneo, come una dottrina oscura, buona per i barbari di Germania, come sempre è apparsa alle intelligenze pronte e brillanti, abituate alle facili letture. Spiriti leggeri come il suo non riescono a capire ciò che Renan capiva così bene, che, cioè, valori storici di grande importanza possono apparire congiunti con una produzione letteraria di evidente mediocrità, quale è appunto la letteratura socialista offerta al popolo». «Io credo che se Clemenceau ha fatto per lungo tempo poco conto del socialismo, meno ancora dovette farne quando vide Jaurès diventare l’idolo dei partiti socialisti. La facondia oratoria di Jaurès lo inaspriva. Nella sua “estrema leggerezza” – la definizione è di Giuseppe Reinach – giudicò che il socialismo non potesse contenere nulla di serio, dal momento che un professore di università, riconosciuto capo della nuova dottrina, non riusciva a ricavarne che vento. Non si curava di sapere se le masse, una volta scosse dalle vacue declamazioni dei capi, non avrebbero saputo trovare nel loro seno dei direttori capaci di condurle verso delle regioni, che i capi della democrazia non potevano neppure sospettare. Clemenceau non crede all’esistenza di una classe che si travaglia a formarsi la coscienza di una grande missione storica da compiere, missione che ha per iscopo il rinnovamento totale della nostra civiltà. Crede che il dovere delle democrazie sia quello di venire in soccorso dei diseredati che assicurano la produzione delle ricchezze materiali, delle quali nessuno può fare a meno. Nei momenti difficili un potere intelligente deve fare delle leggi per imporre ai ricchi dei sagrifici, destinati a salvare la solidarietà nazionale. Un’evoluzione bene ordinata, che conduca ad una vita relativamente dolce, ecco quanto il popolo reclamerebbe in nome della scienza, se avesse dei buoni consiglieri. Ai suoi occhi i socialisti sono dei cattivi pastori quando introducono, nella politica di un paese democratico, la nozione della rivoluzione. Come tutti gli uomini della sua generazione, Clemenceau ha conservato un vivo ricordo della Comune. Credo fermamente che egli non abbia ancora perdonato al popolo di Parigi la brutalità con la quale le guardie nazionali insorte lo cacciarono dal palazzo del Comune di Montmartre». I due brani nell’articolo della Nuova Antologia sono stampati come un tutto organico; nell’«Italia Letteraria» come distinti: tra il primo e il secondo il Missiroli scrive: «E altrove:», ciò che fa meglio comprendere stilisticamente il contesto.
Sorel. Questi due brani spingono sempre più a pensare che occorre ristudiare Sorel, per cogliere, al di sotto delle incrostazioni parassitarie deposte sul suo pensiero dagli ammiratori dilettanti e intellettuali, ciò che vi è di più essenziale e permanente. Bisogna tener presente che si è esagerato alquanto sulla «austerità» e «serietà» morale e intellettuale del Sorel; dall’epistolario col Croce risulta che egli non sempre ha saputo vincere gli stimoli di una certa vanità: ciò risulta dal tono molto impacciato della lettera in cui vuole spiegare al Croce la sua adesione (sia pure platonica) al «Circolo Proudhon» di Valois e il suo civettare con elementi giovani della tendenza monarchica e clericale. Ancora: c’era un certo dilettantismo negli atteggiamenti «politici» del Sorel, che non erano mai schiettamente politici, ma «politici‑culturali», «politici‑intellettuali», «au dessus de la mêlée»: anche a lui si potrebbero muovere alcune delle accuse contenute nell’opuscolo di un suo discepolo I misfatti degli intellettuali. Egli stesso era un «puro» intellettuale e perciò bisognerebbe separare con una analisi accurata ciò che vi è nelle sue opere di superficiale, di brillante, di accessorio, legato alle contingenze della polemica estemporanea, e ciò che vi è di «polposo» e sostanzioso, per farlo entrare, così definito, nel circolo della cultura moderna.
Q4 §45 Struttura e superstrutture. Che il materialismo storico concepisca se stesso come una fase transitoria del pensiero filosofico dovrebbe apparire dall’affermazione di Engels che lo sviluppo storico sarà caratterizzato a un certo punto dal passaggio dal regno della necessità al regno della libertà. Tutta la filosofia finora esistita è nata ed è l’espressione delle contraddizioni intime della società: ma ogni sistema filosofico a sé preso non è l’espressione cosciente di queste contraddizioni, poiché questa espressione può essere data solo dall’insieme dei sistemi filosofici. Ogni filosofo è e non può non essere convinto di esprimere l’unità dello spirito umano, cioè l’unità della storia e della natura: altrimenti gli uomini non opererebbero, non creerebbero nuova storia, cioè le filosofie non potrebbero diventare «ideologie», non potrebbero nella pratica assumere la granitica compattezza fanatica delle «credenze popolari» che hanno il valore di «forze materiali». Hegel rappresenta, nella storia del pensiero filosofico, un posto a sé, perché, nel suo sistema, in un modo o nell’altro, pur nella forma di «romanzo filosofico», si riesce a comprendere cos’è la realtà, cioè si ha, in un solo sistema e in un solo filosofo, quella coscienza delle contraddizioni che prima era data dall’insieme dei sistemi, dall’insieme dei filosofi, in lotta tra loro, in contraddizione tra loro. In un certo senso, adunque, il materialismo storico è una riforma e uno sviluppo dello hegelismo, è la filosofia liberata da ogni elemento ideologico unilaterale e fanatico, è la coscienza piena delle contraddizioni in cui lo stesso filosofo, individualmente inteso o inteso come intero gruppo sociale, non solo comprende le contraddizioni, ma pone se stesso come elemento della contraddizione, e eleva questo elemento a principio politico e d’azione. L’«uomo in generale» viene negato e tutti i concetti «unitari» staticamente vengono dileggiati e distrutti, in quanto espressione del concetto di «uomo in generale» o di «natura umana» immanente in ogni uomo. Ma anche il materialismo storico è espressione delle contraddizioni storiche, anzi è l’espressione perfetta, compiuta di tali contraddizioni: è una espressione della necessità, quindi, non della libertà, che non esiste e non può esistere. Ma se si dimostra che le contraddizioni spariranno, si dimostra implicitamente che sparirà anche il materialismo storico, e che dal regno della necessità si passerà al regno della libertà, cioè a un periodo in cui il «pensiero», le idee non nasceranno più sul terreno delle contraddizioni. Il filosofo attuale può affermare ciò e non andare più oltre: infatti egli non può evadere dal terreno attuale delle contraddizioni, non può affermare, più che genericamente, un mondo senza contraddizioni, senza creare immediatamente una utopia. Ciò non significa che l’utopia non abbia un valore filosofico, poiché essa ha un valore politico, e ogni politica è implicitamente una filosofia. La religione è la più «mastodontica» utopia, cioè la più «mastodontica» metafisica apparsa nella storia, essa è il tentativo più grandioso di conciliare in forma mitologica le contraddizioni storiche: essa afferma, è vero, che l’uomo ha la stessa «natura», che esiste l’uomo in generale, creato simile a Dio e perciò fratello degli altri uomini, uguale agli altri uomini, libero fra gli altri uomini, e che tale egli si può concepire specchiandosi in Dio, «autocoscienza» dell’umanità, ma afferma anche che tutto ciò non è di questo mondo, ma di un altro (utopia). Ma intanto le idee di uguaglianza, di libertà, di fraternità fermentano in mezzo agli uomini, agli uomini che non sono uguali, né fratelli di altri uomini, né si vedono liberi fra di essi. E avviene nella storia, che ogni sommovimento generale delle moltitudini, in un modo o nell’altro, sotto forme e con ideologie determinate, pone queste rivendicazioni. A questo punto interviene un elemento portato da Ilici [Lenin ndc]: nel programma dell’aprile 1917, nel paragrafo dove si parla della scuola unica e precisamente nella breve nota esplicativa (mi riferisco all’edizione di Ginevra del 1918) si afferma che il chimico e pedagogista Lavoisier, ghigliottinato sotto il Terrore, aveva sostenuto il concetto della scuola unica, e ciò in rapporto ai sentimenti popolari del suo tempo, che nel movimento democratico del 1789 vedevano una realtà in isviluppo e non un’ideologia e ne tiravano le conseguenze egualitarie concrete. In Lavoisier si trattava di elemento utopistico (elemento che appare, più o meno, in tutte le correnti culturali che presuppongono l’unicità di natura dell’uomo: cfr B. Croce in un capitolo di Cultura e Vita Morale dove cita una proposizione in latino di una dissertazione tedesca, affermante che la filosofia è la più democratica delle scienze perché il suo oggetto è la facoltà raziocinante, comune a tutti gli uomini – o qualcosa di simile); tuttavia Ilici lo assume come elemento dimostrativo, teorico, di un principio politico.
Q4 §46 Filosofia ‑ Politica ‑ economia. Se si tratta di elementi costitutivi di una stessa concezione del mondo, necessariamente ci deve essere, nei principii teorici, convertibilità da uno all’altro, traduzione reciproca nel proprio specifico linguaggio di ogni parte costitutiva: un elemento è implicito nell’altro e tutti insieme formano un circolo omogeneo (cfr la nota precedente su Giovanni Vailati e il linguaggio scientifico). Da questa proposizione conseguono per lo storico della cultura e delle idee alcuni canoni d’indagine e di critica di grande importanza:
Avviene che una grande personalità esprima il suo pensiero più fecondo non nella sede che apparentemente sarebbe la più «logica» dal punto di vista classificatorio esterno, ma in altra parte che apparentemente sembrerebbe estranea (mi pare che il Croce abbia parecchie volte sparsamente fatta questa osservazione critica). Un uomo politico scrive di filosofia: può darsi che la sua «vera» filosofia sia invece da ricercarsi negli scritti di politica. In ogni personalità c’è un’attività dominante e predominante: è in questa che occorre ricercare il suo pensiero, implicito il più delle volte e talvolta in contraddizione con quello espresso ex professo. È vero che in questo criterio di giudizio storico sono impliciti molti pericoli di dilettantismo e che nell’applicazione occorre andar molto cauti, ma ciò non toglie che il criterio sia fecondo di verità.
Avviene realmente che il «filosofo» occasionale più difficilmente sappia astrarre dalle correnti dominanti del suo tempo, dalle interpretazioni divenute dogmatiche di una certa concezione del mondo ecc.; mentre invece come scienziato della politica si sente libero da questi idola del tempo, affronta più immediatamente la stessa concezione del mondo, vi penetra nell’intimo e la sviluppa originalmente. A questo proposito è ancora utile e fecondo il pensiero espresso dalla Rosa [Luxemburg] sulla impossibilità di affrontare certe quistioni del materialismo storico in quanto esse non sono ancora divenute attuali per il corso della storia generale o di un dato raggruppamento sociale. Alla fase corporativa, alla fase di egemonia nella società civile (o di lotta per l’egemonia), alla fase statale corrispondono attività intellettuali determinate, che non si possono arbitrariamente improvvisare. Nella fase della lotta per l’egemonia si sviluppa la scienza della politica, nella fase statale tutte le superstrutture devono svilupparsi, pena il dissolvimento dello Stato.
Q4 §47 La oggettività del reale e Engels. In un certo punto (credo dell’Antidühring) Engels afferma, su per giù, che l’oggettività del mondo fisico è dimostrata dalle ricerche successive degli scienziati (cfr il testo esatto). Questa asserzione di Engels dovrebbe, secondo me, essere analizzata e precisata. Si intende per scienza l’attività teorica o l’attività pratico‑sperimentale degli scienziati? Io penso che deve essere intesa in questo secondo senso e che Engels voglia affermare il caso tipico in cui si stabilisce il processo unitario del reale, cioè attraverso l’attività pratica, che è la mediazione dialettica tra l’uomo e la natura, cioè la cellula «storica» elementare. Engels si riferisce alla rivoluzione che ha apportato nel mondo scientifico in generale, e anche nell’attività pratica, l’affermarsi del metodo sperimentale, che separa veramente due mondi della storia e inizia la dissoluzione della teologia e della metafisica e la nascita del pensiero moderno, la cui ultima e perfezionata espressione filosofica è il materialismo storico. L’«esperienza» scientifica è la prima cellula del nuovo processo di lavoro, della nuova forma d’unione attiva tra l’uomo e la natura: lo scienziato‑sperimentatore è un «operaio», un produttore industriale e agricolo, non è puro pensiero: è anch’egli, anzi egli è il primo esempio di uomo che il processo storico ha tolto dalla posizione di camminare sulla testa, per farlo camminare sui piedi.
Q4 §48 Il libro di Henri De Man. Nella «Civiltà Cattolica» del 7 settembre 1929, nell’articolo Per la pace sociale (del p. Brucculeri) che commenta il famoso lodo emesso dalla Congregazione del Concilio nel conflitto tra operai e industriali cattolici della regione Roubaix-Tourcoing, c’è questo passo: «Il marxismo – come dimostra nelle sue più belle pagine il De Man – è stata una corrente materializzatrice del mondo operaio odierno». Cioè le pagine del De Man sono tutte belle ma alcune sono più belle ancora. (Può spiegarsi così che Giuseppe Prezzolini, accennando nel «Pègaso» del settembre 1930 al libro del Philip sul «movimento operaio americano», qualifica il Philip come «democratico‑cristiano», sebbene nel libro questa qualità non risulti).
Nei fascicoli della «Civiltà Cattolica» del 5 ottobre e del 16 novembre 1929 è pubblicato un saggio molto diffuso sul libro del De Man. L’opera del De Man è reputata «nonostante le sue deficienze, la più importante e, diciamo pure, geniale, di quante finora ne annoveri la letteratura antimarxista». Verso la fine del saggio c’è questa «impressione complessiva»: «L’A. (il De Man), benché abbia superato una crisi di pensiero respingendo, con gesto magnanimo, il marxismo, è tuttavia ondeggiante, e la sua intelligenza sitibonda di vero non è a pieno soddisfatta. Egli batte sulle soglie della verità, raccoglie dei raggi, ma non si spinge innanzi per tuffarsi nella luce. – Auguriamo al De Man che, compiendo la sua crisi, possa elevarsi, come il gran vescovo di Tagaste (Agostino), dal divino riflesso che è la legge morale nell’anima, al divino infinito, alla sorgente eternamente splendida di tutto ciò cbe per l’universo si squaderna».
Finisce qui il gruppo di comprese sotto il titolo Appunti di filosofia. Materialismo e idealismo. Prima serie.
Q4 §49 Gli intellettuali. Prima quistione: gli intellettuali sono un gruppo sociale autonomo, oppure ogni gruppo sociale ha una sua propria categoria di intellettuali? Il problema è complesso per le varie forme che ha assunto finora il processo storico di formazione delle diverse categorie intellettuali. Le più importanti di queste forme sono due: organicamente, un ceto o più ceti di intellettuali che gli danno omogeneità e consapevolezza della propria funzione nel campo economico: l’imprenditore capitalista crea con sé l’economista, lo scienziato dell’economia politica. Inoltre c’è il fatto che ogni imprenditore è anche un intellettuale, nel senso che deve avere una certa capacità tecnica, oltre che nel campo economico in senso stretto, anche in altri campi, almeno in quelli più vicini alla produzione economica (deve essere un organizzatore di masse di uomini, deve essere un organizzatore della «fiducia» dei risparmiatori nella sua azienda, dei compratori della sua merce, ecc.); se non tutti gli imprenditori, almeno una élite di essi deve avere una capacità tecnica (di ordine intellettuale) di organizzatore della società in generale, in tutto il suo complesso organismo di servizi fino allo Stato, per avere le condizioni più favorevoli all’espansione del proprio gruppo, o per lo meno la capacità di scegliere i «commessi» specializzati in questa attività organizzatrice dei rapporti generali esterni all’impresa.
Anche i signori feudali erano detentori di una particolare forma di capacità: quella militare, ed è appunto dal momento in cui l’aristocrazia perde il monopolio della capacità tecnica militare che si inizia la crisi del feudalismo.
2) Ma ogni gruppo sociale, emergendo alla storia dalla struttura economica, trova o ha trovato, nella storia almeno fino ad ora svoltasi, delle categorie intellettuali preesistenti, e che apparivano anzi come rappresentanti una continuità storica ininterrotta anche dai più complicati mutamenti delle forme sociali e politiche. La più tipica di queste categorie intellettuali è quella degli ecclesiastici, monopolizzatori per lungo tempo di alcuni servizi essenziali (l’ideologia religiosa, la scuola e l’istruzione, e in generale la «teoria», con riferimento alla scienza, alla filosofia, alla morale, alla giustizia ecc., oltre alla beneficenza e all’assistenza ecc.), ma ce ne sono parecchie altre che in regime feudale furono in parte, almeno, equiparate giuridicamente all’aristocrazia (il clero, in realtà, esercitava la proprietà feudale della terra come i nobili ed economicamente era equiparato ai nobili, ma c’era per esempio, un’aristocrazia della toga, oltre a quella della spada, ecc.: nel paragrafo precedente, agli economisti, nati con gli imprenditori, occorre aggiungere i tecnici industriali e gli scienziati «applicati», categoria intellettuale strettamente connessa al gruppo sociale degli imprenditori, ecc.), gli scienziati «teorici», i filosofi non ecclesiastici, ecc. Siccome queste categorie sentono con «spirito di corpo» la continuità della loro qualifica intellettuale (Croce si sente come legato ad Aristotele più che ad Agnelli, ecc.) così appare una certa loro autonomia dal gruppo sociale dominante e il loro complesso può apparire come un gruppo sociale indipendente con propri caratteri, ecc.
Seconda quistione: quali sono i limiti massimi dell’accezione di «intellettuale»? È difficile trovare un criterio unico che caratterizzi ugualmente tutte le disparate attività intellettuali e nello stesso tempo le distingua in modo essenziale dalle attività degli altri raggruppamenti sociali. L’errore metodico più diffuso mi pare quello di aver cercato questa caratteristica essenziale nell’intrinseco dell’attività intellettuale e non invece nel sistema di rapporti in cui essa (o il raggruppamento che la impersona) si viene a trovare nel complesso generale dei rapporti sociali. Invero: 1) L’operaio non è specificamente caratterizzato dal lavoro manuale o strumentale (a parte la considerazione che non esiste lavoro puramente fisico e che anche l’espressione del Taylor di «gorilla ammaestrato» è una metafora per indicare un limite in una certa direzione: c’è, in qualsiasi lavoro fisico, anche il più meccanico e degradato, un minimo di qualifica tecnica, cioè un minimo di attività intellettuale creatrice), ma da questo lavoro in determinate condizioni e in determinati rapporti sociali. 2) È stato già notato che l’imprenditore, per la sua stessa funzione, deve avere in una certa misura un certo numero di qualifiche di carattere intellettuale, sebbene la sua figura sociale sia determinata non da esse ma dai rapporti generali sociali che si caratterizzano dalla posizione dell’imprenditore nell’industria.
Fatte queste distinzioni si può concludere per ora: il rapporto tra gli intellettuali e la produzione non è immediato, come avviene per i gruppi sociali fondamentali, ma è mediato ed è mediato da due tipi di organizzazione sociale: a) dalla società civile, cioè dall’insieme di organizzazioni private della società, b) dallo Stato. Gli intellettuali hanno una funzione nell’«egemonia» che il gruppo dominante esercita in tutta la società e nel «dominio» su di essa che si incarna nello Stato e questa funzione è precisamente «organizzativa» o connettiva: gli intellettuali hanno la funzione di organizzare l’egemonia sociale di un gruppo e il suo dominio statale, cioè il consenso dato dal prestigio della funzione nel mondo produttivo e l’apparato di coercizione per quei gruppi che non «consentono» né attivamente né passivamente o per quei momenti di crisi di comando e di direzione in cui il consenso spontaneo subisce una crisi. Da quest’analisi risulta un’estensione molto grande del concetto di intellettuali, ma solo così mi pare sia possibile giungere ad una approssimazione concreta della realtà.
La maggiore difficoltà ad accogliere questo modo di impostare la quistione mi pare venga da ciò: che la funzione organizzativa dell’egemonia sociale e del dominio statale ha vari gradi e che tra questi gradi ce ne sono di quelli puramente manuali e strumentali, di ordine e non di concetto, di agente e non di funzionario o di ufficiale, ecc., ma evidentemente nulla impedisce di fare questa distinzione (infermieri e medici in un ospedale, sacristi‑bidelli e preti in una chiesa, bidelli e professori in una scuola, ecc. ecc.).
Dal punto di vista intrinseco, l’attività intellettuale può essere distinta in gradi, che nei momenti di estrema opposizione danno una vera e propria differenza qualitativa: nel più alto gradino troviamo i «creatori» delle varie scienze, della filosofia, della poesia ecc.; nel più basso i più umili «amministratori e divulgatori» della ricchezza intellettuale tradizionale, ma nell’insieme tutte le parti si sentono solidali. Avviene anzi che gli strati più bassi sentano di più questa solidarietà di corpo e ne traggano una certa «boria» che spesso li espone ai frizzi e ai motteggi.
È da notare che nel mondo moderno, la categoria degli intellettuali, così intesa, si è ampliata in misura inaudita. La formazione di massa ha standardizzato gli individui e come qualifica tecnica e come psicologia, determinando gli stessi fenomeni che in tutte le altre masse standardizzate: concorrenza individuale che pone la necessità dell’organizzazione professionale di difesa, disoccupazione, ecc.
Diversa posizione degli intellettuali di tipo urbano e di tipo rurale. Gli intellettuali di tipo urbano sono piuttosto legati all’industria; essi hanno la stessa funzione che gli ufficiali subalterni nell’esercito: mettono in rapporto l’imprenditore con la massa strumentale, rendono esecutivo il piano di produzione stabilito dallo stato maggiore dell’industria. Gli intellettuali urbani sono molto standardizzati nella loro media generale, mentre gli alti intellettuali si confondono sempre più col vero e proprio stato maggiore «organico» dell’alta classe industriale.
Gli intellettuali di tipo rurale mettono a contatto la massa contadina con l’amministrazione statale o locale (avvocati, notai, ecc.) e per questa stessa funzione hanno una maggiore importanza politica: questa mediazione professionale infatti è difficilmente scindibile dalla mediazione politica. Inoltre: nella campagna l’intellettuale (prete, avvocato, maestro, notaio, medico, ecc.) rappresenta per il medio contadino un modello sociale nell’aspirazione a uscire dalla propria situazione per migliorare. Il contadino pensa sempre che almeno un suo figlio potrebbe diventare intellettuale (specialmente prete), cioè diventare un signore, elevando il grado sociale della famiglia e facilitandone la vita economica con le aderenze che non potrà non avere tra gli altri signori. L’atteggiamento del contadino verso l’intellettuale è duplice: egli ammira la posizione sociale dell’intellettuale e in generale del dipendente statale, ma finge talvolta di disprezzarla, cioè la sua ammirazione istintiva è intrisa da elementi d’invidia e di rabbia appassionata. Non si comprende nulla dei contadini se non si considera questa loro subordinazione effettiva agli intellettuali e non si comprende che ogni sviluppo delle masse contadine fino a un certo punto è legato ai movimenti degli intellettuali e ne dipende.
Altro è il caso per gli intellettuali urbani; i tecnici di fabbrica non esercitano nessun influsso politico sulle masse strumentali, o almeno è questa una fase già oltrepassata; talvolta avviene proprio il contrario, che le masse strumentali, almeno attraverso i loro propri intellettuali organici, esercitano un influsso sui tecnici.
Il punto centrale della quistione rimane però la distinzione tra intellettuali come categoria organica di ogni gruppo sociale e intellettuali come categoria tradizionale, distinzione da cui scaturisce tutta una serie di problemi e di possibili ricerche storiche. Il problema più interessante è quello che riguarda l’analisi del partito politico da questo punto di vista.
Cosa diventa il partito politico in ordine al problema degli intellettuali? Esso mi pare possa dirsi appunto il meccanismo che nella società civile compie la stessa funzione che compie lo Stato in misura maggiore nella società politica, cioè procura la saldatura tra intellettuali organici di un gruppo sociale e intellettuali tradizionali, funzione che può compiere in dipendenza della sua funzione fondamentale di elevare i membri «economici» di un gruppo sociale alla qualità di «intellettuali politici», cioè di organizzatori di tutte le funzioni inerenti all’organico sviluppo di una società integrale, civile e politica. Si può dire anzi che nel suo ambito il partito politico compie la sua funzione molto più organicamente di quanto lo Stato compia la sua nel suo ambito più vasto: un intellettuale che entra a far parte del partito politico di un determinato gruppo sociale, si confonde con gli intellettuali organici di tal gruppo, si lega strettamente a quel gruppo, ciò che non avviene attraverso la partecipazione alla vita statale che mediocremente e talvolta affatto. Avviene anzi che molti intellettuali pensino di esser loro lo Stato, credenza che data la massa imponente della categoria talvolta ha conseguenze voli e porta a delle complicazioni spiacevoli per il gruppo sociale economico che realmente è lo Stato.
Che tutti i membri di un partito politico debbano essere considerati come intellettuali: ecco un’affermazione che può prestarsi allo scherzo; pure, se si riflette, niente di più esatto. Sarà da fare distinzione di gradi, un partito potrà avere maggiore o minore composizione del grado più alto o del grado più basso; non è ciò che importa: importa la funzione che è educativa e direttiva, cioè intellettuale. Un commerciante non entra a far parte di un partito politico per fare del commercio, né un industriale per produrre di più e meglio, né un contadino per apprendere nuovi metodi di coltivar la terra, anche se qualche aspetto di queste esigenze del commerciante, dell’industriale, del contadino possono trovare soddisfazione nel partito politico (l’opinione generale contraddice a ciò, affermando che il commerciante, l’industriale, il contadino «politicanti» perdono invece di guadagnare, ciò che può essere discusso). Per questi scopi, entro certi limiti, esiste il sindacato professionale, in cui la funzione economico‑corporativa del commerciante, dell’industriale, del contadino trova il suo quadro più adatto. Nel partito politico gli elementi di un gruppo sociale economico superano questo momento del loro sviluppo storico e diventano agenti di attività generali, di carattere nazionale e internazionale (cfr la nota «Rapporti tra struttura e superstruttura» a p. 67). Questa funzione del partito politico dovrebbe apparire molto più chiara da un’analisi storica concreta del come si sono sviluppate le categorie organiche degli intellettuali e gli intellettuali tradizionali sia nel terreno dei vari sviluppi nazionali, sia in quello dello sviluppo dei vari gruppi sociali più importanti nel quadro delle varie nazioni, specialmente di quei gruppi sociali la cui attività economica è stata prevalentemente strumentale. La formazione degli intellettuali tradizionali è il problema storico più interessante. Esso è certamente legato alla schiavitù del mondo classico e alla situazione dei liberti di origine greca e orientale nell’organizzazione sociale dell’Impero romano. Questo distacco non solo sociale ma nazionale, di razza, tra masse voli di intellettuali e la classe dominante nell’Impero Romano si riproduce dopo la caduta di Roma tra guerrieri germanici e intellettuali di origine latina continuatori dei liberti‑intellettuali. Si intreccia con questo fenomeno il nascere e lo svilupparsi del cattolicismo e dell’organizzazione ecclesiastica che per molti secoli assorbe la maggior parte delle attività intellettuali ed esercita il monopolio della direzione intellettuale, con sanzioni penali per chi vuole opporsi o anche eludere questo monopolio.
A questo fenomeno si collega l’altro della funzione cosmopolita degli intellettuali italiani, su cui (ci sono) molte scritte sparsamente nei diversi quaderni.
Nello sviluppo degli intellettuali europei si osservano molte differenze tra nazione e nazione; ne accennerò le più voli, che dovranno essere approfondite (d’altronde tutte le affermazioni contenute in questa nota devono essere considerate semplicemente come spunti e motivi per la memoria, che occorrono di essere controllati e approfonditi):
1) Per l’Italia il fatto centrale è appunto la funzione internazionale o cosmopolita dei suoi intellettuali che è causa ed effetto dello stato di disgregazione in cui rimane la penisola dalla caduta dell’Impero romano fino al 1870.
2) La Francia dà un tipo compiuto di sviluppo armonico di tutte le energie nazionali e specialmente delle categorie intellettuali: quando nel 1789 un nuovo raggruppamento sociale affiora politicamente alla storia, esso è completamente attrezzato per tutte le sue funzioni sociali e perciò lotta per il dominio totale della nazione, senza venire a compromessi essenziali con le vecchie classi, anzi subordinandosele. Le prime cellule intellettuali del nuovo tipo nascono con le prime cellule economiche; la stessa organizzazione ecclesiastica ne è influenzata (gallicanismo, lotte tra Chiesa e Stato molto precoci). Questa massiccia costituzione intellettuale spiega la funzione intellettuale della Francia nella seconda metà del secolo XVIII e in tutto il secolo XIX, funzione internazionale e cosmopolita di irradiazione e di espansione a carattere imperialistico organico, quindi ben diversa da quella italiana, a carattere immigratorio personale e disgregato che non refluisce sulla base nazionale per potenziarla ma invece per renderla impossibile.
3) In Russia diversi spunti: l’organizzazione politica commerciale è creata dai Normanni (Varieghi), quella religiosa dai greci bizantini; in un secondo tempo i tedeschi e i francesi danno uno scheletro resistente alla gelatina storica russa. Le forze nazionali sono passive, ma forse per questa stessa passività assimilano le influenze straniere e anche gli stessi stranieri, russificandoli. Nel periodo storico più moderno avviene il fenomeno inverso: una élite di gente tra la più attiva, intraprendente e disciplinata emigra all’estero, assimila la cultura dei paesi più progrediti dell’occidente, senza perciò perdere i caratteri più essenziali della propria nazionalità, senza cioè rompere i legami sentimentali e storici del proprio popolo e fatto così il suo garzonato intellettuale, rientra nel paese, costringendo il popolo a un forzato risveglio. La differenza tra questa élite e quella tedesca (di Pietro il grande per esempio) consiste nel suo carattere essenziale nazionale‑popolare: essa non può essere assimilata dalla passività russa, perché essa stessa è una energica reazione russa alla propria passività storica. In un altro terreno e in ben diverse condizioni di tempo e di spazio, questo fenomeno russo può essere paragonato alla nascita della nazione americana (Stati Uniti): gli immigrati anglosassoni in America sono anch’essi un’élite intellettuale, ma specialmente morale. Si vuol parlare naturalmente dei primi immigrati, dei pionieri, protagonisti delle lotte religiose inglesi, sconfitti, ma non umiliati né depressi. Essi importano in America, con se stessi, oltre l’energia morale e volitiva, un certo grado di civiltà, una certa fase dell’evoluzione storica europea, che trapiantata nel suolo vergine americano e avendo tali agenti, continua a sviluppare le forze implicite nella sua natura, ma con un ritmo incomparabilmente più rapido che nella vecchia Europa, dove esistono tutta una serie di freni (morali e intellettuali, incorporati in determinati gruppi della popolazione) che si oppongono a un altrettanto rapido processo ed equilibrano nella mediocrità ogni iniziativa, diluendola nel tempo e nello spazio.
4) In Inghilterra lo sviluppo è molto diverso che in Francia. Il nuovo raggruppamento sociale, nato sulla base dell’industrialismo moderno, ha un sorprendente sviluppo economico‑corporativo, ma procede a tastoni nel campo intellettuale‑politico. Molto numerosi sono gli intellettuali organici, nati cioè nello stesso terreno industriale col raggruppamento economico, ma nella fase più elevata di sviluppo troviamo conservata la posizione di quasi monopolio della vecchia classe terriera, che perde la sua supremazia economica, ma conserva a lungo la sua supremazia politico‑intellettuale e viene assimilata come strato dirigente del nuovo raggruppamento al potere. Cioè: la vecchia aristocrazia terriera si unisce agli industriali con un tipo di sutura simile a quello con cui alla classe dominante si uniscono gli «intellettuali tradizionali» in altri paesi.
5) Il fenomeno inglese si presenta anche in Germania aggravato per la complicazione di altri fenomeni. Anche la Germania, come l’Italia, è stata la sede di una istituzione e di una ideologia universalistica, supernazionale (Sacro Romano Impero della Nazione tedesca) ed ha dato una certa quantità di personale alla cosmopoli medioevale, depauperando le proprie energie nazionali, che hanno mantenuto a lungo la disgregazione territoriale del Medio Evo. Lo sviluppo industriale è avvenuto sotto un involucro semifeudale durato fino al novembre 1918 e i latifondisti Junker alleati alla piccola borghesia hanno mantenuto una supremazia politico‑intellettuale ben maggiore di quella dello stesso gruppo inglese. Essi sono stati gli intellettuali tradizionali degli industriali tedeschi, ma con speciali privilegi e con una forte coscienza di raggruppamento indipendente data dal fatto che detenevano un notevole potere economico sulla terra «produttiva» più che in Inghilterra. Gli Junker prussiani rassomigliano a una casta sacerdotale, che svolge un’attività essenzialmente intellettuale, ma nello stesso tempo ha una base economica propria e non dipende dalla liberalità del gruppo dominante. Del resto è facile pensare che la diversa situazione della nobiltà inglese e di quella prussiana si sarebbero equiparate con l’andar del tempo, nonostante il fatto che in Germania la potenza militare territoriale e non solo marittima come in Inghilterra desse agli Junker una base organizzativa favorevole alla conservazione del loro monopolio politico.
Fuori d’Europa sarebbero da esaminare e studiare altre manifestazioni originali dello sviluppo delle categorie intellettuali. Negli Stati Uniti è da notare l’assenza degli intellettuali tradizionali e quindi il diverso equilibrio degli intellettuali in generale; formazione massiccia sulla base industriale di tutte le superstrutture moderne. La necessità di un equilibrio non è data dal fatto che occorra fondere gli intellettuali organici con quelli tradizionali che come categoria non esistono, ma dal fatto che occorre fondere in un unico crogiolo nazionale tipi di culture diverse portati dagli immigrati di varie origini nazionali. La mancanza degli intellettuali tradizionali spiega in parte da una parte il fatto dell’esistenza di due soli partiti, che si potrebbero poi ridurre facilmente a uno solo (cfr con la Francia non solo del dopoguerra, quando la moltiplicazione dei partiti è diventata fenomeno generale) e invece all’opposto la moltiplicazione illimitata delle Chiese (mi pare che sono catalogate 213 sette protestanti; confronta con la Francia e con le lotte accanite sostenute per mantenere l’unità religiosa e morale del popolo francese). Sugli intellettuali americani si trovano varie sparse nei vari quaderni.
Una manifestazione interessante è ancora da studiare in America ed è la formazione di un sorprendente numero di intellettuali negri che assorbono la cultura e la tecnica americana. Si può pensare all’influsso indiretto che questi intellettuali negri americani possono esercitare sulle masse arretrate dell’Africa e a quello diretto se si verificasse una di queste ipotesi: 1) che l’espansionismo americano si serva come di suoi agenti dei negri d’America per conquistare i mercati africani (qualcosa di questo genere è già avvenuto, ma ignoro in qual misura); 2) che le lotte di razza in America si inaspriscano in tal misura da determinare l’esodo e il ritorno in Africa degli elementi negri intellettuali più spiritualmente indipendenti e attivi e quindi meno facili ad assoggettarsi a una possibile legislazione ancora più umiliante del costume attualmente diffuso. Si pone la quistione: 1) della lingua, poiché i negri d’America sono inglesi di lingua e d’altronde in Africa c’è un pulviscolo di dialetti; 2) se il sentimento nazionale può sostituire quello di razza, innalzando il continente africano alla funzione di patria comune di tutti i negri (sarebbe il primo caso di un continente intero considerato unica nazione). I negri d’America mi pare debbano avere uno spirito di razza e nazionale più negativo che positivo, creato cioè dalla lotta che i bianchi fanno per isolarli e deprimerli; ma non fu questo il caso degli ebrei fino a tutto il 700? La Liberia già americanizzata e con lingua ufficiale inglese potrebbe diventare la Sion dei negri americani, con la tendenza a diventare tutta l’Africa, a essere il Piemonte dell’Africa.
Nell’America meridionale e centrale mi pare che la quistione degli intellettuali sia da esaminare tenendo conto di queste condizioni fondamentali: anche nell’America meridionale e centrale non esiste la categoria degli intellettuali tradizionali, ma la cosa non si presenta negli stessi termini che negli Stati Uniti. Infatti troviamo alla base dello sviluppo di questi paesi la civiltà spagnola e portoghese del 500 e del 600 caratterizzata dalla Controriforma e dal militarismo. Le cristallizzazioni più resistenti ancora oggi in questa parte dell’America sono il clero e l’esercito anche oggi, due categorie intellettuali che in parte continuano la tradizione delle madri patrie europee. Inoltre la base industriale è molto ristretta e non ha sviluppato superstrutture complicate: la maggior quantità di intellettuali è di tipo rurale e poiché domina il latifondo, con estese proprietà ecclesiastiche, questi intellettuali sono legati al clero e ai grandi proprietari. Il problema si complica per le masse voli di pellirosse che in alcuni paesi sono la maggioranza della popolazione. Si può dire in generale che nell’America meridionale e centrale esiste ancora una situazione da Kulturkampf e da processo Dreyfus, cioè una situazione in cui l’elemento laico e civile non ha superato la fase della subordinazione alla politica laica del clero e della casta militare. Così avviene che in contrapposto all’influenza dei gesuiti abbia molta importanza la Massoneria e i tipi di organizzazione culturale come la «Chiesa positivista». Gli avvenimenti di questi ultimi tempi (scrivo nel novembre 1930), dal Kulturkampf messicano di Calles ai movimenti militari‑popolari in Argentina, nel Brasile, nel Perù, in Bolivia dimostrano appunto la verità di queste affermazioni. Sugli intellettuali dell’America meridionale ci sono sparse nei vari quaderni.
Un altro tipo di manifestazione dello sviluppo degli intellettuali si può trovare in India, in Cina e nel Giappone. Non che sia da confondere l’India e la Cina col Giappone. Il Giappone si avvicina al tipo di sviluppo inglese e tedesco, cioè di una civiltà industriale che si sviluppa entro l’involucro semifeudale, ma, a quanto mi pare, più al tipo inglese che a quello tedesco. In Cina c’è il problema della scrittura, espressione della completa separazione degli intellettuali dal popolo. In India e in Cina si presenta il fenomeno della enorme distanza tra la religione del popolo e quella del clero e degli intellettuali, anch’essa legata al distacco tra intellettuali e popolo. Questo fatto delle diverse credenze e del modo diverso di concepire e praticare la stessa religione tra i diversi strati della società ma specialmente tra clero e popolo dei fedeli dovrebbe essere studiato in generale, sebbene nei paesi dell’Asia abbia le manifestazioni più estreme. Credo che nei paesi protestanti la differenza sia relativamente piccola. È molto notevole nei paesi cattolici, ma presenta gradi diversi: meno grande nella Germania cattolica e in Francia, più grande in Italia, specialmente meridionale e insulare, grandissima nella penisola iberica e nei paesi dell’America latina. Il fenomeno aumenta di portata nei paesi ortodossi ove bisogna parlare di tre gradi della stessa religione: quella dell’alto clero e dei monaci, quella del clero secolare e quella del popolo; e diventa catastrofico nell’Asia orientale (non nel Giappone) in cui la religione del popolo non ha nulla a che vedere spesso con quella dei libri, sebbene alle due si dia lo stesso nome.
Altri numerosi aspetti ha il problema degli intellettuali, oltre quelli accennati nelle pagine precedenti. Occorrerà farne un prospetto organico, sistemato e ragionato. Attività di carattere prevalentemente intellettuale; istituzioni legate all’attività culturale; metodi e problemi di metodo del lavoro intellettuale, creativo e divulgativo; riviste e giornali come organizzazioni di divulgazione intellettuale; accademie e circoli vari come istituzioni di elaborazione collegiale della vita culturale. Su molti di questi motivi ho scritto sparsamente delle nei vari quaderni sotto diverse rubriche, specialmente sotto quella di «Riviste tipo». Si può osservare in generale che nella civiltà moderna tutte le attività pratiche sono diventate così complesse e che le scienze si sono talmente intrecciate alla vita che ogni attività tende a creare una scuola per i propri specialisti e quindi a creare un gruppo di specialisti intellettuali che insegnino in queste scuole. Così accanto al tipo di scuola che si potrebbe chiamare «umanistica», perché rivolta a sviluppare in ogni individuo umano la cultura generale ancora indifferenziata, la potenza fondamentale di pensare e di sapersi dirigere nella vita, si sta creando tutto un sistema di scuole specializzate di vario grado, per intere branche professionali o per professioni già specializzate e indicate con precisa individuazione. Si può anzi dire che la crisi scolastica che oggi imperversa è appunto legata al fatto che questo processo di differenziazione avviene caoticamente, senza un piano bene studiato, senza principii chiari e precisi: la crisi del programma scolastico, cioè dell’indirizzo generale formativo, è in gran parte una complicazione della crisi più generale. La divisione fondamentale della scuola media in professionale e classica era uno schema razionale: la scuola professionale per le classi strumentali, la scuola classica per le classi dominanti e intellettuali. Ma lo sviluppo della base industriale sia urbana che agricola tendeva a dare incremento al nuovo tipo di intellettuale urbano e allora ci fu una scissione della scuola in classica e tecnica (professionale ma non manuale), ciò che mise in discussione il principio stesso dell’indirizzo di cultura generale, dell’indirizzo umanistico, della cultura generale basata sulla tradizione classica. Questo indirizzo una volta messo in discussione può dirsi spacciato, poiché la sua capacità formativa era in gran parte basata sul prestigio generale di una forma di civiltà. Oggi la tendenza è di abolire ogni tipo di scuola «disinteressata» (cioè non immediatamente interessata) e «formativa» o di lasciarne solo un esemplare ridotto per una piccola élite di ricchi e di signorine che non devono pensare a prepararsi un avvenire e di diffondere sempre più le scuole specializzate professionali in cui il destino dell’allievo e la sua futura attività sono predeterminati.
La crisi avrà certamente una soluzione che razionalmente dovrebbe avere questa linea: scuola unica iniziale di cultura generale, umanistica, con giusto contemperamento dello sviluppo della potenza di operare manualmente (tecnicamente, industrialmente) e della potenza di pensare, di operare intellettualmente. Da questo tipo di scuola unica, attraverso l’orientamento professionale, si passerà a una delle scuole specializzate professionali (in senso largo) ecc.
In ogni modo occorre tener presente il principio che ogni attività pratica tende a crearsi una scuola particolare, così come ogni attività intellettuale tende a crearsi un «circolo di cultura» proprio; avverrà che anche ogni organismo direttivo dovrà scindere la sua operosità in due direzioni fondamentali: quella deliberativa che è la sua essenziale, e quella culturale‑informativa in cui le quistioni su cui occorre discutere saranno prima discusse «accademicamente» per così dire. Il fatto avviene anche oggi, ma in maniera burocratica: ogni corpo deliberante ha i suoi uffici specializzati di periti che preparano il materiale delle discussioni e delle deliberazioni. È questo uno dei meccanismi attraverso cui la burocrazia finisce col dominare nei regimi democratici parlamentari. Mi pare appunto che si porrà la quistione di incorporare nei corpi deliberanti e direttivi stessi la capacità tecnica presupposta per la competenza.
A questo proposito vedere quanto ho scritto in una nota della rubrica «Riviste tipo»: in attesa che si formi un gruppo di intellettuali abbastanza preparati per essere in grado di produrre una regolare attività libraria (s’intende di libri organici e non di pubblicazioni d’occasione o di raccolte di articoli) e come mezzo per accelerare questa formazione, intorno alle riviste tipo dovrebbe costituirsi un circolo di cultura, che collegialmente criticasse ed elaborasse i lavori dei singoli, distribuiti secondo un piano e riguardanti quistioni di principio (programmatiche). I lavori, nella elaborazione definitiva, cioè dopo aver subito la critica e la revisione collegiale, dopo aver raggiunto una estrinsecazione su cui l’opinione collegiale sia fondamentalmente concorde, dovrebbero essere raccolti nell’Annuario a cui accennai nella nota. Attraverso la discussione e la critica collegiale (fatta di suggerimenti, di consigli, di indicazioni metodiche, critica costruttiva e rivolta alla educazione reciproca) si innalzerebbe il livello medio dei membri del circolo, fino a raggiungere l’altezza e la capacità del più preparato. Dopo i primi lavori sarebbe possibile all’ufficio di presidenza o di segreteria avere dei criteri e delle indicazioni sui lavori ulteriori da assegnare e sulla loro distribuzione organica, in modo da indurre i singoli a specializzarsi e a crearsi le condizioni di specializzazione: schedari, spogli bibliografici, raccolte delle opere fondamentali specializzate, ecc. Il metodo di lavoro dovrebbe essere molto severo e rigoroso: nessuna improvvisazione e declamazione. I lavori, scritti e distribuiti preventivamente a tutti i soci del circolo, dovrebbero essere criticati per iscritto, in stringate, che elencassero le manchevolezze, i suggerimenti, i punti necessari di chiarimento, ecc. Si potrebbe introdurre un principio fecondo di lavoro: ogni membro del circolo incaricato di un certo lavoro potrebbe scegliere tra gli altri un consigliere guida che lo indirizzi e lo aiuti con arte «maieutica», cioè che non si sostituisca a lui ma solo lo aiuti a lavorare e a sviluppare in sé una disciplina di lavoro, un metodo di produzione, che lo «taylorizzi» intellettualmente, per così dire.
Q4 §50 La scuola unitaria. Un punto importante nello studio dell’organizzazione pratica della scuola unitaria è la fissazione della carriera scolastica nei suoi vari gradi secondo l’età e la maturità intellettuale‑morale dei giovani e secondo i fini che la scuola vuol raggiungere.
La scuola unitaria o di cultura generale «umanistica» (intesa in senso largo e non solo nel senso tradizionale) dovrebbe proporsi di immettere nella vita attiva i giovani con una certa autonomia intellettuale, cioè con un certo grado di capacità alla creazione intellettuale e pratica, di orientamento indipendente. La fissazione dell’età scolastica obbligatoria varia col variare delle condizioni economiche generali da cui dipendono due conseguenze secondo il nostro punto di vista della scuola unitaria: 1) la necessità di far lavorare i giovani per averne subito un certo apporto produttivo immediato; 2) la disponibilità finanziaria statale da dedicare all’educazione pubblica che dovrebbe essere di una certa grandezza per l’estensione che la scuola assumerebbe come edifizi, come materiale didattico in senso largo, come corpo di insegnanti; il corpo degli insegnanti specialmente crescerebbe di molto, perché la efficienza della scuola è tanto maggiore e rapida quanto più è piccolo il rapporto tra allievi e maestri, ma ciò pone il problema della formazione di un tal corpo, non certo di facile e rapida soluzione. Anche la quistione degli edifizi non è semplice, perché questo tipo di scuola, proponendosi anche la rapidità, deve essere una scuola‑collegio, con dormitori, refettori, biblioteche specializzate, sale adatte per il lavoro di seminario ecc. Si può dire che inizialmente il nuovo tipo di scuola dovrà e non potrà non essere di élites di giovani scelti per concorso o indicati sotto la loro responsabilità dalle istituzioni private idonee.
Prendendo come tipo di riferimento la attuale scuola classica: 1) elementari, 2) ginnasio, 3) liceo, 4) università con le specializzazioni professionali, teoretiche o pratiche si può dire che la scuola unitaria comprenderebbe i primi tre gradi riorganizzati, non solo per il contenuto e il metodo dell’insegnamento, ma anche per la disposizione della carriera scolastica. Le elementari dovrebbero essere di tre-quattro anni e insegnare dogmaticamente (sempre in modo relativo) i primi elementi della nuova concezione del mondo, lottando contro la concezione del mondo data dall’ambiente tradizionale (folklore in tutta la sua estensione) oltre a dare, s’intende, gli strumenti primordiali della cultura: leggere, scrivere, far di conto, nozioni di geografia, storia, diritti e doveri (cioè prime nozioni sullo Stato e la società). Il ginnasio potrebbe essere ridotto a quattro anni e il liceo a due, in modo che un bambino che è entrato in iscuola a sei anni potrebbe a quindici‑sedici aver percorso tutta la scuola unitaria. A chi può obbiettare che un tale corso scolastico è troppo faticoso per la sua rapidità se si vogliono raggiungere gli stessi risultati dell’attuale organizzazione della scuola classica, si può rispondere che il complesso della nuova organizzazione contiene in sé gli elementi generali per cui già oggi per un certo numero di allievi l’attuale organizzazione è invece troppo lenta. Quali sono questi elementi? In una serie di famiglie specialmente delle classi intellettuali, i ragazzi trovano nella vita famigliare una continuazione e una integrazione della vita scolastica, apprendono come si dice «nell’aria» tutta una quantità di nozioni e di attitudini che facilitano la carriera scolastica propriamente detta; inoltre essi cominciano ad apprendere qualche anno prima dell’inizio delle elementari la lingua letteraria, cioè un mezzo di espressione e di pensiero superiore a quello della media della popolazione scolastica dai sei ai dieci anni. Così c’è una differenza tra gli allievi della città e quelli della campagna: per il solo fatto di vivere in città un bambino da uno a sei anni assorbe tutta una quantità di nozioni e di attitudini che rendono più facile, più proficua e più rapida la carriera scolastica.
Nell’organizzazione della scuola unitaria devono esistere almeno le principali di queste condizioni. Intanto è da supporre che durante il suo sviluppo si sviluppino parallelamente gli asili infantili, istituzioni in cui anche sotto i sei anni i bambini si abituano a una certa disciplina collettiva ed acquistano nozioni ed attitudini prescolastiche. Lo stesso avverrà successivamente, se la scuola porterà con sé la vita di collegio diurna e notturna, liberata dalle attuali forme di disciplina ipocrita e meccanica e con l’assistenza agli allievi non solo in classe, ma anche nelle ore di studio individuale, con la partecipazione a questa assistenza dei migliori allievi, ecc.
Il problema fondamentale si pone in quella fase dell’attuale
carriera scolastica che oggi è rappresentata dal liceo, e che
oggi non si differenzia per nulla, come tipo d’insegnamento,
dalle classi precedenti, altro che per la supposizione di una
maggiore maturità intellettuale e morale dell’allievo come un
portato della maggiore età e dell’esperienza accumulata
precedentemente. Di fatto però tra liceo e università c’è un
salto, una vera soluzione di continuità, non un passaggio
normale dalla quantità (età) alla qualità (maturità
intellettuale e morale). Dall’insegnamento quasi puramente
ricettivo si passa alla scuola creativa; dalla scuola con
disciplina dello studio imposta e controllata dal di fuori si
passa alla scuola in cui l’autodisciplina intellettuale e
l’autonomia morale è teoricamente illimitata. E ciò avviene
subito dopo la crisi della pubertà, quando la foga delle
passioni istintive ed elementari non ha ancora finito di lottare
coi freni del carattere e della coscienza morale. In Italia poi,
dove nelle Università non è diffuso il principio del
«seminario», il passaggio è ancora più brusco e meccanico. Ecco
dunque che nella scuola unitaria la fase del Liceo deve essere
concepita come la fase transitoria più importante in cui la
scuola tende a creare i valori fondamentali dell’«umanesimo»,
l’autodisciplina intellettuale e l’autonomia morale necessarie
per l’ulteriore specializzazione, sia che essa sia di carattere
intellettuale (studi universitari) sia che sia di carattere
immediatamente pratico‑produttivo (industria, organizzazione
degli scambi, burocrazia ecc.). Lo studio del metodo scientifico
deve cominciare nel Liceo e non essere più un monopolio
dell’Università: il Liceo deve essere già un elemento
fondamentale dello studio creativo e non solo ricettivo (io
faccio una differenza tra scuola creativa e
scuola attiva: tutta la scuola unitaria è scuola attiva, mentre
la scuola creativa è una fase, il coronamento della scuola
attiva. Naturalmente sia scuola attiva che scuola creativa
devono essere intese rettamente: la scuola attiva, dalla fase
romantica in cui gli elementi della lotta contro la scuola
meccanica e gesuitica si sono dilatati morbosamente per ragioni
di contrasto e di polemica, deve trovare e raggiungere la fase
classica, liberata dagli elementi spuri polemici e che trova in
se stessa e nei fini che vuol raggiungere la sua ragione di
essere e l’impulso a trovare le sue forme e i suoi metodi. Così
scuola creativa non significa scuola di «inventori e scopritori»
di fatti ed argomenti originali in senso assoluto, ma scuola in
cui la «recezione» avviene per uno sforzo spontaneo e autonomo
dell’allievo e in cui il maestro esercita specialmente una
funzione di controllo e di guida amichevole come avviene, o
dovrebbe avvenire oggi nelle Università. Scoprire da se stessi,
senza suggerimenti e impulsi esterni, una verità è «creazione»,
anche se la verità è vecchia: in ogni modo si entra nella fase
intellettuale in cui si possono scoprire verità nuove, poiché da
se stessi si è raggiunta la conoscenza, si è scoperta una
«verità» vecchia). Nel Liceo dunque l’attività scolastica
fondamentale si svolgerà nei seminari, nelle biblioteche, nei
gabinetti sperimentali, nei laboratori: in esso si
raccoglieranno gli elementi fondamentali per l’orientazione
professionale.
Un’innovazione essenziale sarà determinata dall’avvento della scuola unitaria nei rapporti oggi esistenti tra Università e Accademie. Oggi queste due istituzioni sono indipendenti l’una dall’altra e le Accademie (le grandi Accademie, naturalmente) hanno un posto gerarchicamente superiore a quello delle Università. Colla scuola unitaria, le Accademie dovranno diventare l’organizzazione intellettuale (di sistemazione e creazione intellettuale) di quegli elementi che dopo la scuola unitaria non faranno l’Università, ma si inizieranno subito a una professione. Questi elementi non dovranno cadere nella passività intellettuale, ma dovranno avere a disposizione un organismo, specializzato in tutte le branche industriali e intellettuali, al quale potranno collaborare e nel quale dovranno trovare tutti i mezzi necessari per il lavoro creativo che vogliono intraprendere. Il sistema accademico verrà riorganizzato e vivificato. Territorialmente esso avrà una gerarchia: un centro nazionale che si aggregherà le grandi accademie nazionali, delle sezioni provinciali e dei circoli locali urbani e rurali. Si dividerà poi per sezioni specializzate che saranno tutte rappresentate al centro e nelle province e solo parzialmente nei circoli locali. Il principio sarà quello degli Istituti di Cultura di un determinato raggruppamento sociale. Il lavoro accademico tradizionale, cioè la sistemazione del sapere esistente (tipo italiano attuale dell’Accademia) e la guida e stabilizzazione secondo una media (pensiero medio) delle attività intellettuali (tipo francese dell’Accademia) diventerà solo un aspetto della nuova organizzazione che dovrà avere un’attività creativa e di divulgazione con autorità collettiva. Essa controllerà le conferenze industriali, le conferenze e le attività di organizzazione scientifica del lavoro, i gabinetti sperimentali di fabbrica, ecc. e sarà il meccanismo selettivo per mettere in valore le capacità individuali della periferia. Ogni circolo locale di questa organizzazione dovrà avere la sezione di scienze morali e politiche, ma potrà crearsi, a domanda degli interessati, una sezione di scienze applicate, per discutere dal punto di vista della cultura, le quistioni industriali, agrarie, di organizzazione e razionalizzazione del lavoro di fabbrica, agricolo, burocratico. Congressi periodici, elettivi per i rappresentanti, metteranno in luce i più capaci presso i dirigenti dei gradi superiori, ecc. Nelle sezioni provinciali e al centro tutte le attività dovranno essere rappresentate, con laboratori, biblioteche, ecc. I contatti gerarchici saranno tenuti dai conferenzieri e da ispettori: le sezioni provinciali e il Centro (che potrebbe riprodurre l’attuale Collegio di Francia) dovrebbero periodicamente invitare, a fare relazioni accademiche, rappresentanti delle sezioni subordinate, fare dei concorsi, stabilire dei premi (borse di studio all’interno e all’estero). Sarebbe utile avere l’elenco completo delle Accademie attualmente esistenti e delle materie che sono prevalentemente trattate nei loro Atti: in gran parte si tratta di cimiteri della cultura.
La collaborazione tra questa organizzazione e le Università dovrebbe essere stretta, così come con le scuole superiori specializzate di altri rami (militare, navale, ecc.). Si avrebbe, con questa organizzazione, una centralizzazione e un impulso della cultura inaudito su tutta l’area nazionale. Inizialmente si potrebbero avere il Centro nazionale e i circoli locali con poche sezioni.
Lo schema esposto indica solo una linea programmatica di principio, che potrebbe essere percorsa gradualmente. Quindi sarebbe necessario integrare lo schema con le misure transitorie indispensabili: in ogni modo anche queste misure transitorie dovrebbero essere concepite nello spirito generale di questa linea, in modo che le istituzioni transitorie possano mano a mano essere assorbite nello schema fondamentale senza soluzione di continuità e crisi.
Q4 §51 Braccio e cervello. La distinzione delle categorie intellettuali dalle altre si riferisce alla funzione sociale, all’attività professionale, cioè tiene conto del peso massimo che grava nella attività professionale più sullo sforzo cerebrale che su quello muscolare (nervoso). Ma già questo rapporto non è sempre uguale, quindi diversi gradi di attività intellettuale. Bisogna poi riconoscere che in ogni professione non si può mai escludere una certa attività intellettuale e infine che ogni uomo, all’infuori della sua professione, esplica una qualche attività intellettuale, è un filosofo, partecipa di una concezione del mondo e quindi contribuisce a mantenerla, a modificarla, cioè a creare delle nuove concezioni. Si tratta dunque di elaborare questa attività che ha sempre un certo grado di sviluppo, modificando il suo rapporto con lo sforzo muscolare in un nuovo equilibrio.
Q4 §52 Americanismo e fordismo. La tendenza di Leone Davidovi era legata a questo problema. Il suo contenuto essenziale era dato dalla «volontà» di dare la supremazia all’industria e ai metodi industriali, di accelerare con mezzi coercitivi la disciplina e l’ordine nella produzione, di adeguare i costumi alle necessità del lavoro. Sarebbe sboccata necessariamente in una forma di bonapartismo, perciò fu necessario spezzarla inesorabilmente. Le sue soluzione pratiche erano errate, ma le sue preoccupazioni erano giuste. In questo squilibrio tra pratica e teoria era insito il pericolo. Ciò si era manifestato già precedentemente, nel 1921. Il principio della coercizione nel mondo del lavoro era giusto (discorso riportato nel volume sul Terrorismo e pronunziato contro Martov), ma la forma che aveva assunto era errata: il «modello» militare era diventato un pregiudizio funesto, gli eserciti del lavoro fallirono.
Interesse di Leone Davidovi per l’americanismo. Suo interesse, suoi articoli, sue inchieste sul «byt» e sulla letteratura: queste attività erano meno sconnesse tra loro di quanto allora potesse sembrare. Il nuovo metodo di lavoro e il modo di vivere sono indissolubili: non si possono ottenere successi in un campo senza ottenere risultati tangibili nell’altro. In America la razionalizzazione e il proibizionismo sono indubbiamente connessi: le inchieste degli industriali sulla vita privata degli operai, il servizio di ispezione creato da alcuni industriali per controllare la «moralità» degli operai sono necessità del nuovo metodo di lavoro. Chi irridesse a queste iniziative e vedesse in esse solo una manifestazione ipocrita di «puritanismo», si negherebbe ogni possibilità di capire l’importanza, il significato e la portata obbiettiva del fenomeno americano, che è anche il maggiore sforzo collettivo finora esistitoper creare con una rapidità inaudita e con una coscienza del fine mai vista nella storia, un tipo nuovo di lavoratore e d’uomo.
La espressione «coscienza del fine» può sembrare per lo meno esagerata alle anime bennate che ricordano la frase del Taylor sul «gorilla ammaestrato». Il Taylor esprime con cinismo e senza sottintesi il fine della società americana: sviluppare nell’uomo lavoratore al massimo la parte macchinale, spezzare il vecchio nesso psico‑fisico del lavoro professionale qualificato che domandava una certa partecipazione dell’intelligenza, dell’iniziativa, della fantasia del lavoratore, per ridurre le operazioni di produzione al solo aspetto fisico. Ma in realtà non si tratta di una cosa nuova. Si tratta della fase più recente di un processo che si è iniziato col nascere dello stesso industrialismo: questa fase più recente è più intensa delle precedenti e si manifesta in una forma più brutale, ma anche essa verrà superata e un nuovo nesso psico‑fisico si andrà creando, di un tipo diverso di quelli precedenti e indubbiamente di un tipo superiore. Ci sarà indubbiamente una selezione forzata e una parte della vecchia classe lavoratrice verrà implacabilmente eliminata dal mondo della produzione e dal mondo tout court.
Da questo punto di vista occorre vedere le iniziative «puritane» degli industriali americani tipo Ford. È evidente che essi non si preoccupano dell’«umanità», della «spiritualità» del lavoratore che viene schiantata. Questa umanità, questa spiritualità si realizzava nel mondo del lavoro, nella «creazione» produttiva: essa era massima nell’artigianato, in cui l’individualità del lavoratore si rifletteva tutta nell’oggetto creato, in cui si manteneva ancora molto forte il legame tra arte e lavoro. Ma appunto contro questa forma di umanità e di spiritualità lotta il nuovo industrialismo. Le iniziative «puritane» hanno solo questo fine: conservare un equilibrio psico‑fisico fuori del lavoro, per impedire che il nuovo metodo porti al collasso fisiologico del lavoratore. Questo equilibrio è puramente esterno, per ora non è interiore. L’equilibrio interiore non può essere creato che dallo stesso lavoratore e dalla sua particolare società, con mezzi propri e originali. L’industriale si preoccupa della continuità dell’efficienza fisica del lavoratore, dell’efficienza muscolare‑nervosa: è suo interesse costituire una maestranza stabile, un complesso industriale affiatato permanentemente, perché anche il complesso umano è una macchina che non deve essere troppo spesso smontata e rinnovata nei suoi ingranaggi singoli senza gravi perdite. L’alto salario è un elemento di questa necessità: ma l’alto salario è un’arma a due tagli. Occorre che il lavoratore spenda «razionalmente» per rinnovare, mantenere e possibilmente accrescere la sua efficienza muscolare nervosa, non per distruggerla o intaccarla. Ecco la lotta contro l’alcoolismo, l’agente più pericoloso delle forze di lavoro, che diventa funzione di Stato.
È possibile che anche altre lotte «puritane» divengano funzione di Stato, se l’iniziativa privata degli industriali si dimostra insufficiente e si manifesta una crisi di moralità troppo estesa nelle masse lavoratrici, ciò che potrebbe avvenire in conseguenza di crisi troppo vaste e prolungate di disoccupazione.
Una quistione che si può porre è la quistione sessuale, perché l’abuso e la irregolarità delle funzioni sessuali è, dopo l’alcoolismo, il nemico più pericoloso delle energie nervose: d’altronde è osservazione comune e banale che il lavoro «ossessionante» provoca depravazione alcoolica e sessuale. Le iniziative, specialmente di Ford, danno un indizio di queste tendenze ancora private e latenti ma che possono diventare ideologia statale, naturalmente innestandosi nel puritanesimo tradizionale, cioè presentandosi come un rinascimento della moralità dei pionieri, del «vero» americanismo cioè. Il fatto più notevole del fenomeno americano in rapporto a queste manifestazioni è il distacco che si andrà facendo sempre più accentuato tra la moralità‑costume dei lavoratori e quella di altri strati della popolazione. Il proibizionismo dà già un esempio di questo distacco. Chi consuma l’alcool introdotto di contrabbando negli S. U.? L’alcool è diventato una merce di lusso e neanche gli alti salari possono permetterne il consumo ai larghi strati delle masse lavoratrici. Chi lavora a salario, per un orario fisso, non ha il tempo da dedicare alla ricerca dell’alcool, non ha il tempo per esercitare lo sport di eludere le leggi. La stessa osservazione si può fare per riguardo alla sessualità. La «caccia alle donne» domanda troppi «loisirs»; nell’operaio di tipo nuovo avverrà ciò che è avvenuto nei villaggi contadini. La relativa fissità dei matrimoni contadini è strettamente legata al metodo di lavoro delle campagne. Il contadino che torna la sera a casa dopo una lunga giornata affaticante, vuole la Venerem facilem parabilemque di Orazio: egli non ha l’attitudine a fare le fusa intorno alle donne di fortuna; ama la sua donna, sicura, immancabile, che non fa smancerie e non vuole le apparenze della seduzione e dello stupro per essere posseduta. La funzione sessuale viene «meccanizzata», cioè c’è un nuovo modo di rapporto sessuale senza i colori abbaglianti dell’orpello romantico del piccolo borghese e del bohémien sfaccendato.
Il nuovo industrialismo vuole la monogamia, vuole che l’uomo lavoratore non sperperi le sue energie nervose nella ricerca affannosa e disordinata del soddisfacimento sessuale: l’operaio che va al lavoro dopo una notte di stravizio non è un buon lavoratore, l’esaltazione passionale non va d’accordo col movimento cronometrato delle macchine e dei gesti umani produttivi. Questa pressione brutale sulla massa otterrà indubbiamente dei risultati e sorgerà una nuova forma di unione sessuale in cui la monogamia e la stabilità relative saranno un tratto caratteristico e fondamentale.
Sarebbe interessante conoscere le risultanze statistiche dei fenomeni di deviazione dai costumi sessuali negli Stati Uniti analizzati per gruppi sociali: in generale si verificherà che i divorzi sono numerosi specialmente nelle classi alte.
Questo distacco di moralità tra la classe lavoratrice ed elementi sempre più numerosi delle classi dirigenti negli Stati Uniti mi pare il fenomeno più interessante e ricco di conseguenze. Fino a poco tempo fa, il popolo americano era un popolo di lavoratori: l’attività pratica non era solo inerente alle classi operaie, era anche una qualità delle classi dirigenti. Il fatto che un miliardario continui a lavorare indefessamente anche sedici ore al giorno, fino a quando la malattia o la vecchiaia non lo costringono al letto, ecco il fenomeno tipico americano, ecco l’americanata più strabiliante per l’europeo medio. Ho notato in una precedente osservazione che questa differenza è data dalla mancanza di «tradizioni» negli S. U., in quanto tradizione significa anche residuo passivo di tutte le forme sociali tramontate nella storia. Sono questi residui passivi che resistono all’americanismo, perché il nuovo industrialismo li spazzerebbe via spietatamente. È vero, il vecchio non ancora seppellito verrebbe definitivamente distrutto; ma cosa avviene nella stessa America? Il distacco di moralità mostra che si stanno creando margini di passività sociale sempre più ampi. Le donne mi pare abbiano una funzione prevalente in questo fenomeno. L’uomo‑industriale continua a lavorare anche se miliardario, ma sua moglie diventa sempre più un mammifero di lusso, le sue figlie continuano la tradizione materna. I concorsi di bellezza, il cinematografo, il teatro ecc. selezionano la bellezza femminile mondiale e la pongono all’asta. Le donne viaggiano, attraversano continuamente l’oceano. Sfuggono al proibizionismo patrio e contraggono matrimoni stagionali (ricordare che fu tolta ai capitani marittimi la facoltà di sanzionare matrimoni a bordo, perché molte ragazze si sposavano per la traversata): è una prostituzione appena larvata dalle formalità giuridiche.
Questi fenomeni delle classi alte renderanno più difficile la coercizione sulle masse lavoratrici per conformarle ai bisogni della nuova industria: in ogni modo determineranno una frattura psicologica e l’esistenza di due classi ormai cristallizzate apparirà evidente.
A proposito del distacco tra il lavoro manuale e il «contenuto umano» del lavoratore, si potrebbero fare delle osservazioni utili proprio in quelle professioni che sono credute tra le più intellettuali: le professioni legate alla riproduzione degli scritti per la pubblicazione o per altra forma di diffusione e trasmissione. Gli amanuensi di prima dell’invenzione della stampa, i compositori a mano, i linotypisti, gli stenografi, i dattilografi. Questi mestieri in realtà sono ancor più meccanizzati di tanti altri. Perché? Perché è più difficile raggiungere quel grado professionale massimo in cui l’operaio deve dimenticare il contenuto di ciò che riproduce per rivolgere la sua attenzione solo alla forma calligrafica delle singole lettere se amanuense, per scomporre le parole in lettere‑caratteri e rapidamente prendere i pezzi di piombo nelle caselle, per scomporre non più solo le parole ma gruppi di parole meccanicamente aggruppate o parti di parole meccanicamente analizzate in segni stenografici, per ottenere la rapidità del dattilografo. L’interesse del lavoratore per il contenuto dello scritto si misura dai suoi errori, cioè dalle sue deficienze professionali; la sua qualifica è proprio commisurata al suo disinteresse psicologico, alla sua meccanizzazione. Il copista medioevale muta l’ortografia, la morfologia, la sintassi del libro che riproduce, tralascia ciò che non capisce, il corso dei suoi pensieri gli fa inavvertitamente aggiungere parole, talvolta intere frasi; se il suo dialetto o la sua lingua sono diversi da quelli del testo egli dà una sfumatura alloglottica al testo, ecc.: egli è un cattivo copista. La lentezza domandata dall’arte scrittoria medioevale spiega molte di queste deficienze. Il tipografo è già molto più rapido, deve tenere in continuo movimento le mani; ciò rende più facile la sua meccanizzazione. Ma a pensarci bene, lo sforzo che questi lavoratori devono fare per staccare dal contenuto talvolta molto interessante (allora infatti si lavora meno e peggio) la sua simbolizzazione materiale, e applicarsi solo a questa è lo sforzo forse più grande fra tutti i mestieri. Tuttavia esso è fatto e non ammazza spiritualmente l’uomo. Quando il processo di adattamento è avvenuto, in realtà si verifica che il cervello dell’operaio, invece di mummificarsi, ha raggiunto uno stato di completa libertà. Il gesto fisico è diventato completamente meccanico, la memoria del mestiere, ridotto a gesti semplici ripetuti con ritmo intenso, si è «annidata» nei fasci muscolari e nervosi e ha lasciato il cervello libero per altre occupazioni. Come si cammina senza bisogno di riflettere a tutti i movimenti necessari per muovere le gambe e tutto il corpo in quel determinato modo che è necessario per camminare, così in molti mestieri è avvenuto per i gesti professionali fondamentali. Si cammina e si pensa a tutto ciò che si vuole.
Gli industriali americani hanno ben capito questo. Essi intuiscono che il «gorilla ammaestrato» rimane pur sempre uomo e pensa di più o per lo meno ha molta maggior possibilità di pensare, almeno quando ha superato la crisi di adattamento. Non solo pensa, ma l’assenza di soddisfazione immediata dal lavoro, l’essere stato come lavoratore ridotto a gorilla ammaestrato, lo può portare a un corso di pensieri poco conformista. Che una tale preoccupazione esista appare da tutta una serie di fatti e di iniziative educative.
D’altronde è ovvio pensare che i così detti alti salari sono una forma transitoria di retribuzione. L’adattamento ai nuovi metodi di lavoro non può avvenire solo per coercizione: l’apparato di coercizione necessario per ottenere un tale risultato costerebbe certo di più degli alti salari. La coercizione è combinata con la convinzione, nelle forme proprie della società data: il denaro. Ma se il metodo nuovo si affermerà creando un tipo nuovo di operaio, se l’apparecchio meccanico materiale sarà ancora perfezionato, se il turnover esagerato sarà automaticamente limitato dalla disoccupazione estesa, anche i salari diminuiranno. L’industria americana sfrutta ancora profitti di monopolio perché ha avuto l’iniziativa dei nuovi metodi e può dare più alti salari; ma il monopolio sarà necessariamente limitato nel tempo e la concorrenza estera sullo stesso piano farà sparire con i profitti i salari. D’altronde è noto che gli alti salari sono appunto solo legati a una aristocrazia operaia, non sono di tutti i lavoratori americani.
Q4 §53 Concordati e trattati internazionali. La capitolazione
dello Stato moderno che si verifica per i concordati viene
mascherata identificando verbalmente concordati e trattati
internazionali. Ma un concordato non è un comune trattato
internazionale: nel concordato si realizza di fatto
un’interferenza di sovranità in un solo territorio statale;
tutti gli articoli di un concordato si riferiscono ai cittadini
di un solo Stato, sui quali il potere sovrano di uno Stato
estero giustifica e rivendica determinati diritti e poteri di
giurisdizione. Che poteri ha acquistato la Prussia sulla città
del Vaticano in virtù del concordato recente? E ancora: la
fondazione dello Stato della città del Vaticano dà un’apparenza
di legittimità alla finzione giuridica che il concordato sia un
trattato bilaterale. Ma si stipulavano concordati anche prima
che la città del Vaticano esistesse, ciò che significa che il
territorio non è essenziale per l’autorità pontificia.
Un’apparenza, perché mentre il concordato limita l’autorità
statale di una parte contraente nel suo territorio e influisce e
determina la sua legislazione e la sua amministrazione, nessuna
limitazione è neppure accennata per il territorio dell’altra
parte. Il concordato è dunque il riconoscimento di una doppia
sovranità, su uno stesso territorio statale. Non è certo più la
stessa forma di sovranità supernazionale che era formalmente
riconosciuta al papa nel Medio Evo, ma ne è una derivazione di
compromesso. D’altronde anche nei periodi più splendidi del
papato e del suo potere supernazionale, le cose non andavano
così liscie: la supremazia papale, anche se riconosciuta
giuridicamente, era contrastata aspramente di fatto e
nell’ipotesi migliore si riduceva nei privilegi politici,
economici, fiscali dell’episcopato dei singoli paesi. In ogni
modo il concordato intacca essenzialmente il carattere di
autonomia della sovranità dello Stato moderno. Lo Stato ottiene
una contropartita? Certamente, ma la ottiene nel suo territorio,
per ciò che riguarda i suoi stessi cittadini. Lo Stato ottiene:
che la Chiesa non intralci l’esercizio del potere statale ma
anzi lo favorisca e lo sostenga. La Chiesa promette allo Stato
di fargli ottenere quel consenso di una parte dei governati che
lo Stato riconosce implicitamente di non poter ottenere con
mezzi propri: ecco la capitolazione dello Stato, ecco che esso
si mette sotto tutela di una sovranità che riconosce superiore.
La parola concordato è sintomatica… Gli articoli pubblicati nei
«Nuovi Studi» sul concordato sono tra i più interessanti e si
prestano più facilmente alla confutazione. Ricordare il
«trattato» subito dalla Georgia nel 1920 dopo la sconfitta di
Denikin.
Ma anche nel mondo moderno, che cosa significa praticamente la situazione creata in uno Stato dalle stipulazioni concordatarie? Significa riconoscimento pubblico ad una casta di cittadini dello stesso Stato di determinati privilegi politici. La forma non è più quella medioevale, ma la sostanza è la stessa. Nello sviluppo della storia moderna, quella casta aveva visto attaccato e distrutto il monopolio di funzione sociale che spiegava e giustificava la sua esistenza, il monopolio della cultura e dell’educazione. Il concordato riconosce nuovamente questo monopolio, sia pure attenuato e controllato poiché assicura alla casta delle posizioni di partenza che con le sue sole forze, con l’intrinseca adesione alla sua concezione del mondo alla realtà effettuale, non potrebbe mantenere.
Si capisce dunque la lotta sorda e sordida degli intellettuali laici e laicisti contro gli intellettuali di casta per salvare la loro autonomia e la loro funzione. Ma è innegabile la loro intrinseca capitolazione e il loro distacco dallo Stato. Il carattere intellettuale o morale dello Stato concreto, di un determinato Stato, è determinato dalla sua legislazione e non dalle polemiche astratte dei franchi tiratori della cultura. Se questi affermano: siamo noi lo Stato, essi affermano solo che il così detto Stato unitario non è più tale, che in esso esiste una scissione molto grave, tanto più grave in quanto è affermata dagli stessi legislatori e governanti che affermano essere lo Stato nello stesso tempo due cose: quello delle leggi scritte e applicate e quello delle coscienze che quelle leggi intimamente non riconoscono come efficienti e cercano sordidamente di limitare e svuotare di contenuto etico nell’applicazione. È un machiavellismo da bassi politicanti: i filosofi dell’idealismo attuale, specialmente nella sezione pappagalli ammaestrati dei «Nuovi Studi» si possono dire le più illustri vittime di Machiavelli.
Un aspetto curioso e interessante della quistione è la divisione del lavoro che si va stabilendo tra la casta degli intellettuali laici: alla prima viene lasciata la formazione intellettuale e morale dei giovanissimi (scuole elementari e medie), agli altri lo sviluppo ulteriore del giovane nell’Università. Ma il campo universitario non è sottoposto allo stesso regime di monopolio cui invece sottostà la scuola elementare e media. Esiste infatti l’Università del Sacro Cuore e potranno essere organizzate altre Università cattoliche equiparate alle Università statali. Le conseguenze sono ovvie: la scuola elementare e media è la scuola popolare e della piccola borghesia, strati sociali che sono interamente monopolizzati educativamente dalla casta, poiché la grande maggioranza dei loro elementi non arrivano all’Università, cioè non conosceranno l’educazione moderna nella sua fase superiore critico-storica: essi educativamente conosceranno solo l’educazione dogmatica. L’Università è la scuola della classe dirigente in proprio ed è il meccanismo attraverso il quale essa selezione gli elementi individuali delle altre classi da incorporare nel suo personale governativo, amministrativo e dirigente. Ma con l’esistenza, a parità di condizioni, delle Università cattoliche, anche la formazione di questo personale dirigente non sarà più unitaria e omogenea. Non solo: ma la casta, nelle Università proprie, realizzerà una concentrazione di cultura laico-religiosa quale da molti decenni non si vedeva più e si troverà di fatto in condizioni molto migliori della concentrazione laica. Non è infatti nemmeno lontanamente paragonabile l’efficienza organizzativa della Chiesa, che sta tutta come un blocco dietro e a sostegno della propria Università, con l’efficienza organizzativa della cultura laica. Se lo Stato, di fatto, non è più questa organizzazione, perché la sua legislazione in materia di religione è quello che è, e la sua equivocità non può non essere favorevole alla Chiesa, data la sua formidabile struttura e il suo peso di massa organizzata omogeneamente, e se i titoli dei due tipi di Università sono equiparati, è evidente che si formerà la tendenza delle Università cattoliche ad essere esse il meccanismo di selezione degli elementi più intelligenti e capaci delle classi inferiori da immettere nella classe dirigente. Favoriranno questa tendenza: il fatto che non c’è discontinuità educativa tra le scuole medie e l’Università cattolica, mentre questa discontinuità c’è con le Università statali e il fatto che la Chiesa in tutta la sua struttura è già attrezzata per questo lavoro di selezione dal basso. La Chiesa, da questo punto di vista, è un organismo perfettamente democratico: il figlio di un contadino o di un artigiano, se intelligente e capace, e se duttile abbastanza per lasciarsi assimilare dalla struttura ecclesiastica e per sentirne il particolare spirito di corpo e di conservazione egli interessi presenti e futuri, può diventare cardinale e papa. Se nell’alta gerarchia ecclesiastica l’origine democratica è meno frequente di quanto si creda, ciò avviene per ragioni complesse, in cui solo parzialmente incide la pressione delle grandi famiglie aristocratiche cattoliche o la ragione di Stato (internazionale): una ragione molto forte è che molti seminari sono molto male attrezzati e non mettono in valore dei giovani intelligenti, mentre il giovane aristocratico, dal suo stesso ambiente famigliare riceve senza sforzo di apprendimento una serie di qualità che sono di primo ordine per la carriera ecclesiastica: la tranquilla sicurezza della propria dignità e autorità e l’arte di trattare e governare gli altri.
Una ragione di debolezza del clero nel passato consisteva nel fatto che la religione dava scarse possibilità di carriera all’infuori della carriera ecclesiastica: il clero stesso era indebolito qualitativamente dalle «scarse» vocazioni o dalle «vocazioni» di soli elementi subalterni intellettualmente. Questa crisi era già visibile prima della guerra: era un aspetto della crisi generale delle carriere a reddito fisso con organici lenti e pesanti, cioè dello strato intellettuale subalterno (maestri, insegnanti medi, preti ecc.) sottoposto alla concorrenza delle professioni liberali legate allo sviluppo dell’industria e dell’organizzazione privata capitalistica in generale (il giornalismo, per es., che assorbe molti insegnanti, ecc.). Già era incominciata l’invasione da parte delle donne delle scuole magistrali e delle Università. Con le donne entrano nell’Università i preti, ai quali la Curia non può proibire di procurarsi un titolo pubblico che permetta di concorrere a un impiego di Stato che aumenti la «finanza» individuale. Molti di questi preti, appena ottenuto il titolo pubblico, abbandonarono la Chiesa (durante la guerra, per causa della mobilitazione, questo fenomeno acquistò una certa ampiezza). L’organizzazione ecclesiastica subiva dunque una crisi costituzionale, che poteva essere fatale alla sua potenza, se lo Stato manteneva integra la sua posizione di laicità, anche senza bisogno di una lotta attiva. Nella lotta tra le forme di vita, la Chiesa stava per essere vinta automaticamente. Lo Stato salvò la Chiesa. La posizione economica del clero fu migliorata a più riprese, mentre il tenore di vita generale, ma specialmente dei ceti medi, peggiorava. Il miglioramento è tale, che le «vocazioni» si sono maravigliosamente moltiplicate, impressionando lo stesso pontefice, che le spiega appunto con la nuova situazione economica. La base della scelta degli idonei al clericato è stata dunque ampliata, permettendo più rigore e una maggiore esigenza di cultura.
Ma la carriera ecclesiastica, se è il fondamento della potenza del Vaticano, non esaurisce le sue possibilità. La nuova situazione scolastica permette l’immissione nella classe dirigente laica di cellule che andranno sempre più rafforzandosi, di elementi laici che dovranno la loro posizione solamente alla Chiesa. Sul terreno di questa scelta, la Chiesa è imbattibile. Controllando i licei e le altre scuole medie, attraverso i suoi fiduciari, essa seguirà con la tenacia che le è caratteristica, i giovani più valenti delle classi povere e li aiuterà a proseguire gli studi nelle Università cattoliche. Borse di studio, fiancheggiate da convitti organizzati con la massima economia accanto alle Università, permetteranno questa azione. La Chiesa, nella sua fase odierna, con l’impulso dato dall’attuale pontefice all’azione cattolica, non può accontentarsi solo di creare dei preti: essa vuole permeare lo Stato (governo indiretto del Bellarmino) e per quest’azione sono necessari dei laici, è necessaria una concentrazione di cultura cattolica rappresentata da laici. Esistono molti giovani che possono diventare preziosi ausiliari della Chiesa più come professori d’Università che come cardinali ecc. Allargata la base delle «vocazioni» questa attività laico‑culturale ha immense possibilità di estendersi.
L’Università del Sacro Cuore e il centro culturale neoscolastico sono solo la prima cellula di questo lavoro. È intanto stato sintomatico il Congresso Filosofico del 1929: vi si scontrarono idealisti assoluti e neoscolastici e questi parteciparono al Congresso animati da spirito battagliero di conquista. Secondo me il gruppo questo voleva ottenere, di apparire battagliero, pugnace, quindi interessante per i giovani. I cattolici sono fortissimi perché si infischiano delle «confutazioni perentorie» dei loro avversari idealisti o materialisti: la tesi confutata essi la riprendono imperturbati e come se nulla fosse. La mentalità «disinteressata» intellettualmente, la lealtà intellettuale essi non la comprendono o la comprendono come una debolezza e dabbenaggine degli avversari. Essi contano sulla potenza della loro organizzazione mondiale e sul fatto che la grande maggioranza della popolazione non è ancora «moderna», è ancora alla fase tolemaica della scienza. Se lo Stato rinunzia a essere centro di cultura propria, autonoma, la Chiesa non può che trionfare.
Tanto più che lo Stato non solo non interviene come centro autonomo, ma distrugge ogni oppositore della Chiesa all’infuori dell’idealismo attuale pappagallizzato.
Le conseguenze di questa situazione saranno della massima importanza; ma le cose non andranno liscie per molto tempo: la Chiesa è uno Shylok anche più implacabile dello Shylok ebreo: essa vorrà la sua libbra di carne e si infischierà del dissanguamento della vittima. Aveva ragione Disraeli: i cristiani sono stati gli ebrei più intelligenti che hanno conquistato il mondo. La Chiesa non sarà ridotta alla sua forza normale con la confutazione in sede filosofica dei suoi postulati teorici (teologici) e con le affermazioni platoniche della autonomia statale: ma con l’azione pratica, con l’esaltazione delle forze umane in tutta l’area sociale.
La quistione finanziaria del centro religioso: l’organizzazione del cattolicismo in America dà la possibilità di raccogliere fondi molto vistosi, oltre alle rendite normali ormai assicurate e all’obolo di S. Pietro. Potrebbero nascere quistioni internazionali a proposito dell’intervento della Chiesa negli affari interni dei singoli paesi, con lo Stato che sussidia permanentemente la Chiesa? La quistione potrebbe essere elegante, come si dice.
La quistione del finanziamento rende anche più interessante il problema della così detta indissolubilità proclamata dal pontefice del trattato e del concordato: ammesso che il pontefice si trovasse nella necessità di ricorrere a questo mezzo politico di pressione sullo Stato, non si porrebbe subito il problema della restituzione delle somme riscosse (somme legate appunto al trattato e non al concordato)? Ma esse sono così ingenti ed è pensabile che saranno spese in gran parte nei primi anni, che la loro restituzione può ritenersi praticamente impossibile. Nessuno Stato farebbe un così gran prestito al pontefice per trarlo d’imbarazzo e tanto meno un privato o una banca: la denunzia del trattato scatenerebbe una tale crisi nella organizzazione pratica della Chiesa, che la solvibilità di questa sia pure a grande scadenza, sarebbe annientata. La convenzione finanziaria deve essere pertanto considerata come la parte essenziale del trattato, come la garanzia di una quasi impossibilità di denunzia del trattato, prospettata per ragioni di polemica e di pressione politica.
Q4 §54 1918. «Col 1918 si aveva una importantissima innovazione nel nostro diritto, innovazione che stranamente (c’era però la censura nel 1918) passava tra la disattenzione generale: lo Stato riprendeva a sussidiare il culto cattolico, abbandonando dopo sessantatré anni il principio cavourriano ch’era stato posto a base della legge sarda 29 maggio 1855: lo Stato non deve sussidiare alcun culto». A. C. Jemolo, Religione dello Stato e confessioni ammesse, in «Nuovi Studi di Diritto, Economia, Politica», anno 1930, p. 30.
La innovazione fu introdotta coi D. L. 17 marzo 1918, n. 396 e 9 maggio 1918, n. 655. A questo riguardo lo Jemolo rimanda alla nota di D. Schiappoli, I recenti provvedimenti economici a vantaggio del clero, Napoli, 1922, estratta dal vol. XLVIII degli Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli.
Q4 §55 Il principio educativo nella scuola elementare e media. La frattura introdotta ufficialmente nel principio educativo tra la scuola elementare e media e quella superiore. Prima una frattura del genere esisteva solo in modo molto marcato tra la scuola professionale e la scuola media e superiore. La scuola elementare era posta in una specie di limbo, per alcuni suoi caratteri particolari.
Nella scuola elementare due elementi si prestavano all’educazione dei bambini: le nozioni di scienza e i diritti e doveri del cittadino. La «scienza» doveva servire a introdurre il bambino nella «societas rerum», i diritti e doveri nella «società degli uomini». La «scienza» entrava in lotta con la concezione «magica» del mondo e della natura che il bambino assorbe dall’ambiente «impregnato» dal folklore: l’insegnamento è una lotta contro il folklore, per una concezione realistica in cui si uniscono due elementi: la concezione di legge naturale e quella di partecipazione attiva dell’uomo alla vita della natura, cioè alla sua trasformazione secondo un fine che è la vita sociale degli uomini. Questa concezione si unifica cioè nel lavoro, che si basa sulla conoscenza oggettiva ed esatta delle leggi naturali per la creazione della società degli uomini. L’educazione elementare si impernia in ultima analisi nel concetto e nel fatto del lavoro, poiché l’ordine sociale (insieme dei diritti e doveri) è dal lavoro innestato nell’ordine naturale. Il concetto dell’equilibrio tra ordine sociale e ordine naturale sulla base del lavoro, dell’attività pratica dell’uomo crea la visione del mondo elementare, liberata da ogni magia e da ogni stregoneria e dà l’appiglio allo sviluppo ulteriore in una concezione storica, di movimento, del mondo.
Non è completamente esatto che l’istruzione non sia anche educazione: l’aver insistito troppo in questa distinzione è stato un grave errore e se ne vedranno gli effetti. Perché l’istruzione non fosse anche educazione bisognerebbe che il discente fosse una mera passività, ciò che è assurdo in sé anche se proprio viene negato dai sostenitori ad oltranza della pura educatività contro la mera istruzione meccanica. La verità è che il nesso istruzione‑educazione è rappresentato dal lavoro vivente del maestro in quanto la scuola è acceleramento e disciplinamento della formazione del fanciullo. Se il corpo magistrale è deficiente sarà la sua opera ancora più deficiente se gli si domanderà più educazione: farà una scuola retorica, non seria. Ciò si vede ancor meglio nella scuola media, per i corsi di letteratura e di filosofia. Prima gli allievi, per lo meno, lasciavano la scuola con un certo bagaglio di nozioni storiche concrete: ora che il professore dovrebbe essere un filosofo e un esteta, gli allievi trascurano le nozioni concrete e si riempiono la testa di parole senza senso, subito dimenticate. La lotta contro la vecchia scuola era giusta, ma si trattava di una quistione di uomini più che di programmi. In realtà un mediocre insegnante può riuscire a ottenere che gli allievi diventino più istruiti, non riuscirà mai a ottenere che siano più colti: la parte meccanica della scuola egli la svolgerà con scrupolo e coscienza, e l’allievo, se è un cervello attivo, ordinerà per conto suo il «bagaglio». Coi nuovi programmi, che coincidono con un abbassamento di livello del corpo insegnante, non si avrà «bagaglio» e non ci sarà niente da ordinare. I nuovi programmi avrebbero dovuto abolire completamente gli esami: dare un esame adesso dev’essere terribilmente più «giuoco d’azzardo» di una volta. Bene o male, una data è sempre una data, qualsiasi professore esamini, e una definizione è sempre una definizione. Ma un giudizio, un’analisi estetica o filosofica?
Secondo me l’efficacia educativa della vecchia scuola media italiana secondo la vecchia legge Casati, era dovuta all’insieme del suo organamento e dei suoi programmi più che a una volontà espressa di essere scuola «educativa». In questa quistione mi pare che si possa dire ciò che il Carducci diceva della quistione della lingua: gli italiani, invece di parlare, si guardano la lingua. Nella scuola ciò si capisce pensando alla attività dell’allievo. 1 nuovi programmi, quanto più, nei teorici che li hanno preparati e li difendono, affermano e teorizzano l’attività del discente e la sua collaborazione attiva col docente, in realtà tanto più operano come se il discente fosse una mera passività. Nella vecchia scuola dunque, l’organamento stesso dava l’educazione. Come? Lo studio del latino e del greco, delle lingue, con lo studio delle letterature e delle storie politiche rispettive, era alla base di questa educatività. Il carattere di educatività era dato dal fatto che queste nozioni non venivano apprese per uno scopo immediato pratico‑professionale: lo scopo c’era, ma era la formazione culturale dell’uomo, e non si può negare che esso sia un «interesse». Ma lo studio in sé apparisce disinteressato. Non si impara il latino e il greco per parlare queste lingue, per fare i camerieri o gli interpreti o che so io. Si imparano per conoscere la civiltà dei due popoli, la cui vita si pone come base della cultura mondiale. La lingua latina o greca si impara secondo grammatica, un po’ meccanicamente: ma c’è molta esagerazione nell’accusa di meccanicità e di aridità. Si ha che fare con dei ragazzetti, ai quali occorre far contrarre certe abitudini di diligenza, di esattezza di compostezza fisica, di concentrazione psichica in determinati oggetti. Uno studioso di trenta‑quarant’anni sarebbe capace di stare a tavolino sedici ore filate, se da bambino non avesse «coattivamente», per «coercizione meccanica» assunto le abitudini psicofisiche conformi?1 Se si vogliono allevare anche degli studiosi, occorre incominciare di lì e occorre premere su tutti per avere quelle migliaia, o centinaia, o anche solo dozzine di studiosi di gran nerbo, di cui ogni civiltà ha bisogno. (Si potrà migliorare molto, indubbiamente, ma su questa base).
Si impara il latino, lo si analizza nei suoi membretti più elementari, si analizza come una cosa morta, è vero, ma ogni analisi fatta da un bambino non può essere che su una cosa morta; d’altronde non bisogna dimenticare che dove questo studio avviene, in queste forme, la vita dei Romani è un mito che in una certa misura ha già interessato il bambino o lo interessa ora. La lingua è morta, è anatomizzata come un cadavere, è vero, ma il cadavere rivive continuamente negli esempi, nelle narrazioni. Si potrebbe fare lo stesso con l’italiano? Impossibile. Nessuna lingua viva potrebbe essere studiata come il latino: sarebbe o sembrerebbe assurdo. Nessuno dei ragazzi conosce il latino quando ne inizia lo studio con quel tal metodo analitico. Una lingua viva potrebbe essere conosciuta e basterebbe che un ragazzo la conoscesse, per rompere l’incanto: tutti andrebbero alla scuola Berlitz, immediatamente. Il latino e il greco si presentano alla fantasia come un mito, anche per l’insegnante. Il latino non si studia per imparare il latino, si studia per abituare i ragazzi a studiare, ad analizzare un corpo storico che si può trattare come un cadavere ma che continuamente si ricompone in vita. Negli otto anni di latino si studia tutta la lingua, da Fedro ad Ennio e a Lattanzio: un fenomeno storico è analizzato dalle sue origini alla sua morte nel tempo. Si studia la grammatica di un tempo, il vocabolario di un periodo determinato, di un autore determinato, e poi si scopre che la grammatica di Fedro non è quella di Cicerone, non è quella di Plauto ecc., che uno stesso nesso di suoni non ha lo stesso significato nei diversi tempi, nei diversi scrittori. Si paragona continuamente l’italiano e il latino: ma ogni parola è un concetto, un’immagine, che assume sfumature diverse nei tempi, nelle persone, nelle due lingue comparate. Si studia la storia letteraria, la storia dei libri scritti in quella lingua, la storia politica, le gesta degli uomini che parlavano quella lingua. È questo complesso organico che determina l’educazione del giovinetto, il fatto che anche solo materialmente ha percorso tutto quell’itinerario, con quelle tappe, ecc. ecc. Questo studio educava senza averne la volontà espressamente dichiarata, anche col minimo intervento dell’insegnante. Esperienze logiche, psicologiche, artistiche, ecc. erano fatte senza riflettervi su, ma era fatta specialmente una grande esperienza storica, di sviluppo storico.
Naturalmente io non credo che il latino e il greco abbiano delle qualità taumaturgiche intrinseche: dico che in un dato ambiente, in una data cultura, con una data tradizione, lo studio così graduato dava quei determinati effetti. Si può sostituire il latino e il greco e li si sostituirà utilmente, ma occorrerà sapere disporre didatticamente la nuova materia o la nuova serie di materie, in modo da ottenere risultati equivalenti di educazione generale dell’uomo, partendo dal ragazzetto fino all’età della scelta professionale. In questo periodo lo studio o la parte maggiore dello studio deve essere disinteressato, cioè non avere scopi pratici immediati o troppo immediatamente mediati: deve essere formativo, anche se «istruttivo», cioè ricco di nozioni concrete.
Nella scuola moderna mi pare stia avvenendo un processo di progressiva degenerazione: la scuola di tipo professionale, cioè preoccupata di un immediato interesse pratico, prende il sopravvento sulla scuola «formativa» immediatamente disinteressata. La cosa più paradossale è che questo tipo di scuola appare e viene predicata come «democratica», mentre invece essa è proprio destinata a perpetuare le differenze sociali. Come si spiega questo paradosso? Dipende, mi pare, da un errore di prospettiva storica tra quantità e qualità. La scuola tradizionale è stata «oligarchica» perché frequentata solo dai figli della classe superiore destinati a diventare dirigenti: ma non era «oligarchica» per il modo del suo insegnamento. Non è l’acquisto di capacità direttive, non è la tendenza a formare uomini superiori che dà carattere sociale a un tipo di scuola. Il carattere sociale della scuola è dato dal fatto che ogni strato sociale ha un proprio tipo di scuola, destinato a perpetuare in quello strato una determinata funzione tradizionale. Se si vuole spezzare questa trama, occorre dunque non moltiplicare e graduare i tipi di scuola professionale, ma creare un tipo unico di scuola preparatoria (elementare‑media) che conduca il giovane fino alla soglia della scelta professionale, formandolo nel frattempo come uomo capace di pensare, di studiare, di dirigere o di controllare chi dirige. Il moltiplicarsi di tipi di scuole professionali tende dunque a eternare le differenze tradizionali, ma siccome, in esse, tende anche a creare nuove stratificazioni interne, ecco che nasce l’impressione della sua tendenza democratica. Manovale e operaio qualificato per esempio. Contadino e geometra o piccolo agronomo, ecc. Ma la tendenza democratica, intrinsecamente, non può solo significare che un manovale diventi operaio qualificato, ma che ogni «cittadino» può diventare «governante» e che la società lo pone sia pure «astrattamente» nelle condizioni generali di poterlo diventare: la «democrazia politica» tende a far coincidere governanti e governati, assicurando a ogni governato l’apprendimento più o meno gratuito della preparazione «tecnica» generale necessaria. Ma nella realtà, il tipo di scuola praticamente imperante, mostra che si tratta di un’illusione verbale. La scuola va organizzandosi sempre più in modo da restringere la base della classe governativa tecnicamente preparata, cioè con una preparazione universale storico‑critica.
Dogmatismo e criticismo‑storico nella scuola elementare e media: la nuova pedagogia ha voluto battere in breccia il dogmatismo scolastico nel campo dell’«istruzione», cioè dell’apprendimento delle nozioni concrete, proprio nel campo in cui un certo dogmatismo è imprescindibile praticamente e può venir assorbito e disciolto solo nel ciclo intero del corso scolastico (non si può insegnare la grammatica storica in prima ginnasiale), è costretta poi a veder introdotto il dogmatismo per eccellenza nel campo del pensiero religioso e a veder descritta tutta la storia della filosofia come una successione di follie e di delirii.
Insegnamento della filosofia: credo che nelle scuole medie il nuovo metodo impoverisca la scuola e ne abbassi il livello, praticamente (razionalmente il nuovo metodo è bellissimo e giustissimo, ma praticamente con la scuola così com’è, è una bellissima e razionalissima utopia). La filosofia «descrittiva» tradizionale, rafforzata da un corso di storia della filosofia e dalla lettura in casa di certi autori, mi pare la cosa migliore. Ma la filosofia «descrittiva e definitrice» è un’astrazione! Sarà un’astrazione, come la grammatica e la matematica, ma è necessaria. Uno uguale uno è un’astrazione, ma nessuno è condotto a pensare che una mosca è uguale a un elefante. Anche gli strumenti logici sono astrazioni dello stesso genere, sono come la grammatica del pensare normale: e non sono innati, ma acquisiti storicamente. Il nuovo metodo li presuppone acquisiti e siccome ha come fine la educazione dei ragazzi, in cui non possono pensarsi acquisiti, è come se li pensasse innati. La logica formale è come la grammatica: essa viene assimilata in modo «vivente», anche se è necessariamente appresa schematicamente: il discente non è un disco di grammofono, non è un recipiente passivo. Così il ragazzo che si arrabbatta coi barbara, báràlipton, ecc. Si affatica, è certo, e bisogna trovare che egli debba fare la fatica indispensabile e non più. Ma è anche certo che dovrà sempre faticare per imparare e costringere se stesso a privazioni e limitazioni di movimento fisico, cioè a un tirocinio psico‑fisico. Anche lo studio è un mestiere e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio anche nervoso‑muscolare, oltre che intellettuale: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo e il dolore e la noia. La partecipazione di più larghe masse alla scuola media tende a rallentare la disciplina dello studio, a domandare «facilitazioni». Molti pensano addirittura che la difficoltà sia artificiale, perché sono abituati a considerare lavoro e fatica solo il lavoro manuale. È una quistione complessa. Certo il ragazzo di una famiglia tradizionalmente di intellettuali supera più facilmente il processo di adattamento psicofisico: egli già entrando la prima volta in classe ha parecchi punti di vantaggio sugli altri scolari, ha un’ambientazione già acquisita per le abitudini famigliari. Così il figlio di un operaio di città soffre meno entrando in fabbrica di un ragazzo di contadini o di un contadino già sviluppato per la vita dei campi. Anche il regime dei cibi ha un’importanza, ecc. ecc.
Ecco perché molti del «popolo» pensano che nella difficoltà dello studio ci sia un «trucco» a loro danno; vedono il signore (per molti, nelle campagne specialmente, «signore» vuol dire «intellettuale») compiere con scioltezza e con apparente facilità il lavoro che ai loro figli costa lacrime e sangue, e pensano ci sia un «trucco». In una nuova situazione politica, queste quistioni diventeranno asprissime e occorrerà resistere alla tendenza di rendere facile ciò che non può esserlo senza essere snaturato. Se si vorrà creare un nuovo corpo di intellettuali, fino alle più alte cime, da uno strato sociale che tradizionalmente non ha sviluppato le attitudini psico‑fisiche adeguate, si dovranno superare difficoltà inaudite.
Q4 §56 Machiavelli e l’«autonomia» del fatto politico. Quistione del machiavellismo e antimachiavellismo (ogni vero «machiavellico» incomincia la sua attività politica con una confutazione in forma delle dottrine del Machiavelli: es. i gesuiti e Federico II di Prussia). Importanza della quistione del machiavellismo nello sviluppo della scienza della politica: in Italia, almeno, la scienza politica si è sviluppata su questo tema. Costruire una bibliografia critica sull’argomento. Che significato ha la dimostrazione fatta, in modo compiuto, dal Croce, dell’autonomia del momento politico‑economico? Si può dire che il Croce non sarebbe giunto a questo risultato senza l’apporto culturale del marxismo e del materialismo storico? Ricordare che in un punto (vedere) il Croce dice di maravigliarsi del come mai nessuno abbia pensato di dire che il Marx ha compiuto, per una classe moderna determinata, la stessa opera compiuta dal Machiavelli. Da questa posizione incidentale del Croce si potrebbe dedurre la poca giustezza della sua riduzione del materialismo storico a un mero canone empirico di metodologia storica?
Altre quistioni: data l’autonomia della politica, quale rapporto dialettico tra essa e le altre manifestazioni storiche? Problema della dialettica in Croce e sua posizione di una «dialettica dei distinti»: non è una contraddizione in termini, una «ignorantia elenchi»? Dialettica può darsi solo degli opposti, negazione della negazione, non rapporto di «implicazione».
L’arte, la morale, la filosofia «servono» alla politica, cioè si «implicano» nella politica, possono ridursi ad un momento di essa e non viceversa: la politica distrugge l’arte, la filosofia, la morale: si può affermare, secondo questi schemi, la priorità del fatto politico‑economico, cioè la «struttura» come punto di riferimento e di «causazione» dialettica, non meccanica, delle superstrutture.
Il punto della filosofia crociana su cui bisogna far leva mi pare appunto la sua così detta dialettica dei distinti; c’è una esigenza reale in questa posizione, ma c’è anche una contraddizione in termini: occorre studiare questi elementi per svilupparli criticamente. Vedere le obbiezioni non verbalistiche della scuola del Gentile ai «distinti» del Croce; risalire allo Hegel: è «completamente» esatta la riforma dello hegelismo compiuta dal Croce‑Gentile? Non hanno essi reso più «astratto» lo Hegel? non ne hanno tagliato via la parte più realistica, più storicistica? e non è proprio da questa parte invece che è nato essenzialmente il marxismo? Cioè il superamento dell’hegelismo fatto da Marx non è lo sviluppo storico più fecondo di questa filosofia, mentre la riforma di Croce‑Gentile è appunto solo una «riforma» e non un superamento? E non è stato proprio il marxismo a far deviare Croce e Gentile, che ambedue hanno cominciato dallo studio del Marx? (per ragioni implicitamente politiche?) Vico ‑ B. Spaventa come anello di congiunzione rispettivamente per il Croce e il Gentile con l’hegelismo: ma non è questo un far arretrare la filosofia di Hegel a una fase precedente? Può essere pensato Hegel senza la Rivoluzione Francese e le guerre di Napoleone, senza, cioè, le esperienze vitali e immediate di un periodo storico intensissimo in cui tutte le concezioni passate furono criticate dalla realtà in corso in modo perentorio? Cosa di simile potevano dare Vico e Spaventa? (Anche Spaventa, che partecipò a fatti storici di portata regionale e provinciale, in confronto a quelli dall’89 al 1815 che sconvolsero tutto il mondo civile d’allora e obbligarono a pensare «mondialmente»? Che misero in movimento la «totalità» sociale, tutto il genere umano concepibile, tutto lo «spirito»? Ecco perché Napoleone può apparire a Hegel «lo spirito del mondo» a cavallo!) Quale «movimento» storico reale testimonia la filosofia di Vico? Quantunque la sua genialità consista appunto nell’aver concepito il vasto mondo da un angoletto morto della storia, aiutato dalla concezione unitaria e cosmopolita del cattolicismo... In ciò la differenza essenziale tra Vico e Hegel, tra dio e Napoleone ‑ spirito del mondo, tra la pura speculazione astratta e la «filosofia della storia» che dovrà portare alla identificazione di filosofia e di storia, del fare e del pensare, del «proletariato tedesco come solo erede della filosofia classica tedesca».
Q4 §57 Vincenzo Cuoco e la rivoluzione passiva. Vincenzo Cuoco ha chiamato rivoluzione passiva quella avutasi in Italia per contraccolpo delle guerre napoleoniche. Il concetto di rivoluzione passiva mi pare esatto non solo per l’Italia, ma anche per gli altri paesi che ammodernarono lo Stato attraverso una serie di riforme o di guerre nazionali, senza passare per la rivoluzione politica di tipo radicale‑giacobino. Vedere nel Cuoco come egli svolge il concetto per l’Italia.
Q4 §58 Letteratura Popolare. Atkinson N., Eugène Sue et le roman-feuilleton. In 8°, pp. 226, Parigi, Nizet et Bastard, 40 fr.
Q4 §59 Storia delle classi subalterne. Rosmini A., Saggio sul comunismo e sul socialismo, pubblicato a cura e con prefazione di A. Canaletti Gaudenti. In 16°, pp. 85, Roma, Signorelli, L. 6. (Da vedere insieme con le encicliche papali emanate prima del 48 e citate nel Sillabo di Pio IX, come commento italiano al primo paragrafo del Manifesto: cfr anche il capitolo bibliografico nel Mazzini di Salvemini).
Q4 §60 Argomenti di cultura. Una rassegna critico‑bibliografica sulla quistione del capitalismo antico: confronto tra le due edizioni, francese e italiana, del libro del Salvioli, articoli e libri di Corrado Barbagallo (per es. L’Oro e il fuoco) e polemica con Giovanni Sanna. Caratteristico nel Barbagallo il «tono» di questi scritti: la polemica ricorda la quistione settecentesca sugli antichi e i moderni. Che importanza e significato ha avuto questa polemica settecentesca? Essa è stata l’espressione della coscienza in via di sviluppo che una nuova fase storica era ormai iniziata, completamente rinnovatrice di tutti i modi di esistenza, radicalmente sconvolgitrice del passato. Confronta con ciò che scrive Antonio Labriola nel frammento Da un secolo all’altro sul significato del nuovo calendario instaurato dalla Rivoluzione francese (tra il mondo antico e il mondo cristiano non c’è stata una così profonda coscienza di distacco: la storia del calendario accennata dal Labriola dimostra questa assenza). Che significato ha la polemica attuale (moderna) sul capitalismo antico? Essa è indubbiamente reazionaria, tende a diffondere lo scetticismo, a togliere ai fatti economici ogni valore di sviluppo e di progresso; la polemica è però rivolta a piccole cerchie di studiosi professionali e neanche molto significativi, non è un elemento di cultura come è stata la polemica settecentesca. La posizione del Barbagallo è tipica per il così detto «materialismo storico» italiano, poiché il Barbagallo si afferma ancora «materialista storico» (cfr la sua polemichetta col Croce nella «Nuova Rivista Storica» del 1928‑29). Legato a Guglielmo Ferrero e al lorianismo.
Studio sulla funzione mondiale di Londra: come si è costituita storicamente e come nel dopoguerra abbia trovato concorrenti: un aspetto, tecnico, dell’egemonia economica anglosassone e della sterlina nel mondo: tentativi di New York e di Parigi per soppiantare Londra. Quanto rende al capitalismo inglese questa egemonia? In alcuni scritti di Einaudi vi sono larghi cenni su questo argomento. Il libro di Mario Borsa su Londra. Il libro di Angelo Crespi sull’imperialismo britannico.
L’argomento è stato trattato dal Presidente della Westminster (Banca) nel discorso tenuto in occasione dell’assemblea del 1929: l’oratore ha accennato ai lamenti perché gli sforzi fatti per conservare la posizione di Londra come centro finanziario internazionale impongono sacrifizi eccessivi all’industria e al commercio, ma ha osservato che il mercato finanziario di Londra produce un reddito che contribuisce in larga misura a saldare il deficit della bilancia commerciale. Da un’inchiesta fatta dal Ministero del Commercio risulta che nel 28 questo contributo fu di 65 milioni di sterline, nel 27 di 63 milioni, nel 26 di 60 milioni: questa attività deve considerarsi perciò come una fra le maggiori industrie esportatrici inglesi. Va tenuto conto della parte importante che spetta a Londra nell’esportazione di capitali, che frutta un reddito annuo di 285 milioni di sterline e che facilita l’esportazione di merci inglesi perché gl’investimenti inglesi aumentano la capacità d’acquisto dei mercati esteri. L’esportatore inglese trova poi nel meccanismo che la finanza internazionale si è creato a Londra, facilitazioni bancarie, cambiali ecc., superiori a quelle esistenti in qualsiasi altro paese. È evidente dunque che i sacrifizi fatti per conservare a Londra la sua supremazia nel campo della finanza internazionale sono ampiamente giustificati dai vantaggi che ne derivano, ma per conservare questa supremazia è essenziale che il sistema monetario inglese abbia per base il libero movimento dell’oro. Ogni misura che intralciasse questa libertà andrebbe a danno di Londra come centro internazionale per il denaro a vista. I depositi esteri fatti a Londra a questo titolo rappresentano somme volissime messe a disposizione di quella piazza. Se questi fondi cessassero di affluire, il tasso del denaro sarebbe forse più stabile, ma sarebbe indubbiamente più alto.
Quali espressioni commerciali economiche sono nate da questa funzione di Londra e che si trovano nella lettura dei giornali e delle riviste economiche?
Q4 §61 Filosofia‑ideologia, scienza‑dottrina. Cfr Gaëtan Pirou, Doctrines sociales et science économique, Librairie du Recueil Sirey, Parigi. (Capitoli: Science économique et socialisme. Science et doctrines économiques. Nouveaux aspects du coopératisme. L’état actuel de la science économique en France, Fondament de la valeur et lois de l’échange. M. Pantaleoni et la théorie économique). L’autore distingue le teorie volte a spiegare i fatti economici (scienza economica) dalle teorie volte a modificare i fatti economici e sociali (che egli chiama dottrine sociali). Indaga poi le relazioni che si vogliono far correre fra le dottrine sociali e la scienza economica, in particolare considerando la pretesa avanzata volta a volta dal liberalismo e dal marxismo di essere in accordo colla scienza, mentre si tratta di cose diverse. «La verità ci sembra che scienza e dottrine si svolgano su piani differenti, e che le dottrine non sono mai il semplice prolungamento, nell’avvenire, della curva dell’evoluzione o la deduzione obbligatoria degli insegnamenti della scienza». Ricollegandosi al Sorel, l’autore scrive anche che «le dottrine devono essere studiate non come verità messe in formule, ma come forze messe in azione». Alfonso De Pietri‑Tonelli, da un cenno bibliografico del quale (nella «Rivista di Politica Economica», 31 marzo 1930) ho tolto le linee precedenti, rimanda al suo corso di politica economica, nel quale egli avrebbe fatto le stesse distinzioni, anche quella delle «forze messe in azione» che corrisponderebbe alla sua teoria degli impulsi.
Quistione dei rapporti tra scienza e vita. Il marxismo non è una mera dottrina sociale, secondo la distinzione del Pirou, poiché «avanza la pretesa» persino di spiegare la «scienza», cioè di essere più scienza della «scienza». Nella quistione di ideologia‑filosofia = dottrina‑scienza, rientra anche la quistione della «primitività» o «irriducibilità» del momento politico o pratico. L’ideologia = ipotesi scientifica di carattere educativo energetico, verificata e criticata dallo sviluppo reale della storia, cioè fatta diventare scienza (ipotesi reale), sistematizzata.
Q4 §62 Arte militare e politica. Sentenze tradizionali rispondenti al senso comune delle masse di uomini: «I generali, dice Senofonte, devono avanzar gli altri non nella sontuosità della tavola e nei piaceri, ma nella capacità e nelle fatiche». «Difficilmente si possono indurre i soldati a soffrire la penuria e i disagi che derivano da ignoranza o da colpa nel loro comandante; ma quando sono prodotti dalla necessità, ognuno è pronto a soffrirli». «L’ardire col proprio pericolo è valore, con l’altrui è arroganza (Pietro Colletta)» .
Differenza tra ardimento‑intrepidità e coraggio: il primo è istintivo e impulsivo; il coraggio invece è acquisito con l’educazione e attraverso i costumi. A stare a lungo in trincea ci vuole «coraggio», cioè perseveranza nell’intrepidità, che può esser data o dal terrore (certezza di morire se non si rimane) o dalla convinzione di fare cosa necessaria (coraggio).
Q4 §63 Epistolario Sorel‑Croce. Ricordare che nel 1929, dopo la pubblicazione di una lettera in cui Sorel parlava di Oberdan, avvennero pubblicazioni in cui si protestava per alcune espressioni delle lettere e si attaccava il Sorel (una pubblicazione particolarmente violenta di Arturo Stanghellini fu riportata dall’«Italia Letteraria» di quel periodo). L’epistolario fu interrotto nel numero successivo della «Critica» e ripreso, senza accenno alcuno all’incidente, ma con alcune novità: parecchi nomi furono dati solo con le iniziali e si ebbe l’impressione che alcune lettere non siano state pubblicate. Da questo punto incomincia nel giornalismo una valutazione nuova del Sorel, e dei suoi rapporti con l’Italia.
Q4 §64 «Storia e Antistoria». «Sono veramente pochi coloro che riflettono e sono nello stesso tempo capaci di agire. La riflessione amplia, ma infiacchisce; l’azione ravviva, ma limita». Goethe, W. Meister (VIII, 5).
Q4 §65 Passato e presente. Articolo di Salvatore di Giacomo sulla «impraticabilità» delle strade popolari di Napoli per i «sognatori» ed i «poeti»; dalle finestre cadevano i testi di fiori ad ammaccare i cappelli duri e le pagliette signorili e anche i crani contenutivi (articolo nel «Giornale d’Italia» del 20). Episodio dei pomodori che costano e delle pietre che non costano. Senso del distacco, della differenziazione in un ambiente primitivo «riscaldato», che crede prossima l’impunità e si rivela apertamente. Questo stesso ambiente primitivo, in tempi «normali», è sornionamente adulatore e servile. Episodio del popolano veneziano, raccontato dal Manzoni al Bonghi: si sviscerava in inchini e scappellate dinanzi ai nobiluomini, salutava sobriamente dinanzi alle chiese; interrogato su questo apparente minor rispetto per le cose sacre, rispose ammiccando: «Coi santi non si cogliona». Come appariva la differenziazione in una città moderna? Esempi ed episodi.
Q4 §66 L’elemento militare in politica. Quando si analizza la serie delle forze sociali che hanno operato nella storia ed operano nell’attività politica di un complesso statale, occorre dare un giusto posto all’elemento militare e all’elemento burocratico, ma occorre tener presente che in questa designazione non rientrano puramente gli elementi militari e burocratici in atto, ma gli strati sociali da cui, in quel determinato complesso statale, questi elementi tradizionalmente sono reclutati. Un movimento politico può essere di carattere militare anche se l’esercito come tale non vi ha apertamente partecipato, un governo può essere militare anche se non formato di militari. In determinate situazioni può avvenire che convenga non scoprire l’esercito, non farlo uscire dalla costituzionalità, non portare la politica tra i soldati, come si dice, per mantenere l’omogeneità tra ufficiali e soldati in un terreno di apparente neutralità e superiorità sulle «fazioni». Non bisogna dimenticare che l’esercito riproduce la struttura sociale di uno Stato e che perciò la politica introdotta in esso può riprodurvi i dissensi esterni, disgregando la formazione militare*. Tutti questi elementi di osservazione non sono assoluti: essi devono essere «relativizzati» secondo i diversi momenti storici e i diversi Stati.
*Nel ms è aggiunta a piè pagina, in periodo successivo, la seguente nota: «Osservare che si cerca di educare stabilmente un ceto militare nella società, con le associazioni di ex‑combattenti, di ufficiali in congedo ecc. legato all’esercito permanente (cioè allo Stato Maggiore) e mobilitabile all’occorrenza senza bisogno di mobilitare l’esercito di leva, che mantiene la sua funzione di riserva allarmata, e che non può non essere influenzato da queste forze militari extraesercito».
La prima ricerca è questa: esiste in un determinato paese uno strato sociale diffuso per il quale la carriera militare e burocratica sia un elemento molto importante di vita economica e di affermazione politica (partecipazione effettiva al potere, sia pure indirettamente, per «ricatto»)? Nell’Europa moderna questo strato si può identificare nella borghesia rurale media e piccola, più o meno diffusa a seconda dello sviluppo delle forze industriali da una parte e della riforma agraria dall’altra. È evidente che la carriera militare e burocratica non può essere monopolio di questo strato; ma due elementi sono importanti nel determinare una particolare omogeneità ed energia di direttive in questo strato, dandogli un sopravvento politico e una funzione decisiva sull’insieme. La funzione sociale che compie e la psicologia che è determinata da questa funzione. Questo strato è abituato a comandare direttamente nuclei di uomini sia pure esigui, e a comandare «politicamente», non «economicamente»: esso non ha funzioni economiche nel senso moderno della parola; ha un reddito perché ha una «bruta» proprietà del suolo e impedisce al contadino di migliorare la propria esistenza: vive sulla miseria cronica e sul lavoro prolungato del contadino. Ogni minimo accenno di organizzazione del lavoro contadino (organizzazione autonoma) mette in pericolo il suo tenore di vita e la sua posizione sociale. Quindi energia massima nella resistenza e nel contrattacco.
Questo strato trova nella sua «inomogeneità» sociale e nella sua dispersione territoriale i suoi limiti: questi elementi spiegano altri fenomeni che gli sono proprii: la volubilità, la molteplicità dei sistemi seguiti, la stranezza delle ideologie accettate ecc. La volontà è decisa verso un fine, ma tarda e ha bisogno di un lungo processo per centralizzarsi organizzativamente e politicamente. Il processo si accelera quando la «volontà» specifica di questo strato coincide con una volontà generica o specifica della classe alta: non solo il processo si accelera, ma appare allora la «forza militare» di questo strato, che talvolta detta legge alla classe alta, per ciò che riguarda la soluzione specifica, ossia la «forma» della soluzione.
Qui funzionano le leggi altrove osservate dei rapporti città-campagna: la forza della città automaticamente diventa forza della campagna, ma in campagna i conflitti assumono subito forma acuta e personale, per l’assenza di margini economici e per la maggiore «normale» compressione esercitata dall’alto in basso, quindi le reazioni in campagna devono essere più rapide e decise. Questo strato capisce e vede che l’origine dei suoi guai è nelle città, nella forza delle città e perciò capisce di «dover» dettare la soluzione alle classi alte urbane, perché il focolaio sia spento, anche se ciò alle classi alte urbane non converrebbe immediatamente o perché troppo dispendioso o perché pericoloso a lungo andare (queste classi sono più raffinate e vedono cicli ampli di avvenimenti, non solo l’interesse «fisico» immediato). In questo senso deve intendersi la funzione direttiva di questo strato, e non in senso assoluto: tuttavia non è piccola cosa.
Dunque in una serie di paesi influenza dell’elemento militare nella politica non ha solo significato influenza e peso dell’elemento tecnico militare, ma influenza e peso dello strato sociale da cui l’elemento tecnico militare (ufficiali subalterni specialmente) trae specialmente origine. Questo criterio mi pare serva bene ad analizzare l’aspetto più riposto di quella determinata forma politica che si suole chiamare cesarismo o bonapartismo e a distinguerla da altre forme in cui l’elemento tecnico militare predomina, forse in forme ancora più appariscenti ed esclusive.
La Spagna e la Grecia offrono due esempi tipici, con tratti simili e dissimili. Nella Spagna occorre tener conto di alcuni particolari: grandezza del territorio e scarsa densità della popolazione contadina. Tra il nobile latifondista e il contadino non esiste una vasta borghesia rurale: scarsa importanza dell’ufficialità subalterna come forza a sé. I governi militari sono governi di grandi generali. Passività delle masse contadine come cittadinanza e come massa militare. Se nell’esercito si verifica disgregazione è in senso verticale, non orizzontale, per la concorrenza delle cricche dirigenti: le masse dei soldati seguono di solito i rispettivi capi in lotta tra loro. Il governo militare è una parentesi tra due governi costituzionali: l’elemento militare è la riserva permanente dell’«ordine», è una forza politica permanentemente operante «in modo pubblico».
Lo stesso avviene in Grecia con la differenza che il territorio greco è sparpagliato anche nelle isole e che una parte della popolazione più energica e attiva è sempre sul mare, ciò che rende ancora più facile l’intrigo e il complotto militare: il contadino greco è passivo come quello spagnolo, ma nel quadro della popolazione totale, il greco più energico e attivo essendo marinaio e quasi sempre lontano da casa sua, dal suo centro politico, la passività generale vuole essere analizzata diversamente e la soluzione del problema politico non può essere la stessa.
Ciò che è notevole è che in questi paesi l’esperienza del governo militare non crea una ideologia politica e sociale permanente, come avviene invece nei paesi «cesaristi», per così dire. Le radici sono le stesse: equilibrio delle classi urbane in lotta, che impedisce la «democrazia» normale, il governo parlamentare, ma diversa è l’influenza della campagna in questo equilibrio. In Ispagna la campagna, passiva completamente, permette ai generali della nobiltà terriera di servirsi politicamente dell’esercito per ristabilire l’ordine, cioè il sopravvento delle classi alte, dando una coloratura speciale al governo militare di transizione.
In altri paesi la campagna non è passiva, ma il suo movimento non è coordinato politicamente a quello urbano: l’esercito deve rimanere neutrale, finché è possibile, per evitarne la disgregazione orizzontale: entra in iscena la «classe militare‑burocratica», la borghesia rurale, che, con mezzi militari, soffoca il movimento nella campagna (immediatamente più pericoloso), in questa lotta trova una certa unificazione politica e ideologica, trova alleati nella città nelle classi medie (funzione degli studenti di origine rurale nelle città), impone i suoi metodi politici alle classi alte, che devono farle molte concessioni e permettere una determinata legislazione favorevole: insomma riesce a permeare lo Stato dei suoi interessi fino ad un certo punto e a sostituire il personale dirigente, continuando a mantenersi armata nel disarmo generale e minacciando continuamente la guerra civile tra i propri armati e l’esercito nazionale, se la classe alta non le dà certe soddisfazioni. Questo fenomeno assume sempre forme individuate storicamente: Cesare rappresenta una combinazione di elementi diversa da quella rappresentata da Napoleone I, questo diversa da quella di Napoleone III, o da quella di Bismarck ecc. Nel mondo moderno, Zivkovic si avvicina al tipo spagnolo (Zankof al cesarismo?) ecc. Queste osservazioni non sono cioè schemi sociologici, sono criteri pratici di interpretazione storica e politica che volta per volta dall’approssimazione schematica devono incorporarsi in una concreta analisi storica‑politica.
Q4 §67 Grandezza relativa delle potenze. Elementi su cui può calcolarsi la gerarchia di potenza degli Stati: 1) estensione del territorio, 2) forza economica, 3) forza militare, (4), possibilità di imprimere alla loro attività una direzione autonoma, di cui le altre potenze devono subire l’influsso). Il quarto elemento è la conseguenza dei primi tre ed è il modo in cui si esprime appunto l’essere grande potenza. Il terzo elemento è di carattere anch’esso riassuntivo dell’estensione territoriale (con una popolazione relativamente alta) e della forza economica. Nell’elemento territoriale è da considerare la posizione geografica: nella forza economica è da distinguere la capacità industriale e agricola (produzione) dalla forza finanziaria. Un elemento imponderabile è poi la posizione ideologica che una certa potenza occupa nel mondo in quanto rappresenta le forze progressive della storia.
Q4 §68 Il libro di don Chisciotte di E. Scarfoglio [Alfredo Oriani]. È un episodio della lotta per svecchiare la cultura italiana e sprovincializzarla. In sé il libro è mediocre. Vale per il tempo e perché forse è stato il primo tentativo del genere.
Dovendo scrivere su Oriani è da notare il brano che gli dedica lo Scarfoglio (p. 227 dell’edizione Mondadori, 1925). Per lo Scarfoglio (che scrive verso il 1884) l’Oriani e un debole, uno sconfitto, che si consola atterrando tutto e tutti: «Il signor di Banzole ha la memoria ammucchiata di letture frettolose e smozzicate, di teoriche male intese e mal digerite, di fantasmi malamente e fiaccamente formati; di più, l’instrumento della lingua non gli sta troppo sicuramente nelle mani». È interessante una citazione, forse dal libro Quartetto, in cui Oriani scrive: «Vinto ad ogni battaglia ed insultato come tutti i vinti, non scesi mai né scenderò mai alla scempiaggine della replica, alla bassezza del lamento: i vinti hanno torto». Questo tratto mi pare fondamentale del carattere di Oriani, che era un velleitario, sempre scontento di tutti perché nessuno riconosceva il suo genio e che, in fondo, rinunziava a combattere per imporsi, cioè aveva egli stesso una ben strana stima di sé. È uno pseudo‑titano; e nonostante certe sue innegabili doti, prevale in lui il «genio incompreso» di provincia che sogna la gloria, la potenza, il trionfo, proprio come la signorina sogna il principe azzurro.
Q4 §69 Sui partiti. A un certo punto dello sviluppo storico, le classi si staccano dai loro partiti tradizionali, cioè i partiti tradizionali in quella data forma organizzativa, con quei determinati uomini che li costituiscono o li dirigono, non rappresentano più la loro classe o frazione di classe. È questa la crisi più delicata e pericolosa, perché offre il campo agli uomini provvidenziali o carismatici. Come si forma questa situazione di contrasto tra rappresentati e rappresentanti, che dal terreno delle organizzazioni private (partiti o sindacati) non può non riflettersi nello Stato, rafforzando in modo formidabile il potere della burocrazia (in senso lato: militare e civile)? In ogni paese il processo è diverso, sebbene il contenuto sia lo stesso. La crisi è pericolosa quando essa si diffonde in tutti i partiti, in tutte le classi, quando cioè non avviene, in forma acceleratissima, il passaggio delle truppe di uno o vari partiti in un partito che meglio riassume gli interessi generali. Questo ultimo è un fenomeno organico e normale, anche se il suo ritmo di avveramento sia rapidissimo in confronto ai periodi normali: rappresenta la fusione di una classe sotto una sola direzione per risolvere un problema dominante ed esistenziale. Quando la crisi non trova questa soluzione organica, ma quella dell’uomo provvidenziale, significa che esiste un equilibrio statico, che nessuna classe, né la conservatrice né la progressiva hanno la forza di vincere, ma anche la classe conservatrice ha bisogno di un padrone.
Q4 §70 Sorel, i giacobini, la violenza. Vedere come Sorel concilia il suo odio contro i giacobini‑ottimisti e le sue teorie della violenza. Contro i giacobini sono continue le filippiche del Sorel. (Vedere la Lettre à M. Daniel Halévy nel «Mouvement Socialiste», 16 agosto e 15 settembre 1907).
Q4 §71 La scienza. Accanto alla più superficiale infatuazione per la scienza, esiste in realtà la più grande ignoranza dei fatti e dei metodi scientifici, che sono cose molto difficili e lo diventano sempre più per il progressivo specializzarsi di nuovi rami della conoscenza. Superstizione scientifica che porta con sé illusioni ridicole e concezioni più infantili ancora di quelle religiose. Nasce una specie di aspettazione del paese di Cuccagna, in cui le forze della natura, con quasi nessunintervento della fatica umana, daranno alla società in abbondanza il necessario per soddisfare i suoi bisogni. Contro questa infatuazione i cui pericoli ideologici sono evidenti (la superstiziosa fede nella forza dell’uomo porta paradossalmente a isterilire le basi di questa forza stessa), bisogna combattere con vari mezzi, di cui il più importante dovrebbe essere una maggiore conoscenza delle nozioni scientifiche essenziali, divulgando la scienza per opera di scienziati e di studiosi seri e non più di giornalisti onnisapienti e di autodidatti presuntuosi.
Si aspetta «troppo» dalla scienza, e perciò non si sa valutare ciò che di reale la scienza offre.
Q4 §72 Il nuovo intellettuale. Il tipo tradizionale dell’intellettuale: il letterato, il filosofo, il poeta. Perciò il giornalista volgare, che crede di essere letterato, filosofo, artista, crede di essere il «vero» intellettuale.
Nel mondo moderno, l’educazione tecnica, implicitamente legata al lavoro industriale anche più primitivo (manovale), forma la base del «nuovo intellettuale»: è su questa base che bisogna lavorare per sviluppare il «nuovo intellettualismo». Questa è stata la linea dell’«Ordine Nuovo» (ricordare lo spunto per il capitolo «Passato e presente»). L’avvocato, l’impiegato, sono il tipo corrente d’intellettuale, che si crede investito di una grande dignità sociale: il suo modo di essere è l’«eloquenza» motrice degli affetti. Nuovo intellettuale‑costruttore, organizzatore, «persuasore permanentemente» e pure superiore allo spirito astratto matematico: dalla tecnica‑lavoro giunge alla tecnica‑scienza e alla concezione «umanistico‑storica», senza la quale si rimane «specialista» e non si diventa «dirigente» (specialista della politica).
Q4 §73 Lorianismo. Ho già accennato alla necessità di mettere Corso Bovio nel quadro del Lorianismo? Bisogna metterlo, ricordando di mantenere le distanze per la prospettiva. Corso Bovio entra nel quadro in questo senso: come certi fiamminghi (mi pare il Téniers) mettono sempre un cagnolino nei loro quadri di genere, così Corso Bovio sta nel quadro del lorianismo. E forse il cagnolino è già un animale troppo grosso: una blatta sarebbe più adeguata a rappresentarlo
Q4 §74 G. B. Angioletti. Nell’«Italia Letteraria» del 18 maggio 1930 è riportata una serie di verbali per una vertenza tra l’Angioletti e Guglielmo Danzi, che, nel giornale «La Quarta Roma» del 30 aprile 1930, aveva attaccato l’Angioletti sul suo passato politico, a quanto pare. L’Angioletti consegnò ai suoi padrini Nosari e Ungaretti una nota coi dati essenziali del suo stato di servizio militare, politico, giornalistico. L’Angioletti avrebbe partecipato ai fatti di Milano del 15 aprile 1919 e sarebbe stato nel 1923 condirettore della «Scure» di Piacenza col Barbiellini.
Q4 §75 Passato e presente. Riforma luterana – calvinismo inglese – in Francia razionalismo settecentesco e pensiero politico concreto (azione di massa). In Italia non c’è mai stata una riforma intellettuale e morale che coinvolgesse le masse popolari. Rinascimento, filosofia francese del 700, filosofia tedesca dell’800 sono riforme che toccano solo le classi alte e spesso solo gli intellettuali: l’idealismo moderno, nella forma crociana, è una riforma indubbiamente, ed ha avuto una certa efficacia, ma non ha toccato masse voli e si è disgregato alla prima controoffensiva. Il materialismo storico perciò avrà o potrà avere questa funzione non solo totalitaria come concezione del mondo, ma totalitaria in quanto investirà tutta la società fin dalle sue più profonde radici. Ricordare le polemiche (Gobetti, Missiroli, ecc.) sulla necessità di una riforma, intesa meccanicamente.
Q4 §76 Vittorio Macchioro e l’America. Vittorio Macchioro ha scritto un libro: Roma capta. Saggio intorno alla religione romana, Casa Ed. G. Principato, Messina, in cui tutta la costruzione si basa sulla «povertà fantastica del popolo romano». Nel 1930 è andato in America e ha inviato delle corrispondenze al «Mattino» di Napoli e nella prima (del 7 marzo) ecco il motivo (cfr «Italia letteraria» del 16 marzo 1930): «L’americano non ha fantasia, non sa creare immagini. Non credo che, fuori dell’influenza europea (!), mai ci sarà un grande poeta o un grande pittore americano. La mentalità americana è essenzialmente pratica e tecnica: da ciò una particolare sensibilità per la quantità, cioè per le cifre. Come il poeta è sensibile verso le immagini, o il musicista è sensibile verso i suoni, così l’americano è sensibile verso le cifre. – Questa tendenza a concepire la vita come fatto tecnico, spiega la filosofia americana medesima. Il pragmatismo esce per l’appunto da questa mentalità che non pregia e non afferra l’astratto. James e più ancora Dewey sono i prodotti più genuini di questo inconsapevole bisogno di tecnicismo, per cui la filosofia viene scambiata con l’educazione, e un’idea astratta vale non in se stessa, ma solo in quanto si può tradurre in azione. (“La povertà fantastica del popolo romano avviò i Romani a concepire la divinità come un’energia astratta la quale si estrinseca solo nell’azione”; cfr Roma capta). E per questo l’America è la terra tipica delle chiese e delle scuole, dove la teoreticità si innesta alla vita».
Mi pare che la tesi del Macchioro sia un berretto per tutte le teste.
Q4 §77 Riviste tipo. Una rubrica permanente sulle correnti scientifiche. Ma non per divulgare nozioni scientifiche. Per esporre, criticare e inquadrare le «idee scientifiche» e le loro ripercussioni sulle ideologie e sulle concezioni del mondo e per promuovere il principio pedagogico‑didattico della «storia della scienza e della tecnica come base dell’educazione formativa‑storica nella nuova scuola».
IL CANTO DECIMO DELL’INFERNO
Q4 §78 Quistione su «struttura e poesia» nella Divina Commedia
secondo B. Croce e Luigi Russo. Lettura di Vincenzo Morello come
«corpus vile». Lettura di Fedele Romani su Farinata. De Sanctis.
Quistione della «rappresentazione indiretta» e delle didascalie
nel dramma: le didascalie hanno un valore artistico?
contribuiscono alla rappresentazione dei caratteri? In quanto
limitano l’arbitrio dell’attore e caratterizzano più
concretamente il personaggio dato, certamente. Il caso del Don
Giovanni di Shaw con l’appendice del manualetto di John Tanner:
quest’appendice è una didascalia, da cui un attore intelligente
può e deve trarre elementi per la sua interpretazione. La
pittura pompeiana di Medea che uccide i figli avuti da Giasone:
Medea è rappresentata col viso bendato: il pittore non sa o non
vuole rappresentare quel viso. (C’è però il caso di Niobe, ma in
opera di scultura: coprire il viso avrebbe significato togliere
il contenuto proprio all’opera). Farinata e Cavalcante: il padre
e il suocero di Guido. Cavalcante è il punito del girone.
Nessuno ha osservato che se non si tien conto del dramma di
Cavalcante, in quel girone non si vede in atto il tormento del
dannato: la struttura avrebbe dovuto condurre a una valutazione
estetica del canto piú esatta, poiché ogni punizione è
rappresentata in atto. Il De Sanctis notò l’asprezza contenuta
nel canto per il fatto che Farinata d’un tratto muta carattere:
dopo essere stato poesia diventa struttura, egli spiega, fa da
Cicerone a Dante. La rappresentazione poetica di Farinata è
stata mirabilmente rivissuta dal Romani: Farinata è una serie di
statue. Poi Farinata recita una didascalia. Il libro di Isidoro
del Lungo sulla Cronica di Dino Compagni: in esso è stabilita la
data della morte di Guido. È strano che gli eruditi non abbiano
prima pensato a servirsi del Canto X per fissare
approssimativamente questa data (qualcuno l’ha fatto?) Ma
neanche l’accertamento fatto dal Del Lungo servì a interpretare
la figura di Cavalcante e a dare una spiegazione dell’ufficio
fatto fare da Dante a Farinata.
Qual’è la posizione di Cavalcante, qual’è il suo tormento? Cavalcante vede nel passato e vede nell’avvenire, ma non vede nel presente, in una zona determinata del passato e dell’avvenire in cui è compreso il presente. Nel passato Guido è vivo, nell’avvenire Guido è morto, ma nel presente? è morto o vivo? Questo è il tormento di Cavalcante, il suo assillo, il suo unico pensiero dominante. Quando parla, domanda del figlio; quando sente «ebbe», il verbo al passato, egli insiste e tardando la risposta, egli non dubita più: suo figlio è morto; egli scompare nell’arca infuocata.
Come Dante rappresenta questo dramma? Egli lo suggerisce al lettore, non lo rappresenta; egli dà al lettore gli elementi perché il dramma sia ricostruito e questi elementi sono dati dalla struttura. Tuttavia una parte drammatica c’è e precede la didascalia. Tre battute: Cavalcante appare, non dritto e virile come Farinata, ma umile, abbattuto, forse inginocchiato e domanda dubbiosamente del figlio. Dante risponde, indifferente o quasi e adopera il verbo che si riferisce a Guido al passato. Cavalcante coglie subito questo fatto e urla disperatamente. C’è il dubbio in lui, non la certezza; domanda altre spiegazioni con tre domande in cui c’è una gradazione di stati d’animo. «Come dicesti: egli “ebbe”?» – «Non vive egli ancora?» – «Non fiede gli occhi suoi lo dolce lome?» Nella terza domanda c’è tutta la tenerezza paterna di Cavalcante; la generica «vita» umana è vista in una condizione concreta, nel godimento della luce, che i dannati e i morti hanno perduto. Dante indugia a rispondere e allora il dubbio cessa in Cavalcante. Farinata invece non si scuote. Guido è il marito di sua figlia, ma questo sentimento non ha in lui potere in quel momento. Dante sottolinea questa sua forza d’animo. Cavalcante si affloscia ma Farinata non muta aspetto, non mosse collo, non piega costa. Cavalcante cade supino, Farinata non ha nessun gesto di abbattimento; Dante analizza negativamente Farinata per suggerire i (tre) movimenti di Cavalcante, lo stravolgimento del sembiante, la testa che ricade, il dorso che si piega. Tuttavia c’è qualcosa di mutato anche in Farinata. La sua ripresa non è più così altera come la prima sua apparizione.
Dante non interroga Farinata solo per «istruirsi», egli lo interroga perché è rimasto colpito della scomparsa di Cavalcante. Egli vuole che gli sia sciolto il nodo che gli impedì di rispondere a Cavalcante; egli si sente in colpa dinanzi a Cavalcante. Il brano strutturale non è solo struttura, dunque, è anche poesia, è un elemento necessario del dramma che si è svolto.
Q4 §79 Critica dell’«inespresso»? Le osservazioni da me fatte potrebbero dar luogo all’obbiezione: che si tratti di una critica dell’inespresso, di una storia dell’inesistito, di un’astratta ricerca di plausibili intenzioni mai diventate concreta poesia, ma di cui rimangono tracce esteriori nel meccanismo della struttura. Qualcosa come la posizione che spesso assume il Manzoni nei Promessi Sposi, come quando Renzo, dopo aver errato alla ricerca dell’Adda e del confine, pensa alla treccia nera di Lucia: «... e contemplando l’immagine di Lucia! non ci proveremo a dire ciò che sentisse: il lettore conosce le circostanze: se lo figuri». Si potrebbe anche qui trattare di cercare di «figurarsi» un dramma, conoscendone le circostanze.
L’obbiezione ha una parvenza di verità: se Dante non può immaginarsi, come il Manzoni, ponente dei limiti alla sua espressione per ragioni pratiche (il Manzoni si propose di non parlare dell’amore sessuale e di non rappresentarne le passioni nella loro pienezza, per ragioni di «morale cattolica»), il fatto sarebbe avvenuto per «tradizione di linguaggio poetico», che del resto Dante non avrebbe sempre osservato (Ugolino, Mirra, ecc.), «rincalzato» dai suoi speciali sentimenti per Guido. Ma si può ricostruire e criticare una poesia se non nel mondo dell’espressione concreta, del linguaggio storicamente realizzato? Non un elemento «volontario» dunque, «di carattere pratico o intellettivo» tarpò le ali a Dante: egli «volò con le ali che aveva» per così dire, e non rinunziò volontariamente a nulla.
Su questo argomento del neomaltusianismo artistico del Manzoni cfr il libretto del Croce e l’articolo di Giuseppe Citanna nella «Nuova Italia» del giugno 1930.
Q4 §80 Plinio ricorda che Timante di Sicione aveva dipinto la scena del sacrificio di Ifigenia effigiando Agamennone velato. Il Lessing, nel Laocoonte, per primo (?) riconobbe in questo artificio non l’incapacità del pittore a rappresentare il dolore del padre, ma il sentimento profondo dell’artista che attraverso gli atteggiamenti più strazianti del volto, non avrebbe saputo dare un’impressione tanto penosa d’infinita mestizia come con questa figura velata, il cui viso è coperto dalla mano. Anche nella pittura pompeiana del sacrifizio d’Ifigenia, diversa per la composizione generale dal dipinto di Timante, la figura di Agamennone è velata.
Di queste diverse rappresentazioni del sacrifizio di Ifigenia parla Paolo Enrico Arias nel «Bollettino dell’Istituto Nazionale del dramma antico di Siracusa», articolo riassunto dal «Marzocco» del 13 luglio 1930.
Nelle pitture pompeiane esistono altri esempi di figure velate: es. Medea che uccide i figli. La quistione è stata trattata dopo il Lessing, la cui interpretazione non è completamente soddisfacente?
Q4 §81 La data della morte di Guido Cavalcanti fu fissata criticamente per la prima volta da Isidoro Del Lungo nella sua opera Dino Compagni e la sua Cronica di cui nel 1887 fu pubblicato il «volume terzo, contenente gli indici storico e filologico a tutta l’opera e il testo della “Cronica” secondo il codice Laurenziano Ashburnhamiano»; i volumi I e II furono finiti nel 1880 e stampati poco dopo. Bisogna vedere se il Del Lungo, nel fissare la data della morte di Guido, pone in rapporto questa data con il Canto X: mi pare di ricordare di no. Sullo stesso argomento bisognerebbe vedere del Del Lungo: Dante nei tempi di Dante, Bologna 1888; Dal secolo e dal poema di Dante, Bologna 1898, e specialmente Da Bonifazio VIII ad Arrigo VII, pagine di storia fiorentina per la vita di Dante, che è una riproduzione, riveduta e corretta, e talvolta accresciuta, di una parte dell’opera su Dino Compagni e la sua Cronica.
Q4 §82 Il disdegno di Guido. Nella recensione scritta da G. S. Gargàno (La lingua nei tempi di Dante e L’interpretazione della poesia, «Marzocco», 14 aprile 1929) del libro postumo di Enrico Sicardi, La lingua italiana in Dante (Casa Ed. «Optima», Roma), si riporta l’interpretazione del Sicardi sul «disdegno» di Guido. Così, scrive il Sicardi, dovrebbe interpretarsi il passo: «Io non faccio il viaggio di mia libera scelta; non sono libero di venire o non venire; invece sono qui condotto da colui che m’aspetta lì fermo e col quale il vostro Guido ebbe a disdegno di venire qui, ossia di accompagnarsi qui con lui». L’interpretazione del Sicardi è formale, non sostanziale: egli non si ferma a spiegare in che consista il «disdegno» (o della lingua latina, o dell’imperialismo virgiliano o delle altre spiegazioni date dagli interpreti). Dante ebbe largita la «grazia» dal Cielo: come potevasi concedere la medesima grazia ad un ateo? (ciò non è esatto: perché la «grazia» per la sua stessa natura, non può essere limitata da nessuna ragione). Per il Sicardi nel verso: «Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno» il cui si riferisce certamente a Virgilio, ma non è un complemento oggetto, ma uno dei soliti pronomi a cui manca il segnacaso con. E l’oggetto di ebbe a disdegno? Si ricava dal precedente «da me stesso non vegno» ed è, mettiamo il caso, o il sostantivo venuta o, se si vuole, una proposizione oggettiva: di venire.
Nella sua recensione il Gargàno scrive a un certo punto: «L’amico di Guido dice al povero padre deluso di non veder vivo per l’Inferno anche il suo figliolo ecc.». Deluso? È troppo poco: si tratta di una parola del Gargàno o è ricavata dal Sicardi? Non si pone il problema: ma perché Cavalcante deve proprio aspettarsi che Guido venga con Dante nell’Inferno? «Per l’altezza d’ingegno»? Cavalcante non è mosso dalla «razionalità» ma dalla «passione»: non c’è nessuna ragione perch’é Guido dovesse accompagnare Dante; c’è solo che Cavalcante vuol sapere se Guido in quel momento è vivo o morto ed uscire così dalla sua pena.
La parola più importante del verso: «Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno» non è «cui» o «disdegno» ma è solo ebbe. Su «ebbe» cade l’accento «estetico» e «drammatico» del verso ed esso è l’origine del dramma di Cavalcante, interpretato nelle didascalie di Farinata: e c’è la «catarsi»; Dante si corregge, toglie dalla pena Cavalcante, cioè interrompe la sua punizione in atto.
Q4 §83 Vincenzo Morello. Dante, Farinata, Cavalcante, in 8º, p.
80, ed. Mondadori, 1927. Contiene due scritti: 1) Dante e
Farinata. Il canto X dell’Inferno letto nella «Casa di Dante» in
Roma il XXV aprile MCMXXV e 2) Cavalcanti e il suo disdegno.
Nella scheda bibliografica dell’editore è detto: «Le
interpretazioni del Morello daranno occasione a discussioni fra
gli studiosi, perché si distaccano completamente da quelle
tradizionali, e vengono a conclusioni diverse e nuove». Ma il
Morello aveva una qualsiasi preparazione per questo lavoro e per
questa indagine? Egli inizia il primo scritto così: «La critica
dell’ultimo trentennio ha così profondamente esplorato le
sorgenti (!) dell’opera dantesca, che ormai i sensi più oscuri,
i riferimenti più difficili, le allusioni più astruse e perfino
i particolari più intimi dei personaggi delle Tre Cantiche, si
può dire siano penetrati e chiarificati». Chi si contenta gode!
Ed è molto comodo muovere da una simile premessa: esime dal fare
un proprio lavoro e molto faticoso di scelta e di
approfondimento dei risultati raggiunti dalla critica storica ed
estetica. E continua: «Sì che, dopo la debita preparazione, noi
possiamo oggi leggere ed intendere la Divina Commedia, senza più
smarrirci nei labirinti delle vecchie congetture, che la
incompleta informazione storica e la deficiente disciplina
intellettuale gareggiavano nel costruire e rendere
inestricabili». Il Morello dunque avrebbe fatto la debita
preparazione e sarebbe in possesso di una perfetta disciplina
intellettuale: non sarà difficile mostrare che egli ha letto
superficialmente lo stesso canto X e non ne ha compreso la
lettera più evidente. Il canto X è, secondo il Morello, «per
eccellenza politico» e «la politica, per Dante, è cosa tanto
sacra, quanto la religione», quindi occorre una «disciplina più
che mai rigida» nella interpretazione del canto X per non
sostituire le proprie tendenze e le proprie passioni a quelle
altrui e per non abbandonarsi alle più strane aberrazioni. Il
Morello afferma che il canto X è per eccellenza politico, ma non
lo dimostra e non lo può dimostrare perché non è vero: il canto
X è politico come politica è tutta la Divina Commedia, ma non è
politico per eccellenza. Ma al Morello questa affermazione fa
comodo per non affaticare le sue meningi; poiché egli si reputa
grande uomo politico e grande teorico della politica, gli sarà
facile dare una interpretazione politica del canto X dopo aver
leggiucchiato il canto nella prima edizione venuta alla mano,
servendosi delle idee generali che circolano sulla politica di
Dante e di cui ogni buon giornalista di cartello, come il
Morello, deve avere una qualche infarinatura nonché un certo
numero di schede d’erudizione.
Che il Morello non abbia letto che superficialmente il canto X si vede dalle pagine in cui tratta dei rapporti tra Farinata e Guido Cavalcanti (p. 35). Il Morello vuol spiegare l’impassibilità di Farinata durante lo svolgimento «dell’episodio» di Cavalcante. Ricorda l’opinione del Foscolo, per il quale questa indifferenza dimostra la forte tempra dell’uomo, che «non permette agli affetti domestici di distoglierlo dal pensare alle nuove calamità della patria» e del De Sanctis, per il quale Farinata rimane indifferente, perché «le parole di Cavalcante giungono al suo orecchio, non all’anima, che è tutta fisa in un pensiero unico: l’arte mal appresa». Per il Morello vi può essere «forse una spiegazione più convincente». Cioè: «Se Farinata non muta aspetto, né muove collo, né piega costa, così come il poeta vuole, è, forse, non perché insensibile o non curante del dolore altrui, ma perché ignora la persona di Guido, come ignorava quella di Dante e perché ignora che Guido ha stretto matrimonio con sua figlia. Egli é morto nel 1264, tre anni prima del ritorno dei Cavalcanti a Firenze, quando Guido aveva sette anni; e si fidanzò con Bice all’età di nove anni (1269), cinque anni dopo la morte di Farinata. Se è vero che i morti non possono conoscere da sé i fatti dei vivi, ma soltanto per mezzo delle anime che li avvicinano, o degli angeli o dei demoni, Farinata può non conoscere la sua parentela con Guido e rimanere indifferente alle sorti di lui, se nessuna anima o nessun angelo o demone gliene abbian portata notizia. Cosa che non pare avvenuta». Il brano è strabiliante da parecchi punti di vista e mostra quanto siadeficiente la disciplina intellettuale del Morello. 1) Farinata stesso dice apertamente e chiaramente che gli eresiarchi del suo gruppo ignorano i fatti «quando s’approssiman e son», non sempre, e in ciò consiste la loro punizione specifica oltre l’arca infuocata «per avere voluto vedere nel futuro» e solamente in questo caso «s’altri non ci adduce» essi ignorano. Dunque il Morello non ha neanche letto bene il testo. 2) È proprio da dilettante, nei personaggi di un’opera d’arte, andare a cercare le intenzioni oltre la portata della espressione letterale dello scritto. Il Foscolo e il De Sanctis (specialmente il De Sanctis) non si allontanano dalla serietà critica; il Morello invece pensa realmente alla vita concreta di Farinata nell’Inferno oltre il canto di Dante e pensa persino poco probabile che i demoni o gli angeli abbiano potuto, a tempo perso, informare Farinata di ciò che gli era ignoto. È la mentalità dell’uomo del popolo che quando ha letto un romanzo vorrebbe sapere cosa hanno fatto ulteriormente tutti i personaggi (donde la fortuna delle avventure a catena): è la mentalità del Rosini che scrive la Monaca di Monza o di tutti gli scribacchiatori che scrivono le continuazioni di opere illustri o ne svolgono e amplificano episodi parziali.
Che tra Cavalcante e Farinata vi sia rapporto intimo nella poesia di Dante risulta dalla lettera del Canto e dalla sua struttura: Cavalcante e Farinata sono vicini (qualche illustratore immagina addirittura che siano nella stessa arca), i loro due drammi si intrecciano strettamente e Farinata viene ridotto alla funzione strutturale di «explicator» per far penetrare il lettore nel dramma di Cavalcante. Esplicitamente, dopo l’«ebbe», Dante contrappone Farinata a Cavalcante nell’aspetto fisico‑statuario che esprime la loro posizione morale: Cavalcante cade, si affloscia, né più appare fuori, Farinata «analiticamente» non muta aspetto né muove collo né piega costa.
Ma l’incomprensione della lettera del canto da parte del Morello si rivela anche dove egli parla di Cavalcante, pp. 31 e segg.:
«È rappresentato, in questo canto, anche il dramma della famiglia attraverso lo strazio delle guerre civili; ma non da Dante e da Farinata; sì bene da Cavalcante». Perché «attraverso lo strazio delle guerre civili»? Questa è un’aggiunta cervellotica del Morello. Il doppio elemento, famiglia‑politica, è in Farinata e infatti la politica lo sorregge sotto l’impressione del disastro famigliare della figlia. Ma in Cavalcante solo motivo drammatico è l’amore figliale e infatti egli crolla appena è certo che il figlio è morto. Secondo il Morello, Cavalcante «domanda a Dante piangendo: – Perché mio figlio non è teco? – Piangendo. Questo di Cavalcante si può veramente dire il pianto della guerra civile». Stupidaggine, conseguente all’affermazione che il canto X è «per eccellenza politico». E più oltre: «Guido era vivo all’epoca del mistico viaggio; ma era morto quando Dante scriveva. E dunque di un morto Dante realmente scriveva, non ostante, per la cronologia del viaggio, dovesse infine apprendere al padre il contrario», ecc.: passo che dimostra come il Morello abbia appena sfiorato il contenuto drammatico e poetico del canto e l’abbia, letteralmente, sorvolato nella lettera testuale.
Superficialità piena di contraddizioni perché poi il Morello si ferma sulla predizione di Farinata, senza pensare che se questi eresiarchi possono sapere il futuro, devono sapere il passato, dato che il futuro diventa sempre passato: ciò non lo porta a rileggersi il testo e ad accertarne il significato.
Ma anche la così detta interpretazione politica che il Morello fa del X canto è superficialissima: essa non è altro che la ripresa della vecchia quistione: Dante fu guelfo o ghibellino? Per il Morello, sostanzialmente, Dante fu ghibellino e Farinata è «il suo eroe», solo che Dante fu ghibellino come Farinata, cioè «uomo politico» più che «uomo di parte». Si può, in questo argomento dire tutto ciò che si vuole. In realtà Dante, come egli stesso dice, «fece parte per se stesso»: egli è essenzialmente un «intellettuale» e il suo settarismo e la sua partigianeria sono d’ordine intellettuale più che politico in senso immediato. D’altronde la posizione politica di Dante potrebbe esser fissata solo con un’analisi minutissima non solo di tutti gli scritti di Dante stesso, ma delle divisioni politiche del suo tempo che erano molto diverse da quelle di cinquant’anni prima. Il Morello è troppo irretito nella retorica letteraria per essere in grado di concepire realisticamente le posizioni politiche degli uomini del Medio Evo verso l’Impero, il Papato e la loro repubblica comunale.
Quello che fa sorridere nel Morello è il suo «disdegno» per i commentatori che affiora qua e là come a p. 52, nello scritto Cavalcanti e il suo disdegno dove dice che «la prosa dei commentatori spesso altera il senso dei versi»; ma guarda chi lo dice!
Questo scritto Cavalcanti e il suo disdegno appartiene precisamente a quella letteratura d’appendice intorno alla Divina Commedia, inutile e ingombrante con le sue congetture, le sue sottigliezze, le sue alzate d’ingegno da parte di gente che per avere la penna in mano, si crede in diritto di scrivere di qualunque cosa, sgomitolando le fantasticherie del suo talentaccio.
Q4 §84 Le «rinunzie descrittive» nella Divina Commedia. Da un articolo di Luigi Russo, Per la poesia del «Paradiso» dantesco (nel «Leonardo» dell’agosto 1927), tolgo alcuni accenni alle «rinunzie descrittive» di Dante che, in ogni caso, hanno diversa origine e spiegazione che per l’episodio di Cavalcante. Se ne è occupato A. Guzzo nella «Rivista d’Italia» del 15 novembre 1924, pp. 456‑79 (Il «Paradiso» e la critica del De Sanctis). Scrive il Russo: «Il Guzzo parla delle “rinunzie descrittive” che sono frequenti nel Paradiso: – Qui vince la memoria mia lo ingegno, – Se mò sonasser tutte quelle lingue – ecc., ed egli ritiene che questa è una prova che, dove Dante non può trasfigurare celestialmente la terra, egli “piuttosto rinunzia a descrivere il fenomeno celeste anziché, con astratta e artificiosa fantasia, capovolgere, invertire, violentare l’esperienza” (p. 478). Ora anche qui il Guzzo, come gli altri dantisti, riman vittima di una valutazione psicologica di parecchi versi di quel genere, che ricorrono nel Paradiso. Tipico il caso del Vossler che una volta si servì di queste “rinunzie descrittive” del poeta, come fossero confessioni d’impotenza fantastica, per concludere, sulla testimonianza dell’artista stesso, sull’inferiorità dell’ultima cantica; e, recentemente, nel suo ravvedimento critico, si richiamò invece proprio a quelle rinunzie descrittive, per attribuir loro un valore religioso, quasi il poeta volesse avvertire di tratto in tratto che quello è il regno dell’assoluto trascendente (Die Göttliche Komödie, 1925, II Band, pp. 771‑72). Ora a me pare che mai il poeta riesce tanto espressivo, come in queste sue confessioni di impotenza espressiva, le quali, invero, vanno considerate non nel loro contenuto (che è negativo), ma nel loro tono lirico (che è positivo, e qualche volta iperbolicamente positivo). Quella è la poesia dell’ineffabile; e non bisogna scambiare la poesia dell’ineffabile per ineffabilità poetica» ecc.
Per il Russo non si può parlare di rinunzie descrittive in Dante. Si tratta, in forma negativa, di espressioni piene, sufficienti, di tutto quello che si agita veramente nel petto del poeta.
Il Russo accenna in nota a un suo studio, Il Dante del Vossler e l’Unità poetica della Commedia, nel vol. XII degli «Studi Danteschi» diretti da M. Barbi, ma il richiamo al Vossler si deve riferire ai tentativi di gerarchizzare artisticamente le tre cantiche.
Q4 §85 Nel 1918, in un «Sotto la Mole» intitolato Il cieco Tiresia è pubblicato un cenno dell’interpretazione data in queste della figura di Cavalcante. Nella nota pubblicata nel 1918 si prendeva lo spunto dalla notizia pubblicata dai giornali che una ragazzina, in un paesello d’Italia, dopo aver preveduto la fine della guerra per il 1918 diventò cieca. Il nesso è evidente. Nella tradizione letteraria e nel folclore, il dono della previsione è sempre connesso con l’infermità attuale del veggente, che mentre vede il futuro non vede l’immediato presente perché cieco. (Forse ciò è legato alla preoccupazione di non turbare l’ordine naturale delle cose: perciò i veggenti non sono creduti, come Cassandra; se fossero creduti, le loro previsioni non si verificherebbero, in quanto gli uomini, posti sull’avviso, opererebbero diversamente e i fatti allora si svolgerebbero diversamente dalla previsione ecc.).
Q4 §86 Da una lettera del prof. U. Cosmo (dei primi mesi del 1932) riporto alcuni brani sull’argomento di Cavalcante e Farinata: «Mi pare che l’amico nostro abbia colpito giusto, e qualche cosa che s’avvicinava alla sua interpretazione ho sempre insegnato io. Accanto al dramma di Farinata c’è anche il dramma di Cavalcante, e male hanno fatto i critici, e fanno, a lasciarlo nell’ombra. L’amico farebbe dunque opera ottima a lumeggiarlo. Ma per lumeggiarlo bisognerebbe discendere un po’ più nell’anima medioevale. Ognuno dei due, Farinata e Cavalcante, soffre il suo dramma. Ma il proprio dramma non tocca l’altro. Sono legati dalla parentela dei figli, ma sono di parte avversa. Perciò non si incontrano. È la loro forza come dramatis personae, è il loro torto come uomini. Più difficile mi pare provare che l’interpretazione lede in modo vitale la tesi del Croce sulla poesia e la struttura della Commedia. Senza dubbio anche la struttura dell’opera ha valore di poesia. Con la sua tesi il Croce riduce la poesia della Commedia a pochi tratti e perde quasi tutta la suggestione che si sprigiona da essa. Cioè perde quasi tutta la sua poesia. La virtù della grande poesia è di suggerire più che non dica e suggerire sempre cose nuove. Di qui la sua eternità. Bisognerebbe dunque mettere bene in chiaro che tale virtù di suggestione che promana dal dramma di Cavalcante promana dalla struttura dell’opera (la previsione dei dannati del futuro e l’ignoranza del presente, il loro essere in quel determinato cono d’ombra, come dice assai felicemente l’amico, l’essere nella stessa tomba (!?) i due sofferenti, l’essere legati da quelle determinate leggi costruttive). Tutte parti della struttura che diventano fonte di poesia. Togliete queste e la poesia svanisce. – Per raggiungere più sicuro l’effetto, mi pare, sarebbe bene riprovare la tesi con qualche altro esempio. Io, scrivendo del Paradiso, sono arrivato alla conclusione che dove la costruzione è debole, è debole anche la poesia... Ma più efficace sarebbe forse di cercare la riprova in qualche episodio plastico dell’Inferno o del Purgatorio. Penso dunque che l’amico farebbe assai bene a svolgere con il rigore del suo raziocinio e la chiarezza della sua espressione la sua tesi. Il ravvicinamento con le Didascalie dei drammi propriamente detti è arguto e può illuminare. Ti soggiungo qualche indicazione bibliografica più facile. Lo studio del Russo si può vedere completo in L. Russo, Problemi di metodo critico, Bari, Laterza, 1929.
Nella «Critica» sarebbe bene vedere ciò che scrisse l’Arangio Ruiz («Critica», XX, 340‑57). L’articolo è dichiarato dal Barbi «bellissimo». Pretensioso nella sua filosofica sicumera, lo studio di Mario Botti (Per lo studio della genesi della poesia dantesca. La seconda cantica: poesia e struttura nel poema) in «Annali dell’Istruzione media», 1930, pp. 432‑73. Il Barbi se ne occupa, ma non dice nulla di nuovo, nell’ultimo fascicolo degli «Studi Danteschi» (XVI, pp. 47 sgg.), Poesia e struttura nella Divina Commedia. Per la genesi dell’ispirazione centrale della Divina Commedia. Anche il Barbi, in uno studio Con Dante e coi suoi interpreti (vol. XV, «Studi Danteschi»), passa in rivista le ultime interpretazioni del canto di Farinata. E pure il Barbi pubblicò un suo commento nel vol. VIII degli «Studi Danteschi».
Ci sarebbe da osservare molte cose su queste del prof. Cosmo.
Q4 §87 Poiché occorre infischiarsi del gravissimo compito di far progredire la critica dantesca o di portare la propria pietruzza all’edifizio commentatorio e chiarificatorio del divino poema ecc., il modo migliore di presentare queste osservazioni sul Canto decimo pare debba proprio essere quello polemico, per stroncare un filisteo classico come Rastignac [Vincenzo Morello], per dimostrare, in modo drastico e fulminante, e sia pure demagogico, che i rappresentanti di un gruppo sociale subalterno possono far le fiche, scientificamente e come gusto artistico, a ruffiani intellettuali come Rastignac. Ma Rastignac conta meno di un fuscello nel mondo culturale ufficiale! Non ci vuole molta bravura per mostrarne l’inettitudine e la zerità. Ma intanto la sua conferenza è stata tenuta alla Casa di Dante romana: da chi è diretta questa Casa di Dante della città eterna? Anche la Casa di Dante e i suoi dirigenti contano nulla? E se contano nulla perché la grande cultura non li elimina? E come è stata giudicata la conferenza dai dantisti? Ne ha parlato il Barbi, nelle sue rassegne degli «Studi Danteschi» per mostrarne la deficienza ecc.? Eppoi, piace poter prendere per il bavero un uomo come Rastignac e servirsene da palla per un gioco solitario del calcio.
Q4 §88 Shaw e Gordon Craig. Polemica tra i due sul teatro. Shaw difende le sue didascalie lunghissime come aiuto non alla rappresentazione ma alla lettura. Secondo Aldo Sorani («Marzocco» del 1° novembre 1931) queste didascalie dello Shaw «sono precisamente il contrario di quel che Gordon Craig desidera e richiede come atto a ridar vita sulla scena alla fantasia dell’autore drammatico, a ricreare quell’atmosfera da cui l’opera d’arte è sorta e si è imposta allo stesso autore»Il resto della pagina 7 bis è rimasto inutilizzato.
Finisce qui il gruppo di comprese sotto il titolo Il canto decimo dell’Inferno.
Q4 §89 Argomenti di cultura. Una serie di studi sul giornalismo delle capitali più importanti degli Stati del mondo seguendo questi criteri: 1) Esame dei giornali quotidiani che in un giorno determinato escono in una capitale (Londra, Parigi, Madrid, ecc.) per avere un termine omogeneo di comparazione, cioè la relativa somiglianza degli avvenimenti che riflettono in modo vario, a seconda dei partiti o tendenze di partito che rappresentano. Ma poiché il tipo di giornale non può essere conosciuto nell’esemplare di una sola giornata, occorrerà procurarsi gli esemplari di una settimana o del periodo in cui appaiono certe rubriche specializzate, certi supplementi, il cui complesso permette di comprendere la fortuna presso gli assidui, ecc. 2) Esame di tutta la stampa periodica, di ogni specie, (da quella sportiva a quella enigmistica, al bollettino parrocchiale) che completa l’esame dei quotidiani. Informazioni sulla tiratura, sul personale, sulla direzione, sui proventi della pubblicità.
Insomma si dovrebbe ricostruire per ogni capitale l’insieme delle forze ideologiche che operano continuamente e simultaneamente nelle pubblicazioni periodiche di ogni genere. Rapporto dei giornali della capitale con quelli provinciali in genere. Bisogna tener conto per certi paesi, dell’esistenza di altri centri dominanti oltre la capitale, come Milano in Italia, Barcellona in Spagna, Monaco in Germania, Manchester in Inghilterra (e Glasgow), ecc.
Q4 §90 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. Monsignor Ugo Mioni, scrittore di romanzacci a serie di avventure per i giovanetti, era un tempo gesuita e ora non lo è più. Oggi appartiene certamente agli integralisti, come appare dalla recensione, pubblicata nella «Civiltà Cattolica» del 20 agosto 1932 del suo Manuale di sociologia (Torino, Marietti, 1932, in 16°, pp. 392, L. 12). Nella recensione si osserva che nel Manuale «traspare qua e là una diffidenza soverchia del nuovo, vero o presunto che sia». A pag. 121 si inveisce contro la diffusione della cultura: “Perché non vi potrebbe essere qualche analfabeta? ve ne furono tanti e tanti nei secoli passati; i quali vissero tranquilli, sereni e felici!... È poi tanto necessaria la cultura intellettuale e scientifica dei cittadini? Di alcuni, di parecchi, sì... Per tutti? No”». «A pag. 135 si legge che: “la sociologia cristiana è ostile a ogni partecipazione della donna alla vita pubblica”». La «Civiltà Cattolica» nega questa affermazione perentoria e ricorda che «una delle scuole oggi più rinomate della Sociologia cristiana (Le settimane sociali francesi) è tutt’altro che ostile alla partecipazione, di cui ha tanto orrore il nostro Autore». Cita anche il Précis de la doctrine sociale catholique (Editions Spes, p. 129) del gesuita Ferdinando Cavallera, prof. dell’Istituto di Tolosa, dove è scritto: «La partecipazione della donna alla vita pubblica non solleva alcuna obbiezione dal punto di vista cattolico». La «Civiltà Cattolica» rimprovera al Mioni di aver obliato nel suo trattato la vita internazionale che «ha oggi così decisiva importanza anche nelle questioni sociali» e di non aver fatto alcun cenno, parlando della tratta delle bianche, di quanto si è fatto di recente a Ginevra in una speciale commissione della Società delle nazioni.
L’opposizione al trattato del Mioni è dunque radicale. Questo trattato del Mioni può assumersi come uno dei documenti più importanti ideologici del cattolicismo integrale e ultrareazionario.
Q4 §91 Carattere cosmopolita degli intellettuali italiani. Da un articolo di Arturo Pompeati (Tre secoli d’italianismo in Europa, «Marzocco» del 6 marzo 1932) sul volume di Antero Meozzi: Azione e diffusione della letteratura italiana in Europa (sec. XV‑XVII), Pisa, Vallerini, 1932, in 8°, pp. XXXII‑304. È il primo volume di una serie. Il libro è composto di tre lunghi capitoli: Gli Italiani all’Estero, Stranieri in Italia, Le vie di diffusione dell’italianesimo. Capitolo per capitolo le suddivisioni sono metodiche: paese per paese le correnti, i gruppi, gli scrittori e non scrittori migrati dall’Italia o in Italia: e nell’ultimo capitolo i traduttori, i divulgatori, gli imitatori della nostra letteratura, genere per genere, autore per autore. Il libro ha l’andamento di un repertorio di nomi, a cui nelle corrisponde la bibliografia relativa. Ci sono così i materiali della «egemonia» letteraria italiana, durata appunto tre secoli, dal XV al XVII, quando è cominciata la reazione antitaliana: dopo non si può più parlare di influssi italiani in Europa (l’espressione «egemonia» è qui errata, perché gli intellettuali italiani non esercitarono l’influsso come gruppo nazionale, ma ogni individuo direttamente e per emigrazione di massa). Il Pompeati elogia il libro del Meozzi, sia per la raccolta dei materiali, sia per i criteri di ricerca e per l’ideologia moderata. È evidente che per molti aspetti il Meozzi si pone dei problemi inesistenti o retorici.
Molto severo è invece il Croce nella «Critica» del maggio 1932. Per il Croce il libro del Meozzi è una futilità inutile, una raccolta arida di nomi e di notizie né nuove né peregrine. «L’autore ha compilato da libri ed articoli notissimi, e, non avendo seguito ricerche originali in alcuno dei vari campi da lui toccati, non essendo pratico di essi, ha compilato senza discernimento». «Anche la materiale esattezza delle notizie e delle citazioni lascia assai da desiderare». Il Croce dà un mazzetto di errori di fatto e di metodo molto gravi. Tuttavia il libro del Meozzi potrebbe essere utile per questa rubrica come materiale di prima approssimazione.
Q4 §92 Argomenti di Cultura. L’influsso della cultura araba in Occidente. Ezio Levi ha pubblicato in volume Castelli di Spagna una serie di articoli pubblicati sparsamente nelle riviste e riguardanti i rapporti di cultura tra gli Arabi e l’Europa, realizzati specialmente attraverso la Spagna, dove gli studi di arabistica sono numerosi e contano molti specialisti. Nel «Marzocco» del 29 maggio 1932 recensisce la introduzione al libro L’eredità dell’Islam di Angel Gonzalez Palencia (l’introduzione è uscita in opuscolo: El Islam y Occidente, Madrid 1931) ed enumera tutta una serie di prestiti fatti dall’Islam all’Europa nella cucina: frutta, liquori, ecc.; nella medicina, nella chimica, ecc. Il libro del Gonzalez Palencia deve essere molto interessante per lo studio della civiltà europea e del contributo ad essa dato dagli Arabi.
Q4 §93 Intellettuali. relle sulla cultura inglese. Guido Ferrando, in un articolo del «Marzocco» (17 aprile 1932, Libri nuovi e nuove tendenze nella cultura inglese) analizza i mutamenti organici che si stanno verificando nella cultura moderna inglese, e che hanno le loro manifestazioni più vistose nel campo editoriale e nell’organizzazione complessiva degli istituti universitari del Regno Unito. «... in Inghilterra si va sempre più accentuando un orientamento verso una forma di cultura tecnica e scientifica, a scapito della cultura umanistica».
«In Inghilterra, fino a tutto il secolo scorso, si potrebbe quasi dire fino alla guerra mondiale, il fine educativo più alto che si proponevano le migliori scuole era quello di formare il gentleman. La parola gentleman, come tutti sanno, non corrisponde a gentiluomo italiano; e non può esser resa con precisione nella nostra lingua; indica una persona che abbia non solo buone maniere, ma che possegga un senso di equilibrio, una padronanza sicura di se stesso, una disciplina morale che gli permetta di subordinare volontariamente il proprio interesse egoistico a quelli più vasti della società in cui vive».
«Il gentleman è dunque la persona colta, nel significato più nobile del termine, se per cultura intendiamo non semplicemente ricchezza di cognizioni intellettuali, ma capacità di compiere il proprio dovere e di comprendere i propri simili, rispettando ogni principio, ogni opinione, ogni fede che sia sinceramente professata. È chiaro quindi che l’educazione inglese mirava non tanto a coltivare la mente, ad arricchirla di vaste cognizioni, quanto a sviluppare il carattere, a preparare una classe aristocratica la cui superiorità morale veniva istintivamente riconosciuta ed accettata dalle classi più umili. L’educazione superiore o universitaria, anche perché costosissima, era riservata ai pochi, ai figli di famiglie grandi per nobiltà o per censo, senza per questo esser del tutto preclusa ai più poveri, purché riuscissero, per virtù d’ingegno, a vincere una borsa di studio. Gli altri, la grande maggioranza, dovevano accontentarsi di un’istruzione, buona senza dubbio, ma prevalentemente tecnica e professionale, che li preparava per quegli uffici non direttivi, che sarebbero stati più tardi chiamati a coprire nelle industrie, nel commercio, nelle pubbliche amministrazioni».
Fino a qualche decennio fa esistevano in Inghilterra solo tre grandi università complete, Oxford, Cambridge e Londra, e una minore a Durham. Per entrare a Oxford e a Cambridge bisogna venire dalle così dette public schools che sono tutto, tranne che pubbliche. La più celebre di queste scuole, quella di Eton, fu fondata nel 1440 da Enrico VI per accogliere «settanta scolari poveri e indigenti» ed è diventata oggi la più aristocratica scuola dell’Inghilterra, con più di mille allievi; ci sono ancora i settanta posti interni che danno diritto all’istruzione e al mantenimento gratuito e vengono assegnati per concorso ai ragazzi più studiosi; gli altri sono esterni e pagano somme enormi. «I settanta collegiali... son quelli che poi all’università si specializzeranno e diventeranno i futuri professori e scienziati; gli altri mille, che in genere studiano meno, ricevono un’educazione soprattutto morale e diventeranno, attraverso il crisma universitario, la classe dirigente, destinata ad occupare i più alti posti nell’esercito, nella marina, nella vita politica, nell’amministrazione pubblica».
«Questa concezione dell’educazione, che è prevalsa finora in Inghilterra, è a base umanistica». Nella maggior parte delle public schools e nelle università di Oxford e Cambridge che hanno mantenuto la tradizione del Medio Evo e del Rinascimento, «la conoscenza dei grandi autori greci e latini viene ritenuta non solo utile, ma indispensabile per la formazione del gentleman, dell’uomo politico: serve a dargli quel senso di equilibrio, di armonia, quella raffinatezza di gusto che sono elemento integrante della vera cultura». L’educazione scientifica sta prendendo il sopravvento. «La cultura si va democratizzando e fatalmente livellando». Negli ultimi trenta o quaranta anni sono sorte nuove università nei grandi centri industriali, Manchester, Liverpool, Birmingham, Sheffield, Leeds, Bristol; il Galles volle la sua università e la fondò a Bangor, con ramificazioni a Cardiff, Swansea e Aberystwyth. Dopo la guerra e in questi ultimi anni le università si sono ancora moltiplicate; a Hull, a New Castle, a Southampton, a Exeter, a Reading e se ne annunziano altre due, a Nottingham e a Leicester. In tutti questi centri la tendenza è di dare alla cultura un carattere prevalentemente tecnico per soddisfare le richieste del gran pubblico degli studiosi. Le materie che più interessano sono, oltre le scienze applicate, fisica, chimica ecc., quelle professionali, medicina, ingegneria, economia politica, sociologia ecc. «Anche Oxford e Cambridge hanno dovuto far delle concessioni, e sviluppare sempre più la parte scientifica»; inoltre esse hanno istituito gli Extension Courses.
Il movimento verso la nuova cultura è generale: sorgono scuole e istituzioni private, serali, per adulti, con un insegnamento ibrido ma essenzialmente tecnico e pratico. Sorge intanto tutta una letteratura scientifica popolare. Infine l’ammirazione per la scienza è tanta che anche i giovani delle classi colte ed aristocratiche considerano gli studi classici come un inutile perditempo. Il fenomeno è mondiale. Ma l’Inghilterra aveva resistito più a lungo di altri e ora si orienta verso una forma di cultura prevalentemente tecnica. «Il tipo del perfetto gentleman non ha più ragione di essere; rappresentava l’ideale dell’educazione inglese, quando la Gran Bretagna, dominatrice dei mari e padrona dei grandi mercati del mondo, poteva permettersi il lusso di una politica di splendido isolamento, e di una cultura che aveva in sé, indubbiamente, una nota aristocratica. Oggi le cose son mutate». Perdita della supremazia navale e commerciale; dall’America è minacciata anche nella propria cultura. Il libro americano è stato commercializzato con la cultura e diventa un competitore sempre più minaccioso del libro inglese. Gli editori britannici, specialmente quelli che hanno succursali in America, hanno dovuto adottare i metodi di propaganda e di diffusione americani. «In Inghilterra il libro, appunto perché più letto e diffuso che da noi, esercita un’efficacia formativa ed educativa notevole, e rispecchia più fedelmente che da noi la vita intellettuale della nazione». In questa vita intellettuale sta avvenendo un mutamento.
Dei volumi pubblicati nel primo trimestre del 1932 (che numericamente sono cresciuti in confronto al 1° trimestre del 31), il romanzo mantiene il primo posto; il secondo posto non è più dei libri per bambini, ma dei libri pedagogici ed educativi in genere e c’è un sensibile aumento nelle opere storiche e biografiche e nei volumi di carattere tecnico e scientifico, soprattutto popolare.
Dai volumi inviati alla Fiera Internazionale del Libro a Firenze «noi vediamo che i recenti libri di carattere culturale sono più tecnici che educativi, tendono a discutere questioni scientifiche e aspetti della vita sociale, o a fornire cognizioni pratiche, più che a formare il carattere».
Q4 §94 Concordato. Il Direttore generale del Fondo per il culto Raffaele Jacuzio ha pubblicato un Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica con prefazione di Alfredo Rocco (Torino, Utet, 1932, in 8°, pp. 693, L. 60); dove raccoglie e commenta tutti gli atti sia degli organi statali italiani che di quelli vaticaneschi per la messa in esecuzione del Concordato. Accennando alla quistione dell’Azione Cattolica, lo Jacuzio scrive (p. 203): «Ma poiché nel concetto di politica non rientra soltanto la tutela dell’ordinamento giuridico dello Stato, ma anche tutto quanto si attiene alle provvidenze di ordine economico sociale, è ben difficile... ritenere nell’Azione cattolica a priori esclusa ogni azione politica, quando... si fanno rientrare in essa l’azione sociale ed economica e l’educazione spirituale della gioventù».
Q4 §95 Storia delle classi subalterne. Pietro Ellero, La quistione sociale, Bologna 1877.
QUADERNO 5
Q5 §1 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. «I cattolici integrali» ebbero una certa fortuna durante il papato di Pio X. Rappresentavano una tendenza europea del cattolicismo, ma naturalmente furono più diffusi in certi paesi (Italia, Francia, Belgio; nel Belgio, durante l’invasione, i tedeschi trovarono e pubblicarono una certa quantità di documenti degli «integrali» i quali avevano costituito una specie di società segreta, con cifre, fiduciari, pubblicazioni clandestine ecc.; a capo del movimento era monsignor Umberto Benigni e una parte dell’organizzazione era costituita dal «Sodalitium Pianum» – «Pianum» da Pio, che poi non era neanche Pio X, mi pare, ma un altro papa ancor più intransigente). Monsignor Benigni, i cui rapporti attuali con la Chiesa mi sono ignoti, ha scritto un’opera di ampiezza colossale, La Storia sociale della Chiesa, di cui sono usciti 4 volumi di oltre 600 pp. l’uno, in gran formato presso l’editore Hoepli. Gli integrali appoggiavano in Francia il movimento dell’Action Française, erano contro il Sillon e contro ogni modernismo politico dei cattolici, oltre che contro ogni modernismo religioso. Di fronte ai gesuiti prendevano un atteggiamento di carattere «giansenistico», cioè di grande rigore morale e religioso, contro ogni lassismo, opportunismo o centrismo. I gesuiti naturalmente li accusarono di giansenismo e, ancor di più, li accusarono di fare il gioco dei modernisti: 1°) per la loro lotta contro i gesuiti; 2°) perché allargavano talmente il concetto di modernismo e quindi ampliavano talmente il bersaglio, da permettere ai modernisti un campo di manovra comodissimo. Di fatto poi avveniva che nella loro comune lotta contro i gesuiti, integrali e modernisti si trovassero obbiettivamente nello stesso terreno e magari collaborassero effettivamente tra loro.
Cosa rimane oggi dei modernisti e degli integrali? È difficile identificare la loro forza oggettiva nella Chiesa ma certamente essi sono «fermenti» che continuano ad operare, in quanto rappresentano la lotta contro i gesuiti e il loro strapotere, lotta condotta da elementi di destra e da elementi di sinistra. A queste forze interne alla Chiesa conviene avere questi due centri «esterni», con pubblicazioni periodiche e edizioni di opuscoli e di libri; tra questi centri e quelle forze esistono collegamenti clandestini che diventano il canale delle ire, delle denunzie, dei pettegolezzi e tengono sempre viva la lotta contro i gesuiti. Ciò dimostra che la forza coesiva della Chiesa è minore di ciò che si pensa: specialmente la lotta contro il modernismo ha demoralizzato il giovine clero, che non esitava a prestare il giuramento anti-modernista, pur continuando ad essere modernista. (Ricordare gli ambienti torinesi dei preti e religiosi regolari – anche domenicani – prima della guerra).
Da un articolo di padre Rosa nella «Civiltà Cattolica» del 21 luglio 1928 (Risposta ad «Una polemica senza onestà e senza legge») tolgo alcune indicazioni:
Monsignor Benigni continua ad avere una notevole organizzazione: a Parigi Récalde ‑ Luc Verus ‑ Simon (Luc Verus è uno pseudonimo collettivo degli «integrali») pubblicano una collezione intitolata Vérités.
Il Rosa cita l’opuscolo Les découvertes du jésuite Rosa, successeur de Von Gerlach, Paris, Linotypie G. Dosne, 20 Rue Turgot, 1928, che attribuisce al Benigni almeno per il materiale. I gesuiti sono accusati di essere «amici dei massoni e dei giudei», sono chiamati «demagoghi e rivoluzionari» ecc.
A Roma il Benigni si serve dell’Agenzia Urbs o Romana e firma le sue pubblicazioni col nome di suo nipote Mataloni. Il bollettino romano del Benigni si intitolava «Veritas» (esce ancora?) Nel (28 stesso?) il Benigni ha pubblicato un opuscolo, Di fronte alla calunnia, di poche pagine, con documenti che concernono il Sodalizio Piano, opuscolo che è stato riprodotto in parte e difeso da due periodici cattolici, «Fede e Ragione» e la «Liguria del Popolo» (di Genova).
In passato il Benigni stampava una pubblicazione petiodica, «Miscellanea di storia ecclesiastica». Buonaiuti e i modernisti. L’opuscolo Una polemica senza onestà e senza legge contro il padre Rosa è del Buonaiuti. Il padre Rosa parla del recente libro di Buonaiuti Le Modernisme catholique pubblicato nella collezione «Le Christianisme» diretta da P. L. Couchoud presso «les editions Rieder» (è il n. 21 della collezione e costa 12 fr.): questo libro sarebbe interessante perché il Buonaiuti vi affermerebbe alcuni fatti che aveva sempre negato durante la polemica modernista. Il Buonaiuti fu autore della campagna modernistica del «Giornale d’Italia». Il Benigni organizzò il servizio stampa contro i modernisti al tempo dell’Enciclica Pascendi.
Nelle sue «Ricerche religiose» (luglio 1928, p. 335) il Buonaiuti racconta un episodio caratteristico. Nel 1909 il modernista prof. Antonino De Stefano (attualmente prete spretato e professore d’Università) doveva pubblicare a Ginevra una «Revue moderniste internationale»; Buonaiuti gli scrive una lettera. A poche settimane di distanza è chiamato al Santo Uffizio. L’assessore del tempo, il domenicano Pasqualigo, gli contestò parola per parola la lettera al De Stefano. La lettera era stata trafugata a Ginevra: un emissario romano si era «traforato» in casa De Stefano.
Naturalmente per Buonaiuti, Benigni è stato uno strumento e un complice dei gesuiti. (Buonaiuti però collaborò alla «Miscellanea» del Benigni nel 1904).
Su questo argomento, Cattolici inlegrali, gesuiti, modernisti, che rappresentano le tre principali sezioni del cattolicismo politico, cioè sono le forze che si contendono l’egemonia nella Chiesa romana, occorre raccogliere tutto il materiale possibile e costruire la bibliografia essenziale. (La collezione della «Civiltà Cattolica» dal 1900 in poi sarebbe da consultare). (Così la collezione delle «Ricerche religiose» di Buonaiuti e della «Miscellanea» del Benigni nonché la collezione di opuscoli d’occasione delle tre correnti).
Q5 §2 Rotary Club. Atteggiamento contrario, pur con alcune cautele, dei gesuiti della «Civiltà Cattolica». La Chiesa come tale non ha ancora preso un atteggiamento a proposito del Rotary Club. I gesuiti rimproverano al Rotary i suoi legami col protestantesimo e con la massoneria: vedono in esso uno strumento dell’americanismo, quindi di una mentalità anticattolica, per lo meno. Il Rotary però non vuole essere confessionale né massonico: nelle sue file possono entrare tutti, massoni, protestanti, cattolici – in qualche posto vi hanno aderito anche degli arcivescovi cattolici; il suo programma essenziale pare sia la diffusione di un nuovo spirito capitalistico, cioè l’idea che l’industria e il commercio, prima di essere un affare, sono un servizio sociale, anzi sono e possono essere un affare in quanto sono un «servizio». Il Rotary cioè vorrebbe che fosse superato il «capitalismo di rapina» e che si instaurasse un nuovo costume, più propizio allo sviluppo delle forze economiche. L’esigenza che il Rotary esprime si è manifestata in America in forma gravissima recentemente, mentre in Inghilterra era già stata superata, creando una certa media di «onestà» e «lealtà» negli affari. Perché proprio il Rotary Club si è diffuso fuori dell’America e non un’altra delle tante forme di associazione che vi pullulano e vi costituiscono un superamento delle vecchie forme religiose positive? La causa deve essere cercata in America stessa: forse perché il Rotary ha organizzato la campagna per l’Open Shop e quindi per la razionalizzazione.
Dall’articolo Rotary Club e Massoneria (nella «Civiltà Cattolica» del 21 luglio 1928) tolgo alcune informazioni:
Il Rotary, sorto come istituzione nazionale, nel 1910, si costituì in associazione internazionale con un versamento di capitale a fondo perduto, fatto in conformità con le leggi dello Stato di Illinois. Il presidente del Rotary internazionale è Mister Harr Rogers. Il presidente dei clubs italiani è Felice Seghezza. L’«Osservatore Romano» e la «Tribuna» si posero il problema se il Rotary sia un’emanazione massonica. Il Seghezza mandò una lettera («Tribuna», 16 febbraio 1928) protestando e dichiarando infondato ogni sospetto: la «Tribuna», postillando la lettera, scrisse tra l’altro: «Sono ... gli incerti di tutte le organizzazioni internazionali, le quali spesso hanno apparenze perfettamente innocue e legittime, ma possono anche assumere sostanze ben differenti. La sezione italiana del Rotary può sentirsi perfettamente libera di massoneria e in piena regola col Regime; ma questo non significa che il Rotary altrove non sia diverso. E se è, e altri lo afferma, noi non possiamo né dobbiamo ignorarlo».
Il «Codice morale rotariano». Nel Congresso generale tenuto nel 1928 a St. Louis fu deliberato questo principio: «Il Rotary è fondamentalmente una filosofia della vita che si studia di conciliare l’eterno conflitto esistente fra il desiderio del proprio guadagno e il dovere e il conseguente impulso di servire al prossimo. Questa filosofia è la filosofia del servizio: Dare di sé prima di pensare a sé, fondata sopra quel principio morale: Chi meglio serve guadagna di più». Lo stesso congresso deliberò che tutti i soci del Rotary devono accettare «senza giuramento segreto, senza dogma né fede, ma ognuno a modo suo, tale filosofia rotariana del servizio». La «Civiltà Cattolica» riporta questo brano del rotariano comm. Mercurio da «Il Rotary», pp. 97‑98, che dice citato, ma non lo è in questo numero (non so se il Mercurio sia italiano e «Il Rotary» una pubblicazione italiana, oltre alla «Realtà» diretta dal Bevione): «A questo modo si è fatto, per così dire, dell’onestà un interesse e si è creata quella nuova figura dell’uomo di affari il quale sappia associare in tutte le attività professionali, industriali, commerciali, all’interesse proprio l’interesse generale, che è in fondo il vero e grande fine di ogni operosità, perché ogni uomo nobilmente operoso anche inconsciamente serve sopra tutto l’utile generale».
Il carattere prevalente dato dal Rotary all’attività pratica appare da altre citazioni monche e allusive della «Civiltà Cattolica». Nel Programma del Rotary: «un Rotary club è un gruppo di rappresentanti di affari e di professionisti, i quali senza giuramenti segreti, né domma, né Credo... accettano la filosofia del servizio». Esce un «Annuario» italiano del Rotary, a Milano presso la Soc. An. Coop. «Il Rotary». È uscito almeno l’«Annuario» 1927‑28.
Filippo Tajani nel «Corriere della Sera» del 22 giugno 1928 ha scritto che il Rotary è fra «le istituzioni internazionali che tendono, sebbene per vie amichevoli, alla soluzione dei problemi economici e industriali comuni». Su 2639 clubs rotariani esistenti (al momento dell’articolo), 2088 erano negli Stati Uniti, 254 nell’Inghilterra, 85 nel Canadà, 18 in Italia, 13 in Francia, 1 in Germania, 13 In Ispagna, 10 in Isvizzera, 20 a Cuba, 15 nell’Australia, 19 nel Messico e molto meno in altri paesi. (Il Rotary Club non può essere confuso con la Massoneria tradizionale, specialmente con quella dei paesi latini. È un superamento organico della Massoneria e rappresenta interessi più concreti e precisi. Carattere fondamentale della Massoneria è la democrazia piccolo‑borghese, il laicismo, l’anticlericalismo ecc. Il Rotary è organizzazione di classi alte, e non si rivolge al popolo, altro che indirettamente. È un tipo di organizzazione essenzialmente moderna. Che ci siano interferenze tra la Massoneria e il Rotary è possibile e probabile, ma non è essenziale: il Rotary, sviluppandosi, cercherà di dominare tutte le altre organizzazioni e anche la Chiesa cattolica così come in America domina certamente tutte le Chiese protestanti. Certo la Chiesa cattolica non potrà vedere di buon grado «ufficialmente» il Rotary, ma pare difficile che assuma nei suoi riguardi un atteggiamento come quello contro la Massoneria: dovrebbe allora atteggiarsi contro il capitalismo ecc. Lo sviluppo del Rotary è interessante sotto molti aspetti: ideologici, pratici, organizzativi ecc. Bisognerà vedere però se la depressione economica americana e mondiale non darà un colpo al prestigio dell’americanismo e quindi al Rotary).
Q5 §3 Owen, Saint‑Simon e le scuole infantili di Ferrante Aporti. Da un articolo La questione delle scuole infantili e dell’abate Aporti secondo nuovi documenti («Civiltà Cattolica» del 4 agosto 1928) appare che i gesuiti e il Vaticano nel 1836 erano contrari all’apertura di asili infantili a Bologna del tipo sostenuto da F. Aporti perché tra i sostenitori c’era «un certo Dottor Rossi», «in fama di essere fautore del sansimonismo, allora molto rumoroso in Francia e assai temuto pure in Italia, forse anche più di quanto si meritava» (p. 221). L’arcivescovo di Bologna, richiamando l’attenzione della Santa Sede sulla propaganda e distribuzione di opuscoli che si faceva per gli asili infantili, scriveva: «in sé stessa l’opera potrebbe essere buona, ma che temeva assai per certe persone che sono a capo dell’impresa e per il grande impegno che mostrano... che l’autore di queste scuole è un certo Roberto Owen protestante, come v’era riferito nella “Guida dell’educatore” del prof. Lambruschini che stampasi a Firenze, nel n. 2 febbraio 1836, pag. 66» (p. 224).
Il consultore del Santo Uffizio, P. Cornelio Everboeck, gesuita, nel febbraio 1837 diede il suo parere sugli asili all’assessore del Santo Uffizio, Mons. Cattani: è uno studio di 48 grandi e fitte pagine, dove si comincia esaminando la dottrina e il metodo dei sansimoniani e conclude che il metodo delle nuove scuole è infetto, o almeno sospettosissimo, della dottrina e della massima di panteismo e sansimonismo, ne consiglia la condanna e propone un’Enciclica contro la setta e la dottrina dei sansimonisti (p. 227). Lo scrittore della «Civiltà Cattolica» riconosce che mentre la prima parte del parere, contro il sansimonismo in generale come dottrina, mostra «lo studio e l’erudizione del consultore», la seconda parte invece, che dovrebbe dimostrare l’infiltrazione del sansimonismo nella nuova forma di scuole, è molto più breve e più debole, «manifestamente inspirata e in parte sviata dalla notizia e dalla persuasione» degli informatori di Bologna che vi avevano visto e denunziato i metodi, lo spirito o il pericolo del sansimonismo francese. La Congregazione del Santo Uffizio non insistette sul pericolo del sansimonismo ma proibì gli opuscoli e le scuole con quel metodo. Quattro consultori ancora consigliarono l’Enciclica contro il sansimonismo.
Q5 §4 Sansimonismo, Massoneria, Rotary Club. Sarebbe interessante una ricerca su questi nessi ideologici: le dottrine dell’americanismo e il sansimonismo hanno molti punti di contatto, indubbiamente, mentre invece il sansimonismo mi pare abbia influito poco sulla massoneria, almeno per ciò che riguarda il nucleo più importante delle sue concezioni: poiché il positivismo è derivato dal sansimonismo e il positivismo è stato un momento dello spirito massonico, si troverebbe un contatto indiretto. Il Rotarismo sarebbe un sansimonismo di destra moderno.
Q5 §5 Azione sociale cattolica. Nella Relazione presentata da Albert Thomas alla Conferenza Internazionale del lavoro (l’undecima) del 1928, è contenuta una esposizione delle manifestazioni fatte dall’episcopato e da altre autorità cattoliche sulla quistione operaia. Deve essere interessante come breve sommario di storia di questa particolare attività cattolica. La «Civiltà Cattolica» (4 agosto 1928) nell’articolo La conferenza internazionale del lavoro (del Brucculeri) è entusiasta del Thomas.
Q5 §6 Passato e presente. Articoli del 1926 del conte Carlo Lovera di Castiglione nel «Corriere» di Torino; risposte fulminanti del «Corriere d’Italia» di Roma. È da notare che gli articoli del Lovera di Castiglione, pur essendo molto arditi, non erano tuttavia paragonabili al contenuto del libro Storia di un’idea, perché i cattolici non reagirono così energicamente contro il libro, mentre furono feroci col Lovera? Vedere la produzione letteraria del Lovera: collaboratore delle riviste del Gobetti e del «Davide» di Gorgerino: articoli nel «Corriere» di Torino. È un vecchio aristocratico, credo discendente di Solaro della Margarita. È interessante notare che è amico degli scrittori della «Civiltà Cattolica» e che ha messo a loro disposizione l’archivio del Solaro.
Q5 §7 Sul «pensiero sociale» dei cattolici mi pare si possa fare questa osservazione critica preliminare: che non si tratta di un programma politico obbligatorio per tutti i cattolici, al cui raggiungimento sono rivolte le forze organizzate che i cattolici posseggono, ma si tratta puramente e semplicemente di un «complesso di argomentazioni polemiche» positive e negative senza concretezza politica. Ciò sia detto senza entrare nelle quistioni di merito, cioè nell’esame del valore intrinseco delle misure di carattere economico‑sociale che i cattolici pongono alla base di tali argomentazioni.
In realtà la Chiesa non vuole compromettersi nella vita pratica economica e non si impegna a fondo, né per attuare i principi sociali che afferma e che non sono attuati, né per difendere, mantenere o restaurare quelle situazioni in cui una parte di quei principi era già attuata e che sono state distrutte. Per comprendere bene la posizione della Chiesa nella società moderna, occorre comprendere che essa è disposta a lottare solo per difendere le sue particolari libertà corporative (di Chiesa come Chiesa, organizzazione ecclesiastica), cioè i privilegi che proclama legati alla propria essenza divina: per questa difesa la Chiesa non esclude nessun mezzo, né l’insurrezione armata, né l’attentato individuale, né l’appello all’invasione straniera. Tutto il resto è trascurabile relativamente, a meno che non sia legato alle condizioni esistenziali proprie. Per «dispotismo» la Chiesa intende l’intervento dell’autorità statale laica nel limitare o sopprimere i suoi privilegi, non molto di più: essa riconosce qualsiasi potestà di fatto, e purché non tocchi i suoi privilegi, la legittima; se poi accresce i privilegi, la esalta e la proclama provvidenziale.
Date queste premesse, il «pensiero sociale» cattolico ha un puro valore accademico: occorre studiarlo e analizzarlo in quanto elemento ideologico oppiaceo, tendente a mantenere determinati stati d’animo di aspettazione passiva di tipo religioso, ma non come elemento di vita politica e storica direttamente attivo. Esso è certamente un elemento politico e storico, ma di un carattere assolutamente particolare: è un elemento di riserva, non di prima linea, e perciò può essere in ogni momento «dimenticato» praticamente e «taciuto», pur senza rinunziarvi completamente, perché potrebbe ripresentarsi l’occasione in cui sarà ripresentato. I cattolici sono molto furbi, ma mi pare che in questo caso siano troppo furbi.
Sul «pensiero sociale» cattolico è da tener presente il libro del padre gesuita Albert Muller, professore alla scuola superiore commerciale di S. Ignazio in Anversa – s d’économie politique, Première Série, «Èditions Spes», Parigi, 1927, pp. 428, Fr. 8 – di cui vedi la recensione nella «Civiltà Cattolica» del 1° settembre 1928, Pensiero e attività sociali (di A. Brucculeri); il Muller mi pare esponga il punto di vista più radicale cui possono giungere i gesuiti in questa materia (salario famigliare, compartecipazione, controllo, co‑gestione, ecc.).
Q5 §8 L’America e il Mediterraneo. Libro del professor G. Frisella Vella, Il tragico fra l’America e l’Oriente attraverso il Mediterraneo, Sandron, Palermo, 1928, pp. XV‑215, L. 15. Il punto di partenza del Frisella Vella è quello «siciliano». Poiché l’Asia è il terreno più acconcio per l’espansione economica americana e l’America comunica con l’Asia attraverso il Pacifico e attraverso il Mediterraneo, l’Europa non deve opporre resistenze a che il Mediterraneo diventi una grande arteria del commercio America‑Asia. La Sicilia ritrarrebbe grandi benefici da questo traffico, diventando intermediaria del commercio americano‑ asiatico ecc. Il Frisella Vella è persuaso della fatale egemonia mondiale dell’America ecc.
Q5 §9 Lucien Romier e l’Azione Cattolica francese. Il Romier è stato relatore alla Settimana sociale di Nancy del 1927: vi ha parlato della «deproletarizzazione delle moltitudini», argomento che solo indirettamente toccava l’argomento trattato dalla Settimana sociale, che era dedicata alla «Donna nella Società». Così il padre Danset vi parlò della Razionalizzazione sotto il rispetto sociale e morale.
Ma il Romier è elemento attivo dell’Azione Cattolica francese, o solo incidentalmente ha partecipato a questa riunione?
La Settimana sociale di Nancy del 1927 è molto importante per la storia della dottrina politico‑sociale dell’Azione Cattolica. Le sue conclusioni, favorevoli alla più larga partecipazione femminile alla vita politica, sono state approvate dal Card. Gasparri a nome di Pio XI. Il resoconto ne è stato pubblicato nel 1928 Semaines sociales de France, La femme dans la société, Parigi, Gabalda, pp. 564 in 8°. È indispensabile per lo studio della vita politica francese.
Q5 §10 L’Azione Cattolica nel Belgio. Cfr l’opuscolo del gesuita E. de Moreau, Le Catholicisme en Belgique, Ed. La pensée catholique, Liegi, (1928). Qualche cifra: l’Association catholique de la jeunesse belge raccolse nel congresso di Liegi 60 000 giovani (per i giovani di lingua francese). È divisa in sezioni: (operai, studenti medi, studenti universitari, agricoltori ecc.). La Jeunesse Ouvrière Chrétienne ha 18 000 soci divisi in 374 sezioni locali e 16 federazioni regionali. La Confédération des syndicats ouvrièrs chrétiens de Belgique ha 110 000 membri. Les ligues féminines ouvrières hanno 70 000 socie. L’Alliance nationale des fédérations mutualistes chrétiennes de Belgique ha 250 000 membri e con le famiglie loro serve a 650 000 persone. La Coopérative Belge Bien‑Être ha 300 magazzini cooperativi. La Banque centrale ouvrière, ecc. Il Boerenbond (lega di contadini fiamminghi) ha 1175 gilde con 112 686 membri, tutti capi famiglia (nel 1926). Movimento femminile a parte ecc.
Q5 §11 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. «Fede e ragione» pare sia oggi la rivista più importante dei cattolici integrali. Vedere dove esce, da chi è diretta e quali ne sono i principali collaboratori. Vedere in quali punti si pone in contrasto coi gesuiti: se in punti riguardanti la fede, la morale e anche la politica. C’è qualche ordine religioso che nel complesso ha la posizione «integrale»? oppure che simpatizza in modo particolare ecc? (Vedere i domenicani o i francescani).
Q5 §12 Il Risorgimento. Solaro della Margarita. Il Memorandum del Solaro della Margarita va integrato con l’articolo Visita del Solaro della Margarita a Pio IX nel 1846 con documenti inediti (tratti dagli Archivi Vaticani e dall’Archivio Solaro) nella «Civiltà Cattolica» del 15 settembre 1928. La conoscenza della personalità politica di Solaro della Margarita è indispensabile per ricostruire il «nodo storico 48‑49». Bisogna porre bene la quistione: Solaro della Margarita era un reazionario piemontese, fortemente legato alla dinastia: l’accusa di «austriacante» è puramente arbitraria, nel senso volgare della parola. Solaro avrebbe voluto l’egemonia piemontese in Italia e la cacciata degli Austriaci dall’Italia, ma solo con mezzi diplomatici normali, senza guerra e specialmente senza rivoluzione popolare. Contro i liberali voleva l’alleanza con l’Austria, si capisce. L’articolo della «Civiltà Cattolica» serve anche per giudicare la politica di Pio IX fino al 48. In questo articolo c’è qualche indicazione bibliografica sul Solaro.
(Bisogna ricordare il fatto che il governo piemontese dette armi ai cattolici del Sonderbund insorto, svuotando i magazzini militari, nonostante che si preparasse il 48. Solaro voleva che il Piemonte estendesse la sua influenza in Isvizzera, cioè voleva spostare l’asse della politica italiana).
Q5 §13 Azione Cattolica. La dottrina sociale cattolica nei documenti di papa Leone XIII, Roma, Via della Scrofa 70, 1928, in 16°, pp. 348, L. 7,50.
Q5 §14 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. L’articolo L’equilibrio della verità fra gli estremi dell’errore nella «Civiltà Cattolica» del 3 novembre 1928 prende lo spunto dalla pubblicazione di Nicolas Fontaine: Saint‑Siège, «Action Française», et «Catholiques intégraux», Parigi, Gamber, 1928, di cui in nota dà questo giudizio: «L’autore è dominato da pregiudizi politici e liberali, massime quando vede la politica nella condanna dell’Action Française; ma i fatti e i documenti, da lui allegati, sul famoso “Sodalizio”, non furono smentiti». Ora il Fontaine (a quanto mi pare di ricordare) non ha pubblicato nulla di completamente inedito: perché dunque i gesuiti non si sono serviti prima di questi documenti? La quistione è importante e mi pare possa essere risolta così: l’azione pontificia contro l’Action Française è l’aspetto appariscente di un’azione più vasta per liquidare una serie di conseguenze della politica di Pio X, cioè Pio XI vuole togliere ogni importanza ai «cattolici integrali», senza però attaccarli di fronte: la lotta contro il modernismo aveva squilibrato troppo a destra il cattolicismo, occorre nuovamente «incentrarlo» nei gesuiti, cioè dargli una forma politica duttile, senza irrigidimenti dottrinali, una grande libertà di manovra ecc. Pio XI è veramente il papa dei gesuiti.
Ma lottare contro i «cattolici integrali» è molto più difficile che lottare contro i modernisti. La lotta contro l’Action Française offre un terreno ottimo: i cattolici integrali sono combattuti non per sé, ma in quanto sostenitori di Maurras, cioè sono prese di mira le singole persone in quanto disubbidiscono al papa, non il complesso del movimento che ufficialmente è ignorato o quasi. Ecco l’importanza capitale del libro del Fontaine: ma come il Fontaine ha pensato di unire Maurras agli «integrali»? È una sua «intuizione» o gli fu suggerito dagli stessi gesuiti? (Studiare bene il libro del Fontaine da questo punto di vista – e vedere se il Fontaine è uno specialista di studi politico‑cattolici).
Questo articolo della «Civiltà Cattolica», scritto indubbiamente dal padre Rosa, è molto cauto nell’uso dei documenti del Fontaine: evita di analizzare quelli che non solo screditano gli «integrali», ma gettano un’ombra di comicità e di discredito su tutta la chiesa. (Gli «integrali» avevano organizzato una vera «cospirazione» a colori romanzeschi).
Dall’articolo della «Civiltà Cattolica» traggo qualche spunto. Si accenna che anche in Italia Maurras ha trovato difensori tra i cattolici: si parla di «imitatori o fautori, palesi od occulti, ma del pari aberranti dalla pienezza della fede e della morale cattolica, o nella teoria o nella pratica, pure gridando e anche illudendosi di volerle difendere integralmente e meglio di qualsiasi altro». L’Action Française «avventò contro chi scrive queste righe, un cumulo di vilipendii e di calunnie incredibili (?), fino a quelle insinuate ripetutamente di assassinii ed esecuzioni spietate di confratelli!». (Vedere quando queste accuse furono fatte al padre Rosa: tra i gesuiti c’era l’ala integralista e favorevole al Maurras: vedi il caso del cardinale Billot, gesuita, che si dimise – mi pare – dalla sua carica, dimissioni rarissime nella storia della Chiesa e che dimostrano da una parte l’ostinata pervicacia del Billot e la volontà intransigente del papa di superare ogni ostacolo nella lotta contro Maurras).
L’Abate Boulin, direttore della «Revue internationale des sociétés secrètes», «integrale», collegato a Benigni‑Mataloni; il Boulin si serve di pseudonimi (Roger Duguet); accanito antigesuita. L’Action Française e gli «integrali» si attaccano disperatamente a Pio X e pretendono di restare fedeli ai suoi insegnamenti. (Gli «integrali» vogliono rimettere in onore il Sillabo di Pio IX: nella proposta dell’Action Française di avere un ecclesiastico per la cattedra del Sillabo nelle sue scuole, era contenuta un’abile provocazione).
Questo articolo della «Civiltà Cattolica» è veramente importante e bisognerà rivederlo, in caso di stesura di studio su questo argomento. Bisognerà vedere tutte le sfumature dei «distinguo» a proposito della massoneria, dell’antisemitismo, del nazionalismo, della democrazia, ecc. Anche per i modernisti si distingue tra illusi, ecc., e si prende posizione contro l’antimodernismo del Benigni, ecc.: «Tanto più che era da temere, e non mancammo di farlo notare fino da quegli anni a chi di dovere, che siffatti metodi avrebbero fatto il gioco dei modernisti veri, preparando in futuro gravi danni alla Chiesa. Il che si vide poi, ed anche al presente si vede, nello spirito cattivo di reazione, non del vecchio modernismo solamente e del liberalismo, ma del nuovo altresì, e dell’integralismo stesso. Questo mostrava allora di volersi opporre ad ogni forma o parvenza di modernismo, anzi presumeva essere, come suol dirsi, più papale del Papa, ed invece ora con grave scandalo o gli resiste ipocritamente, o apertamente lo combatte, come avviene tra i fautori rumorosi dell’Action Française in Francia e i silenziosi loro complici in Italia».
Gli integrali chiamano i gesuiti «modernizzanti» e «modernizzantismo» la loro tendenza. Divisero i cattolici in «integrali» e «non integrali», cioè «papali» ed «episcopali». (Pare che l’enciclica di Benedetto XV Ad beatissimi notasse, biasimandola, questa tendenza a introdurre tali distinzioni tra i cattolici, che ledevano la carità e l’unità dei fedeli. Vedere la «Civiltà Cattolica» che stampò questa enciclica).
La «Sapinière», associazione segreta, presentata al pubblico col nome di «Sodalizio Piano», organizzò la lotta contro i gesuiti «modernizzanti», «in tutto contrariamente alla prima idea ed al programma officiale proposto al Santo Pontefice Pio X, indi approvato dal Segretario della Concistoriale, non certamente perché servisse allo sfogo di passioni private, alla denunzia e diffamazione di integerrimi ed anche eminenti personaggi, di Vescovi o d’interi Ordini religiosi, nominatamente del nostro, che mai finora erasi veduto in balia a siffatte calunnie, neppure ai tempi della sua soppressione. Da ultimo poi, finita la guerra e molto più dopo lo scioglimento del «Sodalizio Piano» – decretato dalla Sacra Congregazione del Concilio, non certo a titolo di lode, ma di proibizione e di biasimo – fu promossa tutta a spese di un noto e ricchissimo finanziere Simon di Parigi e della sua larga consorteria, la pubblicazione e la prodiga diffusione gratuita di libelli i più ignominiosi e criticamente insipienti contro la Compagnia di Gesù, i suoi Santi, i suoi dottori e maestri, le sue opere e le sue costituzioni, pure solennemente approvate dalla Chiesa. È la nota collezione dei così detti «Récalde», cresciuta già ad oltre una dozzina di libelli, alcuni di più volumi, in cui è troppo riconosciuta e non meno retribuita la parte dei complici romani. Essa viene ora rinforzata dalla pubblicazione sorella di foglietti diffamatori, i più farneticanti, sotto il titolo complessivo ed antifrastico di «Vérités», emuli dei fogli gemelli dell’Agenzia Urbs, ovvero Romana, i cui articoli ritornano poi talora, quasi a verbo, in altri fogli “periodici”».
Gli «integrali» sparsero «le peggiori calunnie» contro Benedetto XV, come si può vedere dall’articolo comparso alla morte di questo papa nella «Vieille France» (di Urbain Gohier, credo) e nella «Ronda» (febbraio 1922), «anche questo (periodico) tutt’altro che cattolico e morale, ma onorato tuttavia dalla collaborazione di Umberto Benigni, il cui nome si trovava registrato nella bella compagnia di quei giovani più o meno scapestrati». «Lo stesso spirito di diffamazione, continuato sotto il presente Pontificato, in mezzo alle file medesime dei cattolici, dei religiosi e del clero, non si può dire quanto abbia fatto di male nelle coscienze, quanto scandalo portatovi e quanta alienazione di animi, in Francia sopra tutto. Quivi infatti la passione politica induceva a credere più facilmente le calunnie, mandate spesso da Roma, dopo che i ricchi Simon e altri compari, di spirito gallicano e giornalistico (sic), ne spesarono gli autori e procurarono la diffusione gratuita dei loro libelli, massime degli antigesuitici sopra menzionati, nei seminari, nelle canoniche, nelle curie ecclesiastiche, ovunque fosse qualche probabilità o verosimiglianza che la calunnia potesse attecchire; ed anche fra laici, massime giovani, e degli stessi licei governativi, con una prodigalità senza esempio». Gli autori già sospetti si servono dell’anonimo o di pseudonimi. «È notorio, tra i giornalisti specialmente, quanto poco meriti qualsiasi titolo di onore un siffatto gruppo col suo principale ispiratore, il più astuto a nascondersi ma il più colpevole e il più interessato nell’intrigo» (a chi si allude? Al Benigni o a qualche altro pezzo grosso del Vaticano?)
Secondo l’articolista tra Action Française e «integrali» non c’era inizialmente «accordo», ma esso si è venuto formando dopo il 26; ma questa mi pare una dichiarazione fatta ad arte, per escludere ogni movente politico (lotta contro gli ultra reazionari) dalla quistione contro l’Action Française. (In nota si dice, – nell’ultima nota –: «Non si deve tuttavia confondere l’uno con l’altro partito, come taluno ha fatto, per es., Nicolas Fontaine, nell’opera citata Saint‑Siège, “Action française” et “Catholiques intégraux”. Questo autore, come notammo, è più che liberale, ma purtroppo informatissimo dei casi niente edificanti della menzionata società clandestina, detta della “Sapinière”, e dei suoi fautori francesi ed italiani, ed in ciò è ridicolo rinfacciare il suo liberalismo: occorre smentire i fatti su cui riparleremo a suo tempo». Strano, quel «purtroppo informatissimo» perché, come ho notato, il Fontaine si è servito di documenti di dominio pubblico (vedere). Fino ad oggi (ottobre 1930) il padre Rosa nella «Civiltà Cattolica» non ha poi «riparlato» della «Sapinière».
L’articolo conclude: «Ma la verità non ha da temere: e per parte nostra, noi siamo ben risoluti a difenderla senza paura né trepidazione od esitanza, anche contro i nemici interni, siano pure ecclesiastici facoltosi e potenti, che hanno fuorviato i laici per trarli ai loro disegni e interessi». In fondo alla nota si riporta poi qualcuno dei nomi del lungo catalogo dei «denunziati» dal «Sodalizio Piano» (tra gli altri i Cardinali Amette di Parigi, Piffl di Vienna, Mercier, Van Rossum, ecc.).
Ricorda poi un viaggio del Benigni in America (di cui parlò la «Civiltà Cattolica», 1927, IV, p. 399) dove distribuì i libelli antigesuitici; a Roma ci sarebbe un deposito di più decine di migliaia di copie di tali libelli.
Q5 §15 Lucien Romier e l’Azione Cattolica francese. Ricordare che nel 1925 il Romier aveva accettato di entrare a far parte del gabinetto di concentrazione nazionale di Herriot: aveva anche accettato di collaborare con Herriot il capo del gruppo cattolico parlamentare francese formatosi poco prima. Il Romier non era né deputato né senatore; era redattore politico del «Figaro». Dopo questa sua accettazione di entrare in un gabinetto Herriot, dovette lasciare il «Figaro». Il Romier si era fatto un nome con le sue pubblicazioni di carattere industriale‑sociale. Credo che il Romier sia stato redattore dell’organo tecnico degli industriali francesi «La journée industrielle».
Q5 §16 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. L’«Action Française» aveva a Roma un suo redattore, Havard de la Montagne, che dirigeva il settimanale in lingua francese «Rome», destinato ai cattolici francesi, preti, religiosi o laici, residenti o di passaggio a Roma. Questo settimanale doveva essere e sarà ancora il portavoce degli «integrali» e dei maurrassiani.
Q5 §17 Movimento pancristiano. La XV settimana sociale di Milano settembre 1928 trattò la quistione: «La vera unità religiosa», e il volume degli atti è uscito con questo titolo presso la Società editrice «Vita e pensiero» (Milano, 1928, L. 15). L’argomento è stato trattato dal punto di vista del Vaticano, secondo le direttive date dall’Enciclica Mortalium animos del gennaio 1928, e contro il movimento pancristiano dei protestanti, che vorrebbero creare una specie di federazione delle diverse sette cristiane, con eguaglianza di diritti.
È questa un’offensiva protestante contro il cattolicismo che presenta due momenti essenziali: 1) le Chiese protestanti tendono a frenare il movimento disgregatore nelle loro file (che dà luogo continuamente a nuove sette); 2) si alleano tra loro e ottenendo un certo consenso da parte degli ortodossi, pongono l’assedio al Cattolicismo per fargli rinunziare al suo primato e per offrire nella lotta un fronte unico protestante imponente, invece che una moltitudine di chiese, sette, tendenze di diversa importanza e che una per una più difficilmente potrebbero resistere alla tenace e unificata iniziativa missionaria cattolica. La quistione dell’unità delle chiese cristiane è un formidabile fenomeno del dopoguerra ed è degno della massima attenzione e di studio accurato.
Q5 §18 Il pensiero sociale dei cattolici. Un articolo da ricordare, per comprendere l’atteggiamento della Chiesa dinanzi ai diversi regimi politico‑statali, è Autorità e «opportunismo politico» nella «Civiltà Cattolica» del 1° dicembre1928. Potrebbe dare qualche spunto per la rubrica passato e presente. Sarà da confrontare con i punti corrispondenti del Codice Sociale.
La quistione si pose al tempo di Leone XIII e del ralliement di una parte dei cattolici alla repubblica francese e fu risolta dal papa con questi punti essenziali: 1) accettazione, ossia riconoscimento del potere costituito; 2) rispetto ad esso prestato come a rappresentanza di un’autorità venuta da Dio; 3) obbedienza a tutte le leggi giuste da tale autorità promulgate, ma resistenza alle leggi ingiuste con lo sforzo concorde di emendare la legislazione e cristianeggiare la società.
Per la «Civiltà Cattolica» questo non sarebbe «opportunismo», ma tale sarebbe solo l’atteggiamento servile ed esaltatorio in blocco di autorità che sono tali di fatto e non di diritto (l’espressione «diritto» ha un valore particolare per i cattolici).
I cattolici devono distinguere tra «funzione dell’autorità» che è diritto inalienabile della società, che non può vivere senza un ordine, e «persona» che esercita tale funzione e che può essere un tiranno, un despota, un usurpatore, ecc. I cattolici si sottomettono alla «funzione» non alla persona. Ma Napoleone III fu chiamato uomo provvidenziale dopo il colpo di stato del 2 dicembre, ciò che significa che il vocabolario politico dei cattolici è diverso da quello comune.
Q5 §19 Azione cattolica italiana. Per la storia dell’Azione Cattolica italiana è indispensabile l’articolo Precisazioni, pubblicato dall’«Osservatore Romano» del 17 novembre 1928 e riassunto dalla «Civiltà Cattolica» del 1° dicembre successivo a p. 468.
Q5 §20 Machiavelli ed Emanuele Filiberto. Un articolo della «Civiltà Cattolica» del 15 dicembre 1928 (Emanuele Filiberto di Savoia nel IV Centenario della nascita) si inizia così: «La coincidenza della morte del Machiavelli con la nascita di Emanuele Filiberto, non è senza ammaestramento. È piena di alto significato l’antitesi rappresentata dai due personaggi, l’uno dei quali scompare dalla scena del mondo, amareggiato e deluso, mentre l’altro sta per affacciarsi alla vita, ancora circondata di mistero, in quegli anni appunto che possiamo considerare come la linea di distacco tra l’età del Rinascimento e la Riforma cattolica. Machiavelli ed Emanuele Filiberto: chi può meglio personificare i due volti diversi, le due correnti opposte che si contendono il dominio del secolo XVI? Avrebbe mai immaginato il Segretario Fiorentino che proprio quel secolo, al quale aveva auspicato un Principe, in sostanza, pagano nel pensiero e nell’opera, avrebbe invece veduto il monarca che più si avvicinò all’ideale del perfetto principe cristiano?».
Le cose sono molto diverse da quelle che paiono allo scrittore della «Civiltà Cattolica», ed Emanuele Filiberto continua e realizza Machiavelli più di quanto non possa sembrare: per esempio nell’ordinamento delle milizie nazionali. D’altronde Emanuele Filiberto per altre cose poteva richiamarsi al Machiavelli; egli non rifuggiva anche dal far sopprimere con la violenza e con la frode i suoi nemici.
Questo articolo della «Civiltà Cattolica» interessa per i rapporti tra Emanuele Filiberto e i gesuiti e per la parte presa da questi nella lotta contro i Valdesi.
Q5 §21 Per la storia del movimento operaio italiano. Vedere: Agostino Gori, Ricordo, con una nota bibliografica. Sotto gli auspici e a spese del Comune di Firenze. Firenze, Tip. M. Ricci, 1927, in 8Q5 §, pp. 44. Il Gori è morto nel 26, ha scritto sul movimento operaio qualche saggio di storia. Nella bibliografia dei suoi scritti compilata in questa pubblicazione commemorativa da Ersilio Michel, si potranno trovare le indicazioni.
Q5 §22 Azione Cattolica in Germania. Die Katholische Aktion. Materialien und Akten, von Dr. Erhard Schlund, O.P.M. ‑ Verlag Josef Kosel & Friedrich Pustet, München, 1928.
È una rassegna dell’Azione Cattolica nei principali paesi e un’esposizione delle dottrine papali in proposito. In Germania non esiste l’Azione Cattolica del tipo comune, ma viene considerata tale l’insieme dell’organizzazione cattolica. (Ciò significa che in Germania il cattolicismo è dominato dal protestantesimo e non osa attaccarlo con una propaganda intensa). Su questa base sarebbe da studiare come si spieghi la base politica del «Centro». (Cfr anche il libro di Monsignor Kaller, Unser Laienapostolat, 2a ediz., vol. I, pp. 320, Leusterdorf am Rhein, Verlag des Johannesbund, 1927).
Il libro dello Schlund tende a introdurre e popolarizzare in Germania l’Azione Cattolica di tipo italiano, e certo Pio XI deve spingere in tal senso (forse però con cautela, perché una accentuata attività potrebbe risvegliare vecchi rancori e vecchie lotte).
Q5 §23 relle sulla cultura cinese. 1) La posizione dei gruppi intellettuali in Cina è «determinata» dalle forme pratiche che l’organizzazione materiale della cultura vi ha assunto storicamente. Il primo elemento di questa specie è il sistema di scrittura, quella ideografica. Il sistema di scrittura è ancor più difficile di quanto volgarmente si supponga, perché la difficoltà non è solo data dall’enorme quantità di segni materiali, ma questa quantità è ancora complicata dalle «funzioni» dei singoli segni a seconda del posto che occupano. Inoltre l’ideogramma non è organicamente legato a una determinata lingua, ma serve a tutta quella serie di lingue che sono parlate dai cinesi colti, cioè l’ideogramma ha un valore «esperantistico»: è un sistema di scrittura «universale» (entro un certo mondo culturale) e tenuto conto che le lingue cinesi hanno un’origine comune. Questo fenomeno deve essere studiato accuratamente, perché può servire contro le infatuazioni «esperantistiche»: cioè serve a dimostrare come le così dette lingue universali convenzionali, in quanto non sono l’espressione storica di condizioni adeguate e necessarie, diventano elemento di stratificazione sociale e di fossilizzazione di alcuni strati. In queste condizioni non può esistere in Cina una cultura popolare di larga diffusione: l’oratoria, la conversazione rimangono la forma più popolare di diffusione della cultura. Bisognerà, ad un certo punto, introdurre l’alfabeto sillabico: questo fatto presenta una serie di difficoltà: prima, la scelta dell’alfabeto stesso: quello russo o quello inglese (intendo per «alfabeto inglese» non solo la pura notazione dei segni fondamentali, uguale per l’inglese e le altre lingue ad alfabeto latino, ma il nesso diacritico di consonanti e vocali che danno la notazione dei suoni effettivi, come sh per š, j per g italiano, ecc.): certo che l’alfabeto inglese avrà il sopravvento in caso di scelta e ciò sarà legato a conseguenze di carattere internazionale: una certa cultura avrà il sopravvento, cioè.
2) L’introduzione dell’alfabeto sillabico avrà conseguenze di grande portata sulla struttura culturale cinese: sparita la scrittura «universale», affioreranno le lingue popolari e quindi nuovi gruppi di intellettuali su questa nuova base. Cioè si romperebbe l’unità attuale di tipo «cosmopolitico» e ci sarebbe un pullulare di forze «nazionali» in senso stretto. Per alcuni aspetti la situazione cinese può essere paragonata a quella dell’Europa occidentale e centrale nel Medio Evo, al «cosmopolitismo cattolico» cioè, quando il «mediolatino» era la lingua delle classi dominanti e dei loro intellettuali: in Cina la funzione del «mediolatino» è svolta dal «sistema di scrittura», proprio delle classi dominanti e dei loro intellettuali. La differenza fondamentale è data da ciò: che il pericolo che teneva unita l’Europa medioevale, pericolo mussulmano in generale – arabi, a Sud, Tartari e poi Turchi a Oriente e Sud‑Est – non può essere neanche lontanamente paragonato ai pericoli che minacciano l’autonomia cinese nel periodo contemporaneo. Arabi, Tartari, Turchi erano relativamente «meno» organizzati e sviluppati dell’Europa di quel tempo e il pericolo era «meramente» o quasi tecnico‑militare. Invece l’Inghilterra, l’America, il Giappone sono superiori alla Cina non solo «militarmente» ma economicamente, culturalmente, su tutta l’area sociale, insomma. Solo l’unità «cosmopolitica» attuale, di centinaia di milioni di uomini, col suo particolare nazionalismo di «razza» – xenofobia – permette al governo centrale cinese di avere la disponibilità finanziaria e militare minima per resistere alla pressione dei rapporti internazionali, e per tenere disuniti i suoi avversari.
La politica dei successori di destra di Sun Yat‑Sen deve essere esaminata da questo punto di vista. Il tratto caratteristico di questa politica è rappresentato dalla «non volontà» di preparare, organizzare e convocare una Convenzione pancinese a mezzo del suffragio popolare (secondo i principi di Sun) ma nel voler conservare la struttura burocratico‑militare dello Stato: la paura cioè di abbandonare le forme tradizionali di unità cinese e di scatenare le masse popolari. Non bisogna dimenticare che il movimento storico cinese è localizzato lungo le coste del Pacifico e dei grandi fiumi che vi sboccano: la grande massa popolare dell’hinterland è più o meno passiva. La convocazione di una Convenzione pancinese darebbe il terreno per un grande movimento anche di queste masse e per l’affiorare, attraverso i deputati eletti, delle configurazioni nazionali in senso stretto esistenti nella cosmopoli cinese, renderebbe difficile l’egemonia degli attuali gruppi dirigenti senza la realizzazione di un programma di riforme popolari e costringerebbe a cercare l’unità in una unione federale e non nell’apparato burocratico‑militare. Ma questa è la linea di sviluppo. La guerra incessante dei generali è una forma primitiva di manifestarsi del nazionalismo contro il cosmopolitismo: essa non sarà superata, cioè non avrà termine il caos militare‑burocratico senza l’intervento organizzato del popolo nella forma storica di una Convenzione pancinese.
(Sulla quistione degli intellettuali cinesi occorre raccogliere e organizzare molto materiale per elaborare un paragrafo sistematico della rubrica sugli intellettuali: il processo di formazione e il modo di funzionare sociale degli intellettuali cinesi ha caratteri proprii e originali, degni di molta attenzione).
Rapporti della cultura cinese con l’Europa. Prime notizie sulla cultura cinese sono date dai missionari, specialmente gesuiti, nei secoli XVII‑XVIII. Intorcetta, Herdrich, Rougemont, Couplet, rivelano all’Occidente l’universalismo confuciano; du Halde (1736) scrive la Description de l’Empire de la Chine; Fourmont (1742), da Glemona, Prémare.
Nel 1815, con la formazione nel Collège de France della prima cattedra di lingua e letteratura cinese, la cultura cinese viene studiata dai laici (per fini e con metodi scientifici e non di apostolato cattolico com’era il caso dei gesuiti); questa cattedra è tenuta da Abel Rémusat, considerato oggi come il fondatore della sinologia europea. Discepolo del Rémusat fu Stanislas Julien, che è considerato come il primo sinologo del suo tempo; tradusse un’enorme massa di testi cinesi, romanzi, commedie, libri di viaggi e opere di filosofia e infine riassunse la sua esperienza filologica nella Syntaxe nouvelle de la langue chinoise. L’importanza scientifica del Julien è data dal fatto che egli riuscì a penetrare il carattere della lingua cinese e le ragioni della sua difficoltà per gli europei, abituati alle lingue flessive. Anche per un cinese lo studio della sua lingua è più difficile di ciò che non sia per un europeo lo studio della propria: occorre un doppio sforzo, di memoria e d’intelligenza, di memoria per ricordare i molteplici significati di un ideogramma, di intelligenza per collegare questi in modo da trovare in ognuno di essi la parte, per così dire, connettiva che permette di trarre dal nesso delle frasi un senso logico ed accettabile. Più il testo è denso ed elevato (nel senso dell’astrazione) e più difficile è tradurlo: anche il più esperto letterato cinese deve sempre far precedere un lavorio d’analisi, più o meno rapido, all’interpretazione del testo che legge. L’esperienza ha nel cinese un valore più grande che in altre lingue, dove base prima all’intelligenza è la morfologia che in cinese non esiste. (Mi pare difficile accettare che in cinese non esista assolutamente la morfologia: nelle descrizioni della lingua cinese fatte da europei bisogna tener conto del fatto che il «sistema di scrittura» prende necessariamente il primo posto nell’importanza: ma il «sistema di scrittura» coincide perfettamente con la lingua parlata che è la «lingua reale»? è possibile che la funzione morfologica in cinese sia più legata alla fonetica e alla sintassi, cioè al tono dei singoli suoni e al ritmo musicale del periodo, cosa che non potrebbe apparire nella scrittura se non sotto forma di notazione musicale, ma anche in questo caso mi pare difficile escludere una qualche funzione morfologica autonoma: bisognerebbe vedere il libretto del Finck sui tipi principali di lingue. Ricordare ancora che la funzione morfologica anche nelle lingue flessive ha come origine parole indipendenti divenute suffissi, eccetera: questa traccia forse può servire per identificare la morfologia del cinese, che rappresenta una fase linguistica forse più antica delle più antiche lingue di cui si è conservata la documentazione storica. Le notizie che qui riassumo sono prese da un articolo di Alberto Castellani, Prima sinologia, nel «Marzocco» del 24 febbraio 1929).
Nel cinese «chi più legge più sa»: infatti, tutto riducendosi a sintassi, solo una lunga pratica con i modi, le clausole della lingua può essere di certo indirizzo alla intelligenza del testo. Tra il vago valore degli ideogrammi e la comprensione integrale del testo ci deve essere un esercizio dell’intelligenza che, nella necessità di adattamento logico, non ha quasi limite in paragone alle lingue flessive.
Un libro sulla cultura cinese. Eduard Erkes, Chinesische Literatur, Ferdinand Hirt, Breslau, 1926.
È un volumetto di meno che cento pagine in cui, secondo Alberto Castellani, mirabilmente si condensa tutto il ciclo culturale cinese, dalla più antica età fino ai giorni nostri. Non si può comprendere il presente cinese senza conoscerne il passato, senza una informazione demopsicologica: questo è giusto, ma è esagerata, almeno nella forma data, questa affermazione: «La conoscenza del passato dimostra che la gente cinese è già da diverse diecine di secoli, confucianamente comunista: tanto che certi recenti tentativi d’innesto eurasiatico ci ricordano il portar nottole ad Atene». Questa affermazione si può fare per ogni popolo arretrato di fronte all’industrialismo moderno e poiché si può fare per molti popoli, ha un valore primitivo: tuttavia la conoscenza della reale psicologia delle masse popolari, da questo punto di vista o come si può ricostruire attraverso la letteratura, ha grande importanza. La letteratura cinese è d’impronta genuinamente religioso‑statale. L’Erkes tenta una ricostruzione critico‑sintetica dei diversi momenti della letteratura cinese, attraverso le epoche più significative, per dare a questi momenti maggior rilievo di necessità storica. (Non è cioè una storia della letteratura in senso erudito e descrittivo, ma una storia della cultura). Tratteggia la figura e l’opera di Chu Hsi (1130-1200) che pochi occidentali sanno essere stata la personalità più significativa della Cina, dopo Confucio, grazie ai meditati silenzi dei missionari che hanno visto in questo riplasmatore della moderna coscienza cinese l’ostacolo più grande ai loro sforzi di propaganda.
Libro del Wiegor, La Chine à travers les Ages. L’Erkes arriva fino alla fase recente della Cina europeizzante e informa anche sullo svolgimento che si sta compiendo anche a proposito della lingua e dell’educazione.
Nel «Marzocco» del 23 ottobre 1927 Alberto Castellani dà notizia del libro di Alfredo Forke: Die Gedankenwelt des chinesischen Kulturkreises, München‑Berlin, 1927 (Filosofia cinese in veste europea e... giapponese). Il Forke è professore di lingua e di civiltà della Cina all’Università di Amburgo ed è noto come specialista dello studio della filosofia cinese. Lo studio del pensiero cinese è difficile per un occidentale per varie ragioni: 1) i filosofi cinesi non hanno scritto trattati sistematici del loro pensiero: furono i discepoli a raccogliere le parole dei maestri, non i maestri a scriverle per gli eventuali discepoli; 2) la filosofia vera e propria era intrecciata e come soffocata nelle tre grandi correnti religiose, Confucianismo, Taoismo, Buddismo; così i Cinesi passarono spesso agli occhi dell’europeo non specialista o come privi di filosofia vera e propria o come aventi tre religioni filosofiche (questo fatto però, che la filosofia sia stata intrecciata alla religione ha un significato dal punto di vista della cultura e caratterizza la posizione storica degli intellettuali cinesi). Il Forke appunto ha cercato di presentare il pensiero cinese secondo le forme europee, ha cioè liberato la filosofia vera e propria dai miscugli e dalle promiscuità eterogenee; quindi ha reso possibile qualche parallelo tra il pensiero europeo e quello cinese. L’Etica è la parte più rigogliosa di questa ricostruzione: la Logica è meno importante «perché anche i Cinesi stessi ne hanno avuto sempre, più un senso istintivo, come intuizione, che non un concetto esatto, come scienza». (Questo punto è molto importante, come momento culturale). Solo alcuni anni fa, uno scrittore cinese, il prof. Hu Shi, nella sua Storia della Filosofia Cinese (Scianghai, 1919) assegna alla Logica un posto eminente, ridisseppellendola dagli antichi testi classici, di cui, non senza qualche sforzo, tenta di rivelare il magistero. Forse il rapido invadere del Confucianismo, del Taoismo e del Buddismo, che non hanno interesse per i problemi della Logica, può avere intralciato il suo divenire come scienza. «Sta di fatto che i Cinesi non hanno mai avuto un’opera come il Nyàya di Gautama e come l’Organon di Aristotile». Così manca in Cina una disciplina filosofica sulla «conoscenza» (Erkenntnistheorie). Il Forke non vi trova che tendenze.
Il Forke esamina inoltre le diramazioni della filosofia cinese fuori della Cina, specialmente nel Giappone. Il Giappone ha preso dalla Cina insieme alle altre forme di cultura anche la filosofia, pur dandole un certo carattere proprio. Il Giapponese non ha tendenze metafisiche e speculative come il cinese (è «pragmatista» ed empirista). I filosofi cinesi tradotti in giapponese, acquistano però una maggiore perspicuità. (Ciò significa che i giapponesi hanno preso dal pensiero cinese ciò che era utile per la loro cultura, un po’ come i romani hanno fatto coi greci).
Il Castellani ha recentemente pubblicato: La dottrina del Tao ricostruita sui testi ed esposta integralmente, Bologna, Zanichelli, e La regola celeste di Lao‑Tse, Firenze, Sansoni, 1927. Il Castellani fa un paragone tra Lao‑Tse e Confucio (non so in quale di questi due libri): «Confucio è il Cinese del Settentrione, nobile, colto, speculativo; Lao‑Tse, 50 anni più vecchio di lui, è il Cinese del mezzogiorno, popolare, audace, fantasioso. Confucio è uomo di Stato; Lao-Tse sconsiglia l’attività pubblica: quegli non può vivere se non a contatto col governo, questi fugge il consorzio civile e non partecipa alle sue vicende. Confucio si contenta di richiamare i regnanti e il popolo agli esempi del buon tempo antico; Lao‑Tse sogna senz’altro l’era dell’innocenza universale e lo stato virgineo di natura; quegli è l’uomo di corte e dell’etichetta, questi l’uomo della solitudine e della parola brusca. Per Confucio, riboccante di forme, di regole, di rituali, la volontà dell’uomo entra in maniera essenziale nella produzione e determinazione del fatto politico; Lao‑Tse invece crede che i fatti tutti, senza eccezione, si facciano da sé, oltre e senza la nostra volontà; ch’essi abbiano tutti in se stessi un ritmo inalterato e inalterabile da qualunque nostro intervento. Nulla per lui di più ridicolo dell’ometto confuciano, faccendiero e ficcanaso, che crede all’importanza e quasi al peso specifico di ogni suo gesto; nulla di più meschino di quest’animula miope e presuntuosa, lontana dal Tao, che crede di dirigere ed è diretta, crede di tenere ed è tenuta». (Questo brano è tolto da un articolo di A. Faggi nel «Marzocco» del 12 giugno 1927, Sapere cinese). Il «non fare» è il principio del Taoismo, è appunto il «Tao», la «strada».
La forma statale cinese. La monarchia assoluta è fondata in Cina nell’anno 221 avanti Cristo e dura fino al 1912, nonostante il mutare di dinastie, le invasioni straniere, ecc. Questo è il punto interessante; ogni nuovo padrone trova l’organismo bello e fatto, di cui si impadronisce impadronendosi del potere centrale. La continuità è così un fenomeno di morte e di passività del popolo cinese. Evidentemente anche dopo il 1912 la situazione è rimasta ancora relativamente stazionaria, nel senso che l’apparato generale è rimasto quasi intatto: i militari tuciun si sono sostituiti ai mandarini e uno di essi, volta a volta, tenta di rifare l’unità formale, impadronendosi del centro. L’importanza del Kuomintang, sarebbe stata ben più grande se avesse posto realmente la quistione della Convenzione pancinese. Ma ora che il movimento è scatenato, mi pare difficile che senza una profonda rivoluzione nazionale di massa, si possa ricostituire un ordine duraturo.
Q5 §24 Passato e presente. Il rispetto del patrimonio artistico nazionale. È molto interessante a questo proposito l’articolo di Luca Beltrami: Difese d’arte in luoghi sacri e profani, nel «Marzocco» del 15 maggio 1927. Gli aneddoti riportati dal Beltrami dalla stampa quotidiana sono molto interessanti ed edificanti. Poiché questo punto è sempre messo innanzi per ragioni di polemica culturale, sarà bene ricordare questi episodi di volgare trimalcionismo delle cosidette classi colte.
Q5 §25 Machiavelli e Manzoni. Qualche accenno al Machiavelli del Manzoni si può trovare nei Colloqui col Manzoni di N. Tommaseo, pubblicati per la prima volta e annotati da Teresa Lodi, Firenze, G. C. Sansoni, 1929. Da un articolo di G. S. Gargano nel «Marzocco» del 3 febbraio 1929 (Manzoni in Tommaseo) riporto questo brano: «E pur attribuito al Manzoni è il giudizio sul Machiavelli, la cui autorità empì di pregiudizi le teste italiane e le cui massime alcuni ripetevano senza osare adoperarle e alcuni operavano senza osare dirle; “e sono i liberali che le cantano e i re che le fanno”; commento quest’ultimo che è forse del trascrittore, il quale aggiunge che il Manzoni aveva pochissima fede nelle guarantigie degli Statuti e nella potenza dei Parlamenti e che l’unico suo desiderio era per allora di fare la nazione una e potente anche a costo della libertà, “quando pure l’idea della libertà fosse in tutti i cervelli vera e uno il sentimento di lei in tutti i cuori”».
Q5 §26 I nipotini di padre Bresciani. Alfredo Panzini. La traduzione delle Opere e i Giorni di Esiodo, stampata dal Panzini nel 1928 (prima nella Nuova Antologia poi in volumetto Treves), è esaminata nel «Marzocco» del 3 febbraio 1929 da Angiolo Orvieto (Da Esiodo al Panzini). La traduzione tecnicamente è molto imperfetta. Per ogni parola del testo il Panzini ne adopera due o tre delle sue; si tratta più di una traduzione commento che di una traduzione, alla quale manca «il colorito particolarissimo dell’originale, salvo quella certa solennità maestosa ch’egli in più luoghi è riuscito a conservare». L’Orvieto cita alcuni gravi spropositi del Panzini: invece d’«infermità che portano la vecchiezza all’uomo» il Panzini traduce «infermità che la vecchiezza porta agli uomini». Esiodo parla della «quercia che porta in vetta le ghiande e in mezzo (nel tronco) le api» e il Panzini traduce comicamente «le querce montane (!) maturano le ghiande, e quelle delle convalli (!) accolgono le api nel loro tronco», distinguendo due famiglie di querce ecc. (un alunno di liceo sarebbe stato bocciato per un tale sproposito). Per Esiodo le Muse sono «donatrici di gloria coi carmi», per Panzini «gloriose nell’arte del canto». Altri esempi porta l’Orvieto in cui appare che oltre alla conoscenza superficiale del greco, gli spropositi del Panzini siano anche dovuti al pregiudizio politico (caso tipico di Brescianesimo) come là dove muta il testo per far partecipare Esiodo alla campagna demografica.
Sarà da vedere se le riviste di filologia classica si sono occupate della traduzione del Panzini: in ogni modo l’articolo dell’Orvieto mi pare sufficiente per il mio scopo (bisogna rivederlo perché in questo momento me ne manca una parte).
Q5 §27 I nipotini di padre Bresciani. Enrico Corradini. È stata ristampata nel 1928 nella Collezione teatrale Barbera la Carlotta Corday di E. Corradini, che nel 1907 o 8, quando fu scritta, ebbe accoglienze disastrose e fu ritirata dalle scene. Il Corradini stampò il dramma con una prefazione (anch’essa ristampata nella ed. Barbera) in cui accusava del disastro un articolo dell’«Avanti!» che aveva sostenuto il Corradini aver voluto diffamare la rivoluzione francese. La prefazione del Corradini deve essere interessante anche dal punto di vista teorico, per la compilazione di questa rubrica del Brescianesimo, perché il Corradini sembra far distinzione fra «piccola politica» e «grande politica» nelle «tesi» contenute nei lavori d’arte. Naturalmente per il Corradini, la sua essendo «grande politica», l’accusa di «politicantismo» in sede artistica non potrebbe essere elevata contro di lui. Ma la quistione è un’altra: nelle opere d’arte si tratta di vedere se c’è intrusione di elementi extra-artistici, siano questi di alto o di basso carattere, cioè se si tratta di «arte» o di oratoria a fini pratici. E tutta l’opera del Corradini è di questo tipo: non arte e anche cattiva politica, cioè semplice rettorica ideologica.
Q5 §28 Ideologia, psicologismo, positivismo. Studiare questo passaggio nelle correnti culturali dell’800: il sensismo + l’ambiente danno lo psicologismo: la dottrina dell’ambiente è offerta dal positivismo. Brandes, Taine nella letteratura ecc.
Q5 §29 Oriente‑Occidente . In una conferenza, pubblicata nel volume L’énergie spirituelle (Parigi, 1920), Bergson cerca di risolvere il problema: che cosa sarebbe avvenuto se l’umanità avesse rivolto il proprio interesse e la propria indagine ai problemi della vita interiore anziché a quelli del mondo materiale. Il regno del mistero sarebbe stato la materia e non più lo spirito, egli dice.
Questa conferenza bisognerà leggerla. In realtà «umanità» significa Occidente, perché l’Oriente si è proprio fermato alla fase dell’indagine rivolta solo al mondo interiore. La quistione sarebbe questa, da porre in base allo studio della conferenza di Bergson: se non è proprio lo studio della materia – e cioè il grande sviluppo delle scienze intese come teoria e come applicazione industriale – che ha fatto nascere il punto di vista che lo spirito sia un «mistero», in quanto ha impresso al pensiero un ritmo accelerato di movimento, facendo pensare a ciò che potrà essere «l’avvenire dello spirito» (problema che non si pone quando la storia è stagnante) e facendo quindi vedere lo spirito come una entità misteriosa che si rivela un po’ capricciosamente ecc.
Q5 §30 Funzione internazionale degli intellettuali italiani. Nel «Bollettino storico lucchese» del 1929 o degli inizi del 1930 è apparso uno studio di Eugenio Lazzareschi sui rapporti colla Francia dei mercanti lucchesi nel Medio Evo. I lucchesi, frequentando ininterrottamente dal sec. XII i grandi mercati delle città e le famose fiere della Fiandra e della Francia, erano divenuti proprietari di larghi fondi, agenti commerciali o fornitori delle Corone di Francia e di Borgogna, funzionari ed appaltatori nelle amministrazioni civili e finanziarie: avevano contratto parentadi illustri e s’erano così bene acclimatati in Francia che potevano ormai dire di avere due patrie: Lucca e la Francia. Perciò uno di loro, Galvano Trenta, all’inizio del 1411 scriveva a Paolo Guinigi di pregare il nuovo Papa, non appena eletto, che richiedesse al re di Francia che ogni lucchese fosse riconosciuto «borghese» di Parigi.
Q5 §31 Sulla tradizione nazionale italiana. Cfr articolo di B. Barbadoro nel «Marzocco» del 26 settembre 1926: a proposito della Seconda lega lombarda e della sua esaltazione come «primo conato per la indipendenza della stirpe dalla straniera oppressione che prepara i fasti del Risorgimento», il Barbadoro metteva in guardia contro questa interpretazione e osservava che «la stessa fisionomia storica di Federico II è ben diversa da quella del Barbarossa, ed altra è la politica italiana del secondo Svevo: padrone di quel Mezzogiorno d’Italia, la cui storia era disgiunta da secoli da quella della restante penisola, parve in un certo momento che la restaurazione dell’autorità imperiale nel centro e nel settentrione portasse finalmente alla costituzione di una forte monarchia nazionale».
Nel «Marzocco» del 16 dicembre 1928 il Barbadoro, in una breve nota, ricorda questa sua affermazione a proposito di un ampio studio di Michelangelo Schipa pubblicato nell’Archivio storico per le province napoletane in cui lo spunto è ampiamente dimostrato.
Questa corrente di studi è molto interessante per comprendere la funzione storica dei Comuni e della prima borghesia italiana che fu disgregatrice dell’unità esistente, senza sapere o poter sostituire una nuova propria unità: il problema dell’unità territoriale, non fu neanche posto o sospettato e questa fioritura borghese non ebbe seguito: fu interrotta dalle invasioni straniere. Il problema è molto interessante dal punto di vista del materialismo storico e mi pare possa collegarsi con quello della funzione internazionale degli intellettuali italiani. Perché i nuclei borghesi formatisi in Italia, che pure raggiunsero la completa autonomia politica, non ebbero la stessa iniziativa degli Stati assoluti nella conquista dell’America e nell’apertura di nuovi sbocchi? Si dice che un elemento della decadenza delle repubbliche italiane è stata l’invasione turca che interruppe o almeno disorganizzò il commercio col levante e lo spostarsi dell’asse storico mondiale dal Mediterraneo all’Atlantico per la scoperta dell’America e la circumnavigazione dell’Africa. Ma perché Cristoforo Colombo servì la Spagna e non una repubblica italiana? Perché i grandi navigatori italiani servirono altri paesi? La ragione di tutto questo è da ricercare in Italia stessa, e non nei turchi o in America. La borghesia si sviluppò meglio, in questo periodo, con gli Stati assoluti, cioè con un potere indiretto che non avendo tutto il potere. Ecco il problema, che deve essere collegato con quello degli intellettuali: i nuclei borghesi italiani, di carattere comunale, furono in grado di elaborare una propria categoria di intellettuali immediati, ma non di assimilare le categorie tradizionali di intellettuali (specialmente il clero) che invece mantennero ed accrebbero il loro carattere cosmopolitico. Mentre i gruppi borghesi non italiani, attraverso lo Stato assoluto, ottennero questo scopo molto facilmente poiché assorbirono gli stessi intellettuali italiani. Forse questa tradizione storica spiega il carattere monarchico della borghesia moderna italiana e può servire a comprendere meglio il Risorgimento.
Q5 §32 Ugo Foscolo e la retorica letteraria italiana. I Sepolcri devono essere considerati come la maggiore «fonte» della tradizione culturale retorica che vede nei monumenti un motivo di esaltazione delle glorie nazionali. La «nazione» non è il popolo, o il passato che continua nel «popolo», ma è invece l’insieme delle cose materiali che ricordano il passato: strana deformazione che poteva spiegarsi ai primi dell’800 quando si trattava di svegliare delle energie latenti e di entusiasmare la gioventù, ma che è appunto «deformazione» perché è diventato puro motivo decorativo, esteriore, retorico (l’ispirazione dei sepolcri non è nel Foscolo simile a quella della così detta poesia sepolcrale: è un’ispirazione «politica», come egli stesso scrive nella lettera al Guillon).
Q5 §33 M. Iskowicz, La Littérature à la lumière du matérialisme historique, 1929, 30 franchi (annunziato nel bollettino del 1° febbraio 1929, «Nouveautés», Listes mensuelles de la M.L.F.).
Q5 §34 Passato e presente. Sul movimento della «Voce» di Prezzolini, che aveva certamente uno spiccato carattere di campagna per un rinnovamento morale e intellettuale della vita italiana (in ciò poi, continuava, con più maturità, il «Leonardo», e si distinse poi da «Lacerba» di Papini e dall’«Unità» di Salvemini, ma più da «Lacerba» che dall’«Unità»), cfr il libro di Giani Stuparich su Scipio Slataper, edito nel 1922 dalla «Casa Ed. La Voce».
Q5 §35 Risorgimento. Il trasporto della capitale da Torino a Firenze e le stragi di settembre. Cfr il volume Confidenze di Massimo d’Azeglio a cura di Marcus de Rubris (Mondadori, Milano, 1930): si tratta del carteggio di Massimo d’Azeglio con Teresa Targioni Tozzetti. Il carattere del d’Azeglio vi appare in rilievo, coi suoi livori, il suo scetticismo, il suo piemontesismo. Alcune osservazioni che fa sui fatti del settembre sono però utili e interessanti.
Q5 §36 Passato e presente. Sull’impressione reale che ha fatto l’inizio d’attività dell’Accademia d’Italia cfr l’«Italia letteraria» del 15 giugno 1930, La prima seduta pubblica dell’Accademia d’Italia. In un articolo editoriale si critica acerbamente il modo con cui l’Accademia d’Italia ha distribuito la somma di un milione che era a sua disposizione per aiutare le patrie lettere, in 150 premiati: la distribuzione pare abbia assunto l’aspetto di una elargizione tipo minestra da convento; un altro pezzo Cronaca per la Storia di Antonio Aniante presenta la seduta come se fosse l’assemblea di un Consiglio Comunale di città provinciale.
Q5 §37 La funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. «Pour Nietzsche, l’intellectuel est “chez lui”, non pas là où il est né (la naissance, c’est de l’“histoire”), mais là où lui‑même engendre et met au monde: Ubi pater sum, ibi patria, “Là où je suis père, où j’engendre, là est ma patrie”; et non pas, où il fut engendré». Stefan Zweig, Influence du Sud sur Nietzsche, «Nouvelles Littéraires», 19 luglio 1930 (è forse il capitolo di un libro tradotto da Alzir Hella et Olivier Bournac).
Q5 §38 Carattere della letteratura italiana non nazionale‑popolare. Articolo di Orazio Pedrazzi nell’«Italia letteraria» del 4 agosto 1929: Le tradizioni antiletterarie della burocrazia italiana. Il Pedrazzi non fa alcune distinzioni necessarie. Non è vero che la burocrazia italiana sia così «antiletteraria» come sostiene il Pedrazzi, mentre è vero che la burocrazia (e si vuol dire l’alta burocrazia) non scrive della sua propria attività. Le due cose sono diverse: credo anzi che ci sia una mania letteraria propria della burocrazia, ma riguarda il «bello scrivere», «l’arte», ecc.: forse si potrebbe trovare che la grande massa della paccottiglia letteraria è dovuta a burocrati. Invece è vero che non esiste in Italia (come in Francia e altrove) una letteratura dovuta ai funzionari statali (militari e civili) di valore e che riguardi l’attività svolta, all’estero, dal personale diplomatico, al fronte, dagli ufficiali, ecc.; quella che c’è, per lo più è «apologetica». «In Francia, in Inghilterra, generali ed ammiragli scrivono per il loro popolo, da noi scrivono solo per i loro superiori». La burocrazia cioè non ha un carattere nazionale, ma di casta.
Q5 §39 Scetticismo. L’obbiezione di senso comune che si può fare allo scetticismo è questa: che per essere coerente a se stesso, lo scettico non dovrebbe fare altro che vivere come un vegetale, senza intrigarsi negli affari della vita comune. Se lo scettico interviene nella discussione, significa che egli crede di poter convincere, cioè non è più scettico, ma rappresenta una determinata opinione positiva, che di solito è cattiva e può trionfare solo convincendo la comunità che le altre sono anche peggiori, in quanto sono inutili. Lo scetticismo è collegato col materialismo volgare e col positivismo: è interessante un brano di Roberto Ardigò, in cui si dice che occorre lodare il Bergson per il suo volontarismo. Ma che significa ciò? Non è una confessione della impotenza della propria filosofia a spiegare il mondo, se occorre rivolgersi a un sistema opposto per trovare l’elemento necessario per la vita pratica? Questo punto di Ardigò (contenuto negli Scritti vari raccolti e ordinati da G. Marchesini, Firenze, Le Monnier, 1922) deve essere messo in rapporto con le tesi su Feuerbach di Marx e dimostra appunto di quanto Marx avesse superato la posizione filosofica del materialismo volgare.
Q5 §40 Pirandello. Sulla concezione del mondo implicita nei drammi di Pirandello occorre leggere la prefazione di Benjamin Crémieux alla traduzione francese di Enrico IV (Éditions de la «N.R.F.»).
Q5 §41 L’orientazione professionale. Cfr lo studio del padre Brucculeri nella «Civiltà Cattolica» del 6 ottobre, 3 novembre, 17 novembre 1928: vi si può trovare il primo materiale per una prima impostazione delle ricerche in proposito. Lo studio della quistione è complesso: 1) perché nella situazione attuale di divisione sociale delle funzioni, certi gruppi sono limitati nella loro scelta professionale (intesa in senso largo) da diverse condizioni, economiche (non poter attendere) e tecniche (ogni anno di più di scuola modifica le disposizioni generali in chi deve scegliere la professione); 2) perché deve sempre esser tenuto presente il pericolo che gli istituti chiamati a giudicare sulle disposizioni del soggetto, lo indichino come capace di fare un certo lavoro anche quando egli non voglia accettare (questo caso è da tener presente dopo l’introduzione della razionalizzazione ecc.; la quistione non è puramente tecnica, è anche salariale. L’industria americana si è servita degli alti salari per «selezionare» gli operai dell’industria razionalizzata, almeno entro una certa misura: altre industrie invece, ponendo avanti questi schemi scientifici o pseudoscientifici, possono tendere a «costringere» tutte le maestranze tradizionali a lasciarsi razionalizzare senza avere ottenuto le possibilità salariali per un sistema di vita appropriato, che permetta di reintegrare le maggiori energie nervose consumate. Ci si può trovare dinanzi a un vero pericolo sociale: il regime salariale attuale è basato specialmente sulla reintegrazione di forze muscolari. L’introduzione della razionalizzazione senza un cambiamento di sistema di vita, può portare a un rapido logoramento nervoso e determinare una crisi di morbosità inaudita). Lo studio della quistione deve poi esser fatto dal punto di vista della scuola unica del lavoro.
Q5 §42 La tradizione di Roma. Registrare le diverse reazioni (e il diverso carattere di queste) all’ideologia legata alla tradizione di Roma. Il futurismo fu in Italia una forma di questa reazione, in quanto contro la retorica tradizionale e accademica, e questa in Italia era strettamente legata alla tradizione di Roma (La terra dei morti del Giusti: «noi eravamo grandi e là non eran nati»; «tutto che al mondo è civile, ‑ grande, augusto, egli è romano ancora» del Carducci, dipendenti dai Sepolcri di Foscolo, come momento «moderno» di questa retorica). Questa reazione ha vari aspetti, oltre che diversi caratteri. Tende, per esempio, a contestare che l’Italia moderna sia erede della tradizione romana (l’espressione del Lessing sui «vermi usciti dalla decomposizione della carogna romana») o a contestare l’importanza stessa di tale tradizione. Nel libro dello Wells Breve storia del mondo (ed. Laterza, con postilla polemica del traduttore Lorizio), questa reazione assume diversi aspetti: 1) nega che la storia mondiale antica si unifichi nell’impero romano, allargando la visione storica mondiale con la storia della Cina, dell’India e dei Mongoli; 2) tende a svalutare in sé la grandezza della storia romana e della sua tradizione, sia come tendenza politica (Sacro Romano Impero), sia come tendenza culturale (Chiesa cattolica), Nel libro dello Wells, se è esatto il primo punto, il secondo soffre di nuova intrusione di elementi ideologici ed è moralistico.
Altro aspetto da osservare è la valorizzazione dell’elemento non romano nella formazione delle nazioni moderne: elemento germanico nella formazione degli stati romano-germanici: questo aspetto è coltivato dai tedeschi e continua nella polemica sull’importanza della Riforma come premessa della modernità. Ma nella formazione degli Stati romano‑germanici, oltre all’elemento romano e a quello germanico, c’è un terzo e anche talvolta un quarto elemento; in Francia, oltre all’elemento romano e a quello franco, c’è l’elemento celtico, dato dalla autoctona popolazione gallica; in Ispagna c’è ancora, in più, l’elemento arabo con la sua influenza scientifica nel Medio Evo. A proposito dell’elemento gallico nella formazione della civiltà francese, c’è sempre stata tutta una letteratura, di carattere misto storico e popolare. Nel tempo più recente è da vedere l’Histoire de la Gaule di Camille Jullian, dove (nell’VIII vol., p. 311) si può leggere che è tempo di farla finita colla «ossessione della storia imperiale» e che «è necessario che noi sappiamo sbarazzarci dei modi di sentire e di ragionare che sono l’eredità dell’impero romano. I pregiudizi quasi invincibili coi quali noi siamo usciti dall’educazione classica, lo storico deve saperli vincere». Dall’articolo La figura di Roma in uno storico celtista di Piero Baroncelli nella Nuova Antologia del 16 marzo 1929 pare che il Jullian a questi pregiudizi ne abbia sostituito degli altri (la celtomania), ma in ogni caso è notevole il fatto che uno storico accreditato come il Jullian, membro dell’Accademia, abbia dedicato un tale scritto monumentale a sostegno della sua tesi e abbia avuto il premio dell’Accademia. Il Baroncelli ritiene che: «La gelosia, con cui oggi si guarda quasi dappertutto al nostro Paese, si rivela anche nel favore col quale sono accolte all’estero le pubblicazioni che, per un verso o per l’altro, cercano di sfatare il nome di Roma e dell’Italia. Di questa indole è appunto la citata Histoire de la Gaule, opera fortunata per diffusione, imponente per mole, autorevole per il nome dello scrittore», e che: «Quanto agli sfregi che oggi si tentano sulla figura di Roma antica, ben sappiamo che la Roma signora e maestra di popoli ha in sé, per taluni, una grave colpa: Roma, fino da’ suoi inizi, fu sempre Italia». Ai pregiudizi storici che combatte, il Baroncelli ne sostituisce anch’egli dei suoi propri, e, ciò che è più importante, dà loro una veste politica. L’argomento sarebbe da studiare con spregiudicatezza: cosa rimane ancora oggi, di proprio e inconfondibile, della tradizione romana? Concretamente molto poco: l’attività più spiccata, moderna, è quella economica, sia teorica che pratica, e quella scientifica, e di esse nulla continua il mondo romano. Ma anche nel campo del diritto, in che rapporto esatto si trova il romanesimo con gli apporti del germanesimo e quelli più recenti anglosassoni e qual è l’area geografica in cui il diritto romano ha più diffusione? Sarebbe ancora da notare che nella forma in cui è diventato tradizionale, il diritto romano è stato elaborato a Costantinopoli, dopo la caduta di Roma. Quanto alla tradizione statale romana è vero che l’Italia, come tale (cioè nella figura che oggi ha assunto) non l’ha continuata (osservazione del Sorel), ecc. Seguire le pubblicazioni di Ezio Levi sull’arabismo spagnolo e sulla sua importanza per la civiltà moderna.
Q5 §43 L’episodio dell’arresto dei fratelli La Gala nel 1863. Nell’articolo Ricordi personali di politica interna («Nuova Antologia», 1° aprile 1929) Tommaso Tittoni dà alcuni particolari inediti sull’arresto dei La Gala a Genova. I La Gala, rifugiatisi negli Stati Pontifici, si erano stabiliti a Oriolo Romano, paesello prossimo a Manziana dove era nato Vincenzo Tittoni (padre di Tommaso). Un amico di Vincenzo e corrispondente del Comitato Nazionale romano avvertì il Comitato stesso che i La Gala si erano imbarcati a Civitavecchia sul vapore francese «Aunis» che si recava a Marsiglia facendo scalo a Livorno e a Genova. Il Comitato avvertì a Livorno Vincenzo Tittoni al quale la notizia pervenne mentre l’«Aunis» salpava per Genova. Il Tittoni corse dal prefetto e lo indusse a telegrafare al prefetto di Genova, il quale, senza attendere le istruzioni del ministero, prese su di sé la responsabilità di arrestare i La Gala a bordo dell’«Aunis». Sull’affare La Gala cfr Isaia Ghiron Annali d’Italia in continuazione al Muratori e al Coppi («Rassegna storica del Risorgimento», 1927, fasc. 1°) e cfr specialmente la «Civiltà Cattolica» del 1863 (i La Gala furono arrestati nel luglio 1863).
Q5 §44 T. Tittoni, Ricordi personali di politica interna, Nuova Antologia, 1° aprile ‑ 16 aprile 1929. Il Tittoni ha scritto queste sue memorie subito dopo la Conciliazione, per dimostrare come questo evento abbia corrisposto a tutta l’attività politica della sua carriera di liberale moderato ossia di conservatore clericale. L’interesse dei Ricordi è tutto qui, si può dire: nel cercare di ricostruire la storia italiana dal 70 ad oggi come una lotta tra conservatori clericali e democrazia o demagogia, per il ripristino dell’influsso clericale nella vita del paese, ponendo pertanto in luce l’attività della corrente conservatrice in quanto rappresentata da Tittoni. Annoto qualcuno degli spunti offerti dal Tittoni:
Per la storia dell’Azione Cattolica. Nel novembre 1871 l’Unione Romana per le elezioni amministrative coll’assenso di Pio IX, per il quale la partecipazione dei cattolici all’amministrazione comunale e provinciale era compatibile coll’ossequio alla Santa Sede. Cfr Paolo Campello della Spina, Ricordi di più che cinquant’anni, Roma, Loescher, 1910. Vi si legge: «Pio IX, a quel gruppo di visitatori che usava andare alla sua udienza del mattino e lo accompagnava talvolta alla passeggiata nei giardini, disse: “Ma sì, ma sì, non l’hanno capito e pure l’ho detto tante volte, che mi fa piacere che vadano alle elezioni amministrative”». Notizie intorno al tentativo, fatto da Roberto Stuart e da altri, di creare un partito conservatore cattolico e quindi di un gruppo cattolico alla Camera, tentativo stroncato dal Vaticano (che tuttavia lasciò fare per qualche tempo, il che è da notare).
Positivismo e reazione. Dice Tittoni: «Per molto tempo il Cours de philosophie positive di Augusto Comte è stato il mio breviario filosofico e politico. A mio avviso nessuno meglio di Comte ha risolto il preteso conflitto tra la scienza e la religione, assegnando la prima alla ragione e la seconda al sentimento, e separando nettamente il campo del libero esame da quello riservato alla fede. Comte considerava il Papato come un grande elemento conservatore della società. Egli aveva immaginato negli ultimi anni della sua vita una lega di difesa religiosa e sociale presieduta dal Pontefice. A questa epoca appartiene il volumetto Catechisme positiviste. In un esemplare che io comprai in Roma da un venditore ambulante di libri, trovai la seguente dedica: “À Monsieur Bex, Général des Jésuites, offert par l’auteur Auguste Comte, Paris le 10 aristote 69”. Littré, al quale scrissi, inviandogli il facsimile dell’autografo mi rispose garantendone l’autenticità. Il padre Bex non aveva tenuto alcun conto del volumetto poiché i fogli non ne erano stati nemmeno tagliati». (Ma poteva averlo già letto in altro esemplare).
Intorno ai fatti del 98. Sistemi elettorali escogitati: da un brano di memorie dell’on. Gianforte Suardi riportato dal Tittoni risulta che quando il gabinetto Rudin’‑Pelloux mutò la legge elettorale, l’obbligo di votare nel comune di origine fu escogitato «per impedire il voto di artificiali (!) aggruppamenti come quelli di Torino, ove per le officine delle ferrovie si trovava concentrato un gran numero di ferrovieri, tale da costituire un’artificiosa maggioranza fortuita (!) di operai di Romagna e di altre parti d’Italia all’infuori di Torino». Nelle memorie di Tittoni si potrebbero spigolare vari episodi di simili pastette politiche, in cui hanno sempre avuto incontestabile eccellenza i reazionari.
Tittoni prefetto di Napoli, dal 900 al 903. Idillio: non parla dei fatti concreti di cui fu accusato. Cfr gli Atti parlamentari del 1903: nella seduta del 2 dicembre Tittoni fu attaccato da Barzilai e Bissolati il quale riportò le accuse della «Propaganda».
Fatti del 1904. Ho già annotato l’azione svolta da Tittoni nel 1904 riassumendo un articolo di Gianforte Suardi nell’«Antologia» del 1° novembre 1927: Tittoni è più diffuso.
Tittoni e Giolitti. Tittoni non spiega con molta chiarezza i suoi rapporti politici con Giolitti, del quale fu intimo collaboratore: è vero che tale collaborazione è significativa anche per giudicare la politica dello stesso Giolitti. Impacciati e reticenti sono anche gli accenni di Tittoni a Sonnino e a Rudin.
Ondata anticlericale del 1907. Nel luglio 1907 scandalo Fumagalli ‑ don Riva, e fatti di Alassio. Tittoni clericaleggiante.
Tittoni propugnatore della guerra civile. Tittoni era rimasto colpito dal fatto che per riunire la forza pubblica necessaria a fronteggiare i tumulti scoppiati in una località, occorreva sguarnire altre regioni: durante la settimana rossa del giugno 14, per reprimere i moti di Ancona si era sguarnita Ravenna, dove poi il prefetto, privato della forza pubblica dovette chiudersi nella Prefettura abbandonando la città ai rivoltosi. «Più volte io ebbi a domandarmi, che cosa avrebbe potuto fare il Governo se un movimento di rivolta fosse scoppiato contemporaneamente in tutta la penisola». Tittoni propose al Governo l’arruolamento dei «volontari dell’ordine», ex combattenti inquadrati da ufficiali in congedo. Il progetto di Tittoni parve degno di considerazione, ma non ebbe seguito.
Il Partito Popolare. Tittoni aveva riposto molte speranze nel Partito Popolare fosse stato diverso da quello che era stato il primo movimento cattolico politico. Contro Miglioli, ma anche contro Meda e Rodinò.
Q5 §45 Enrico Catellani, La libertà del mare, Nuova Antologia del 1° aprile 1929.
Q5 §46 Claudio Faina, Il carburante nazionale, Nuova Antologia del 16 aprile 1929 (continua l’articolo dello stesso Faina pubblicato precedentemente dalla Nuova Antologia e rubricato altrove).
Q5 §47 Azione Cattolica. Gianforte Suardi nella «Nuova Antologia» del 1° maggio 1929 (Costantino Nigra e il XX settembre 1870) aggiunge un particolare alla sua narrazione del 1° novembre 1927 sulla partecipazione dei cattolici alle elezioni del 1904 col consenso di Pio X, particolare che aveva omesso per riserbo prima della Conciliazione. Pio X, salutando i bergamaschi (Paolo Bonomi ecc.), avrebbe aggiunto: «Ripetete a Rezzara – (che non aveva preso parte all’udienza e che, come è noto, era uno dei più autorevoli capi dell’organizzazione cattolica) – qual è la risposta che vi ho dato e ditegli che il Papa tacerà». Il sottolineato è appunto il particolare prima omesso. Una bellissima cosa, come si vede, e di altissima portata morale.
Q5 §48 Domenico Spadoni, Le Società segrete nella Rivoluzione milanese dell’aprile 1814, Nuova Antologia del 16 maggio 1929. Intervento della massoneria in quel movimento (culminato nell’uccisione del ministro Prina) secondo gli atti di un processo per complotto militare, trovati dallo Spadoni. Qualche particolare nuovo, ma non gran cosa.
Q5 §49 Bernardo Sanvisenti, La questione delle Antille, «Nuova Antologia», 1° giugno 1929. Sulla dottrina di Monroe, sui rapporti tra Stati Uniti e America Spagnola ecc. Contiene citazioni bibliografiche su questi argomenti di libri di scrittori sudamericani e riporta notizie su movimenti culturali legati al predominio degli Stati Uniti che possono essere utili.
Q5 §50 relle sulla cultura giapponese. Nella «Nuova Antologia» del 1° giugno 1929 è pubblicata l’introduzione (La religione nazionale del Giappone e la politica religiosa dello Stato giapponese) al volume su La Mitologia Giapponese che Raffaele Pettazzoni ha pubblicato nella collana di «Testi e Documenti per la Storia della Religione» editi dalla Zanichelli di Bologna. Perché il Pettazzoni ha intitolato il suo libro Mitologia? C’è una certa differenza tra «Religione» e «Mitologia» e sarebbe bene tenere ben distinte le due parole. La religione è diventata nel Giappone una semplice «mitologia» cioè un elemento puramente «artistico» o di «folklore» oppure ha ancora il valore di una concezione del mondo ancora viva e operante? Poiché pare dall’introduzione che sia quest’ultimo il valore che il Pettazzoni dà alla religione giapponese, il titolo è equivoco. Da questa introduzione noto alcuni elementi che potranno essere utili per studiare un paragrafo «giapponese» alla rubrica degli «intellettuali»:
Introduzione del Buddismo nel Giappone, avvenuta nel 552 d. C. Fino allora il Giappone aveva conosciuto una sola religione, la sua religione nazionale. Dal 552 ad oggi la storia religiosa del Giappone è stata determinata dai rapporti e dalle interferenze fra questa religione nazionale e il Buddismo (tipo di religione extranazionale e supernazionale come il cristianesimo e l’islamismo); il cristianesimo, introdotto nel Giappone nel 1549 dai gesuiti (Francesco Saverio), fu sradicato con la violenza nei primi decenni del secolo XVII; reintrodotto dai missionari protestanti e cattolici nella seconda metà del secolo XIX, non ha avuto grande importanza complessivamente. Dopo l’introduzione del Buddismo, la religione nazionale fu chiamata con parola sino‑giapponese Shinto cioè «via (cinese: tao) degli dei (cinese: Shen)» mentre butsu‑do indicò il Buddismo («do»‑via, «butsu»-Budda). In giapponese Shinto si dice Kami‑no‑michi (Kami-divinità). Kami non significa «dio» nel senso occidentale, ma più genericamente «esseri divini» compresi anche gli antenati divinizzati. (Dalla Cina fu introdotto nel Giappone non solo il Buddismo, ma anche il culto degli antenati, che, a quanto pare, si incorporò più intimamente nella religione nazionale). Lo Shintoismo è però fondamentalmente una religione naturistica, un culto di divinità (Kami) della natura, tra cui primeggiano la dea del sole Amaterasu, il dio degli uragani Susanowo, la coppia Cielo e Terra, cioè Izanagi e Izanami ecc. È interessante il fatto che lo Shintoismo rappresenta un tipo di religione che è scomparso del tutto nel mondo moderno occidentale, ma che era frequente presso i popoli civili dell’antichità (religioni nazionali e politeistiche degli Egiziani, dei Babilonesi, degli Indiani, dei Greci, dei Romani, ecc.). Amaterasu è una divinità come Osiride, o Apollo o Artemide; è interessante che un popolo civile moderno come il giapponese, creda e adori una tale divinità. (Forse però le cose non sono così semplici come può apparire). Tuttavia accanto a questa religione nazionale sussiste il Buddismo, tipo di religione supernazionale, per cui si può dire che anche in Giappone si è avuto fondamentalmente lo stesso sviluppo religioso che nell’Occidente (col Cristianesimo). Anzi Cristianesimo e Buddismo si diffondono nelle rispettive zone sincronicamente e ancora: il Cristianesimo che si diffonde in Europa non è quello della Palestina, ma quello di Roma o di Bisanzio (con la lingua latina o greca per la liturgia) così come il Buddismo che si diffonde nel Giappone non è quello dell’India, ma quello cinese, con la lingua cinese per la liturgia. Ma a differenza del Cristianesimo, il Buddismo lasciò sussistere le religioni nazionali preesistenti (in Europa le tendenze nazionali si manifestarono in seno al Cristianesimo).
All’inizio il Buddismo fu accolto nel Giappone dalle classi colte, insieme alla civiltà cinese (ma la civiltà cinese portò solo il Buddismo?) Successe un sincretismo religioso: Buddismo‑Shintoismo. Elementi di confucianismo. Nel secolo XVIII ci fu una reazione al sincretismo in nome della religione nazionale che culminò nel 1868 con l’avvento del Giappone moderno. Lo Shintoismo dichiarato religione di Stato. Persecuzione del Buddismo. Ma per breve tempo. Nel 1872 il Buddismo fu riconosciuto ufficialmente e parificato allo Shintoismo tanto nelle funzioni, tra cui principalmente quella pedagogica di educare il popolo ai sentimenti e ai principii del patriottismo, del civismo, e del lealismo, quanto nei diritti con la soppressione dell’«Ufficio dello Shinto» e la istituzione di un Ministero della religione, avente giurisdizione tanto sullo Shintoismo che sul Buddismo. Ma nel 1875 il governo mutò ancora la politica: le due religioni furono separate e lo Shintoismo andò assumendo una posizione speciale e unica. Provvedimenti burocratici vari andarono succedendosi che culminarono nella elevazione dello Shintoismo a istituzione patriottica e nazionale, con la rinunzia ufficiale al suo carattere religioso (divenne una istituzione – mi pare – del tipo di quella romana del culto dell’Imperatore, ma senza carattere religioso in senso stretto, per cui anche un Cristiano può esercitarlo). I Giapponesi possono appartenere a qualsiasi religione, ma devono inchinarsi dinanzi all’immagine dell’Imperatore. Così lo Shinto di Stato si è separato dallo Shinto delle sette religiose. Anche burocraticamente si ebbe una sanzione: esiste oggi un «Ufficio delle religioni» presso il Ministero dell’Educazione, per le varie chiese dello Shintoismo popolare, per le varie chiese buddistiche e cristiane e un «Ufficio dei santuari» per lo Shintoismo di Stato presso il Ministero dell’Interno. Secondo il Pettazzoni questa riforma fu dovuta all’applicazione meccanica delle Costituzioni occidentali al Giappone: per affermare cioè il principio della libertà religiosa e della uguaglianza di tutte le religioni dinanzi allo Stato e per togliere il Giappone dallo stato di inferiorità e arretratezza che lo Shintoismo, come religione, gli conferiva in confronto col tipo di religione vigente in Occidente.
Mi pare artificiale la critica del Pettazzoni (vedere anche in Cina quel che avviene a proposito di Sun Yat Sen e dei tre principi: si sta formando un tipo di culto di Stato, areligioso: mi pare che l’immagine di Sun abbia un culto come quello dell’Imperatore vivente in Giappone). Nel popolo e anche nelle persone colte rimane però viva la coscienza e il sentimento dello Shinto come religione (ciò è naturale, ma mi pare innegabile l’importanza della Riforma, che tende, coscientemente o no, alla formazione di una coscienza laica, in forme paradossali quanto si vuole). (Questa discussione, se lo Shinto di Stato sia una religione o no mi pare la parte più importante del problema culturale giapponese: ma tale discussione non si può fare per il Cristianesimo, certamente).
Q5 §51 relle di cultura cinese. Dall’articolo Il riformatore cinese Suen Uen e le sue teorie politiche e sociali, nella «Civiltà Cattolica» del 4 maggio e del 18 maggio 1929. «Il partito nazionalista ha promulgato decreti su decreti per onorare Suen Uen. Il più importante è quello che prescrive la “cerimonia del lunedì”. In tutte le scuole, uffici, posti militari, in qualsiasi istituzione appartenente in qualche modo al partito nazionalista, ogni lunedì, tutti si aduneranno innanzi al ritratto del “Padre della patria” e gli faranno, tutti insieme, il triplice inchino della testa. Indi si leggerà il suo “Testamento politico”, che contiene la quintessenza delle sue dottrine, e seguiranno tre minuti di silenzio per meditarne i grandi principii. Questa cerimonia sarà fatta in ogni adunanza importante». A tutte le scuole è fatto obbligo di studiare il Sen Min‑ciu‑i (triplice demismo), anche alle scuole dei cattolici e di qualsiasi confessione religiosa, come conditio sine qua non per la loro esistenza legale. Il delegato apostolico della Cina, mons. Celso Costantini, in una lettera al padre Pasquale d’Elia S. J., missionario italiano e membro dell’Ufficio Sinologico di Zi‑Ka-Wei, ha preso posizione su questi obblighi legali. La lettera è pubblicata al principio dell’opera: Le triple démisme de Sun Wen, traduit, annoté et apprécié par Pascal M. D’Elia S. J., Bureau Sinologique de Zi‑Ka‑Wei, Imprimérie de T’ou‑Sè‑Wè, Chang‑Hai 1929, in 8° pp. CLVIII‑530, 4 dollari cinesi.
Il Costantini non crede che Sun sia stato «divinizzato»: «Quanto agli inchini del capo innanzi al ritratto di Sun Yat-Sen, gli scolari cristiani non sono da inquietarsi. Per sé e di sua natura l’inchino del capo non ha senso superstizioso. Secondo l’intenzione del governo questa cerimonia non è altro che un ossequio meramente civile ad un uomo considerato quale Padre della Patria. Potrà essere eccessivo, ma non è in nessun modo idolatrico (il Governo per sé è ateo) e non vi è legato nessun sacrifizio. Se in qualche luogo per abuso si facessero dei sacrifizi, ciò dovrà ritenersi superstizioso e i cristiani non vi potrebbero assistere in niun modo. Non è nostro ufficio creare una coscienza erronea, ma illuminare gli alunni dove fosse qualche dubbio sul significato di tali cerimonie civili». Quanto all’insegnamento obbligatorio del triplice demismo, il Costantini scrive: «Secondo il mio giudizio personale, è lecito, se non insegnare, almeno spiegare nelle scuole pubbliche i principii del triplice demismo del Dr. Sun Yat Sen. Trattasi di materia non libera, ma imposta dal Governo, come condizione sine qua non. Parecchie cose, nel triplice demismo, sono buone, o almeno non cattive, e corrispondono più o meno o possono accomodarsi con la sociologia cattolica (Rerum novarum, Immortale Dei, Codice Sociale). Si deve procurare, nelle nostre scuole, di deputare alla spiegazione di questa materia, dei maestri cattolici ben formati nella dottrina e nella sociologia cristiana. Alcune cose devono essere spiegate e corrette...»
L’articolo della «Civiltà Cattolica» riassume la posizione dei Cattolici verso le dottrine del nazionalismo cinese, posizione attiva, come si vede, perché tende a creare una tendenza «nazionalistica cattolica» con una interpretazione particolare delle dottrine stesse. Dal punto di vista storico politico sarebbe bene vedere come i gesuiti sono giunti a questo risultato, rivedendo tutte le pubblicazioni della «Civiltà Cattolica» sugli avvenimenti cinesi dal 25 in poi. Nel suo libro il padre d’Elia, prevedendo l’obiezione che potrebbe venirgli da parte di alcuni dei suoi lettori i quali avrebbero consigliato piuttosto il silenzio che la pubblicità di queste idee nuove «con ragione ... risponde: “Non parlare di queste questioni, non vuol dire risolverle. Si voglia o non si voglia, i nostri Cattolici Cinesi le conosceranno per mezzo di commentari tendenziosi e ostili. Sembra che vi sia meno pericolo d’istruirli noi stessi, proponendo loro direttamente la dottrina di Suen Uen. Sforziamoci di far vedere come i cinesi possono essere buoni cattolici, non solo restando cinesi, ma anche tenendo conto di alcune teorie di Suen Uen”».
Q5 §52 Domenico Meneghini, Industrie chimiche italiane, «Nuova Antologia», 16 giugno 1929.
Q5 §53 Riforma e Rinascimento. Nicola Cusano. Nella «Nuova Antologia» del 16 giugno 1929 è pubblicata una nota di L. von Bertalanffy su Un Cardinale germanico (Nicolaus Cusanus) curiosa in se stessa e per la rella che la redazione della «Nuova Antologia» le fa seguire. Il Bertalanffy espone sul Cusano l’opinione tedesco‑protestante, sinteticamente, senza apparato critico‑bibliografico; la Nuova Antologia fa osservare meschinamente che il Bertalanffy non ha parlato degli «studi numerosi e importanti che anche in Italia furono dedicati al Cusano in questi ultimi decenni» e ne dà una sfilza fino al Rotta. L’unico cenno di merito è nelle ultime linee: «Il Bertalanffy vede nel Cusano un precursore del pensiero liberale e scientifico moderno, il Rotta invece opina che il Vescovo di Bressanone “per quello che è lo spirito, se non la forma della sua speculazione, è tutto nell’orbita del pensiero medioevale”. La verità non è mai tutta da una parte». Cosa vuol dire?
È certo che il Cusano è un riformatore del pensiero medioevale e uno degli iniziatori del pensiero moderno; lo prova il fatto stesso che la Chiesa lo dimenticò e il suo pensiero fu studiato dai filosofi laici che vi avevano ritrovato uno dei precursori della filosofia classica moderna.
Importanza dell’azione pratica del Cusano per la storia della Riforma protestante. Al Concilio (di Costanza?) fu contro il papa per i diritti del Concilio. Si riconciliò col papa. Al Concilio di Basilea sostenne la riforma della Chiesa. Tentò di conciliare Roma con gli hussiti: di riunire Oriente e Occidente e persino pensò di preparare la conversione dei Turchi, rilevando il nucleo comune nel Corano e nell’Evangelo. Docta ignorantia e coincidentia oppositorum. Per primo concepì l’idea dell’infinito, precorrendo Giordano Bruno e gli astronomi moderni.
Si può dire che la Riforma luterana scoppiò perché fallì l’attività riformatrice del Cusano, cioè perché la Chiesa non seppe riformarsi dall’interno. Per la tolleranza religiosa, ecc. (Nato nel 1401 ‑ morto nel 1464).
Michele Losacco, La dialettica del Cusano, nota di 38 pp. presentata dal socio Luigi Credaro nell’adunanza del 17 giugno di una istituzione che la Nuova Antologia dimentica di indicare (forse i Lincei?).
Q5 §54 I nipotini di padre Bresciani. Letteratura popolare‑nazionale. Bisognerà fissare bene ciò che deve intendersi per «interessante» nell’arte in generale e specialmente nella letteratura narrativa e nel teatro. L’elemento «interessante» muta secondo gli individui o i gruppi sociali o la folla in generale: è quindi un elemento della cultura, non dell’arte, ecc. Ma è perciò un fatto completamente estraneo e separato dall’arte? Intanto l’arte stessa interessa, è interessante cioè per se stessa, in quanto soddisfa una esigenza della vita. Ancora: oltre questo carattere più intimo all’arte di essere interessante per se stessa, quali altri elementi di «interesse» può presentare un’opera d’arte, per esempio un romanzo o un poema o un dramma? Teoricamente infinito. Ma quelli che «interessano» non sono infiniti: sono precisamente solo gli elementi che si ritiene contribuiscano più direttamente alla «fortuna» immediata o mediata (in primo grado) del romanzo, del poema, del dramma. Un grammatico si può interessare ad un dramma di Pirandello perché vuol sapere quanti elementi lessicali, morfologici e sintattici di marca siciliana il Pirandello introduce o può introdurre nella lingua italiana letteraria: ecco un elemento «interessante» che non contribuirà molto alla diffusione del dramma in parola. I «metri barbari» del Carducci erano un elemento «interessante» per una cerchia più vasta, per la corporazione dei letterati di professione, e per quelli che intendevano diventarlo: furono dunque un elemento di «fortuna» immediata già notevole, contribuirono a diffondere qualche migliaia di copie dei versi scritti in metri barbari. Questi elementi «interessanti» variano secondo i tempi, i climi culturali e secondo le idiosincrasie personali.
L’elemento più stabile di «interesse» è certamente l’interesse «morale» positivo o negativo, cioè per adesione o per contraddizione: «stabile» in un certo senso, cioè nel senso della «categoria morale», non del contenuto concreto morale. Strettamente legato a questo è l’elemento «tecnico» in un certo senso particolare, cioè «tecnico» come modo di far capire nel modo più immediato e più drammatico il contenuto morale, il contrasto morale del romanzo, del poema, del dramma: così abbiamo nel dramma i «colpi» di scena, nel romanzo l’«intrigo» prevalente, ecc. Tutti questi elementi non sono necessariamente «artistici», ma non sono neanche necessariamente non artistici. Dal punto di vista dell’arte essi sono in un certo senso «indifferenti», cioè extra‑artistici: sono dati di storia della cultura e da questo punto di vista devono essere valutati.
Che ciò avvenga, che così sia, è appunto provato dalla così detta letteratura mercantile, che è una sezione della letteratura popolare‑nazionale: il carattere «mercantile» è dato dal fatto che l’elemento «interessante» non è «ingenuo», «spontaneo», intimamente fuso nella concezione artistica, ma ricercato dall’esterno, meccanicamente, dosato industrialmente come elemento certo di «fortuna» immediata. Ciò significa, in ogni caso, però, che anche la letteratura commerciale non dev’essere trascurata nella storia della cultura: essa anzi ha un valore grandissimo proprio da questo punto di vista, perché il successo di un libro di letteratura commerciale indica (e spesso è il solo indicatore esistente) quale sia la «filosofia dell’epoca», cioè quale massa di sentimenti e di concezioni del mondo predomini nella moltitudine «silenziosa». Questa letteratura è uno «stupefacente» popolare, è un «oppio». (Da questo punto di vista si potrebbe fare un’analisi del Conte di Montecristo di A. Dumas, che è forse il più «oppiaceo» dei romanzi popolari: quale uomo del popolo non crede di aver subito un’ingiustizia dai potenti e non fantastica sulla «punizione» da infliggere loro? Edmondo Dantès gli offre il modello, lo «ubbriaca» di esaltazione, sostituisce il credo di una giustizia trascendente in cui non crede più «sistematicamente»).
Q5 §55 La Romagna e la sua funzione nella storia italiana. Cfr l’articolo di Luigi Cavina, Fiorentini e Veneziani in Romagna, nella Nuova Antologia del 16 giugno 1929. Tratta la quistione specialmente nel periodo immediatamente precedente alla lega di Cambrai contro i Veneziani, dopo la morte di Alessandro VI Borgia e la malattia del Valentino. La Romagna era elemento essenziale dell’equilibrio interno italiano, specialmente dell’equilibrio tra Venezia e Firenze e tra Venezia e il Papa: tanto Firenze che il Papa non potevano sopportare un’egemonia veneziana sulla Romagna. (Machiavelli e il Valentino, durante la campagna di questi per la conquista della Romagna: Machiavelli e il Valentino dopo la morte di Alessandro VI, durante il Conclave e nei primi tempi di Giulio II: al Valentino era venuta a mancare la base statale: tutta la sua figura politica e anche la «capacità» politico‑militare crolla; egli è diventato un comune «capitano di ventura» e, ancora, in cattive acque).
In questo articolo del Cavina c’è uno spunto «curioso». Egli cita il principio del Machiavelli: «Alcuna provincia non fu mai unita e felice, se la non viene tutta alla obedienza d’una repubblica o d’uno principe, come è avvenuto alla Francia ed alla Spagna» e continua: «E che questo non sia avvenuto all’Italia è bensì da imputarsi, con giudizio empirico, specialmente alla Chiesa – che non fu mai tanto forte da potere occupare essa tutta la penisola, né mai tanto debole da dover permettere che un altro l’occupasse, come dice il Machiavelli – e in parte anche agli altri Stati; ma è soprattutto da imputarsi al sistema dell’equilibrio delle potenze italiane. Qui è da vedersi la ragione storica e nazionale della mancata unione della patria, in quanto essa derivava non già da un pensiero individuale, ma da un effettivo pensiero universale, tramandatosi da generazione a generazione, lungo secoli, e rispondente dunque al genio nazionale». Cosa vuol dire tutto ciò? Che il «genio nazionale» consisteva nel non essere «nazionale»? E il «sistema di equilibrio» delle potenze italiane non era in gran parte determinato dalle necessità di esistenza dello Stato pontificio, che era potenza mondiale e italiana nello stesso tempo? Una grande confusione viene in questa serie di problemi dal fatto che si cercano le cause del perché un certo evento storico (unità territoriale‑politica della penisola italiana) non si è verificato prima del 1870. Ora se è difficile trovare e mettersi d’accordo sulle cause di un evento determinato, è certo molto difficile e quasi assurdo voler trovare le cause del perché la storia si sia sviluppata in un senso piuttosto che in un altro. In realtà non si tratta di un problema storico, ma di una necessità di carattere sentimentale e politico. Si parte dal presupposto (di carattere sentimentale e pratico immediato) che la nazione italiana sia sempre stata una nazione nei quadri attuali geografici ed ecco che allora ci si domanda perché non ha conseguito prima l’unità politica territoriale, come la Francia o la Spagna ecc.
Tuttavia il problema non è completamente assurdo, purché sia inteso e circoscritto esattamente nel suo carattere politico‑attuale, cioè per spiegare certi sviluppi storici legati alla vita moderna, o come elemento per studiare determinati criteri di metodo. L’accenno del Cavina all’«effettivo pensiero universale» è uno spunto interessante, se precisato e svolto nel senso che io ho fatto in altre . Cioè, l’Italia, per la sua funzione «cosmopolita», durante il periodo dell’Impero Romano e durante il Medio Evo subì passivamente i rapporti internazionali; cioè nello sviluppo della sua storia i rapporti internazionali prevalsero sui rapporti nazionali. Ma il Papato appunto è l’espressione di questo fatto; dato il carattere duplice del regno papale, di essere sede di una monarchia spirituale universale e di un principato temporale, è certo che la sua potenza terrena doveva essere limitata (il Machiavelli vide benissimo ciò, come si rileva dal III capitolo del Principe e da ciò che egli riporta d’aver detto al cardinale di Roano; il Roano, al tempo in cui il Valentino veniva occupando la Romagna, gli aveva detto che gli italiani non si intendevano di guerra, ed egli rispose che i francesi non si intendevano di Stato – di politica –, «perché se se n’intendessino, non lascerebbano venire la Chiesa in tanta grandezza», ecc. ecc.). È certo che se la Chiesa avesse avuto come principato terreno tutta la penisola, l’indipendenza degli Stati europei avrebbe corso serio pericolo: il potere spirituale può essere rispettato finché non rappresenta una egemonia politica e tutto il Medio Evo è pieno delle lotte contro il potere politico del Papa.
È vero dunque che negli italiani la tradizione dell’universalità romana e medioevale impedì lo sviluppo delle forze nazionali (borghesi) oltre il campo puramente economico-municipale, cioè le «forze» nazionali non divennero «forza» nazionale che dopo la Rivoluzione francese e la nuova posizione che il papato ebbe ad occupare in Europa, posizione irrimediabilmente subordinata, perché limitata e contesa nel campo spirituale dal laicismo trionfante. Tuttavia questi elementi internazionali «passivamente» prementi sulla vita italiana continuarono a operare fino al 1914 e anche (sempre meno forti) fino alla Conciliazione del febbraio 1929 e continuano anche oggi in una certa misura, determinando i rapporti esterni tra Stato italiano e Pontefice, costringendo a un certo linguaggio ecc.
(Bisognerebbe poter fare, per comprendere esattamente il grado di sviluppo raggiunto dalle forze nazionali in Italia nel periodo che va dal nascere dei Comuni al sopravvento del dominio straniero, una ricerca del tipo di quella del Groethuysen nelle Origines de l’esprit bourgeois en France. Bisognerebbe ricercare questi elementi nelle «Cronache», negli «Epistolari», nei libri di politica, nella letteratura amena, e nei libri dei pedagogisti o dei trattatisti di morale ecc. Un libro molto interessante è quello di Leon Battista Alberti, per esempio. Si potrebbe vedere per la bibliografia le storie della pedagogia in Italia ecc. Il Cortegiano di B. Castiglione indica già il prevalere di un altro tipo sociale, come modello, che non sia il borghese delle Repubbliche comunali ecc. Un posto a parte i grandi scrittori di politica, come il Machiavelli e il Guicciardini. Così un posto a parte gli scritti religiosi, prediche, trattati, ecc.).
Q5 §56 Azione Cattolica. La pace industriale (di A. Brucculeri) nella «Civiltà Cattolica» del 5 gennaio 1929. (Annota i tentativi fatti in Inghilterra per la pace industriale, le tendenze collaborazioniste del bit, i comitati paritetici di fabbrica, la legislazione del lavoro, gli alti salari in America, ecc.). Questa serie di articoli del Brucculeri sulle quistioni industriali è stata poi raccolta in volume. Il Brucculeri fa parte (o ha fatto parte) dell’Ufficio di Malines che ha compilato il Codice Sociale.
Q5 §57 L’Azione Cattolica negli Stati Uniti. Articolo della «Civiltà Cattolica» del 5 gennaio 1929 su La Campagna elettorale degli Stati Uniti e le sue lezioni. A proposito della candidatura Smith alla presidenza della Repubblica.
La «Civiltà Cattolica» registra l’accanita resistenza delle Chiese protestanti contro Smith e parla di «guerra di religione». Non c’è accenno alla posizione assunta dallo Smith verso il Papa nella sua famosa lettera (cfr libro del Fontaine sulla Santa Sede ecc.), che è un elemento di americanismo cattolico. (Posizione dei cattolici contro il proibizionismo e a favore dei farmers). Si vede che ogni azione concentrata dei cattolici provoca una tale reazione che i risultati sono inferiori alla forza che i cattolici dicono di possedere, quindi pericoli di azione su scala nazionale concentrata: è stato un errore per i cattolici fondarsi su un partito tradizionale come quello democratico? mostrare la religione come legata a un determinato partito? d’altronde potrebbero, nel sistema attuale americano, fondare un proprio partito? L’America è un terreno interessante per studiare la fase attuale del cattolicismo sia come elemento culturale che come elemento politico.
Q5 §58 L’Azione Cattolica. Una delle misure più importanti escogitate dalla Chiesa per rafforzare la sua compagine nei tempi moderni è l’obbligo fatto alle famiglie di far fare la prima comunione ai sette anni. Si capisce l’effetto psicologico che deve fare sui bambini di sette anni l’apparato cerimoniale della prima comunione, sia come avvenimento familiare individuale, sia come avvenimento collettivo: e quale fonte di terrori divenga e quindi di attaccamento alla Chiesa. Si tratta di «compromettere» lo spirito infantile appena incomincia a riflettere. Si capisce perciò la resistenza che la misura ha trovato nelle famiglie, preoccupate dagli effetti deleteri sullo spirito infantile di questo misticismo precoce e la lotta della Chiesa per vincere questa opposizione. (Ricordare nel Piccolo Mondo Antico di Fogazzaro la lotta tra Franco Maironi e la moglie quando si tratta di condurre la bimbetta in barca, in una notte tempestosa, ad assistere alla messa di Natale. Francoa Maironi vuol creare nella bimba dei «ricordi» incancellabili, delle «impressioni» decisive; la moglie non vuole turbare lo sviluppo normale dello spirito della figlia, ecc.). La misura è stata decretata da Pio X nel 1910. Nel 1928 l’editore Pustet di Roma ne ha ripubblicato il decreto con prefazione del cardinal Gasparri e commento di monsignor Jorio, dando luogo a una nuova campagna di stampa.
Q5 §59 L’Azione Cattolica in Germania. I Cattolici tedeschi per iniziativa dell’Episcopato hanno, già dal 1919, fondato una «Lega di Pace dei Cattolici tedeschi». Su questa Lega, sulle iniziative successive per svilupparla e sul suo programma confrontare la «Civiltà Cattolica» del 19 gennaio 1929.
In questo stesso fascicolo vedi la lettera di Pio XI al cardinal Bertram, arcivescovo di Breslavia, a proposito dell’Azione Cattolica in Germania, e che deve considerarsi come un intervento personale del Papa per dare un maggiore impulso al movimento dell’Azione Cattolica che in Germania pare non trovi caldi organizzatori: la lettera del Papa è un vero programma teorico‑pratico ed è interessante in generale, oltre che per la Germania. La «Civiltà Cattolica» commenta a lungo la lettera e si capisce che il commento serve anche per altri paesi.
Q5 §60 La schiavitù del lavoro indigeno (di A. Brucculeri) nella «Civiltà Cattolica» del 2 febbraio 1929. Riassume le quistioni che si riferiscono allo stato di schiavitù ancora esistente in parecchi paesi (Abissinia, Nepal, Tibet, Heggiaz, ecc.): alla condizione schiavile delle donne nei paesi a poligamia; al lavoro forzato cui sono sottoposti gli indigeni in molte colonie (per es. nell’Africa centrale francese); alle forme di schiavitù o servitù della gleba determinate in molti paesi dai debiti e dall’usura (in America il peonaggio; America centrale e meridionale; in India). (Questo fatto avveniva, e forse avverrà ancora, anche per gli emigranti italiani nell’America Meridionale: per avere il viaggio pagato, di poche centinaia di lire, l’emigrato lavora gratis per un certo tempo). Nei casi di usura premeditata, il debito non si estingue mai e la servitù si tramanda anche di generazione in generazione. Lavoro dei bambini e delle donne nelle fabbriche cinesi. Nell’articolo c’è una certa bibliografia specialmente per la schiavitù.
Q5 §61 Rotary Club. Confrontare nella «Civiltà Cattolica» del 16 febbraio 1929 l’articolo Ancora Rotary Club e Massoneria. Gli argomenti dei gesuiti per mettere in guardia contro il carattere massonico del Rotary vi sono esauriti. Il «sospetto» è di due gradi: 1) che il Rotary sia una vera e propria emanazione della massoneria tradizionale; 2) che il Rotary sia un nuovo tipo di massoneria. A questi due motivi si intrecciano altri di carattere subordinato: 1) che in ogni caso la massoneria tradizionale se ne serva astutamente approfittando dell’«ingenuità» e dell’agnosticismo dei rotariani; 2) il carattere «agnostico», di indifferenza o di tolleranza religiosa, del Rotary è per i gesuiti un tal difetto capitale da indurli a una levata di scudi e a prendere atteggiamenti di sospetto e di polemica (stadio preparatorio che potrebbe concludersi con la condanna del Rotary da parte della Chiesa). Questo secondo motivo non dà luogo ancora a una campagna a fondo, preludio di una «scomunica», perché i gesuiti devono distinguere tra paesi a maggioranza cattolica e paesi a maggioranza acattolica. In questi ultimi essi domandano la tolleranza religiosa, senza cui non potrebbero diffondersi: la loro posizione «offensiva» richiede anzi l’esistenza di istituzioni amorfe in cui inserirsi per procederne alla conquista. Nei paesi cattolici, la posizione «difensiva» domanda invece la lotta a fondo contro le istituzioni amorfe che offrono terreno favorevole agli acattolici in generale.
La fase attuale dell’atteggiamento verso il Rotary è: di offensiva ideologica senza sanzioni pratiche di carattere universale (scomunica o altra forma attenuata di proibizione) e neanche nazionale, ma solo di carattere vescovile (in qualche diocesi, spagnola per esempio, il vescovo ha preso atteggiamento contro il Rotary). L’offensiva ideologica si basa su questi punti: 1) il Rotary ha origini massoniche; 2) in molti paesi si trova nelle migliori relazioni con la massoneria; 3) in qualche luogo ha assunto un atteggiamento apertamente ostile al cattolicismo; 4) la morale rotariana non è se non un travestimento della morale laica massonica.
Il problema dell’atteggiamento dei gesuiti verso il Rotary è complicato dalle condizioni italiane: il Rotary è permesso in Italia, mentre la massoneria è illegale; sostenere in forma tassativa che il Rotary è un travestimento della massoneria o un suo strumento, porterebbe a conseguenze di carattere giudiziario. Inoltre i rotariani hanno iniziato la loro vita italiana sotto auspici eminenti: uno dei primi rotariani è stato il principe ereditario, noto per le sue tendenze cattoliche e devote. In ogni caso, poi, per riconoscimento dei rotariani stranieri, il Rotary italiano ha un suo particolare carattere, legato alla situazione locale. La «Civiltà Cattolica» riporta alcuni brani di una relazione di Stanley Leverton, pubblicata dopo una visita ai clubs d’Italia per incarico del Rotary Internazionale, in «The Rotary Wheel», organo ufficiale del Rotary Britannico, e riportata nel fascicolo di agosto 1928, p. 317, dell’organo italiano «Il Rotary»: «si ha l’impressione che in Italia il Rotary non tiri la nostra stessa barca»; «il loro Rotary è il solo Rotary possibile in Italia», «appare un po’ diverso, piuttosto un primo cugino che un fratello»; «il loro presente regime dirige le loro attività con larghezza di propositi (eh eh!!! – esclama lo scrittore della “Civiltà Cattolica” ma il loro fine è uguale al nostro...»; «per quanto possa sembrare inconsueto e diverso, vi è sempre una buona ragione perché esso sia così». «Ad ogni modo il signor Leverton ha l’impressione che i Rotariani italiani», per quanto ecc. ecc., «sono gli uomini che stanno facendo l’Italia moderna».
Q5 §62 Redazione della «Civiltà Cattolica». Gli articoli sulla massoneria sono scritti dal padre Pietro Pirri (è probabile che il Pirri abbia scritto quindi gli articoli sul Rotary). Gli articoli d’arte dal padre Carlo Bricarelli (che di solito firma). Gli articoli sull’unità delle Chiese dal padre Celi; sulla scienza naturale (quistioni dell’evoluzionismo e del trasformismo) dal padre Gaya; sulla letteratura (specialmente su Dante) dal Busnelli, ecc. Il padre Brucculeri scrive sulle quistioni economiche e industriali. Sotto il titolo Problemi odierni del lavoro ha raccolto (in un volume in 8° di pp. 145, L. 8) i seguenti articoli già apparsi nella «Civiltà Cattolica» anonimi: 1) L’organizzazione internazionale; 2) L’organizzazione scientifica; 3) L’orientazione professionale; 4) Verso la pace industriale; 5) La schiavitù del lavoro indigeno. Del padre Brucculeri erano già uscite presso l’Amministrazione della «Civiltà Cattolica» le seguenti pubblicazioni (certamente estratte dalla rivista): 1) Salariato e compartecipazione, in 16°, di pp. 70, L. 2,50; 2) Il problema della terra, IIa ed., in 16°, pp. 162, L. 3,50; 3) Lo sciopero nella storia, nella morale, nell’economia, IIa ed., in 16°, pp. 136, L. 5,00; 4) La limitazione della giornata di lavoro e il principio delle otto ore, IIa ed., in 16°, pp. 50 5 lire; 5) Sul problema di Malthus. Rilievi, L. 7,50.
Q5 §63 I nipotini di padre Bresciani. Scrittori «tecnicamente» brescianeschi. Per questi scrittori occorre vedere: Giovanni Casati, Scrittori cattolici italiani viventi. Dizionario biobibliografico ed indice analitico delle opere, con prefazione di Filippo Meda, Milano, Romolo Ghirlanda editore, Via Unione 7, in 8°, pp. VIII‑112, L. 15,00. Di questo dizionario occorrerà vedere anche le possibili successive edizioni e confrontarle tra loro, per controllare le aggiunte o le omissioni volute.
Don Giovanni Casati è lo specialista cattolico in bio‑bibliografia. Dirige la «Rivista di Letture» che consiglia e sconsiglia i libri da leggere e da acquistare per i privati e per le biblioteche cattoliche; sta compilando un repertorio Scrittori d’Italia dalle origini fino ai viventi in ordine alfabetico (secondo l’articolo della «Civiltà Cattolica» del 2 marzo 1929 da cui tolgo queste notizie, sono comparsi finora quelli delle lettere A‑B); ha scritto un volume di Saggi di libri letterari condannati dall’Indice.
Nel dizionario degli Scrittori cattolici italiani viventi ne sono registrati 591. Alcuni non risposero all’appello; il Casati, nel caso di scrittori che pubblicano libri presso librerie non cattoliche, ne ha interpretato il silenzio «come tacita preghiera di non farli figurare nel dizionario». Bisognerebbe vedere perché sono stati richiesti: perché «battezzati» o perché nei loro libri appariva un carattere strettamente e confessatamente «cattolico»? Dice la «Civiltà Cattolica» che nel Dizionario mancano, per esempio, Gaetano De Sanctis, Pietro Fedele e «non pochi altri professori d’Università e scrittori di vaglia». Il De Sanctis è certamente uno scrittore «cattolico», volutamente, confessatamente cattolico: ma Pietro Fedele? Lo sarà diventato negli ultimi anni; non lo fu certamente almeno fino al 1924. Appare dunque che il criterio nel fissare la «cattolicità» non è stato molto rigoroso e che si è voluto confondere tra «cattolici» scrittori e scrittori «cattolici».
Nel Dizionario non sono inclusi i giornalisti e pubblicisti che non hanno pubblicato qualche libro: così non appare il conte Della Torre, direttore dell’«Osservatore Romano» e il Calligari (Mikros) direttore dell’«Unità Cattolica» (morto recentemente). Alcuni si scusano «per modestia».
Chi sono i «convertiti» compresi nel Dizionario? (Tipi: Papini, Giuliotti, Mignosi, ecc.). Dice la «Civiltà Cattolica»: «Dalla guerra in qua si nota un certo ridestarsi della coscienza religiosa negli scrittori contemporanei, un interessamento insolito per i problemi religiosi, un orientarsi più di frequente verso la Chiesa Cattolica, al quale (orientarsi) avranno certamente non poco contribuito i convertiti compresi nel dizionario del Casati».
Dei 591 scrittori cattolici italiani viventi, 374 («salvo errore», scrive la «Civiltà Cattolica») sono uomini di Chiesa, sacerdoti e religiosi, tra cui tre cardinali, nove vescovi, tre o quattro abati (senza contare Pio XI); 217 sono laici, tra cui 49 donne: una sola donna è religiosa.
La «Civiltà Cattolica» nota qualche errore. Esiste un Katholischer Literaturkalender (ed. Herder, Freiburg i. B., 1926) che registra 5313 scrittori cattolici tedeschi. Per la Francia, l’Almanach Catholique Français (pubblicato da Bloud et Gay, Parigi, fin dal 1920) pubblica un piccolo dizionario delle «principales personnalités catholiques». Per l’Inghilterra, The Catholic Who’s Who, 1928 (Londra, Burns Oates and Washbourne).
La «Civiltà Cattolica» si augura che, allargati i quadri (inclusione giornalisti e pubblicisti) e vinta la ritrosia dei «modesti», l’elenco italiano si raddoppi, il che sarebbe sempre ben poco. Il curioso è che la «Civiltà Cattolica» parli di «snidare alcuni dalla propria modestia» e accenna all’«orientalista prof. P. S. Rivetta», il quale se è modesto come «orientalista» e come «prof. P. S. Rivetta», non è certo modesto come «Toddi», freddurista del «Travaso delle Idee», e redattore del foglio «Via Vittorio Veneto» per le garçonnes e per i frequentatori dei caffè di lusso e per tutti gli snobs.
Q5 §64 Chiesa e Stato in Italia prima della Conciliazione. È da rivedere a questo proposito l’articolo La Conciliazione fra lo Stato italiano e la Chiesa (Cenni cronistorici) nella «Civiltà Cattolica» del 2 marzo 1929 (la rubrica continua nei fascicoli successivi ed è da rivedere), per alcuni accenni interessanti (– interessanti anche perché avere accennato, a certi fatti indica che ad essi, quando avvennero, si dava una certa importanza –). Così si fa un cenno speciale alla «Settimana Sociale» di Venezia del 1912, presieduta dal Marchese Sassoli de Bianchi e alla «Settimana sociale» di Milano del 1913 che trattò delle «libertà civili dei cattolici»; perché proprio nel 1912 e 1913 i cattolici come organizzazione di massa trattarono della Quistione romana e ne determinarono i punti fondamentali da superare per la sua soluzione? Basta pensare alla guerra libica, e al fatto che in ogni periodo di guerra lo Stato ha bisogno della massima pace e unità morale e civile.
In questo articolo sono riportati brani di articoli d’occasione pubblicati al momento della conciliazione. Così il sen. Petrillo (nel «Popolo d’Italia» del 17 febbraio 1929) ricorda ciò che avvenne nei circoli governativi e parlamentari italiani alla morte di Benedetto XV. (Il governo Bonomi voleva evitare una commemorazione in Parlamento di Benedetto XV, ciò che avrebbe costretto il governo a intervenire ed esso non voleva fare nessuna manifestazione politica né in un senso né in un altro. Bonomi era appoggiato dai popolari e aveva ministri popolari nel gabinetto; ricordare che io mi trovavo a Roma in quei giorni e mi recai da Bevione – sottosegretario alla presidenza – in compagnia di Bombacci per avere un passaporto: Bevione era impaziente e voleva assicurarsi che nessun gruppo avrebbe preso un’iniziativa che potesse trascinare altri gruppi e mettere il governo nella necessità di intervenire. In realtà nessuno parlò, ma Petrillo si guarda bene dallo spiegare perché, proprio nessuno, nessuno, abbia parlato. Sarebbe stato bene, da certi punti di vista, che avesse parlato Salandra, si può concedere; ma perché, avendo rifiutato Salandra di parlare, nessun altro parlò? e perché solo Salandra deve essere rimproverato?).
Q5 §65 Risorgimento. Il nodo storico 1848‑49. L’ultimo paragrafo di un lungo articolo della «Civiltà Cattolica» (2 marzo ‑ 16 marzo 1929), Il P. Saverio Bettinelli e l’abbate Vincenzo Gioberti, può essere interessante come spunto. Sempre in polemica col Gioberti, la «Civiltà Cattolica», ancora una volta, dice di voler smentire l’affermazione che i gesuiti del secolo XIX siano stati avversari dell’Italia e anzi cospiranti coll’Austria. Secondo la «Civiltà Cattolica»: «Cominciando da Pio IX fino al più semplice prete di contado, l’unità italiana non era avversata da nessuno. Si potrebbe anche dimostrare ... che all’invito di Pio IX, nel 1848, per una lega italiana e per l’unione politica dell’Italia, chi si oppose fu il solo ministero piemontese. Il clero italiano, e ciò è da porsi fuori di ogni dubbio, chi non voglia negare la luce meridiana, non si oppose all’unità ma la voleva in modo diverso in quanto all’esecuzione. Questa era l’idea di Pio IX, dell’alta gerarchia de’cardinali, e dello stesso antico partito conservatore piemontese, capitanato dal conte Solaro della Margarita». Difende specificatamente i gesuiti dall’accusa di antiunitarismo e austriacantismo contro un articolo di Antonio Bruers pubblicato nella «Stirpe» dell’agosto 1928: il Bruers recensisce sfavorevolmente il libro del prof. U. A. Padovani della Università del Sacro Cuore, Vincenzo Gioberti e il Cattolicesimo, Milano, Soc. Ed. «Vita e Pensiero», 1927, che appunto deve polemizzare col Gioberti per il suo antigesuitismo. Scrive la «Civiltà Cattolica»: «In sentenza definitiva, accertiamo che i gesuiti, come Pio IX, e tutto in generale il clero italiano e l’intero partito conservatore laicale che non era poco, non combatterono mai l’unità in se stessa, ma l’unità violenta come si andava praticando, ossia il modo di attuare quell’unità che era nel desiderio comune. Oh che non si può amare la patria se non alla stregua altrui?» Ricorda poi che «a far porre nell’Indice dei libri proibiti le opere del Gioberti, fu lo stesso re Carlo Alberto» e nota gesuitescamente «dunque il re Carlo Alberto avrebbe condannato la politica del Gioberti, cioè la propria!»; ma probabilmente nel momento in cui Carlo Alberto domandava i rigori della Chiesa contro Gioberti, la sua politica era quella di Solaro della Margarita. In ogni modo è bellissimo il fatto paradossale che oggi i gesuiti possano mettere nel sacco questi scrittorelli tipo Bruers.
Q5 §66 I nipotini di padre Bresciani. Ugo Ojetti e i gesuiti. La Lettera al Rev. Padre Enrico Rosa di U. Ojetti è stata pubblicata nel «Pégaso» del marzo 1929 e riportata nella «Civiltà Cattolica» del 6 aprile successivo con la lunga postilla del p. Rosa stesso. La lettera dell’Ojetti è raffinatamente gesuitica. Comincia così: «Rev.do Padre, tanta è dall’11 febbraio la calca dei convertiti a un cattolicesimo di convenienza e di moda che Ella permetterà ad un romano, di famiglia, come si diceva una volta, papalina, battezzato in S. Maria in Via ed educato alla religione proprio in S. Ignazio di Roma e da loro gesuiti, d’intrattenersi mezz’ora con Lei, di riposarsi cioè dal gran bailamme considerando un uomo come lei, integro e giudizioso, che era ieri quel ch’è oggi e quello che sarà domani». Più oltre, ricordando i suoi primi maestri gesuiti: «Ed eran tempi difficili, ché fuori a dir Gesuita era come dire subdola potenza o fosca nequizia, mentre là dentro, all’ultimo piano del Collegio Romano sotto i tetti (– dove era posta la scuola – di religione – gesuita dove l’Ojetti fu educato –), tutto era ordine, fiducia, ilare benevolenza e, anche in politica, tolleranza e mai una parola contro l’Italia, e mai, come purtroppo accadeva nelle scuole di Stato, il basso ossequio alla supremazia vera o immaginaria di questa o di quella cultura straniera sulla nostra cultura». Ancora: ricorda di essere «vecchio abbonato della “Civiltà Cattolica”» e «fedele lettore degli articoli ch’Ella vi pubblica» e perciò «io scrittore mi dirigo a lei scrittore, e le dichiaro il mio caso di coscienza». C’è tutto: la famiglia papalina, il battesimo nella chiesa gesuitica, l’educazione gesuitica, l’idillio culturale di queste scuole, i gesuiti soli o quasi soli rappresentanti della cultura nazionale, la lettura della «Civiltà Cattolica», il padre Rosa come vecchia guida spirituale dell’Ojetti, il ricorso dell’Ojetti oggi alla sua guida per un caso di coscienza.
L’Ojetti dunque non è un cattolico di oggi, un cattolico dell’11 febbraio, per convenienza o per moda; egli è un gesuita tradizionale, la sua vita è un «esempio» da portare nelle prediche ecc. L’Ojetti non è mai stato «made in Paris», non è mai stato un dilettante dello scetticismo e dell’agnosticismo, non è mai stato voltairriano, non ha mai considerato il cattolicesimo tutto al più come un puro contenuto sentimentale delle arti figurative. Perciò l’11 febbraio l’ha trovato preparato ad accogliere la Conciliazione con «ilare benevolenza»; egli non pensa neppure (dio liberi) che si possa trattare di un instrumentum regni perché egli stesso ha sentito «che forza sia nell’animo degli adolescenti il fervore religioso, e come, una volta acceso, esso porti il suo calore in tutti gli altri sentimenti, dall’amore per la patria e per la famiglia fino alla dedizione verso i capi, dando alla formazione morale del carattere addirittura un premio e una sanzione divina». Non è questa, in compendio, la biografia, anzi l’autobiografia dell’Ojetti? Però, però: «E la poesia? E l’arte? E il giudizio critico? E il giudizio morale? Tornerete tutti a obbedire ai gesuiti?» domanda uno spiritello all’Ojetti, nella persona di «un poeta francese, che è davvero un poeta»-
L’Ojetti non per nulla è stato alla scuola dei gesuiti: a queste domande ha trovato una soluzione squisitamente gesuitica, salvo che in un aspetto: nell’averla divulgata e resa aperta. L’Ojetti dovrebbe ancora migliorare la sua «formazione morale del carattere» con sanzione e premio divino: queste sono cose che si fanno e non si dicono: Ecco infatti la soluzione dell’Ojetti: «... la Chiesa, fermi i suoi dogmi, sa indulgere ai tempi e ben l’ha dimostrato nel Rinascimento (ma dopo il Rinascimento c’è stata la Controriforma, di cui i gesuiti sono appunto campioni e rappresentanti) e Pio undecimo, umanista, sa di quant’aria abbisogni la poesia per respirare; e che ormai da molti anni, senza aspettare la Conciliazione, anche in Italia la cultura laica e quella religiosa collaborano cordialmente nella scienza e nella storia». «Conciliazione non è confusione. Il Papato condannerà com’è suo diritto; il Governo d’Italia permetterà com’è suo dovere. E Lei, se lo crederà opportuno, spiegherà sulla “Civiltà Cattolica” i motivi della condanna e difenderà le ragioni della fede; e noi qui, senza ira, difenderemo le ragioni dell’arte, se proprio ne saremo convinti, perché potrà darsi, come spesso è avvenuto da Dante al Manzoni, da Raffaello al Canova, che anche a noi fede e bellezza sembrino due lati dello stesso volto, due raggi della stessa luce. E talvolta ci sarà caro educatamente discutere. Baudelaire, ad esempio, è o non è un poeta cattolico?» «Il fatto è che oggi il conflitto pratico e storico è risolto. Ma quell’altro – tra assoluto e relativo, tra spirito e corpo, eterno contrasto che è nella coscienza di ciascuno di noi, dice Ojetti, cosa per cui B. Croce e G. Gentile, non cattolici, furono contro il modernismo (?), soddisfatti (?) di vederlo sconfitto perché (?) sarebbe stato la cattiva (?) Conciliazione, il subdolo equivoco fatto sacra dottrina – che è intimo ed eterno (e se è eterno come può essere conciliato?) non lo è, non può esserlo; e l’aiuto che a ciascuno può dare e dà quotidianamente la religione per risolverlo, a noi cattolici (come si può essere cattolici col “contrasto eterno”? si può essere tutt’al più gesuiti!) la religione lo dava anche prima. Pochezza nostra se non siamo riusciti ancora con quell’aiuto a risolverlo una volta per sempre (!?); ma Ella sa che proprio dal continuo risorgere, rinnovarsi e rinfocarsi di quell’eterno conflitto sprizzano e sfavillano poesia ed arte».
Documento stupefacente davvero digesuitismo e di bassezza morale. L’Ojetti può creare una nuova setta supergesuitica: un modernismo estetizzante gesuitico.
La risposta del p. Rosa è meno interessante perché gesuiticamente più anodina: il Rosa si guarda bene dal guardare per il sottile nel cattolicismo di Ojetti e in quello dei neo convertiti. Troppo presto: è bene che Ojetti e C. si dicano cattolici e si strofinino ai gesuiti, forse anzi da loro non si domanderà di più. Dice bene il Rosa: «convenienza o moda tuttavia – diciamolo tra noi in confidenza e di passaggio – che è forse un minor male e quindi un certo bene, rispetto a quella convenienza o moda antecedente, di futile anticlericalismo e di gretto materialismo, per cui molti (...) si tenevano lontani dalla professione della fede che pure serbavano ancora in fondo all’anima “naturalmente cristiana”».
Q5 §67 Azione Cattolica. Ricordare, per uno studio della struttura mondiale del Cattolicesimo, l’«Annuario Pontificio», che si pubblica in grossi volumi di circa 1000 pp. a Roma presso la Tipografia Poliglotta Vaticana.
Per l’Azione Cattolica italiana in senso stretto (laico) vedere gli Almanacchi Cattolici pubblicati ora da «Vita e Pensiero»: il più interessante e di maggiore valore storico è l’Almanacco Cattolico per il 1922 che registra la situazione cattolica nel primo periodo del dopoguerra.
Q5 §68 Mons. Francesco Lanzoni, Le Diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (anno 604), Studio critico, Faenza, Stab. Graf. F. Lega, 1927, «Studi e Testi», n. 35, pp. XVI‑1122, L. 125 (in appendice un Excursus sui Santi africani venerati in Italia). Opera fondamentale per lo studio sulla vita storica locale in Italia in questi secoli: risponde alla domanda: come vennero formandosi i raggruppamenti culturali religiosi durante il tramonto dell’Impero romano e l’inizio del Medio Evo) Evidentemente questo raggrupparsi non può essere separato dalla vita economica e sociale e dà indicazioni per la storia del nascere dei Comuni. Per l’origine delle città mercantili. Un’importante sede vescovile non poteva mancare di certi servizi ecc. (vettovagliamento, difesa militare ecc.) che determinavano un raggruppamento di elementi laici intorno a quelli religiosi (questa origine «religiosa» d’una serie di città medioevali, non è studiata dal Pirenne, almeno nel libretto da me posseduto; vedere nella bibliografia delle sue opere complete): la stessa scelta della sede vescovile è un’indicazione di valore storico, perché sottintende una funzione organizzativa e centralizzatrice del luogo scelto. Dal libro del Lanzoni sarà possibile ricostruire le quistioni più importanti di metodo nella critica di questa ricerca in parte di carattere deduttivo e la bibliografia.
Sono importanti anche gli studi del Duchesne sul cristianesimo primitivo (per l’Italia: Les évêchés d’Italie et l’invasion Lombarde, e Le sedi episcopali dell’antico Ducato di Roma) e sulle antiche diocesi della Gallia, e gli studi dello Harnack sulle origini cristiane, specialmente Die Mission und Ausbreitung des Christentums. Oltre che per l’origine dei centri di civiltà medioevali tali ricerche sono interessanti per la storia reale del Cristianesimo, naturalmente.
Q5 §69 Nozioni enciclopediche. Nella polemica sulle funzioni dello Stato, lo Stato «guardiano notturno» (veilleur de nuit) corrisponde all’italiano «lo Stato carabiniere» cioè lo Stato le cui funzioni sono limitate alla sicurezza pubblica e al rispetto delle leggi, mentre lo sviluppo civile è lasciato alle forze private, della società civile. Pare che l’espressione «veilleur de nuit» che ha un valore più sarcastico che non «Stato carabiniere» o «Stato poliziotto», sia di Lassalle. Il suo opposto è lo «Stato etico» o lo «Stato intervenzionista» in generale: ma ci sono differenze tra una e altra espressione: «Stato etico» è di origine filosofica (Hegel) e si riferisce piuttosto all’attività educativa e morale dello Stato; «Stato intervenzionista» è di origine economica ed è legato alle correnti protezionistiche o di nazionalismo economico. Le due correnti tendono a fondersi, ma la cosa non è necessaria. Naturalmente i liberali sono per lo Stato veilleur de nuit in maggiore o minore misura: gli «economisti» totalmente, i filosofi con distinzioni molto importanti, perché presuppongono la lotta del laicismo contro le religioni positive nella società civile. I cattolici realmente sono agnostici: essi vorrebbero lo Stato intervenzionista a loro favore; in assenza di ciò, lo Stato indifferente, perché se lo Stato non è favorevole, potrebbe aiutare i loro nemici: in realtà i cattolici vogliono tutto per loro.
Q5 §70 Stato è Chiesa. La circolare ministeriale su cui insiste «Ignotus» nel suo libretto Stato fascista, Chiesa e Scuola (Libreria del Littorio, Roma, 1929), dicendo che «non viene da molti giudicata un monumento di prudenza politica, in quanto si esprimerebbe con eccessivo zelo, con quello zelo che Napoleone (vorrà dire Talleyrand) non voleva assolutamente, con uno zelo che potrebbe sembrare eccessivo se il documento anziché da un Ministero civile, fosse stato diramato dalla stessa amministrazione ecclesiastica» è firmata dal ministro Belluzzo e inviata il 28 marzo 1929 ai Provveditori (Circolare n. 54 pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero dell’Educazione Nazionale il 16 aprile 1929, riportata integralmente nella «Civiltà Cattolica» del 18 maggio successivo). Secondo «Ignotus» questa circolare avrebbe facilitato ai cattolici un’interpretazione estensiva dell’articolo 36 del Concordato. Ma è poi vero? «Ignotus» scrive che l’Italia con l’art. 36 del Concordato non riconoscerebbe ma appena (!?) considererebbe «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica». Ma è logica questa restrizione di «Ignotus» e questa interpretazione cavillosa del verbo «considerare»? La quistione certo è grave e probabilmente i compilatori dei documenti non pensarono a tempo alla portata delle loro concessioni, quindi questo brusco arretramento. (È da pensare che il cambiamento di nome del Ministero, da «Istruzione pubblica» in «Educazione nazionale», sia legato a questa necessità di interpretazione restrittiva dell’articolo 36 del Concordato, volendo poter affermare che altro è «istruzione», momento «informativo», ancora elementare e preparatorio, e altro è «educazione», momento «formativo», coronamento del processo educativo, secondo la pedagogia del Gentile).
Le parole «fondamento e coronamento» del Concordato ripetono l’espressione del R. Decreto 1° ottobre 1923 n. 2185 sull’Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell’istruzione elementare: «A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l’insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica». Il 21 marzo 1929 la «Tribuna» in un articolo, L’insegnamento religioso nelle scuole medie, ritenuto di carattere ufficioso, scrisse: «Lo Stato fascista ha disposto che la religione cattolica, base dell’unità intellettuale e morale del nostro popolo, fosse insegnata non soltanto nella scuola dei fanciulli, ma anche in quella dei giovani».
I cattolici, naturalmente, mettono in relazione tutto ciò col 1° articolo dello Statuto, riconfermato nel 1° articolo del Trattato con la Santa Sede interpretando che lo Stato, in quanto tale, professa la religione cattolica e non già solo che lo Stato, in quanto, nella sua attività, ha bisogno di cerimonie religiose, determina che esse devono essere «cattoliche». Confrontare sul punto di vista cattolico per la scuola pubblica l’articolo (del padre M. Barbera) Religione e filosofia nelle scuole medie, nella «Civiltà Cattolica» del 1° giugno 1929.
Q5 §71 Natura dei Concordati. Nella sua lettera al cardinal Gasparri del 30 maggio 1929, Pio XI scrive: «Anche nel Concordato sono in presenza, se non due Stati, certissimamente due sovranità pienamente tali, cioè pienamente perfette, ciascuna nel suo ordine, ordine necessariamente determinato dal rispettivo fine, dove è appena d’uopo soggiungere che la oggettiva dignità dei fini, determina non meno oggettivamente e necessariamente l’assoluta superiorità della Chiesa».
Questo è il terreno della Chiesa: avendo accettato due strumenti distinti nello stabilire i rapporti tra Stato e Chiesa, il Trattato e il Concordato, si è accettato questo terreno necessariamente: il Trattato determina questo rapporto tra due Stati, il Concordato determina i rapporti tra due sovranità nello «stesso Stato», cioè si ammette che nello stesso Stato ci sono due sovranità uguali, poiché trattano a parità di condizioni (ognuna nel suo ordine). Naturalmente anche la Chiesa sostiene che non c’è confusione di sovranità, ma perché sostiene che nello «spirituale» allo Stato non compete sovranità e se lo Stato se l’arroga, commette usurpazione. Anche la Chiesa sostiene inoltre che non ci può essere duplice sovranità nello stesso ordine di fini, ma appunto perché sostiene la distinzione dei fini e si dichiara unica sovrana nel terreno dello spirituale.
Q5 §72 Passato e presente. Articolo dell’«Osservatore Romano» dell’11‑12 marzo, riportato (alcuni brani) dalla «Civiltà Cattolica» del 6 aprile 1929: «Così come non desta più l’impressione funesta, che sembra indurre in altri, la parola “rivoluzione”, allorché vuole indicare un programma e un moto che si svolge nell’ambito degli istituti fondamentali dello Stato, lasciando al loro posto il Monarca e la Monarchia: vale a dire gli esponenti maggiori e più sintetici dell’Autorità politica del Paese; senza sedizione cioè né insurrezione, da cui non sembravano poter prescindere fin qui il senso ed i mezzi di una rivoluzione».
Q5 §73 Direzione politico‑militare della guerra. Nella «Nuova Antologia» del 16 giugno 1929 è pubblicata una piccola nota a firma G. S. (o non era forse C. S., cioè Cesare Spellanzon? Sarebbe grossa!) Beneš l’immemore, abbastanza curiosa perché si afferma che la «politica delle nazionalità» fu voluta dai nostri più avveduti uomini politici, caldeggiata con pronto intuito dai maggiori giornali dell’interventismo, adottata spontaneamente dal governo italiano. È vero che G. S. scrive che questa politica si precisava sin d’allora «nei suoi veri termini», cioè favorevole specialmente all’Italia, ma non è neppure vero in questo senso ristretto, perché la politica delle nazionalità si «impose» solo dopo l’ottobre 1917. Ora G. S. si lamenta che Beneš nei suoi Souvenirs de guerre et de révolution (Ernest Leroux, Parigi) attenui i ricordi dell’amicizia «bellica» e giunga alla conclusione che tutti i guai dell’Italia durante e dopo la guerra siano da attribuirsi alla mancanza di chiarezza e di decisione della politica di guerra del paese.
Q5 §74 Funzione cosmopolitica degli intellettuali italiani. Alto medioevo (fase culturale dell’avvento del Medio Latino). Confrontare la Storia della letteratura latina cristiana di A. G. Amatucci (Bari, Laterza). A pp. 343‑44 l’Amatucci scrivendo di Cassiodoro dice: «... senza scoprirvi nulla, ché non era talento da far scoperte, ma dando uno sguardo al passato, in mezzo a cui ergevasi gigantesca la figura di Gerolamo», Cassiodoro «affermò che la cultura classica, la quale per lui voleva dire cultura romana, doveva essere il fondamento di quella sacra, e questa avrebbe dovuto acquistarsi in pubbliche scuole». Papa Agapito (535‑36) avrebbe attuato questo programma se non ne avesse avuto impedimento dalle guerre e dalle lotte di fazione che devastavano l’Italia. Cassiodoro fece conoscere questo programma nei due libri di Institutiones e lo attuò nel «Vivarium», il cenobio da lui fondato presso Squillace.
Un altro punto da studiare è l’importanza avuta dal monachesimo nella creazione del feudalesimo. Nel suo volume S. Benedetto e l’Italia del suo tempo (Laterza, Bari, a pp. 170‑71) Luigi Salvatorelli scrive: «Una comunità, e per giunta una comunità religiosa, guidata dallo spirito benedettino, era un padrone assai più umano del proprietario singolo, col suo egoismo personale, il suo orgoglio di casta, le tradizioni di abusi secolari. E il prestigio del monastero, anche prima di concentrarsi in privilegi legali, proteggeva in una certa misura i coloni contro la rapacità del fisco e le incursioni delle bande armate legali ed illegali. Lontano dalle città in piena decadenza, in mezzo alle campagne corse e spremute che minacciavano di tramutarsi in deserto, il monastero sorgeva, nuovo nucleo sociale traente il suo essere dal nuovo principio cristiano, fuori di ogni mescolanza col decrepito mondo che si ostinava a chiamarsi dal gran nome di Roma. Così san Benedetto, senza proporselo direttamente, fece opera di riforma sociale e di vera creazione. Ancor meno premeditata fu la sua opera di cultura». Mi pare che in questo brano del Salvatorelli ci siano tutti o quasi gli elementi fondamentali, negativi e positivi, per spiegare storicamente il feudalismo.
Meno importante, ai fini della mia ricerca, è la quistione dell’importanza di S. Benedetto o di Cassiodoro nell’innovazione culturale di questo periodo.
Su questo nesso di quistioni oltre al Salvatorelli è da vedere il volumetto di Filippo Ermini Benedetto da Norcia nei «Profili» di Formiggini, in cui (si trova una) bibliografia dell’argomento. Secondo l’Ermini: «... le case benedettine diverranno veramente asilo del sapere; e, più che il castello, il monastero sarà il focolare d’ogni scienza. Ivi la biblioteca conserverà ai posteri gli scritti degli autori classici e cristiani... Il disegno di Benedetto si compie; l’orbis latinus, spezzato dalla ferocia degli invasori, si ricompone in unità e s’inizia con l’opera dell’ingegno e della mano, soprattutto dei suoi seguaci, la mirabile civiltà del Medio Evo».
Q5 §75 Maggiorino Ferraris e la vita italiana dal 1882 al 1926. Nella «Nuova Antologia» del 1° luglio 1929 è pubblicata la lista degli articoli pubblicati da Maggiorino Ferraris nella rivista stessa dal gennaio 1882 al 21 aprile 1926 (il Ferraris è morto nel giugno 1929 ed è stato direttore della Nuova Antologia dal 90 circa fino al 1926). Il Ferraris era un uomo mediocre, di tendenze liberali moderate con una punta verso il giolittismo e verso il nittismo, ma appunto perciò i suoi articoli hanno un interesse generale di sintomo. Era un pubblicista accurato nell’informarsi degli elementi tecnici dei problemi trattati, cosa non molto comune in Italia. Scrisse molto sui problemi agrari anche meridionali e su altri problemi di carattere tecnico economico (comunicazioni – ferrovie, telegrafo, navigazione –, tariffe doganali e dazii, cambi ecc.): alcune di queste serie di articoli sono da rivedere e studiare. Il Ferraris era piemontese (di Acqui).
Q5 §76 Sulla crisi del 98. Del Ferraris cfr Il rincaro del pane (16 agosto 1897), L’ora presente (16 maggio 1898), Il nuovo rincaro del pane (1° febbraio 1898), Politica di lavoro (16.VI. 98).
Q5 §77 Il passaggio di Garibaldi in Calabria nel 1860. Ricordare la quistione sull’atteggiamento di Vittorio Emanuele in questo momento e il biglietto riservato che avrebbe mandato a Garibaldi. Il Ferraris, nella Nuova Antologia del 1° gennaio 1912 ha scritto un articolo Vittorio Emanuele e Garibaldi ed il passaggio del Faro nel 1860. Da documenti storici.
Q5 §78 Monachesimo e regime feudale. Sviluppo pratico della regola benedettina e del principio «ora et labora». Il «labora» era già sottomesso all’«ora», cioè evidentemente lo scopo principale era il servizio divino. Ecco che ai monaci‑contadini si sostituiscono i coloni, perché i monaci possano in ogni ora trovarsi nel convento per adempiere ai riti. I monaci nel convento cambiano di «lavoro»; lavoro industriale (artigiano) e lavoro intellettuale (che contiene una parte manuale, la copisteria). Il rapporto tra coloni e convento è quello feudale, a concessioni livellarie, ed è legato oltre all’elaborazione interna che avviene nel lavoro dei monaci, anche all’ingrandirsi della proprietà fondiaria del monastero. Altro sviluppo è dato dal sacerdozio: i monaci servono come sacerdoti il territorio circonvicino e la loro specializzazione aumenta: sacerdoti, intellettuali di concetto, copisti, operai industriali‑artigiani. Il convento è la «corte» di un territorio feudale, difeso più che dalle armi, dal rispetto religioso ecc. Esso riproduce e sviluppa il regime della «villa» romana patrizia. Per il regime interno del Monastero fu sviluppato e interpretato un principio della Regola, ove è detto che nella elezione dell’abate debba prevalere il voto di coloro che si stimano più savi e prudenti e che del consiglio di costoro debba l’abate munirsi quando debba decidere affari gravi, non tali tuttavia che convenga consultare l’intera congregazione; vennero così distinguendosi i monaci sacerdoti, che si dedicavano agli uffici corrispondenti al fine dell’istituzione, dagli altri che continuavano ad attendere ai servizi della casa.
Q5 §79 A. G. Bianchi, I clubs rossi durante l’assedio di Parigi, «Nuova Antologia», 1° luglio 1929. Riassume un opuscolo, pubblicato nel 1871, di M. G. Molinari, Les clubs rouges pendant le siège de Paris. È una raccolta di cronache pubblicate prima nel «Journal des Débats» sulle riunioni dei clubs durante l’assedio (forse si tratta dello stesso De Molinari, il noto scrittore liberista e direttore dei «Débats»; ma il Bianchi scrive che è «un modesto ma diligente giornalista»). L’opuscolo è interessante perché registra tutte le proposte strampalate che venivano fatte dai frequentatori di questi circoli popolari. Perciò sarebbe interessante leggerlo e trarne materiale per sostenere la necessità dell’ordine intellettuale e della «sobrietà» morale nel popolo. Può servire anche per studiare come fino al 70 Parigi sia rimasta sotto l’incanto delle forme politiche create dalla Rivoluzione del 1789, di cui i clubs furono la manifestazione più appariscente ecc. (Non potendo leggere l’opuscolo originale del Molinari, si può ricorrere a questo articolo del Bianchi).
Q5 §80 Sorel e i giacobini. Nell’articolo riferito nella nota precedente è riportato questo giudizio di Proudhon sui giacobini: Il giacobinismo è «l’applicazione dell’assolutismo di diritto divino alla sovranità popolare». «Il giacobinismo si preoccupa poco del diritto: procede volentieri per mezzi violenti, esecuzioni sommarie. La rivoluzione per esso sono i colpi di folgore, le razzie, le requisizioni, il prestito forzato, l’epurazione, il terrore. Diffidente, ostile alle idee, si rifugia nell’ipocrisia e nel machiavellismo: i giacobini sono i gesuiti della rivoluzione». Queste definizioni sono estratte dal libro: La justice dans la révolution. L’atteggiamento di Sorel contro i giacobini è preso da Proudhon.
Q5 §81 Passato e presente. Distribuzione territoriale della popolazione italiana. Secondo il censimento del 1921 su ogni 1000 abitanti, 258 vivevano in case sparse e 262 in centri con meno di 2000 abitanti (questa può dirsi tutta popolazione rurale), 125 nei centri con 2000‑5000 abitanti, 134 nei centri con 5 000‑20 000 abitanti (piccole città), 102 nei centri con 20 000 ‑ 100 000 (medie città), 119 nelle grandi città con più di 100 000 abitanti (cfr Giorgio Mortara, Natalità e urbanesimo in Italia nella Nuova Antologia del 1° luglio 1929). Cfr con lo spostamento delle categorie dei centri abitati dovuto alle aggregazioni di vari comuni dopo il 1927 che ha aumentato il numero delle grandi e medie città specialmente (ma anche delle piccole, forse anche in maggior proporzione), senza però mutarne la struttura sociale. Secondo (sempre) il Mortara nel 1928 la popolazione dei venti comuni con oltre 100 000 abitanti (comuni e non soltanto centri, perché dopo le aggregazioni) supera di poco 17 milioni, cioè corrisponde al 173 per mille della popolazione nazionale; in Francia la proporzione è 160 per mille, in Germania 270 per mille, in Gran Bretagna circa 400 per mille, nel Giappone 150 per mille. Cent’anni fa i comuni con oltre 100 000 abitanti comprendevano 68 su mille abitanti e cinquant’anni or sono 86 per mille, oggi 173 per mille.
Q5 §82 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. In che misura lo sciamare in tutta Europa di eminenti e mediocri personalità italiane (ma di un certo vigore di carattere) fu dovuto ai risultati delle lotte interne delle fazioni comunali, al fuoruscitismo politico cioè? Questo fenomeno fu persistente dopo la seconda metà del secolo XIII: lotte comunali con dispersione delle fazioni vinte, lotte contro i principati, elementi di protestantesimo ecc. fino al 1848; nel secolo XIX il fuoruscitismo muta di carattere, perché gli esiliati sono nazionalisti e non si lasciano assorbire dai paesi di immigrazione (non tutti però: vedi Antonio Panizzi divenuto direttore del British Museum e baronetto inglese). Di questo elemento occorre tener conto, ma non è certo quello prevalente nel fenomeno generale. Così in un certo periodo occorre tener conto del fatto che i principi italiani sposavano le loro figlie con principi stranieri e ogni nuova regina di origine italiana portava con sé un certo numero di letterati, artisti, scienziati italiani (in Francia con le Medici, in Spagna con le Farnesi, in Ungheria ecc.) oltre a diventare un centro di attrazione dopo la salita al trono.
Tutti questi fenomeni devono essere studiati e la loro importanza relativa fissata esattamente, in modo da dare il proprio valore al fatto fondamentale. Nell’articolo Il Petrarca a Montpellier, nella Nuova Antologia del 16 luglio 1929, Carlo Segrè ricorda come ser Petracco, bandito da Firenze e stabilitosi con la famiglia a Carpentras, volle che suo figlio Francesco frequentasse l’Università di Montpellier per intraprendere l’attività legale. «La scelta poi si mostrava ottima, perché in Italia e nel mezzogiorno della Francia grande era allora la richiesta di giuristi da parte di principi e di governi municipali, che li adoperavano come giudici, magistrati, ambasciatori e consulenti, senza dire che restava loro aperto l’esercizio privato dell’avvocatura, meno onorifico ma sempre vantaggioso per chi non mancasse di sveltezza». L’Università di Montpellier fu fondata nel 1160 dal giureconsulto Piacentino, che si era formato a Bologna e aveva portato in Provenza i metodi dell’insegnamento di Irnerio (questo Piacentino era però italiano? occorre sempre fare delle ricerche perché i nomi italiani possono essere soprannomi o italianizzazioni). Certo che molti italiani furono chiamati dall’estero, per organizzarvi università sul modello bolognese, pavese ecc.
Q5 §83 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. Articolo di Ferdinando Nunziante Gli italiani in Russia durante il secolo XVIII nella Nuova Antologia del 16 luglio 1929. Articolo mediocre e superficiale, senza indicazioni di fonti per le notizie riportate. Se ne possono trarre spunti e indicazioni generiche. Già l’importanza degli intellettuali italiani era caduta e si apriva l’era degli avventurieri. Scrive il Nunziante per la Russia del 700: «Dalla Germania venivano ingegneri e generali per l’esercito; dall’Inghilterra ammiragli per la flotta; dalla Francia ballerini, parrucchieri e filosofi, cuochi ed enciclopedisti; dall’Italia principalmente pittori, maestri di cappella e cantanti». Ricorda che i Panini d’origine lucchese furono il ceppo della famiglia dei conti Panin, ecc.
Q5 §84 Letteratura popolare. Wells. Cfr l’articolo di Laura Torretta, L’ultima fase di Wells, nella Nuova Antologia del 16 luglio 1929. Interessante e pieno di spunti utili per questa rubrica. Wells dovrà essere considerato come scrittore che ha inventato un nuovo tipo di romanzo di avventure, diverso da quello di Verne. Nel Verne ci troviamo, generalmente, nell’ambito del verosimile, con una antecipazione sul tempo. Nello Wells lo spunto generale è inverosimile, mentre i particolari sono scientificamente esatti o almeno verosimili; Wells è più immaginoso e ingegnoso, Verne più popolare. Ma Wells è scrittore popolare anche in tutto il resto della sua produzione: è scrittore «moralista» e non solo nel senso normale ma anche in quello deteriore. Però non può essere popolare in Italia e in genere nei paesi latini e in Germania: è troppo legato alla mentalità anglosassone.
Q5 §85 Sviluppo dello spirito borghese in Italia. Cfr l’articolo Nel centenario della morte di Albertino Mussato di Manlio Torquato Dazzi nella Nuova Antologia del 16 luglio 1929. Secondo il Dazzi, il Mussato si stacca dalla tradizione della storia teologica per iniziare la storia moderna o umanistica più di qualsiasi altro del suo tempo (vedere i trattati di storia della storiografia, di B. Croce, del Lisio, del Fueter, del Balzani ecc.); appaiono le passioni e i motivi utilitari degli uomini come motivi della storia. A questa trasformazione della concezione del mondo hanno contribuito le lotte feroci delle fazioni comunali e dei primi signorotti. Le sviluppo può essere seguito fino al Machiavelli, al Guicciardini, a L. B. Alberti. La Controriforma soffoca lo sviluppo intellettuale. Mi pare che in questo sviluppo si potrebbero distinguere due correnti principali. Una ha il suo coronamento letterario nell’Alberti: essa rivolge l’attenzione a ciò che è «particulare», al borghese come individuo che si sviluppa nella società civile e che non concepisce società politica oltre l’ambito del suo «particulare»; è legato al guelfismo, che si potrebbe chiamare un sindacalismo teorico medioevale. È federalista senza centro federale. Per le quistioni intellettuali si affida alla Chiesa, che è il centro federale di fatto per la sua egemonia intellettuale e anche politica. È da studiare la costituzione reale dei Comuni, cioè l’atteggiamento concreto che i rappresentanti prendevano verso il governo comunale: il potere durava pochissimo (due mesi soli, spesso) e in questo tempo i membri del governo erano sottoposti a clausura, senza donne; essi erano gente molto rozza, che erano stimolati dagli interessi immediati della loro arte (cfr per la Repubblica Fiorentina il libro di Alfredo Lensi sul Palazzo della Signoria dove dovrebbero essere molti aneddoti su queste riunioni di governo e sulla vita dei signori durante la clausura). L’altra corrente ha il coronamento in Machiavelli e nell’impostazione del problema della Chiesa come problema nazionale negativo. A questa corrente appartiene Dante, che è avversario dell’anarchia comunale e feudale ma ne cerca una soluzione semimedioevale; in ogni caso pone il problema della Chiesa come problema internazionale e rileva la necessità di limitarne il potere e l’attività. Questa corrente è ghibellina in senso largo. Dante è veramente una transizione: c’è affermazione di laicismo ma ancora col linguaggio medioevale.
Q5 §86 Inghilterra. La bilancia commerciale inglese già da circa 50 anni prima della guerra andava modificando la sua struttura interna. La parte costituita dalle esportazioni di merci perdeva relativamente e l’equilibrio si fondava sempre più sulle così dette esportazioni invisibili, cioè gli interessi dei capitali collocati all’estero, i noli della marina mercantile e gli utili realizzati da Londra come centro finanziario internazionale. Dopo la guerra, per la concorrenza degli altri paesi, l’importanza delle esportazioni invisibili è ancora aumentata. Da ciò la cura dei cancellieri dello Scacchiere e della Banca d’Inghilterra di riportare la sterlina alla parità dell’oro e quindi reintegrarla nella sua posizione di moneta internazionale. Questo fine fu raggiunto, ma ha determinato il rincaro del prezzo di costo della produzione industriale, che ha perduto terreno nei mercati stranieri.
Ma è stata questa la causa (almeno l’elemento più importante) della crisi industriale inglese? In che misura il governo sacrificò gli interessi degli industriali a quelli dei finanziari, portatori di prestiti all’estero e organizzatori del mercato finanziario mondiale londinese? Intanto: il ristabilimento del valore della sterlina può aver anticipato la crisi, non averla determinata, poiché tutti i paesi, anche quelli rimasti per qualche tempo a moneta fluttuante e che l’hanno consolidata a un valore più basso dell’originario, hanno subito e subiscono la crisi: si potrebbe dire che avere anticipato la crisi in Inghilterra avrebbe dovuto indurre gli industriali a correre prima ai ripari e a rimettersi quindi prima degli altri paesi, ritrovando così l’egemonia mondiale. D’altronde il ritorno immediato alla parità aurea ha evitato in Inghilterra le crisi sociali determinate dai passaggi di proprietà e dalla decadenza fulminea delle classi medie piccolo-borghesi: in un paese tradizionalista, conservatore, ossificato nella sua struttura sociale, come l’Inghilterra, quali risultati avrebbero avuto i fenomeni di inflazione, di oscillazione, di stabilizzazione in perdita della moneta? Certo molto più gravi che negli altri paesi.
In ogni modo bisognerebbe fissare con esattezza il rapporto tra l’esportazione di merci e le esportazioni invisibili, tra il fatto industriale e quello finanziario: ciò servirebbe a spiegare la relativa scarsa importanza politica degli operai e il carattere ambiguo del partito laburista e la scarsezza di stimoli alla sua differenziazione e al suo sviluppo.
Q5 §87 Direzione politico‑militare della guerra 1914-1918. Confronta l’articolo di Mario Caracciolo (colonnello) Il comando unico e il comando italiano nel 1918 nella «Nuova Antologia» del 16 luglio 1929. Molto interessante e indispensabile per compilare definitivamente questa rubrica. Il Caracciolo è scrittore militare molto serio e che difficilmente si lascia trasportare dalla retorica. Ha scritto un volume nella Collezione Gatti presso Mondadori, Le truppe italiane in Francia.
Per ora mi interessa un particolare (che potrebbe apparire nella rubrica «Passato e presente»), legato alla ripetuta affermazione del Caracciolo della insufficienza dell’apparato industriale italiano: verso il gennaio‑febbraio 1918 (cfr il volume del Caracciolo citato per stabilire esattamente il fatto) l’Italia mandò in Francia 60 000 uomini, lavoratori ausiliari, «che avevamo disponibili perché la nostra industria ancora non aveva potuto darci tutte le armi necessarie per armarli». Questo elemento può dar luogo ad alcune conseguenze: 1) Come sia politicamente erroneo chiamare «imboscati» gli addetti all’industria in tempo di guerra. Erano essi necessari e indispensabili all’attività bellica? Erano tanto necessari che risulta esserci stati troppo pochi «imboscati», tanto da rendere inutilizzabili in Italia 60 000 uomini. Questa propaganda contro i pseudo‑imboscati ebbe conseguenze deplorevoli: già prima dell’armistizio furono mandati a Torino dei reparti d’assalto che incominciarono subito la caccia all’«imboscato»; all’uscita dalle officine gli uomini dal bracciale di esonero, e poi nelle vie centrali, erano aggrediti, bastonati e spesso sfregiati in faccia; gli avvenimenti alla spicciolata culminarono nella notte di capodanno 1919 coi fatti di palazzo Siccardi. La censura non permise di fare neanche un cenno a questi avvenimenti.
2) La contrapposizione di combattenti e di esonerati e imboscati da fatto privato diventò fatto di diritto pubblico e ciò è l’aspetto più grave della quistione, perché lasciò formarsi l’opinione che gli esonerati fossero dei veri «imboscati», non elementi indispensabili per l’attività bellica anche se non combattenti, con sanzione ufficiale. Per legge si deve preferire un ex combattente nelle officine, ecc. (Se nelle officine ci furono degli imboscati veri questi sono da ricercare specialmente nei tecnici di secondo grado: la riduzione al minimo delle operazioni di lavoro determinata dal limitato numero di oggetti fabbricati e dalla loro struttura elementare e il lavoro a serie, avevano ridotto la funzione da quella di maestro d’arte a quella di pura sorveglianza disciplinare: ciò unito all’ampliamento degli impianti dette la possibilità di imboscarsi a molta gente che non aveva mai avuto a che fare coll’industria; questi sono veri imboscati, perché il posto poteva essere assegnato a dipendenti anziani della fabbrica stessa. Così non può parlarsi di imboscati per i contadini che entrarono allora in quantità voli nelle fabbriche, direttamente dalle campagne o comandati dall’autorità militare. A Torino, la manovalanza delle officine era in gran parte costituita da soldati comandati d’origine contadina). In questi regolamenti sulla assunzione dei disoccupati non si fa neanche il caso speciale dei riformati, per i quali non essere stati combattenti è stato ancora più involontario.
In Italia, col ristretto apparato industriale in confronto delle necessità del tempo di guerra, il problema è spinoso: necessariamente, l’industria metallurgica e meccanica, ma parzialmente anche altre industrie (chimiche, del legno, tessili) devono essere mobilitate e siccome la produzione deve essere teoricamente illimitata, anche ampliate: quindi non solo devono rimanere in officina le maestranze vecchie, ma dovranno farsi nuove assunzioni. La composizione dell’esercito sarà perciò in prevalenza contadina, mentre la maggior parte degli operai, o almeno una porzione ragguardevole, dovrà lavorare per l’attrezzamento e il munizionamento. Fare di questa necessità un elemento di agitazione demagogica e sanzionarla di inferiorità per gli addetti all’industria, potrà avere questa conseguenza (in assenza di una soluzione organica che è difficile: rotazione tra officina e fronte, ecc.): che realmente nelle officine vorranno rimanere i panciafichisti e che il problema della produzione subirà una crisi, cioè la guerra potrà essere perduta nelle officine per mancanza di rendimento.
Q5 §88 Sul Risorgimento italiano. Michele Amari e il sicilianismo. Confrontare l’articolo su Michele Amari di Francesco Brandileone nella Nuova Antologia del 1° agosto 1929 che è poi una lunga recensione polemica de Le più belle pagine di Michele Amari scelte da V. E. Orlando, con una prefazione molto interessante per capire l’origine anche dell’attuale «sicilianismo» di cui l’Orlando è un rappresentante (a due facce: una verso il continente velata dei sette veli dell’unitarismo e una verso la Sicilia, più franca: ricordare il discorso di Orlando a Palermo durante le elezioni amministrative del 1925 e il suo elogio indiretto della mafia, presentata nel suo aspetto sicilianista di ogni virtù e generosità popolana).
L’Amari nato nel 1806 a Palermo e cresciuto tra la costituzione del 1812 e la rivoluzione del 1820 quando la costituzione fu abolita, come tanti altri siciliani del suo tempo era persuaso che il bene dell’isola fosse da ricercare nel ristabilimento della Costituzione, ma soprattutto nell’autonomia e nel distacco da Napoli.
«L’aspirazione a costituire uno Stato a sé fu il sentimento dominante fra gli isolani almeno fino al 1848», scrive il Brandileone. L’Amari, come scrisse egli stesso (cfr Alessandro D’Ancona, Carteggio di M. Amari raccolto e pubblicato coll’elogio di lui letto nell’Accademia della Crusca, Torino, 1896‑97, in 3 volumi; cfr vol. II, p. 371) si sentiva italiano (di cultura) ma la vita nazionale italiana gli pareva un bel sogno e nulla più. Volle raccontare gli avvenimenti del 1812‑20 per preparare gli animi a una nuova rivoluzione, ma la ricerca dei nessi storici lo spinse a risalire nel passato della storia costituzionale siciliana e così si fissò sulla costituzione avuta dopo i Vespri, che gli parve «la forma più netta» la più tipica. Ma la ricerca del passato lo portò ancor più in là, fino alla fase musulmana della storia di Sicilia.
L’Orlando, nella sua scelta, ha disposto i brani in ordine cronologico, in modo da dare un racconto abbreviato ma ininterrotto degli avvenimenti siciliani dei cinque secoli, dall’827, inizio della conquista araba, al 1302, pace di Caltabellotta. Nella prefazione (a p. 23) l’Orlando afferma che quei cinque secoli «sembrano costituire un monolitico periodo, durante il quale la storia ha bagliori di epopea» e che essi non sono da riguardare come storia particolare, o locale che dir si voglia, ma come storia universale, perché «se universale è la storia che all’umanità si riferisce come un tutto ideale, sebbene abbia il suo centro vitale solo in un determinato punto dello spazio, come Atene, Roma, Gerusalemme, ecc., non si può negare che in quei cinque secoli la Sicilia fu un nodo centrale, in cui si incontrarono, si urtarono, si elisero e si ricomposero le forze dominatrici del tempo». Per il Brandileone l’Orlando si lascia «guidare un po’ troppo dalla carità del natio loco» (è il modo solito di attutire e interpretare canonicamente i sentimenti politici centrifughi). L’Orlando divide questi cinque secoli in due periodi, dei quali il primo (dominio musulmano e normanno‑svevo sarebbe «statico», poiché in esso solo «venne elaborandosi tutta una civiltà specifica che costituì un’era e culminò nella creazione dello Stato e nella massima potenza di esso» e nel secondo «più dinamico», «di quello Stato avvenne la consacrazione storica e cioè la passione per la difesa dell’indipendenza nel suo più formidabile cimento».
Il Brandileone polemizza sottilmente coll’Orlando e le cose che dice sono molto interessanti per la storia siciliana e meridionale, ma in questa rubrica interessa il punto di vista dell’Orlando in sé e per sé come riflesso del sicilianismo nella forma intellettuale. Realmente l’Orlando è d’accordo coll’Amari, ne sente lo stesso impulso intellettuale e morale, di valorizzare la storia siciliana, di affermare che la Sicilia è stata un momento della storia universale, che il popolo siciliano ha avuto una fase creatrice di Stato, che non può non essere l’espressione di una «nazionalità siciliana» (anche se fino a questa affermazione l’Orlando non voglia arrivare come non arrivava l’Amari, dicendo di essersi sentito italiano anche prima del 48).
Il Brandileone oppone all’Orlando il punto di vista espresso dal Croce nella Storia del Regno di Napoli, cioè che «quella storia nella sua sostanza non è nostra o nostra è soltanto per piccola parte e secondaria», «storia rappresentata nella nostra terra e non generata dalle sue viscere»; è vero che il Croce si riferisce al periodo normanno‑svevo per il Mezzogiorno, ma secondo il Brandileone deve riferirsi anche alla Sicilia. Il punto di vista del Croce genericamente è esatto, ma nel tempo in cui quella storia si svolgeva era essa sentita dal popolo come propria e in che misura? E quale era la parte creativa della popolazione? In ogni modo questi avvenimenti impressero una certa direttiva alla storia del paese, crearono certe condizioni che continuarono e continuano ancora ad operare in certi limiti.
Q5 §89 Gabriele Gabbrielli, India ribelle, nella «Nuova Antologia» del 1° agosto 1929. (Questo signor G. G. è specializzato per scrivere e articoli sulla «Nuova Antologia» e probabilmente in qualche giornale quotidiano, contro l’attività dell’Ispolcom. Si serve del materiale che pubblica a Ginevra l’Entente contre la T. I. specialmente nel suo «Bollettino mensile» ed ha delle simpatie generiche col movimento per la difesa dell’Occidente di Henri Massis: simpatie generiche perché mentre per il Massis l’egemone dell’unione latino‑cattolica non può essere che la Francia, per il Gabbrielli invece deve essere l’Italia; a proposito del Massis e della difesa dell’Occidente è da ricordare che il padre Rosa nella risposta a Ugo Ojetti vi accenna in modo molto brusco; il Rosa vi vede un pericolo di deviazione o una deviazione bell’e buona dall’ortodossia romana).
Quattro milioni e seicento settantacinque mila Km, 319 milioni di abitanti, 247 milioni di abitanti nelle quindici enormi province amministrate direttamente dal governo inglese, che occupano la metà del territorio; l’altra metà è ripartita fra circa 700 Stati tributari. Cinque religioni principali, un’infinità di sette, 150 fra lingue e dialetti; caste; analfabetismo dominante; 80% della popolazione contadini; schiavitù della donna, pauperismo, carestie endemiche. Durante la guerra 985 000 indiani mobilitati.
Rapporti tra Gandhi e Tolstoi nel periodo 1908-1910 (cfr Romain Rolland, Tolstoi e Gandhi, nella rivista «Europe», 1928, nel numero unico tolstoiano). Tutto l’articolo è interessante in mancanza di altre informazioni.
Q5 §90 relle di cultura islamitica. Assenza di un clero regolare che serva di trait‑d’union tra l’Islam teorico e le credenze popolari. Bisognerebbe studiare bene il tipo di organizzazione ecclesiastica dell’Islam e l’importanza culturale delle Università teologiche (come quella del Cairo) e dei dottori. Il distacco tra intellettuali e popolo deve essere molto grande, specialmente in certe zone del mondo musulmano: così è spiegabile che le tendenze politeiste del folklore rinascano e cerchino di adattarsi al quadro generale del moismo maomettano. Cfr l’articolo I santi nell’Islâm di Bruno Ducati nella Nuova Antologia del 1° agosto 1929. Il fenomeno dei santi è specifico dell’Africa settentrionale, ma ha una certa diffusione anche in altre zone. Esso ha la sua ragione di essere nel bisogno (esistente anche nel Cristianesimo) popolare di trovare intermediari tra sé e la divinità. Maometto, come Cristo, fu proclamato, – si proclamò – l’ultimo dei profeti, cioè l’ultimo legame vivente tra la divinità e gli uomini; gli intellettuali (sacerdoti o dottori) avrebbero dovuto mantenere questo legame attraverso i libri sacri; ma una tal forma di organizzazione religiosa tende a diventare razionalistica e intellettualistica (cfr il protestantesimo che ha avuto questa linea di sviluppo), mentre il popolo primitivo tende a un misticismo proprio, rappresentato dall’unione con la divinità con la mediazione dei santi (il protestantesimo non ha e non può avere santi e miracoli); il legame tra gli intellettuali dell’Islâm e il popolo divenne solo il «fanatismo», che non può essere che momentaneo, limitato, ma che accumula masse psichiche di emozioni e di impulsi che si prolungano in tempi anche normali. (Il cattolicesimo agonizza per questa ragione: che non può creare, periodicamente, come nel passato, ondate di fanatismo; negli ultimi anni, dopo la guerra, ha trovato dei sostituti, le cerimonie collettive eucaristiche che si svolgono con splendore fiabesco e suscitano relativamente un certo fanatismo: anche prima della guerra qualcosa di simile suscitavano, ma in piccolo, su scala localissima, le così dette missioni, la cui attività culminava nell’erezione di un’immensa Croce con scene violente di penitenza, ecc.). Questo movimento nuovo dell’Islâm è il sufismo.
I Santi musulmani sono uomini privilegiati che possono, per speciale favore, entrare in contatto con Dio, acquistando una perenne virtù miracolosa e la capacità di risolvere i problemi e i dubbi teologici della ragione e della coscienza. Il sufismo, organizzatosi a sistema ed esternatosi nelle scuole sufiche e nelle confraternite religiose, sviluppò una vera teoria della santità e fissò una vera gerarchia di santi. L’agiografia popolare è più semplice di quella sufica. Sono santi per il popolo i più celebri fondatori o capi di confraternite religiose; ma anche uno sconosciuto, un viandante che si fermi in una località a compier opere di ascetismo e benefici portentosi a favore delle popolazioni circostanti, può essere proclamato santo dalla pubblica opinione. Molti santi ricordano i vecchi iddii delle religioni vinte dall’Islâm.
Il Marabutismo dipende da una fonte della santità musulmana, diversa dal sufismo: Murâbit (marabutto) vuol dire che è nel ribât, cioè nel luogo fortificato della frontiera dal quale irrompere, nella guerra santa, contro gli infedeli. Nel ribât il culto doveva essere più austero, per la funzione di quei soldati presidiari, più fanatici e costituiti spesso di volontari (arditi dell’Islam): quando lo scopo militare perdé d’importanza, rimase un particolare abito religioso e i «santi» più popolari ancora che quelli sufici. Il centro del Marabutismo è il Marocco; verso Est, le tombe di Marabutti vanno sempre più diradandosi.
Il Ducati analizza minutamente questo fenomeno africano, insistendo sull’importanza politica che hanno i Marabutti, che si trovano a capo delle insurrezioni contro gli Europei, che esercitano una funzione di giudici di pace, e che talvolta furono il veicolo di una civiltà superiore. Conclude: «Questo culto (dei santi) per le conseguenze sociali, civilizzatrici e politiche, le quali ne derivano, merita di essere sempre meglio studiato e sempre più attentamente sorvegliato, poiché i Santi costituiscono una potenza, una forza straordinaria, la quale può essere l’ostacolo maggiore alla diffusione della civiltà occidentale, come pure, se abilmente sfruttata, può divenire un’ausiliaria preziosa dell’espansione europea».
Q5 §91 Rinascimento e Riforma. Bisognerà leggere il volume di Fortunato Rizzi, L’anima del Cinquecento e la lirica volgare che, dalle recensioni lette, mi pare più importante come documento della cultura del tempo che per il suo valore intrinseco. (Sul Rizzi ho scritto in altro quaderno una rella, considerandolo come «italiano meschino» a proposito di una sua recensione del libro di un nazionalista francese sul Romanticismo, recensione che dimostrava la sua assoluta inettitudine a orientarsi fra le idee generali e i fatti di cultura). Sul libro del Rizzi occorrerà rileggere l’articolo di Alfredo Galletti La lirica volgare del Cinquecento e l’anima del Rinascimento nella Nuova Antologia del 1° agosto 1929. (Anche sul Galletti occorrerà allargare le proprie informazioni: il Galletti dopo la guerra – per la quale ha lottato strenuamente col Salvemini e col Bissolati, date le sue origini riformistiche, aggiungendo un particolare spirito antigermanico – nel primo, ma specialmente nel secondo dopoguerra, è caduto in uno stato d’animo di esasperazione culturale, di piagnonismo intellettuale, proprio di chi ha avuto «gli ideali infranti»; i suoi scritti sono riboccanti di recriminazioni, di digrignar di denti in sordina, di allusioni critiche sterili nella loro disperazione comica). Nella critica della poesia cinquecentesca italiana prevale questa opinione: che essa sia per quattro quinti artificiosa, convenzionale, priva di intima sincerità. «Ora – osserva il Rizzi con molto buon senso – è sentenza comune che nella poesia lirica si trovi l’espressione più schietta e viva del sentimento di un uomo, di un popolo, di un periodo storico. È egli possibile che ci sia stato un secolo – il Cinquecento appunto – il quale abbia avuto la disgrazia di nascere senza una propria fisonomia spirituale o che di tale fisonomia si sia compiaciuto (?!) a riverberare un’immagine falsa proprio nella poesia lirica? Il più intellettualmente vivace, il più spiritualmente intrepido, il più cinico dei secoli, dicono i suoi tanti avversarî (!!), avrebbe ipocritamente dissimulato il suo vero animo nella studiata armonia dei sonetti e delle canzoni petrarcheggianti; oppure si sarebbe divertito a mistificare i posteri ..., fingendo nei versi un platonico sospiroso idealismo, che poi le novelle, le commedie, le satire, tante altre testimonianze letterarie di quell’età, smentiscono apertamente?». Tutto il problema è falsato a pieno, nella sua impostazione di conflitti e contraddizioni intime.
E perché il Cinquecento non potrebbe essere pieno di contraddizioni? Non è anzi esso proprio il secolo in cui si aggroppano le maggiori contraddizioni della vita italiana, la cui non soluzione ha determinato tutta la storia nazionale fino alla fine del Settecento? Non c’è contraddizione tra l’uomo dell’Alberti e quello di Baldassar Castiglione, tra l’uomo dabbene e il «cortegiano»? Tra il cinismo e il paganesimo dei grandi intellettuali e la loro strenua lotta contro la Riforma e in difesa del Cattolicesimo? Tra il modo di concepire la donna in generale (che poi era la dama alla Castiglione) e il modo di trattar la donna in particolare, cioè la donna del popolo? Le regole della cortesia cavalleresca erano forse applicate alle donne del popolo? La donna in generale era ormai un feticcio, una creazione artificiosa, e artificiosa fu la poesia lirica, amorosa, petrarcheggiante almeno per i quattro quinti. Ciò non vuol dire che il Cinquecento non abbia avuto un’espressione lirica, cioè artistica; l’ha avuta, ma non nella «poesia lirica» propriamente detta.
Il Rizzi pone la quistione delle contraddizioni del Cinquecento nella seconda parte del suo libro, ma non capisce che dall’urto di queste contraddizioni avrebbe potuto nascer la poesia lirica sincera: ciò non fu ed è questa una mera constatazione storica. La controriforma non poteva essere e non fu un superamento di questa crisi, ne fu un soffocamento autoritario e meccanico. Non erano più cristiani, non potevano essere non‑cristiani: dinanzi alla morte tremavano e anche dinanzi alla vecchiaia. Si posero dei problemi più grandi di loro e si avvilirono: d’altronde erano staccati dal popolo.
Q5 §92 Diplomazia italiana. A proposito dell’incidente del Carthage e del Manouba tra Italia e Francia occorre confrontare la versione che sull’origine dei fatti dà Alberto Lumbroso nel secondo volume della sua opera‑zibaldone sulle Origini economiche e diplomatiche della guerra mondiale (Collezione Gatti, ed. Mondadori) col paragrafo di Tittoni (Veracissimus!) dedicato all’incidente stesso nell’articolo I documenti diplomatici francesi (1911‑1912), pubblicato nella «Nuova Antologia» del 16 agosto 1929 e forse ristampato in volume (nelle edizioni Treves dei libri di Tittoni). L’esposizione del Tittoni è evidentemente non chiara e reticente: ora egli era appunto l’ambasciatore italiano a Parigi al quale, secondo il Lumbroso, Poincaré si era rivolto assicurandolo che il Carthage e il Manouba non contenevano contrabbando di guerra e pregandolo di telegrafare a Roma perché i due battelli non fossero fermati. È strano come il Tittoni, che è così sensibile per tutto ciò che riguarda la sua carriera, non accenni al Lumbroso o per smentirlo o per sminuire l’effetto della sua versione. Bisogna però ricordare che il Tittoni pare abbia in disdegno le abborracciature del Lumbroso, e questi gli rimprovera di non tener conto dei documenti tedeschi sulla guerra e quindi di essere perciò tedescofobo (per ciò che riguarda le responsabilità dello scatenamento del conflitto).
Q5 §93 Costumi italiani nel Settecento. Cfr l’articolo di Alessandro Giulini, Una dama avventuriera del settecento, «Nuova Antologia», 16 agosto 1929. (L’Italia ormai dava all’Europa solo avventurieri e anche avventuriere e non più grandi intellettuali. Né la decadenza dei costumi era solo quella che risulta dal Giorno del Parini e dal cicisbeismo: l’aristocrazia creava scrocconi e ladri internazionali accanto ai Casanova e ai Balsamo borghesi).
Q5 §94 Carattere negativo popolare‑nazionale della letteratura italiana. Nel trattare questa quistione ma specialmente nel fare la storia dell’atteggiamento di tutta una serie di letterati e di critici, che sentivano la falsità della tradizione e il suono falso della sua intima retorica, della sua non aderenza con la realtà storica, non bisogna dimenticare Enrico Thovez, il suo libro Il pastore, il gregge, la zampogna. La reazione del Thovez non è stata giusta, ma importa in questo caso che egli abbia reagito, cioè che abbia sentito almeno che qualcosa non andava.
La sua distinzione tra poesia di forma e poesia di contenuto era falsa teoricamente: la poesia così detta di forma è caratterizzata dall’indifferenza del contenuto, cioè dall’indifferenza morale, ma è anche questo un «contenuto», il «vuoto storico e morale dello scrittore». Il Thovez in gran parte si riattaccava al De Sanctis, per il suo aspetto di «innovatore della cultura» italiana ed è da ritenere insieme alla «Voce» una delle forze che lavoravano, caoticamente a dire il vero, per una riforma intellettuale e morale nel periodo prima della guerra.
Sul Thovez bisognerebbe vedere anche le polemiche che suscitò col suo atteggiamento. Nell’articolo Enrico Thovez poeta e il problema della formazione artistica di Alfonso Ricolfi nella «Nuova Antologia» del 16 agosto 1929 c’è qualche spunto utile, ma troppo poco. Bisognerebbe trovare l’articolo di Prezzolini Thovez il precursore.
Q5 §95 L’uomo del Quattrocento e del Cinquecento. Leon Battista Alberti, Baldassarre Castiglione, Machiavelli mi sembrano i tre scrittori più importanti per studiare la vita del Rinascimento nel suo aspetto «uomo» e nelle sue contraddizioni morali e civili. L’Alberti rappresenta il borghese (vedere anche il Pandolfini), Castiglione il nobile cortigiano (vedere anche il Della Casa), Machiavelli rappresenta e cerca di rendere organiche le tendenze politiche dei borghesi (repubbliche) e dei principi, in quanto vogliono, gli uni e gli altri, fondare Stati o ampliarne la potenza territoriale e militare.
Secondo Vittorio Cian (Il conte Baldassar Castiglione (1529‑1929), Nuova Antologia del 16 agosto ‑ 1° settembre 1929) Francesco Sansovino, contemporaneo, là dove informa che Carlo V era assai parco lettore, soggiunge: «Si dilettava di leggere tre libri solamente, li quali esso avea fatti tradurre in lingua sua propria: l’uno per l’instituzione della vita civile, e questo fu il Cortegiano del conte Baldesar da Castiglione, l’altro per le cose di Stato, e questo fu il Principe co’ Discorsi del Machiavelli, et il terzo per l’ordine della milizia, e questo fu la Historia con tutte le altre cose di Polibio». Scrive il Cian: «Non abbastanza è stato avvertito che il Cortegiano, documento storico di primissimo ordine, attesta e illustra luminosamente l’evoluzione della cavalleria medioevale, la quale, attecchita in iscarsa misura, dicono, in Italia, in realtà, differenziatasi, sin dalle origini, da quella d’oltr’Alpi, nel clima italiano della Rinascita diventa una nuova cavalleria, assume il carattere d’una milizia civile, combattente all’insegna di Marte, ma anche di Apollo, di Venere e di tutte le Muse. Evoluzione, dico, e non affatto degenerazione o decadenza, come parve al De Sanctis».
Ma il Cian si basa solo sul Cortegiano, che è un tentativo di organizzare una aristocrazia intorno al «principe» e di differenziarla dalla morale borghese trionfante: che questa cavalleria fosse superficiale è dimostrato dall’Orlando Furioso, che precede il Don Chisciotte e lo prepara. In ogni caso l’articolo del Cian è da rivedere: egli è conoscitore filologicamente perfetto del Cortegiano e bisognerà procurarsi la sua edizione del libro (III ed., editore Sansoni).
Q5 §96 Carattere negativo nazionale‑popolare della letteratura italiana. Nel 1892 l’editore Hoepli indisse un referendum sulla letteratura italiana raccolto in volume, I migliori libri italiani consigliati da cento illustri contemporanei che dev’essere interessante da vedere per questa rubrica, per stabilire quali siano state le opere più apprezzate e da chi e per quali ragioni.
Q5 §97 Gli intellettuali. Nella rubrica «Intellettuali» in altro quaderno, ho accennato alle Accademie italiane e all’utilità di averne una lista ragionata. Nella Nuova Antologia del 1° settembre 1929 (p. 128) è annunziato un libro di E. Salaris Attraverso gli Istituti Culturali italiani, opera di prossima pubblicazione sulle Accademie d’Italia.
Q5 §98 Storia del dopoguerra. Vedi l’articolo di Giovanni Marietti, Il trattato di Versailles e la sua esecuzione, nei fascicoli del 16 settembre e 16 ottobre 1929 della Nuova Antologia. È un riassunto diligente dei principali avvenimenti legati all’esecuzione del trattato di Versailles, una trama schematica che può essere utile come inizio di una ricostruzione analitica o per fissare le concordanze internazionali agli avvenimenti interni dei vari paesi.
Q5 §99 Armamento della Germania al momento dell’armistizio. Al momento dell’armistizio furono consegnati dall’esercito operante: cannoni 5000; mitragliatrici 25 000; bombarde 3000; aeroplani 1700; autocarri 5000; locomotive 5000; carri ferroviari 150 000. La Commissione per il disarmo distrusse nel territorio tedesco: cannoni 39 600; affusti finiti 23 061; fucili e pistole 4 574 000; mitragliatrici 88 000; proietti d’artiglieria 39 254 000; proietti per bombarde 4 028 000; cartucce 500 294 000; bombe a mano 11 530 000; esplosivi 2 131 646 tonnellate (e molte armi non furono consegnate).
Q5 §100 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. Per il mondo slavo confrontare Ettore Lo Gatto, L’Italia nelle letterature slave, fascicoli 16 settembre, 1° ottobre, 16 ottobre della Nuova Antologia. Oltre ai rapporti puramente letterari, determinati dai libri, ci sono molti accenni all’immigrazione di intellettuali italiani nei diversi paesi slavi, specialmente in Russia e in Polonia, e alla loro importanza come fattori della cultura locale.
Un altro aspetto della funzione cosmopolita degli intellettuali italiani da studiare, o almeno da accennare, è quella svolta in Italia stessa, attirando studenti alle Università e studiosi che volevano perfezionarsi. In questo fenomeno di immigrazione di intellettuali stranieri in Italia occorre distinguere due aspetti: immigrazione per vedere l’Italia come territorio‑museo della storia passata, che è stata permanente e dura ancora con ampiezza maggiore o minore secondo le epoche, e immigrazione per assimilare la cultura vivente sotto la guida degli intellettuali italiani viventi; è questa seconda che interessa per la ricerca in quistione. Come e perché avviene che a un certo punto sono gli italiani ad emigrare all’estero e non gli stranieri a venire in Italia? (con eccezione relativa per gli intellettuali ecclesiastici, il cui insegnamento in Italia continua ad attirare discepoli in Italia fino ad oggi; in questo caso occorre però tener presente che il centro romano è andatosi relativamente internazionalizzando). Questo punto storico è di massima importanza: gli altri paesi acquistano coscienza nazionale e vogliono organizzare una cultura nazionale, la cosmopoli medioevale si sfalda, l’Italia come territorio perde la sua funzione di centro internazionale di cultura, non si nazionalizza per sé, ma i suoi intellettuali continuano la funzione cosmopolita, staccandosi dal territorio e sciamando all’estero.
Q5 §101 I nipotini di padre Bresciani. Filippo Crispolti. Uno dei documenti più brescianeschi del Crispolti è l’articolo La madre di Leopardi nella Nuova Antologia del 16 settembre 1929. Che dei puri eruditi, appassionati anche delle minuzie biografiche dei grandi uomini, come il Ferretti, abbiano cercato di «riabilitare» la madre del Leopardi, non fa meraviglia: ma le allumacature gesuitiche che il Crispolti sbava sullo scritto del Ferretti, fanno ribrezzo. Tutto il tono è ripugnante, intellettualmente e moralmente. Intellettualmente perché il Crispolti interpreta la psicologia del Leopardi con i suoi «grandi dolori» giovanili (certamente suo è il manoscritto inedito di memorie cui si riferisce due volte) per essere povero, cattivo ballerino e noioso conversatore: paragone ripugnante. Moralmente perché il tentativo di giustificare la madre del Leopardi è meschino, cavilloso, gesuitico nel senso tecnico della parola. Davvero che tutte le madri aristocratiche dei primi del secolo XIX erano come Adelaide Antici? Si potrebbero portare documenti in contrario a profusione e anche l’esempio del D’Azeglio non serve, perché la durezza nell’educazione fisica per avere dei soldati, è ben diversa dalla secchezza morale e sentimentale: quando il D’Azeglio bambino si ruppe il braccio e il padre lo indusse a tenere nascosto il male una notte intera per non spaventare la madre, chi non vede quale sostrato affettuoso famigliare è contenuto nell’episodio e come ciò doveva esaltare il bambino e legarlo più intimamente ai genitori? (Questo episodio del D’Azeglio è citato in un altro articolo dello stesso fascicolo della Nuova Antologia, Pellegrinaggio a Recanati, di Alessandro Varaldo). La difesa della madre del Leopardi non è un puro fatto d’erudizione curiosa, è un elemento ideologico, accanto alla riabilitazione dei Borboni, ecc.
Q5 §102 Letteratura italiana. Contributo dei burocratici. Ho scritto già una nota su questo argomento, osservando quanto poco scrivano i funzionari italiani di ogni categoria, intorno a ciò che costituisce la loro specialità e la loro particolare attività (se scrivono lo fanno solo per i superiori non per il popolo‑nazione). Nella Nuova Antologia del 16 settembre 1929, a p. 267 è detto che il libro Nazioni e minoranze etniche (Zanichelli, 2 voll.) è stato scritto «da un giovane gentiluomo romano, che, non volendo confusi i suoi studi giuridici e storici con i suoi uffici diplomatici, ha adottato il nome un poco arcaico di Luca dei Sabelli».
Q5 §103 Letteratura popolare. Teatro. «Il dramma lacrimoso e la commedia sentimentale avevano popolato il palcoscenico di pazzi e di delinquenti di ogni genere e la Rivoluzione francese – tranne pochi lavori d’occasione – niente aveva ispirato agli autori drammatici che segnasse un nuovo indirizzo d’arte e che sviasse il pubblico dai sotterranei misteriosi, dalle foreste perigliose, dai manicomi...» (Alberto Manzi, Il conte Giraud, il Governo italico e la censura nella Nuova Antologia del 1° ottobre 1929).
Il Manzi riporta un brano di un opuscolo dell’avv. Maria Giacomo Boïeldieu, del 1804: «Ai nostri giorni la scena si è trasformata: e non è raro il caso di veder gli assassini nelle loro caverne e i pazzi nel manicomio. Non si può lasciare ai tribunali il compito di punire quei mostri che disonorano il nome di uomo, e ai medici quello di cercar di curare gli sventurati i cui delitti colpiscono penosamente l’umanità, anche se simulati? Quale possente attrattiva, quale soluzione può esercitare sullo spettatore il quadro dei mali che nell’ordine morale e fisico desolano la specie umana, e dai quali da un momento all’altro e per la più piccola scossa dei nostri nervi esauriti, possiamo noi stessi diventare vittime meritevoli di compassione?! Che bisogno c’è di andare al teatro per vedere Briganti (commedia tipo: Robert chef des brigands, di Lamartelière, finito poi impiegato di Stato, e il cui enorme successo, nel 1791, fu determinato dalla frase “guerre aux châteaux, paix aux chaumières”; derivata dai Masnadieri di Schiller) Pazze e Malati d’amore (commedie tipo Nina la pazza per amore, Il cavaliere de la Barre, Il delirio, ecc.)», ecc. ecc. Il Boïeldieu critica «il genere che, in realtà, mi sembra pericoloso e da deplorare».
L’articolo del Manzi contiene qualche spunto sull’atteggiamento della censura napoleonica contro questo tipo di teatro, specialmente quando i casi anormali rappresentati toccavano il principio monarchico.
Q5 §104 Il Cinquecento. Il modo di giudicare la letteratura del Cinquecento secondo determinati canoni stereotipati ha dato luogo in Italia a curiosi giudizi e a limitazioni di attività critica che sono significativi per giudicare il carattere astratto dalla realtà nazionale‑popolare dei nostri intellettuali. Qualcosa ora sta cambiando lentamente, ma il vecchio reagisce. Nel 1928 Emilio Lovarini ha stampato una commedia in 5 atti La Venexiana, commedia di ignoto cinquecentesco (Zanichelli, 1928, n. 1 della «Nuova scelta di curiosità letterarie inedite o rare») che è stata riconosciuta come una bellissima opera d’arte (cfr Benedetto Croce, nella «Critica» del 1930). Ireneo Sanesi (autore del volume La Commedia nella collezione dei Generi letterari del Vallardi) in un articolo La Venexiana nella Nuova Antologia del 1° ottobre 1929, così imposta quello che per lui è il problema critico posto dalla commedia: l’autore ignoto della Venexiana è un ritardatario, un codino, un conservatore, perché rappresenta la commedia nata dalla novellistica medioevale, la commedia realistica, vivace (anche se scritta in latino) che prende gli argomenti dalla realtà della comune vita borghese o cittadinesca, i cui personaggi sono riprodotti da questa medesima realtà, le cui azioni sono semplici, chiare, lineari e il cui maggiore interesse riposa appunto nella loro sobrietà e nella loro lucidezza. Mentre, secondo il Sanesi, sono rivoluzionari gli scrittori del teatro erudito e classicheggiante, che riportavano sulla scena gli antichissimi tipi e motivi cari a Plauto e Terenzio. Per il Sanesi, gli scrittori della nuova classe storica sono codini e sono rivoluzionari gli scrittori cortigiani: è stupefacente.
È interessante ciò che è avvenuto per la Venexiana a poca distanza da ciò che era avvenuto per le commedie del Ruzzante, tradotte in francese arcaicizzante dal dialetto padovano del Cinquecento da Alfredo Mortier. Il Ruzzante era stato rivelato da Maurizio Sand (figlio di Georges Sand) che lo proclamò maggiore non solo dell’Ariosto (nella commedia) e del Bibbiena, ma dello stesso Machiavelli, precursore del Molière e del naturalismo francese moderno. Anche per la Venexiana, Adolfo Orvieto («Marzocco», 30 settembre 1928) scrisse sembrare essa «il prodotto di una fantasia drammatica dei nostri tempi» e accennò al Becque.
È interessante notare questo doppio filone nel Cinquecento: uno veramente nazionale‑popolare (nei dialetti, ma anche in latino) legato alla novellistica precedente, espressione della borghesia, e l’altro aulico, cortigiano, anazionale, che però è portato sugli scudi dai retori.
Q5 §105 Americanismo. Confrontare Carlo Linati, Babbitt compra il mondo, nella Nuova Antologia del 16 ottobre 1929. Articolo mediocre, ma appunto perciò significativo come espressione di una media opinione. Può servire appunto per fissare cosa si pensa dell’americanismo, da parte dei piccoli borghesi più intelligenti. L’articolo è una variazione del libro di Edgard Ansel Mowrer, This American World, che il Linati giudica «veramente acuto, ricco di idee e scritto con una concisione tra classica e brutale che piace, e da un pensatore a cui certo non fanno difetto né lo spirito d’osservazione né il senso delle gradazioni storiche né la varietà della cultura». Il Mowrer ricostruisce la storia culturale degli Stati Uniti fino alla rottura del cordone ombelicale con l’Europa e all’avvento dell’Americanismo.
Sarebbe interessante analizzare i motivi del grande successo avuto da Babbitt in Europa. Non si tratta di un gran libro: è costruito schematicamente e il meccanismo è anche troppo manifesto. Ha importanza culturale più che artistica: la critica dei costumi prevale sull’arte. Che in America ci sia una corrente letteraria realistica che incominci dall’essere critica dei costumi è un fatto culturale molto importante: significa che si estende l’autocritica, che nasce cioè una nuova civiltà americana cosciente delle sue forze e delle sue debolezze: gli intellettuali si staccano dalla classe dominante per unirsi a lei più intimamente, per essere una vera superstruttura, e non solo un elemento inorganico e indistinto della struttura‑corporazione.
Gli intellettuali europei hanno già in parte perduto questa funzione: non rappresentano più l’autocoscienza culturale, l’autocritica della classe dominante; sono ridiventati agenti immediati della classe dominante, oppure se ne sono completamente staccati, costituendo una casta a sé, senza radici nella vita nazionale popolare. Essi ridono di Babbitt, si divertono della sua mediocrità, della sua ingenua stupidaggine, del suo modo di pensare a serie, della sua mentalità standardizzata. Non si pongono neanche il problema: esistono in Europa dei Babbitt? La quistione è che in Europa il piccolo borghese standardizzato esiste, ma la sua standardizzazione invece di essere nazionale (e di una grande nazione come gli Stati Uniti) è regionale, è locale. I Babbitt europei sono di una gradazione storica inferiore a quella del Babbitt americano: sono una debolezza nazionale, mentre l’americano è una forza nazionale; sono più pittoreschi ma più stupidi e più ridicoli; il loro conformismo è intorno a una superstizione imputridita e debilitante, mentre il conformismo di Babbitt è ingenuo e spontaneo, intorno a una superstizione energetica e progressiva. Per il Linati, Babbitt è «il prototipo dell’industriale americano moderno», mentre invece Babbitt è un piccolo borghese e la sua mania più tipica è quella di entrare in famigliarità con gli «industriali moderni», di essere un loro pari, di sfoggiare la loro «superiorità» morale e sociale. L’industriale moderno è il modello da raggiungere, il tipo sociale a cui conformarsi, mentre per il Babbitt europeo il modello e il tipo sono dati dal canonico della cattedrale, dal nobilastro di provincia, dal capo sezione del Ministero. È da notare questa acritica degli intellettuali europei: il Siegfrid, nella prefazione al suo libro sugli Stati Uniti, contrappone all’operaio taylorizzato americano l’artigiano dell’industria di lusso parigino, come se questo fosse il tipo diffuso del lavoratore; gli intellettuali europei in genere pensano che Babbitt sia un tipo puramente americano e si rallegrano con la vecchia Europa. L’antiamericanismo è comico, prima di essere stupido.
Q5 §106 Luigi Villari, Il governo laburista britannico, «Nuova Antologia» del 16 ottobre 1929. Articolo mediocre: qualche aneddoto. È da ricordare per il fatto che la «Nuova Antologia» quantunque diretta dal Presidente del Senato prima, dal Presidente dell’Accademia dopo e quindi tenuta a un certo riserbo, pubblichi di tali articoli in cui sui membri dei governi stranieri sono espressi giudizi di carattere personalistico, settario e poco riguardoso, all’infuori della polemica politica.
Q5 §107 Italia e Palestina. Confrontare nella «Nuova Antologia» del 16 ottobre 1929 l’articolo La riforma del mandato sulla Palestina, di Romolo Tritonj. Vi si espone il programma minimo italiano, cioè l’internazionalizzazione della Palestina, secondo il progetto concordato durante la guerra fra le potenze dell’Intesa e abbandonato da Francia e Inghilterra dopo la caduta dello zarismo in Russia, lasciando l’Italia in asso, poiché la Francia ebbe la Siria e l’Inghilterra la Palestina stessa. L’articolo è moderato in generale, ma accanito contro il sionismo. Si dovrà rivedere per ricostruire la politica italiana in Oriente (nel prossimo Oriente).
Q5 §108 Sicilia. Il Pantheon siciliano di S. Domenico. È a Palermo, nella chiesa di S. Domenico. Ci sono le tombe, fra gli altri, di Crispi, di Rosolino Pilo, del gen. Giacinto Carini. Non credo che esista qualcosa di simile nelle altre regioni, oltre il Pantheon di Roma e Santa Croce di Firenze. Sarebbe interessante avere la lista completa e ragionata di tutti i sepolti nel Pantheon siciliano: è interessante la scelta del nome Pantheon, proprio, nell’uso moderno, di una capitale nazionale. (A Parigi quando incominciò ad essere adoperato il nome di Pantheon?) (Dopo la Rivoluzione: si trattava di una chiesa destinata a Santa Genoveffa, patrona di Parigi; la Rivoluzione le dette il nome di Pantheon e la destinò a ricevere le ceneri dei grandi francesi; sotto la Restaurazione fu ridotto a Chiesa; sotto Luigi Filippo a tempio della Gloria, sotto Napoleone III a Chiesa. Con la III repubblica ritornò alla sua funzione di Pantheon nazionale). Il nome di Pantheon modernamente è quindi legato al movimento delle nazionalità.
Q5 §109 Sicilia. Cfr Romeo Vuoli, Il generale Giacinto Carini, Nuova Antologia, 1° novembre ‑ 16 novembre 1929: «Il Carini, ancor giovinetto, introdusse per primo in Sicilia la macchina a vapore per la montatura (o mondatura?) del sommaco e per questa industria si acquistò tanta popolarità fra i contadini delle campagne palermitane da poter guidare l’insurrezione del 1848». (Su questo punto cfr Colonna, I quattro candidati ai collegi di Palermo, Palermo, Ufficio tipografico Lo Bianco, 1861). Nella prima parte dell’articolo si può trovare qualche particolare sugli avvenimenti della Rivoluzione siciliana del 48, sulla vita all’estero degli emigrati politici e sull’impresa dei Mille con indicazioni bibliografiche. La seconda parte è meno interessante, eccetto qualche episodio.
Q5 §110 Francia e Italia. Nell’Histoire d’un crime V. Hugo scrive: «Ogni uomo di cuore ha due patrie in questo secolo. La Roma di un giorno e Parigi di oggi». Questa patria d’un giorno associata a quella d’oggi presuppone che la Francia sia l’erede di Roma: ecco un’affermazione che non era fatta e specialmente non è fatta per piacere a molti.
Q5 §111 L’Accademia d’Italia. Nella Nuova Antologia del 1° novembre 1929 sono pubblicati i discorsi inaugurali del Capo del Governo e di Tittoni.
Q5 §112 Carlo Schanzer, Sovranità e giustizia nei rapporti fra gli Stati, Nuova Antologia, 1° novembre 1929.
Moderato nella forma e nella sostanza. Può essere preso come documento dell’atteggiamento ufficioso del Governo verso la Società delle Nazioni e i problemi di politica internazionale che le sono connessi.
Q5 §113 Su Enrico Ibsen. Cfr Guido Manacorda, Il pensiero religioso di Enrico Ibsen, Nuova Antologia del 1° novembre 1929. Questo articolo del Manacorda, che appartiene al gruppo degli intellettuali «cattolici integrali» e polemisti per la Chiesa di Roma, è interessante per capire Ibsen indirettamente, per intendere a pieno il valore delle sue vedute ideologiche, ecc.
Q5 §114 Enciclopedia di concetti politici, filosofici ecc. Postulato. Nelle scienze matematiche, specialmente, si intende per postulato una proposizione che non avendo la evidenza immediata e la indimostrabilità degli assiomi, né potendo, d’altra parte, essere sufficientemente dimostrata come un teorema, è tuttavia provvista, in base ai dati dell’esperienza, di una tale verosimiglianza che può essere acconsentita e concessa anche dall’avversario e posta quindi a base di talune dimostrazioni. Il postulato è quindi, in questo senso, una proposizione richiesta ai fini della dimostrazione e costruzione scientifica. Nell’uso comune, invece, postulato vuol dire un modo d’essere o d’agire che si desidera si realizzi, che anzi si vorrebbe e in certi casi si dovrebbe volere fosse attuato e si suppone o si afferma essere il risultato di una indagine scientifica (storia, economia, scienze esatte, ecc.). In questo caso il significato di «postulato» si avvicina a quello di «rivendicazione», di «desiderata», di «esigenza», ossia sta tra queste nozioni e quella di «principio»: i postulati di un partito politico sarebbero i suoi «principii» pratici, da cui immediatamente conseguono le rivendicazioni, ecc., di carattere più immediato e particolare (è vero che in questo senso, che implica il dover essere più che l’essere, postulato dovrebbe piuttosto chiamarsi postulando).
Q5 §115 Niccolò Machiavelli. Un’edizione delle Lettere di Niccolò Machiavelli è stata fatta dalla Società Editrice «Rinascimento del libro», Firenze, nella «Raccolta nazionale dei classici», curata e con prefazione di Giuseppe Lesca (la prefazione è stata pubblicata nella Nuova Antologia del 1° novembre 1929). Le lettere erano già state stampate nel 1883 dall’Alvisi presso il Sansoni di Firenze con lettere di altri al Machiavelli (del libro dell’Alvisi è stata fatta una nuova edizione con prefazione di Giovanni Papini).
Q5 §116 G. B., La Banca dei regolamenti internazionali, «Nuova Antologia», 16 novembre 1929.
Q5 §117 Argus, Il disarmo navale, i sottomarini e gli aeroplani, «Nuova Antologia», 16 novembre 1929. Brevi cenni alle prime trattative tra Stati Uniti e Inghilterra per il disarmo e la parità navale. Accenna anche rapidamente all’innovazione che nell’armamento navale è portata dal sottomarino e dall’aeroplano, che, con costi relativamente bassi, possono dare risultati molto rilevanti, e alla sempre maggiore inutilità delle grandi corazzate.
Q5 §118 Stresemann. Cfr nella Nuova Antologia del 16 novembre 1929 l’articolo di Francesco Tommasini, Il pensiero e l’opera di Gustavo Stresemann, interessante per studiare la Germania del dopoguerra e il mutamento nella psicologia dei nazionalisti borghesi e piccolo borghesi.
Q5 §119 Enciclopedia di concetti politici, filosofici, ecc. Classe media. Il significato di classe media muta da un paese all’altro e dà luogo spesso a equivoci molto curiosi. Il termine è venuto dalla letteratura politica inglese ed indica in questa lingua la borghesia industriale, posta tra la nobiltà e il popolo: in Inghilterra la borghesia non è stata mai concepita come un tutto col popolo, ma sempre staccata da questo. Nella storia inglese è avvenuto anzi che non la borghesia abbia guidato il popolo e si sia fatta aiutare da esso per abbattere i privilegi feudali, ma invece è avvenuto che la nobiltà abbia formato un grande partito di popolo contro lo sfrenato sfruttamento della borghesia industriale e contro le conseguenze dell’industrialismo. C’è una tradizione di torismo popolare (Disraeli, ecc.). Anche la storia dei partiti politici britannici riflette questo sviluppo: gli whigs erano aristocratici che lottavano contro i privilegi e i soprusi della corona; i tories piccoli aristocratici popolareggianti: gli whigs sono diventati il partito degl’industriali, delle classi medie, mentre i tories sono diventati il partito della nobiltà, sempre popolareggiante. Dopo l’entrata in vigore, ormai irreparabile, delle grandi riforme whigs, dopo cioè che l’industria ebbe completamente conformato lo Stato ai suoi interessi e bisogni, tra i due partiti ci fu scambio di personale, divennero ambedue interclassisti, ma i tories conservarono sempre una certa popolarità e la conservano ancora: gli operai, se non votano per il partito laburista, votano per i conservatori.
In Francia si può parlare meno di classe media, perché c’è la tradizione politica e culturale del terzo stato, cioè del blocco tra borghesia e popolo. Gli anglicizzanti adoperano il termine nel senso inglese, ma altri l’adoperano nel senso italiano di «piccoli borghesi» e le due correnti si fondono creando talvolta confusione.
In Italia, dove la aristocrazia guerriera è stata distrutta dai Comuni (distrutta fisicamente nella persona dei primi ghibellini) – eccetto che nell’Italia Meridionale e in Sicilia – mancando il concetto e la cosa «classe alta», nell’uso corrente e politico, almeno – l’espressione classe media venne naturalmente a significare «piccola e media borghesia», e, negativamente, non popolo nel senso «non operai e contadini», quindi anche «intellettuali»; per molti anzi classe media indica proprio i ceti intellettuali, gli uomini di cultura (in senso lato, quindi anche gli impiegati ma specialmente i professionisti). Concetto di «signori» in Sardegna, di «galantuomini» e di «civili» nel Mezzogiorno e in Sicilia.
Q5 §120 Nazionalismo culturale cattolico. È la tendenza che più meraviglia nel leggere, per esempio, la «Civiltà Cattolica»: poiché, se essa divenisse realmente una regola di condotta, il cattolicismo stesso diverrebbe impossibile. L’incitamento ai filosofi italiani ad abbracciare il tomismo, perché S. Tommaso è nato in Italia e non perché in esso può trovarsi una migliore via per trovare la verità, come potrebbe servire ai francesi o ai tedeschi? E non può diventare invece, per logica conseguenza, un incitamento a ogni nazione di cercare nella sua propria tradizione un archetipo intellettuale, un «maestro» di filosofia religiosa nazionale, cioè un incitamento a disgregare il Cattolicismo in tante chiese nazionali? Posto il principio, perché poi fissare S. Tommaso come espressione nazionale e non il Gioberti e il Socini ecc.?
Che i Cattolici e anzi i gesuiti della «Civiltà Cattolica» siano dovuti e devano ricorrere a una tale propaganda è un segno dei tempi. C’è stato un tempo in cui Carlo Pisacane era predicato come l’elemento nazionale da contrapporre sugli altari ai brumosi filosofi tedeschi; ancor di più Giuseppe Mazzini. Nella filosofia attualistica si rivendica Gioberti come lo Hegel italiano, o quasi. Il cattolicismo religioso incita (o ha dato l’esempio?) al cattolicismo filosofico e a quello politico sociale.
Q5 §121 Francia. André Siegfried, Tableau des Partis en France,
Paris, Grasset, 1930.
Q5 §122 Nazionale‑popolare. Ho scritto alcune per osservare come le espressioni «nazione» e «nazionale» abbiano in Italiano un significato molto più limitato di quelli che nelle altre lingue hanno le parole corrispondenti date dai vocabolari. L’osservazione più interessante si può fare per il cinese, dove pure gli intellettuali sono tanto staccati dal popolo: per tradurre l’espressione cinese Sen Min‑ciu‑i che indica i tre principi della politica nazionale‑popolare di Sun Yat‑Sen, i gesuiti hanno escogitato la formula di «triplice demismo» (escogitata dal gesuita italiano D’Elia nella traduzione francese del libro di Sun Yat‑Sen, Le triple demisme de Sun Wen); cfr «Civiltà Cattolica» del 4 maggio e 18 maggio 1929 in cui la formula cinese Sen Min‑ciu‑i è analizzata nella sua composizione grammaticale cinese e confrontata con varie traduzioni possibili.
Q5 §123 Rinascimento. Articolo di Vittorio Rossi, Il Rinascimento, nella Nuova Antologia del 16 novembre 1929. Molto interessante e comprensivo nella sua brevità. Per il Rossi, giustamente, il rifiorire degli studi intorno alle letterature classiche fu un fatto di formazione secondaria, un indizio, un sintomo e non il più appariscente della profonda essenza dell’età cui spetta il nome di Rinascimento. «Il fatto centrale e fondamentale, quello onde ogni altro germoglia, fu la nascita e la maturazione d’un nuovo mondo spirituale che dall’energica e coerente virtù creativa sprigionatasi dopo il Mille in ogni campo dell’umana attività, fu portato allora sulla scena della storia non pure italiana, ma europea». Dopo il Mille s’inizia la reazione contro il regime feudale «che improntava di sé tutta la vita» (con l’aristocrazia fondiaria e il chiericato): nei due o tre secoli seguenti si trasforma profondamente l’assetto economico, politico e culturale della società: si rinvigorisce l’agricoltura, si ravvivano, estendono ed organizzano le industrie e i commerci; sorge la borghesia, nuova classe dirigente (questo punto è da precisare e il Rossi non lo precisa) fervida di passione politica (dove, in tutta Europa, o solamente in Italia e nelle Fiandre?) e stretta in corporazioni finanziarie potenti; si costituisce con crescente spirito di autonomia lo Stato comunale.
(Anche questo punto è da precisare: bisogna fissare che significato ha avuto lo «Stato» nello Stato comunale: un significato «corporativo» limitato, per cui non si è potuto sviluppare oltre il feudalismo medio, cioè quello successo al feudalismo assoluto – senza terzo stato, per così dire, – esistito fino al Mille e a cui successe la monarchia assoluta nel secolo XV, fino alla Rivoluzione francese. Un passaggio organico dal comune a un regime non più feudale si ebbe nei Paesi Bassi e solo nei Paesi Bassi. In Italia i Comuni non seppero uscire dalla fase corporativa, l’anarchia feudale ebbe il sopravvento in forme appropriate alla nuova situazione e ci fu poi la dominazione straniera. Confrontare a questo proposito alcune sugli «Intellettuali italiani». Per tutto lo sviluppo della società europea, cui accenna il Rossi, dopo il Mille, occorre tener conto del libro di Henri Pirenne sull’origine delle città).
Movimenti di riforma della Chiesa; sorgono ordini religiosi nuovi che vogliono ripristinare la vita apostolica. (Questi movimenti sono sintomi positivi o negativi del nuovo mondo che si sviluppa? Certamente essi si presentano come reazione alla nuova società economica, sebbene la domanda di riformare la Chiesa sia progressiva: però è vero che essi indicano un maggior interesse del popolo verso le quistioni culturali e un maggior interesse verso il popolo da parte di grandi personalità religiose, cioè gli intellettuali più in vista dell’epoca: ma anche essi, in Italia almeno, sono o soffocati o addomesticati dalla Chiesa, mentre in altre parti d’Europa si mantengono come fermento per sboccare nella Riforma. Parlando delle tendenze culturali dopo il Mille non bisognerebbe dimenticare l’apporto arabo attraverso la Spagna: cfr gli articoli di Ezio Levi nel «Marzocco» o nel «Leonardo»; e, con gli arabi, gli ebrei spagnuoli). «Nelle scuole filosofiche e teologiche di Francia s’accendono fieri dibattiti, che fan segno del rinato spirito religioso e insieme delle cresciute esigenze della ragione». (Queste dispute non sono dovute alle dottrine averroiste che cercano di conquistare il mondo europeo, cioè alla pressione della cultura araba?) «Scoppia la lotta per le investiture, che, suscitata dal ridesto senso della romanità imperiale (cosa vuol dire? dal ridesto senso dello Stato che vuole assorbire in sé tutte le attività dei cittadini, come nell’Impero Romano?) e dalla coscienza di presenti interessi spirituali, politici, economici, sommuove tutto il mondo dei principi secolari ed ecclesiastici e la massa anonima dei monaci, dei borghesi, dei contadini, degli artigiani». Eresie (ma soffocate col ferro e col fuoco).
«La cavalleria, mentre sancisce e consacra nell’individuo il possesso di virtù morali, alimenta un amore di cultura umana e pratica certa raffinatezza di costumi». (Ma la cavalleria in che senso si può legare al Rinascimento dopo il Mille? Il Rossi non distingue i movimenti contraddittori, perché non tiene conto delle diverse forme di feudalismo e di autonomia locale entro la cornice del feudalismo. D’altronde non si può non parlare della cavalleria come elemento del Rinascimento vero e proprio del 1500, sebbene l’Orlando furioso ne sia già un rimpianto in cui il sentimento di simpatia si mescola a quello caricaturale ed ironico, e il Cortegiano ne sia la fase sufficientemente filistea, scolastica, pedantesca). Le Crociate, le guerre dei re cristiani contro i Mori in Spagna, dei Capetingi contro l’Inghilterra, dei Comuni italiani contro gli imperatori svevi, in cui matura o spunta il sentimento delle unità nazionali (esagerazione). E strana, in un erudito come il Rossi, questa proposizione: «Nello sforzo con cui quegli uomini rigenerano se stessi e costruiscono le condizioni d’una nuova vita, essi sentono ribulicare i fermenti profondi della loro storia, e nel mondo romano, così ricco di esperienze di libera e piena spiritualità umana, trovano anime congeniali», che mi pare tutta una filza di affermazioni vaghe e vuote di senso: 1) perché c’è sempre stata una continuità tra il mondo romano e il periodo dopo il Mille (medio‑latino); 2) perché «le anime congeniali» è una metafora senza senso e in ogni caso il fenomeno avvenne nel 400‑500 e non in questa prima fase; 3) perché di romano non ci fu nulla nel Rinascimento italiano, altro che la vernice letteraria, perché mancò proprio ciò che è specifico della civiltà romana: l’unità statale e quindi territoriale.
La cultura latina, fiorente nelle scuole di Francia del XII secolo con magnifico rigoglio di studi grammaticali e rettorici, di composizioni poetiche e di prose regolate e solenni, a cui in Italia corrisponde una più tarda e modesta produzione dei poeti ed eruditi veneti e dei dettatori – è una fase del medio‑latino, è un prodotto schiettamente feudale nel senso primitivo di prima del Mille; così si dica degli studi giuridici, rinati per il bisogno di dare assetto legale ai nuovi e complessi rapporti politici e sociali, che si volgono è vero al diritto romano, ma rapidamente degenerano nella casistica più minuziosa, appunto perché il diritto romano «puro» non può dare assetto ai nuovi complessi rapporti: in realtà attraverso la casistica dei glossatori e dei post‑glossatori si formano delle giurisprudenze locali, in cui ha ragione il più forte (o il nobile o il borghese) e che è l’«unico diritto» esistente: i principi del diritto romano vengono dimenticati o posposti alla glossa interpretativa che a sua volta è stata interpretata, con un prodotto ultimo in cui di romano non c’era nulla, altro che il principio puro e semplice di proprietà.
La Scolastica, «che viene nuovamente pensando e sistemando entro alle forme della filosofia antica» (rientrata, si noti, nel circolo della civiltà europea, non per il «ribulicare» dei fermenti profondi della storia, ma perché introdottavi dagli arabi e dagli ebrei) «le verità intuite dal Cristianesimo».
L’Architettura romanica. Il Rossi ha molta ragione di affermare che tutte queste manifestazioni dal 1000 al 1300 non sono frutto di artificiosa volontà imitatrice, ma spontanea manifestazione d’una energia creativa, che scaturisce dal profondo e mette quegli uomini in grado di sentire e di rivivere l’antichità. Questa ultima proposizione è però erronea, perché quegli uomini, in realtà, si mettono in grado di sentire e vivere intensamente il presente, mentre successivamente si forma uno strato di intellettuali che sente e rivive l’antichità e che si allontana sempre più dalla vita popolare, perché la borghesia in Italia decade o si degrada fino a tutto il Settecento.
E ancora strano che il Rossi non s’accorga delle contraddizioni in cui cade affermando: «Tuttavia se per Rinascimento senza complementi s’ha ad intendere, come a me non par dubbio, tutto il multiforme prorompere dell’attività umana nei secoli dall’XI al XVI, indizio fra tutti cospicuo del Rinascimento vuol essere considerato, non il rifiorire della cultura latina, ma il sorgere della letteratura in lingua volgare, da cui acquista rilievo uno dei più voli prodotti di quella energia, lo scindersi dell’unità medioevale in differenziate entità nazionali». Il Rossi ha una concezione realistica e storicistica del Rinascimento, ma non sa abbandonare completamente la vecchia concezione retorica e letteraria: ecco l’origine delle sue contraddizioni e della sua acribria: il sorgere del volgare segna un distacco dall’antichità, ed è da spiegare come a questo fenomeno si accompagni una rinascita del latino letterario. Giustamente dice il Rossi che «l’uso che un popolo faccia d’una piuttosto che d’un’altra lingua per disinteressati fini intellettuali, non è capriccio di individui o di collettività, ma è spontaneità di una peculiare vita interiore, balzante nell’unica forma che le sia propria», cioè che ogni lingua è una concezione del mondo integrale, e non solo un vestito che faccia indifferentemente da forma a ogni contenuto. Ma allora? Non significa ciò che erano in lotta due concezioni del mondo: una borghese‑popolare che si esprimeva nel volgare e una aristocratico‑feudale che si esprimeva in latino e si richiamava all’antichità romana e che questa lotta caratterizza il Rinascimento e non già la serena creazione di una cultura trionfante? Il Rossi non sa spiegarsi il fatto che il richiamo all’antico è un puro elemento strumentale‑politico e non può creare una cultura di per sé e che perciò il Rinascimento doveva per forza risolversi nella Controriforma, cioè nella sconfitta della borghesia nata dai Comuni e nel trionfo della romanità, ma come potere del papa sulle coscienze e come tentativo di ritorno al Sacro Romano Impero: una farsa dopo la tragedia.
In Francia la letteratura di lingua d’oc e di lingua d’oil sboccia tra la fine del primo e il principio del secondo secolo dopo il Mille, quando il paese è tutto in fermento per i grandi fatti politici, economici, religiosi, culturali accennati prima. «E se in Italia l’avvento del volgare all’onore della letteratura ritarda d’oltre un secolo, gli è che fra noi il grande moto, che instaura sulle rovine dell’universalismo medioevale una nuova civiltà nazionale, è, per la varietà della storia molte volte secolare delle nostre città, più vario e dovunque autoctono e spontaneo, e manca la forza disciplinatrice di una monarchia e di potenti signori, onde più lenta e faticosa riesce la formazione unitaria appunto di quel nuovo mondo spirituale, di cui la nuova letteratura in volgare è l’aspetto più appariscente». Altro groppo di contraddizioni: in realtà il moto innovatore dopo il Mille fu più violento in Italia che in Francia e la classe portatrice della bandiera di quel moto si sviluppò economicamente prima e più potentemente che in Francia e riuscì a rovesciare il dominio dei suoi nemici, ciò che in Francia non avvenne. La storia si svolse diversamente in Francia che in Italia; questo è il truismo del Rossi, che non sa indicare le differenze reali dello sviluppo e le pone in una maggiore o minore spontaneità e autoctonia, molto difficili o impossibili da provare. Intanto anche in Francia il movimento non fu unitario, perché tra Nord e Sud c’è stata una bella differenza, che si esprime letterariamente in una grande letteratura epica nel Nord e nell’assenza di epica nel Sud. L’origine della differenziazione storica tra Italia e Francia si può trovare testimoniata nel giuramento di Strasburgo (verso l’841), cioè nel fatto che il popolo partecipa attivamente alla storia (il popolo‑esercito) diventando il garante dell’osservanza dei trattati tra i discendenti di Carlo Magno; il popolo‑esercito garantisce «giurando in volgare», cioè introduce nella storia nazionale la sua lingua, assumendo una funzione politica di primo piano, presentandosi come volontà collettiva, come elemento di una democrazia nazionale. Questo fatto «demagogico» dei Carolingi di appellarsi al popolo nella loro politica estera è molto significativo per comprendere lo sviluppo della storia francese e la funzione che vi ebbe la monarchia come fattore nazionale. In Italia i primi documenti di volgare sono dei giuramenti individuali per fissare la proprietà su certe terre dei conventi, o hanno un carattere antipopolare («Traite, traite, fili de putte»). Altro che spontaneità e autoctonia. L’involucro monarchico, vero continuatore dell’unità statale romana, permise alla borghe sia francese di svilupparsi più che la completa autonomia economica raggiunta dalla borghesia italiana, che però fu incapace di uscire dal terreno grettamente corporativo e di crearsi una propria civiltà statale integrale. (È da vedere come i Comuni italiani, rivendicando i diritti feudali del Conte sul territorio circostante del comitato, ed essendoseli incorporati, divennero un elemento feudale, col potere esercitato da un comitato corporativo invece che dal conte).
Il Rossi nota che alla letteratura volgare si accompagnano, «coeve e significative della medesima attività interiore del popolo nostro, le forme comunali del cosiddetto preumanesimo del Dugento e del Trecento» e che alla letteratura volgare e a questo preumanesimo consegue l’umanesimo filologico dell’ultimo Trecento e del Quattrocento, concludendo: «Tre fatti che a una considerazione puramente estrinseca (!) di contemporanei e di posteri, poterono parere l’un l’altro antitetici, mentre segnano nell’ordine culturale tappe dello sviluppo dello spirito italiano, progressive e in tutto analoghe a quelle che nell’ordine politico sono il Comune, cui corrisponde la letteratura volgare con certe forme del preumanesimo, e la Signoria, il cui correlativo letterario è l’umanesimo filologico». Così tutto è a posto, sotto la vernice generica dello «spirito italiano».
Con Bonifacio VIII, l’ultimo dei grandi pontefici medioevali e con Arrigo VII erano finite le lotte epiche fra le due più alte potestà della terra. Decadenza dell’influsso politico della Chiesa: «servitù» avignonese e scisma. L’impero, come autorità politica municipale, muore (tentativi sterili di Ludovico il Bavaro e di Carlo IV). «La vita era nella giovane e industre borghesia dei Comuni, che veniva rassodando il suo potere contro i nemici esterni e contro i popolani minuti e che mentre seguitava il suo cammino nella storia, stava per generare o già aveva generato le signorie nazionali». Che signorie nazionali? L’origine delle signorie è ben diversa in Italia dagli altri paesi: in Italia nasce dall’impossibilità della borghesia di mantenere il regime corporativo, cioè di governare con la pura violenza il popolo minuto. In Francia invece l’origine dell’assolutismo è nelle lotte tra borghesia e classi feudali, in cui però la borghesia è unita al popolo minuto e ai contadini (entro certi limiti, s’intende). E si può parlare in Italia di «signoria nazionale»? Cosa voleva dire «nazione» in quel tempo?
Continua il Rossi: «Dinanzi a questi grandi fatti l’idea, che pareva incarnarsi nella perpetuità universale dell’Impero, della Chiesa e del diritto romano, e che è ancora di Dante, di una continuazione universale, nella vita del Medio Evo, della universale vita romana, cedeva all’idea che una grande rivoluzione s’era compiuta negli ultimi secoli e che una nuova era della storia era cominciata. Nasceva il senso di un abisso che separasse ormai la nuova civiltà dall’antica; onde l’eredità di Roma non era più sentita come una forza immanente nella vita quotidiana; ma gli Italiani cominciavano a volgere lo sguardo all’antichità come ad un proprio passato, ammirevole di forza, di freschezza, di bellezza, cui dovessero tornare col pensiero per via di meditazione e di studio e per un fine di educazione umana, simili a figlioli che dopo un lungo abbandono tornassero ai padri, non a vecchi che ripensassero e rimpiangessero l’età giovanile». E questo è un vero romanzo storico: dove si può trovare l’«idea che una grande rivoluzione s’era compiuta»?, ecc. Il Rossi dilata a fatto storico degli aneddoti di carattere libresco e il senso del disprezzo dell’umanista per il latino medioevale e l’alterigia del signore raffinato per la «barbarie» medioevale; ha ragione Antonio Labriola nel suo brano Da un secolo all’altro che solo con la Rivoluzione Francese si sente il distacco dal passato, da tutto il passato e questo sentimento ha la sua espressione ultima nel tentativo di rinnovare il computo degli anni col calendario repubblicano. Se ciò che pretende il Rossi si fosse manifestato davvero, non sarebbe avvenuto così facilmente il passaggio dal Rinascimento alla Controriforma. Il Rossi non sa liberarsi dalla concezione retorica del Rinascimento e perciò non sa valutare il fatto che esistevano due correnti: una progressiva e una regressiva e che quest’ultima trionfò in ultima analisi, dopo che il fenomeno generale raggiunse il suo massimo splendore nel Cinquecento (non come fatto nazionale e politico, però, come fatto culturale prevalentemente se non esclusivamente), come fenomeno di una aristocrazia staccata dal popolo‑nazione, mentre nel popolo si preparava la reazione a questo splendido parassitismo nella riforma protestante, nel Savonarolismo coi suoi «bruciamenti delle vanità», nel banditismo popolare come quello di re Marcone in Calabria e in altri movimenti che sarebbe interessante registrare e analizzare almeno come sintomi indiretti: lo stesso pensiero politico del Machiavelli è una reazione al Rinascimento, è il richiamo alla necessità politica e nazionale di riavvicinarsi al popolo come hanno fatto le monarchie assolute di Francia e di Spagna, come è un sintomo la popolarità del Valentino in Romagna, in quanto deprime i signorotti e i condottieri ecc.
Secondo il Rossi «la coscienza della separazione ideale prodottasi nei secoli fra l’antichità e l’epoca nuova» è già virtualmente nello spirito di Dante, ma appare attuale e s’impersona, nell’ordine politico, in Cola di Rienzo, che «erede del pensiero di Dante, vuole rivendicare la romanità e quindi l’italianità (perché “quindi”?, Cola di Rienzo pensava proprio solo al popolo di Roma, materialmente inteso) dell’Impero e col vincolo sacro della romanità stringere in unità di nazione tutte le genti italiane; quanto alla cultura popolare, nel Petrarca, che saluta Cola “nostro Camillo, nostro Bruto, nostro Romolo” e con istudio paziente rievoca l’antico, mentre con anima di poeta lo risente e rivive». (Continua il romanzo storico: quale fu il risultato degli sforzi di Cola di Rienzo? nulla assoluto; e come si può far la storia con le velleità sterili e i pii desideri? E i Camilli, i Bruti, i Romoli messi insieme dal Petrarca non sentono la pura retorica?)
Il Rossi non riesce a porre il distacco tra Medio latino e latino umanistico o filologico come egli lo chiama; non vuol capire che si tratta in realtà di due lingue, perché esprimono due concezioni del mondo, in certo senso antitetiche, sia pure limitate alla categoria degli intellettuali e ancora non vuol capire che il preumanesimo (Petrarca) è ancora diverso dall’umanesimo, perché la «quantità è diventata qualità». Il Petrarca, si può dire, è tipico di questo passaggio: egli è un poeta della borghesia come scrittore in volgare, ma è già un intellettuale della reazione antiborghese (signorie, papato) come scrittore in latino, come «oratore», come personaggio politico. Ciò spiega anche il fenomeno cinquecentesco del «petrarchismo» e la sua insincerità: è un fenomeno puramente cartaceo, perché i sentimenti da cui era nata la poesia del dolce stil nuovo e del Petrarca stesso, non dominano più la vita pubblica, come non domina più la borghesia comunale, ricacciata nei suoi fondachi e nelle sue manifatture in decadenza. Politicamente domina un’aristocrazia in gran parte di parvenus, raccolta nelle corti dei signori e protetta dalle compagnie di ventura: essa produce la cultura del Cinquecento e aiuta le arti, ma politicamente è limitata e finisce sotto il dominio straniero.
Così il Rossi non può vedere le origini di classe del passaggio dalla Sicilia a Bologna e alla Toscana della prima poesia in volgare. Egli pone accanto il «preumanismo (nel suo senso) imperiale ed ecclesiastico di Pier delle Vigne e di maestro Berardo da Napoli, così cordialmente odiato dal Petrarca» e che ha «ancora radice nel sentimento della continuità imperiale della vita antica» (cioè è ancora Medio latino, come il «preumanismo» comunale dei filologi e poeti veronesi e padovani e dei grammatici e retori bolognesi) con la scuola poetica siciliana e dice che l’uno e l’altro fenomeno sarebbero stati sterili perché ambedue legati «ad un mondo politico e intellettuale ormai tramontato»; la scuola siciliana non fu sterile perché Bologna e la Toscana ne animarono «il vuoto tecnicismo del nuovo spirito culturale democratico». Ma è giusto questo nesso interpretativo? In Sicilia la borghesia mercantile si sviluppò sotto l’involucro monarchico e con Federico II si trovò coinvolta nella quistione del Sacro romano impero della Nazione germanica: Federico era un monarca assoluto in Sicilia e nel Mezzogiorno, ma era anche l’Imperatore medioevale. La borghesia siciliana, come quella francese, si sviluppò più rapidamente, dal punto di vista culturale, che la Toscana; lo stesso Federico e i suoi figli poetarono in volgare e da questo punto di vista essi parteciparono della nuova spinta di attività umane posteriore al Mille; ma non solo da questo punto di vista: in realtà la borghesia toscana e quella bolognese erano più arretrate ideologicamente che Federico II, l’Imperatore medioevale. Paradossi della storia. Ma non bisogna falsificare la storia, come fa il Rossi, capovolgendo i termini per amore di tesi generale. Federico II fallì, ma si trattò di ben altro tentativo che quello di Cola di Rienzo e di ben altro uomo. Bologna e la Toscana accolsero il «vuoto tecnicismo siculo» con ben altra intelligenza storica del Rossi: capirono che si trattava di «cosa loro», mentre non capirono che era loro anche Enzo, sebbene portasse la bandiera dell’Impero universale e lo fecero morire in carcere.
A differenza del «preumanesimo» imperiale ed ecclesiastico il Rossi trova che «nella scabra e talvolta bizzarra latinità del preumanesimo fiorito all’ombra delle signorie comunali, covavano (!) invece la reazione all’universalismo medioevale e aspirazioni indistinte a forme di stile nazionali (cosa significa? che il volgare era travestito di forme latine?); onde i nuovi studiosi del mondo classico dovevano sentirvi precorrimenti di quell’imperialismo romano che Cola aveva vagheggiato come centro di unificazione nazionale e che essi sentivano e auspicavano come forma di dominio culturale dell’Italia sul mondo. La nazionalizzazione (!) dell’umanesimo, che il secolo XVI vedrà compiersi in tutti i paesi civili d’Europa, nascerà appunto dall’impero universale d’una cultura, la nostra, che germoglia sì dallo studio dell’antico, ma nel tempo stesso s’afferma e si diffonde anche come letteratura volgare e quindi nazionale italiana». (Questa è la concezione retorica in pieno del Rinascimento; che gli umanisti abbiano auspicato il dominio culturale d’Italia sul mondo è tutt’al più l’inizio della «retorica» come forma nazionale. A questo punto si inserisce l’interpretazione della «funzione cosmopolita degli intellettuali italiani» che è ben altra cosa che non «dominio culturale» di carattere nazionale: è invece proprio testimonianza di assenza del carattere nazionale della cultura.)
La parola humanista compare solo nella seconda metà del secolo XV e in italiano solo nel terzo decennio del XVI: la parola umanesimo è ancora più recente. Sulla fine del secolo XIV i primi umanisti chiamarono i loro studi studia humanitatis, cioè «studi intesi al perfezionamento integrale dello spirito umano, e quindi i soli degni veramente dell’uomo. Per loro la cultura non è soltanto sapere, ma è anche vivere… è dottrina, è moralità, è bellezza … specchiate nell’unità della vivente opera letteraria». Il Rossi, preso nelle sue contraddizioni, determinate dalla concezione meccanicamente unitaria della storia del Rinascimento ricorre a delle immagini per spiegare come il latino umanistico sia andato deperendo, finché il volgare celebrò i suoi trionfi in ogni dominio della letteratura «e l’umanesimo italiano ebbe finalmente la lingua che era sua, mentre il latino scendeva nel suo sepolcro». (Non completamente, però, perché rimase nella Chiesa e nelle scienze fino al Settecento, a dimostrare quale sia stata la corrente sociale che ne aveva sostenuto sempre la permanenza: il latino dal campo laicale fu espulso solo dalla borghesia moderna, lasciandone il rimpianto nei diversi forcaioli).
«Umanesimo non è latinismo; è affermazione di umanità piena, e l’umanità degli umanisti italiani era, nella sua storicità, italiana; talché esprimersi non poteva se non nel volgare che anche gli umanisti parlavano nella pratica della vita e che, malgrado ogni proposito classicheggiante, forzava baldanzosamente i cancelli del loro latino. Potevano essi, astraendosi dalla vita, sognare il loro sogno, e fermi nell’idea che letteratura degna di questo nome non potesse darsi se non in latino, ripudiare la nuova lingua; altra era la realtà storica, della quale essi stessi e quel loro spirito sognante erano figli e nella quale vivevano la loro vita di uomini nati quasi un millennio e mezzo dopo il grande oratore romano». Che significa tutto ciò? Perché questa distinzione tra latino‑sogno e volgare ‑ realtà storica? E perché il latino non era una realtà storica? Il Rossi non sa spiegare questo bilinguismo degli intellettuali, cioè non vuol ammettere che il volgare, per gli umanisti, era come un dialetto, cioè non aveva carattere nazionale e che pertanto gli umanisti erano i continuatori dell’universalismo medioevale – in altre forme, si capisce – e non un elemento nazionale – erano una «Casta cosmopolita», per i quali l’Italia rappresentava forse ciò che è la regione nella cornice nazionale moderna, ma nulla di più e di meglio: essi erano apolitici e anazionali.
«C’era nel classicismo umanistico, non più un fine di moralità religiosa, bensì un fine di educazione integrale dell’anima umana; c’era soprattutto la riabilitazione dello spirito umano, come creatore della vita e della storia», ecc., ecc. Giustissimo: questo è l’aspetto più interessante dell’umanesimo. Ma è esso in contraddizione con ciò che ho detto prima sullo spirito anazionale e quindi regressivo – per l’Italia – dell’umanesimo stesso? Non mi pare. L’umanesimo infatti non sviluppò in Italia questo suo contenuto più originale e pieno d’avvenire. Esso ebbe il carattere di una restaurazione, ma come ogni restaurazione assimilò e svolse, meglio della classe rivoluzionaria che aveva soffocato politicamente, i principi ideologici della classe vinta che non aveva saputo uscire dai limiti corporativi e crearsi tutte le superstrutture di una società integrale. Solo che questa elaborazione fu «campata in aria», rimase patrimonio di una casta intellettuale, non ebbe contatti col popolo‑nazione. E quando in Italia il movimento reazionario, di cui l’umanesimo era stato una premessa necessaria, si sviluppò nella Controriforma, la nuova ideologia fu soffocata anch’essa e gli umanisti (salvo poche eccezioni) dinanzi ai roghi abiurarono (cfr il capitolo su Erasmo pubblicato dalla «Nuova Italia» dal libro del De Ruggiero, Rinascimento, riforma e controriforma).
Il contenuto ideologico del Rinascimento si svolse fuori d’Italia, in Germania e in Francia, in forme politiche e filosofiche: ma lo Stato moderno e la filosofia moderna furono in Italia importati perché i nostri intellettuali erano anazionali e cosmopoliti come nel Medio Evo, in forme diverse, ma negli stessi rapporti generali.
Nell’articolo del Rossi vi sono altri elementi, interessanti, ma essi sono di carattere particolare. Bisognerà studiare il libro del Rossi sul Quattrocento (coll. Vallardi), il libro del Toffanin, Cosa fu l’umanesimo (ediz. Sansoni), il libro del De Ruggiero su citato, oltre le opere classiche sul Rinascimento pubblicate da scrittori stranieri (Burkhardt, Voigt, Symonds, ecc.).
Q5 §124 Passato e presente. Alcuni intellettuali. Il barone Raffaele Garofalo: il suo articolo sull’amnistia pubblicato nella Nuova Antologia e annotato in un altro quaderno, la sua conferenza nel volume L’Italia e gli italiani del secolo XIX a cura di Jolanda De Blasi. Giovanni Gentile: il suo discorso a Palermo nel 1925 (o 24? cfr la nota di Croce in Cultura e Vita morale). Antonio Baldini: la sua conferenza nel volume curato dalla De Blasi su Carducci, D’Annunzio, Pascoli. Il Garofalo rappresenta la vecchia tradizione del latifondista meridionale (ricordare il suo passo al Senato per fare aumentare i canoni enfiteutici e per mantenere nel nuovo Codice la segregazione cellulare); il Gentile e il Baldini altro tipo d’intellettuali, più «spregiudicati» del Garofalo.
Del Gentile è da ricordare il discorso agli operai romani, contenuto nel suo volume su Fascismo e cultura (edizione Treves).
Q5 §125 Riviste‑tipo. Rassegne critiche bibliografiche. Una importantissima sui risultati della critica storica applicata alle origini del Cristianesimo, alla personalità storica di Gesù, agli Evangeli, alle loro differenze, agli evangeli sinottici e a quello di Giovanni, agli evangeli così detti apocrifi, all’importanza di S. Paolo e degli apostoli, alle discussioni se Gesù possa essere l’espressione di un mito ecc. (Cfr i libri dell’Omodeo ecc., le collezioni del Couchoud presso l’editore Rieder ecc.).
Lo spunto mi è stato suggerito dall’articolo di Alessandro Chiappelli Il culto di Maria e gli errori della recente critica storica nella Nuova Antologia del 1° dicembre 1929, contro A. Drews e il suo libro Die Marien Mithe. Su questi argomenti bisognerebbe vedere gli articoli di Luigi Salvatorelli (per es. il suo articolo nella «Rivista storica italiana», N. S., VII, 1928, sul nome e il culto di un divino Joshua). Nelle di questo articolo del Chiappelli ci sono molte citazioni bibliografiche.
Q5 §126 Passato e presente. Gli intellettuali: la decadenza di Mario Missiroli. Cfr l’articolo su Clemenceau di Mario Missiroli (Spectator) nella Nuova Antologia del 16 dicembre 1929. Articolo abbastanza interessante perché il Missiroli non ha perduto la capacità di grande giornalista nel sapere impostare un articolo brillante valendosi di alcune idee fondamentali e organizzandovi intorno una serie di fatti intelligentemente scelti. Ma perché e come Clemenceau fu a contatto con la Francia, col popolo francese e lo rappresentò nel momento supremo? Il Missiroli non lo sa dire: egli è diventato vittima del luogo comune antiparlamentare antidemocratico, «antidiscussionistico», antipartito ecc. La quistione è questa: nella Francia di prima del 1914 la molteplicità dei partiti, la molteplicità dei giornali d’opinione, la molteplicità delle frazioni parlamentari, il settarismo e l’accanimento nelle lotte politico‑parlamentari e nelle polemiche giornalistiche erano un segno di forza o di debolezza nazionale (egemonia della classe media, ossia del terzo stato), un segno di ricerca continua di nuova più compatta unità o di disgregazione? Alla base della nazione, nello spirito popolare c’erano in realtà due soli partiti: la destra, dei nobili, del clero alto e di una parte dei generali; il centro, costituito da un solo grande partito diviso in frazioni personali o di gruppi politici fondamentalmente affini; e piccole minoranze non organizzate politicamente alla periferia sinistra, nel proletariato.
La divisione morale della Francia era tra la destra e il resto della nazione, riproduceva la divisione tradizionale avvenuta dopo il 93, dopo il terrore e l’esecuzione del re, dei nobili e dell’alto clero per le sentenze del Tribunale rivoluzionario robespierrista. Le divisioni interne erano nelle alte cime della gerarchia politica, non alla base, ed erano legate alla ricchezza di sviluppi interni della politica nazionale francese dal 1789 al 1870: era un meccanismo di selezione di personalità politiche capaci di dirigere, più che una disgregazione, era un perfezionamento continuo dello Stato maggiore politico nazionale. In tale situazione si spiegano la forza e la debolezza di Clemenceau e la sua funzione. Così si spiegano anche le diagnosi sempre disastrose della situazione francese, sempre smentite dai fatti reali succeduti alla diagnosi. Il fenomeno di disgregazione interna nazionale (cioè di disgregazione dell’egemonia politica del terzo stato) era molto più avanzato nella Germania del 14 che nella Francia del 14, solo che la burocrazia ne faceva sparire i sintomi sotto la brillante vernice della disciplina coatta militaresca. Il fenomeno di disgregazione nazionale è avvenuto in Francia, ossia ha iniziato il suo processo di sviluppo, ma dopo il 19, molto dopo, molto più tardi che nei paesi a regime autoritario, che sono essi stessi un prodotto di tale disgregazione.
Ma Missiroli è diventato una vittima più o meno interessata dei luoghi comuni e la sua intelligenza della storia e della reale efficienza dei nessi ideologici è catastroficamente declinata. In un articolo Sorel e Clemenceau pubblicato nel «L’Italia Letteraria» del 15 dicembre, il Missiroli riporta su Clemenceau un giudizio di Sorel cui non aveva accennato nell’articolo della «Nuova Antologia». Nel febbraio 1920 il Missiroli pregò il Sorel di scrivere un articolo sulla candidatura presentata e ritirata da Clemenceau alla Presidenza della Repubblica. Il Sorel non volle scrivere l’articolo, ma in una lettera comunicò al Missiroli il suo giudizio: «Clemenceau sarebbe stato un presidente assai più sul tipo di Casimir Périer che di Loubet e di Fallières. Egli ha sempre lottato appassionatamente contro gli uomini che per la loro popolarità potevano dargli ombra. Se Clemenceau fosse stato eletto, sarebbe successa una vera rivoluzione nelle istituzioni francesi. Sarebbero stati accontentati coloro i quali chiedono che i poteri del presidente della Repubblica vengano estesi come quelli dei presidenti americani». Il giudizio è acuto, ma Missiroli non ha saputo servirsene nel suo articolo della «Nuova Antologia» perché contraria alla sua falsificazione della storia politica francese.
Q5 §127 Machiavelli. Nella Nuova Antologia del 16 dicembre 1929 è pubblicata una noticina di certo M. Azzalini, La politica, scienza ed arte di Stato, che può essere interessante come presentazione degli elementi tra cui si dibatte lo schematismo scientifico. L’Azzalini incomincia affermando che fu gloria «fulgidissima» del Machiavelli «l’aver circoscritto nello Stato l’ambito della politica». Cosa voglia dire l’Azzalini non è facile da capire: egli riporta dal cap. III del Principe il periodo: «Dicendomi el cardinale di Roano che li italiani non si intendevano della guerra, io li risposi ch’e’ Franzesi non si intendevano dello Stato» e su questa sola citazione basa l’affermazione che, dunque, per Machiavelli «la politica dovesse intendersi come scienza e come scienza dello Stato» e che fu sua gloria ecc. (il termine «scienza di Stato» per politica sarebbe stato adoperato, nel corretto significato moderno, prima di Machiavelli solo da Marsilio da Padova). L’Azzalini è abbastanza leggero e superficiale. L’aneddoto del cardinale di Roano, avulso dal testo, non significa nulla. Nel contesto assume un significato che non si presta a deduzioni scientifiche: si tratta evidentemente di un motto di spirito, di una battuta di ritorsione immediata. Il cardinale di Roano aveva affermato che gli italiani non si intendono di guerra: per ritorsione il Machiavelli risponde che i francesi non si intendono dello Stato, perché altrimenti non avrebbero permesso al Papa di ampliare il suo potere in Italia, ciò che era contro gli interessi dello Stato francese. Il Machiavelli era ben lungi dal pensare che i francesi non s’intendevano di Stato, perché anzi egli ammirava il modo con cui la monarchia (Luigi XI) aveva ridotto a unità statale la Francia e dell’attività francese di Stato faceva un termine di paragone per l’Italia. In quel suo discorso col cardinale di Roano egli fece della «politica» in atto e non della «scienza politica» poiché, secondo lui, se era dannoso alla «politica estera» francese che il Papa si rafforzasse, ciò era ancor più dannoso alla politica interna italiana.
Il curioso è che partendo da tale incongrua citazione l’Azzalini continui che «pur enunciandosi che quella scienza studia lo Stato, si dà una definizione (!?) del tutto imprecisa (!) perché non si indica con che criterio debba riguardarsi l’oggetto dell’indagine. E la imprecisione è assoluta dato che tutte le scienze giuridiche in generale ed il diritto pubblico in particolare, si riferiscano indirettamente e direttamente a quell’elemento». Cosa vuol dire tutto ciò, riferito al Machiavelli? Meno di niente: confusione mentale.
Il Machiavelli ha scritto dei libri di «azione politica immediata», non ha scritto un’utopia in cui uno Stato già costituito, con tutte le sue funzioni e i suoi elementi costituiti, fosse vagheggiato. Nella sua trattazione, nella sua critica del presente, ha espresso dei concetti generali, che pertanto si presentano in forma aforistica e non sistematica, e ha espresso una concezione del mondo originale, che si potrebbe anch’essa chiamare «filosofia della praxis» o «neo‑umanesimo» in quanto non riconosce elementi trascendentali o immanentici (in senso metafisico) ma si basa tutta sull’azione concreta dell’uomo che per le sue necessità storiche opera e trasforma la realtà. Non è vero, come pare credere l’Azzalini, che nel Machiavelli non sia tenuto conto del «diritto costituzionale», perché in tutto il Machiavelli si trovano sparsi principi generali di diritto costituzionale ed anzi egli afferma, abbastanza chiaramente, la necessità che nello Stato domini la legge, dei principi fissi, secondo i quali i cittadini virtuosi possano operare sicuri di non cadere sotto i colpi dell’arbitrario. Ma giustamente il Machiavelli riconduce tutto alla politica, cioè all’arte di governare gli uomini, di procurarsene il consenso permanente, di fondare quindi i «grandi Stati». Bisogna ricordare che il Machiavelli sentiva che non era Stato il Comune o la Repubblica e la signoria comunale, perché mancava loro con il vasto territorio una popolazione tale da essere la base di una forza militare che permettesse una politica internazionale autonoma: egli sentiva che in Italia, col Papato, permaneva una situazione di non‑Stato e che essa sarebbe durata finché anche la religione non fosse diventata «politica» dello Stato e non più politica del Papa per impedire la formazione di forti Stati in Italia intervenendo nella vita interna dei popoli da lui non dominati temporalmente per interessi che non erano quelli degli Stati e perciò erano perturbatori e disgregatori.
Si potrebbe trovare nel Machiavelli la conferma di ciò che ho altrove notato, che la borghesia italiana medioevale non seppe uscire dalla fase corporativa per entrare in quella politica perché non seppe completamente liberarsi dalla concezione medioevale‑cosmopolitica rappresentata dal Papa, dal clero e anche dagli intellettuali laici (umanisti), cioè non seppe creare uno Stato autonomo, ma rimase nella cornice medioevale feudale e cosmopolita.
Scrive l’Azzalini che «basta … la sola definizione di Ulpiano e, meglio ancora, gli esempi di lui, recati nel digesto, … la identità estrinseca (e allora?) dell’oggetto delle due scienze: “Ius publicum ad statum rei (publicae) romanae spectat. – Publicum ius, in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit”. Si ha quindi una identità d’oggetto nel diritto pubblico e nella scienza politica, ma non sostanziale perché i criteri con cui l’una o l’altra scienza riguardano la medesima materia sono del tutto diversi. Diverse infatti sono le sfere dell’ordine giuridico e dell’ordine politico. E per vero mentre la prima osserva l’organismo pubblico sotto un punto di vista statico, come il prodotto naturale di una determinata evoluzione storica, la seconda osserva quel medesimo organismo da un punto di vista dinamico, come un prodotto che può essere valutato nei suoi pregi e nei suoi difetti e che, conseguentemente, deve essere modificato a seconda delle nuove esigenze e delle ulteriori evoluzioni». Perciò si potrebbe dire che «l’ordine giuridico è ontologico ed analitico, perché studia ed analizza i diversi istituti pubblici nel loro reale essere» mentre «l’ordine politico, deontologico e critico perché studia i vari istituti non come sono, ma come dovrebbero essere e cioè con criteri di valutazione e giudizi di opportunità che non sono né possono essere giuridici».
E un tal barbassore crede di essere un ammiratore di Machiavelli e di esserne discepolo, magari, anzi, perfezionatore!
«Da ciò consegue che alla formale identità suddescritta si oppone una sostanziale diversità tanto profonda e notevole da non consentire, forse, il giudizio espresso da uno dei massimi pubblicisti contemporanei che riteneva difficile se non impossibile creare una scienza politica completamente distinta dal diritto costituzionale. A noi sembra che il giudizio espresso sia vero solo se si arresta a questo punto l’analisi dell’aspetto giuridico e dell’aspetto politico, ma non se si prosegue oltre individuando quell’ulteriore campo che è di esclusiva competenza della scienza politica. Quest’ultima, infatti, non si limita a studiare l’organizzazione dello Stato con un criterio deontologico e critico e però diverso da quello usato per il medesimo oggetto dal diritto pubblico, ma amplia la sua sfera ad un campo che le è proprio, indagando le leggi che regolano il sorgere, il divenire, il declinare degli Stati. Né vale l’affermare che tale studio è della storia (!) intesa con significato generale (!), perché pur ammettendo che sia indagine storica la ricerca delle cause, degli effetti, dei mutui vincoli d’interdipendenza delle leggi naturali che governano l’essere e il divenire degli Stati, rimarrà sempre di pertinenza esclusivamente politica, non storica quindi, né giuridica, la ricerca di mezzi idonei per presiedere praticamente all’indirizzo generale politico. La funzione che il Machiavelli si riprometteva di svolgere e sintetizzava dicendo: “disputerò come questi principati si possano governare e tenere” (Principe, c. II) è tale per importanza intrinseca di argomento e per specificazione, non solo da legittimare l’autonomia della politica, ma da consentire, almeno sotto l’aspetto ultimamente delineato, una distinzione anche formale fra essa ed il diritto pubblico». Ed ecco cosa intende per autonomia della politica!
Ma, dice l’Azzalini, oltre una scienza, esiste un’arte politica. «Esistono uomini che traggono o trassero dall’intuizione personale la visione dei bisogni e degli interessi dei paesi governati, che nell’opera di governo attuarono nel mondo esterno la visione dell’intuito personale. Con ciò non vogliamo certamente dire che l’attività intuitiva e però artistica sia l’unica e la prevalente nell’uomo di Stato; vogliamo solo dire che in esso, accanto alle attività pratiche, economiche e morali, deve sussistere anche quell’attività teoretica sopraindicata, sia sotto l’aspetto soggettivo dell’intuizione che sotto l’aspetto oggettivo (!) dell’espressione e che, mancando tali requisiti, non può sussistere l’uomo di governo e tanto meno (!) l’uomo di Stato il cui fastigio è caratterizzato appunto da quella inacquistabile (?) facoltà. Anche nel campo politico, quindi, oltre lo scienziato in cui prevale la attività teoretica conoscitiva, sussiste l’artista in cui prevale l’attività teoretica intuitiva. Né con ciò si esaurisce interamente la sfera d’azione dell’arte politica che oltre all’essere osservata in relazione allo statista che colle funzioni pratiche del governo estrinseca la rappresentazione interna dell’intuito, può essere valutata in relazione allo scrittore che realizza nel mondo esterno (!) la verità politica intuita non con atti di potere ma con opere e scritti che traducono l’intuito dell’autore. È il caso dell’indiano Kamandaki (III secolo d. C.), del Petrarca nel Trattatello pei Carraresi, del Botero nella Ragion di Stato e, sotto certi aspetti del Machiavelli e del Mazzini».
È veramente un bel pasticcio, degno del... Machiavelli, ma specialmente di Tittoni, direttore della «Nuova Antologia». L’Azzalini non sa orientarsi né nella filosofia, né nella scienza della politica. Ma ho voluto prendere tutte queste per cercare di sbrogliarne l’intrigo e vedere di giungere a concetti chiari per conto mio.
È da distrigare, per es., ciò che può significare «intuizione» nella politica e l’espressione «arte» politica, ecc. – Ricordare insieme alcuni punti del Bergson: «L’intelligenza non ci offre della vita (la realtà in movimento) che una traduzione in termini di inerzia. Essa gira tutt’attorno, prendendo dal di fuori il più gran numero possibile di vedute dell’oggetto che essa attira presso di sé invece di entrare in esso. Ma nell’interno stesso della vita ci condurrà l’intuizione: intendo dire l’istinto divenuto disinteressato». «Il nostro occhio percepisce i tratti dell’essere vivente, ma avvicinati l’una all’altro, non organizzati tra loro. L’intenzione della vita, il movimento semplice che corre attraverso le linee, che le lega una con l’altra e dà loro un significato, gli sfugge; ed è questa intenzione che l’artista tende ad afferrare collocandosi nell’interno dell’oggetto con una specie di simpatia, abbassando con uno sforzo di intuizione la barriera che lo spazio pone fra lui e il modello. È vero però che l’intuizione estetica non afferra che l’individuale». «L’intelligenza è caratterizzata da una incomprensibilità naturale della vita poi che essa non rappresenta chiaramente che il discontinuo e l’immobilità». Distacco, intanto, dell’intuizione politica dall’intuizione estetica, o lirica, o artistica: solo per metafora si parla di arte politica. L’intuizione politica non si esprime nell’artista, ma nel «capo» e si deve intendere per «intuizione» non la «conoscenza degli individuali» ma la rapidità di connettere fatti apparentemente estranei tra loro e di concepire i mezzi adeguati al fine per trovare gli interessi in gioco e suscitare le passioni degli uomini e indirizzare questi a una determinata azione. L’«espressione» del «capo» è l’«azione» (in senso positivo o negativo: scatenare un’azione o impedire che avvenga una determinata azione, congruente o incongruente col fine che si vuol raggiungere). D’altronde il «capo in politica» può essere un individuo, ma anche un corpo politico più o meno numeroso, nel qual ultimo caso la unità d’intenti sarà raggiunta da un individuo o da un piccolo gruppo interno e nel piccolo gruppo da un individuo che può mutare volta a volta pur rimanendo il gruppo unitario e coerente nella sua opera continuativa.
Se si dovesse tradurre in linguaggio politico moderno la nozione di «Principe», così come essa serve nel libro del Machiavelli, si dovrebbe fare una serie di distinzioni: «principe» potrebbe essere un capo di Stato, un capo di governo, ma anche un capo politico che vuole conquistare uno Stato o fondare un nuovo tipo di Stato; in questo senso «principe» potrebbe tradursi in lingua moderna «partito politico». Nella realtà di qualche Stato il «capo dello Stato», cioè l’elemento equilibratore dei diversi interessi in lotta contro l’interesse prevalente, ma non esclusivista in senso assoluto, è appunto il «partito politico»; esso però a differenza che nel diritto costituzionale tradizionale né regna, né governa giuridicamente: ha «il potere di fatto», esercita la funzione egemonica e quindi equilibratrice di interessi diversi, nella «società civile», che però è talmente intrecciata di fatto con la società politica che tutti i cittadini sentono che esso invece regna e governa. Su questa realtà che è in continuo movimento, non si può creare un diritto costituzionale, del tipo tradizionale, ma solo un sistema di principii che affermano come fine dello Stato la sua propria fine, il suo proprio sparire, cioè il riassorbimento della società politica nella società civile.
Q5 §128 Lorianismo. Domenico Giuliotti. Alla teoria di Loria della necessaria concomitanza del misticismo e della sifilide, fa riscontro Domenico Giuliotti, il quale, nella prefazione a Profili di Santi edito dalla Casa Ed. Rinascimento del Libro, scrive: «Eppure, o edifichiamo unicamente in Cristo o, in altri modi, edifichiamo nella morte. Nietzsche, per esempio, l’ultimo anticristiano di grido, è bene non dimenticare che fini luetico e pazzo». Nietzsche è solo l’esempio di una serie, a quanto pare, cioè si tratta di una legge, ciò che è rinforzato dal «è bene non dimenticare», cioè: state attenti, ragazzi, a non essere anticristiani, perché altrimenti morrete luetici e pazzi. È proprio l’anti‑Loria perfetto. (La prefazione del Giuliotti è riportata nell’«Italia Letteraria» del 15 dicembre 1929, quindi il libro sarà uscito nel 1930: pare si tratti di una serie di vite di Santi tradotte dal Giuliotti).
Q5 §129 Passato e presente. I cattolici e lo Stato. Confrontare l’articolo molto significativo Tra «ratifiche» e «rettifiche» (del padre Rosa) nella «Civiltà Cattolica» del 20 luglio 1929, riguardante anche il plebiscito del 1929. Su questo articolo confrontare anche il fascicolo successivo della stessa «Civiltà Cattolica» (del 3 agosto). A proposito del Concordato è da rilevare che l’art. 1° dice testualmente: «L’Italia, ai sensi dell’art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, ecc.». Perché si parla di potere, che ha un preciso significato giuridico, e non, per esempio, di «attività» o altro termine meno facilmente interpretabile in senso politico? Sarebbe utile fare una ricerca, anche di nomenclatura, negli altri concordati stipulati dalla Chiesa e nella letteratura di ermeneutica dei concordati dovuta ad agenti del Vaticano.
Q5 §130 Nozioni enciclopediche. La parola ufficiale o officiale. Questa parola specialmente nelle traduzioni da lingue straniere (in primo luogo l’inglese) dà luogo a equivoci e nel caso migliore a incomprensione e stupore. In italiano «ufficiale» ha sempre più ristretto il suo significato e tende a indicare ormai solo gli ufficiali dell’esercito: è rimasto solo, in significato estensivo, in alcune espressioni diventate idiomatiche e di origine burocratica: «pubblico ufficiale», «ufficiale dello stato civile», ecc. In inglese invece «official» indica in generale ogni specie di funzionario (per ufficiale dell’esercito si usa «officer» che indica però anch’esso il «funzionario» in generale) e non solo quello dello Stato, ma di ogni sorta di ufficio privato (funzionario sindacale, ecc.) fino ad indicare persino il semplice «impiegato». (Si potrebbe fare una più ampia indagine, di carattere etimologico, giuridico, politico).
Q5 §131 Riviste‑tipo. Una rubrica grammaticale‑linguistica. La rubrica Querelles de langage affidata nelle «Nouvelles Littéraires» ad André Thérive (che è il critico letterario del «Temps») mi ha colpito pensando alla utilità che una simile rubrica avrebbe nei giornali e nelle riviste italiane. Per l’Italia la rubrica sarebbe molto più difficile da compilare, per la mancanza di grandi dizionari moderni e specialmente di grandi opere di insieme sulla storia della lingua (come i libri del Littré e del Brunot in Francia, e anche di altri) che potrebbero mettere in grado un qualsiasi medio letterato o giornalista di alimentare la rubrica stessa. L’unico esempio di tal genere di letteratura in Italia è stato l’Idioma Gentile del De Amicis (oltre ai capitoli sul vocabolario nelle Pagine Sparse) che però aveva carattere troppo linguaiolo e retorico, oltre all’esasperante manzonismo. Carattere linguaiolo e per di più leziosamente stucchevole aveva la rubrica iniziata da Alfredo Panzini nella prima «Fiera Letteraria» di U. Fracchia, rapidamente smessa. Perché la rubrica sia interessante, il suo carattere dovrebbe essere molto spregiudicato e prevalentemente ideologico storico, non linguaiolo e grammaticale: la lingua dovrebbe essere trattata come una concezione del mondo, come l’espressione di una concezione del mondo; il perfezionamento tecnico dell’espressione, sia quantitativo (acquisto di nuovi mezzi di espressione), sia qualitativo (acquisto delle sfumature di significato e di un ordine più complesso sintattico e stilistico) significa ampliamento e approfondimento della concezione del mondo e della sua storia. Si potrebbe cominciare con notizie curiose: l’origine di «cretino», i significati di «villano», la stratificazione sedimentaria delle vecchie ideologie (per esempio: disastro dall’astrologia, sancire e sanzionare: rendere sacro, dalla concezione religiosa sacerdotale dello Stato, ecc.). Si dovrebbero così correggere gli errori più comuni del popolo italiano, che in gran parte apprende la lingua dagli scritti (specialmente i giornali) perciò non sa accentare giustamente le parole (per esempi «profùgo» durante la guerra: ho sentito persino, da un milanese, pronunciare «rosèo» per roseo, ecc.). Errori molto gravi di significato (significato particolare esteso, o viceversa), errori e garbugli sintattici e morfologici molto curiosi (i congiuntivi dei siciliani: «si accomodasse, venisse», per «s’accomodi, venga», ecc.).
Q5 §132 Passato e presente. Nella «Civiltà Cattolica» del 20 luglio 1929 è contenuta la cronaca della prima udienza, per la presentazione delle credenziali, concessa da Pio XI all’ambasciatore De Vecchi presso la Città del Vaticano. Nelle parole rivolte da Pio XI al De Vecchi, al secondo capoverso, si dice: «Parlando di novità di rapporti così felicemente iniziata, lo diciamo, signor conte, con riguardo particolare alla sua persona, lieti che questa novità di cose si inizi e prenda avviamento da quello che Ella rappresenta, di persona e di opere, da quello che Ella è venuta già facendo per il bene, non solo del Paese, ma anche delle nostre Missioni».
Q5 §133 Azione Cattolica. I «Ritiri operai». Confrontare la «Civiltà Cattolica» del 20 luglio 1929: «Come il popolo torna a Dio». L’opera dei «Ritiri operai».
I «Ritiri» o «Esercizi Spirituali chiusi» sono stati fondati da S. Ignazio di Loyola (la cui opera più diffusa sono gli Esercizi spirituali, editi nel 29 da G. Papini); ne sono una derivazione i «Ritiri Operai» iniziati nel 1882 nel Nord della Francia. L’Opera dei Ritiri Operai iniziò la sua attività in Italia nel 1907, col primo ritiro per operai tenuto a Chieri (cfr «Civiltà Cattolica», 1908,vol. IV, p. 61: I «Ritiri Operai» in Italia). Nel 1929 è uscito il volume: Come il popolo ritorna a Dio, 1909‑1929. L’Opera dei Ritiri e le Leghe di Perseveranza in Roma in 20 anni di vita; vol. in 8°, con illustrazioni, 136 pp., L. 10,00. (Si vende a beneficio dell’Opera, alla «Direzione dei Ritiri Operai»; Roma, Via degli Astalli, 16‑17). Dal libro appare che dal 1909 al 29 l’Opera ha raccolto nelle Leghe di Perseveranza di Roma e del Lazio più di 20 000 operai, molti dei quali erano convertiti di recente. Negli anni 1928‑29 si ottenne nel Lazio e nelle province vicine un esito superiore a quello dato da Roma nei precedenti 18 anni.
Sono stati praticati finora 115 Ritiri chiusi con la partecipazione di circa 2200 operai, in Roma. «In ogni ritiro, scrive la «Civiltà Cattolica», vi è sempre un nucleo di buoni operai che serve di lievito e di esempio, gli altri sono raccolti in vario modo tra gente del popolo o fredda o indifferente e anche ostile, i quali si inducono, parte per curiosità, parte per condiscendere all’invito di amici, e non di rado anche per la comodità di tre giorni di riposo e di buon trattamento gratuito».
Nell’articolo si dànno altri particolari su vari comuni del Lazio: la Lega di Perseveranza di Roma ha 8000 inscritti con 34 centri; nel Lazio sono 25 sezioni della Lega con 12 000 inscritti. (Comunione mensile, mentre la Chiesa si accontenta di una comunione all’anno). L’Opera è diretta dai gesuiti. (Si potrebbe fare un paragrafo della rubrica «Passato e Presente»).
Le leghe di Perseveranza tendono a mantenere i risultati ottenuti nei ritiri e ad ampliarli nella massa. Esse creano una «opinione pubblica» attiva in favore della pratica religiosa, capovolgendo la situazione precedente, in cui l’opinione pubblica era negativa, o per lo meno passiva, o scettica e indifferente.
Q5 §134 Movimenti religiosi. È da vedere il movimento pancristiano e la sua organizzazione dipendente: «Alleanza mondiale per promuovere l’amicizia internazionale per mezzo delle Chiese». Il movimento pancristiano è significativo per queste ragioni: 1) Perché le Chiese protestanti tendono non solo a unirsi tra loro, ma ad acquistare, attraverso l’unione, una forza di proselitismo; 2) delle Chiese protestanti solo quelle americane, e in minor grado, quelle inglesi, avevano una forza espansiva di proselitismo: questa forza passa al movimento pancristiano anche se esso è diretto da elementi europei continentali, specialmente norvegesi e tedeschi; 3) l’unionismo può arrestare la tendenza a scindersi sempre più delle Chiese protestanti; 4) gli ortodossi partecipano, come centri dirigenti autocefali, al movimento pancristiano.
La Chiesa Cattolica è molto turbata da questo movimento. La sua organizzazione massiccia e la sua centralizzazione e unicità di comando, la poneva in condizioni di vantaggio nell’opera lenta ma sicura di assorbimento di eretici e scismatici. L’unione pancristiana turba il monopolio e fa trovare Roma dinanzi a un fronte unico. D’altronde la Chiesa Romana non può accettare di entrare nel movimento come uguale alle altre Chiese e ciò favorisce la propaganda pancristiana che può rimproverare a Roma di non volere l’unione di tutti i Cristiani per i suoi interessi particolari, ecc.
Q5 §135 Risorgimento italiano. Lamennais. Il Lamennais dovrà essere studiato per l’influsso che le sue idee ebbero su alcune correnti culturali del Risorgimento, specialmente per orientare una parte del clero verso le idee liberali e anche come elemento ideologico dei movimenti democratico‑sociali prima del 48. Per la lotta del Lamennais contro i gesuiti, cfr l’articolo Il padre Roothaan e il La Mennais nella «Civiltà Cattolica» del 3 agosto 1929. Il padre Roothaan divenne generale della Compagnia di Gesù verso la fine degli anni 20 e morì, mi pare, nel 1853; è quindi il generale che presiedette all’azione dei gesuiti prima e dopo il 48. Si potranno vedere nella «Civiltà Cattolica» altri articoli sul Lamennais e sul padre Roothaan.
Q5 §136 Nozioni enciclopediche. È da notare, nel linguaggio storico‑politico italiano, una serie di espressioni, che è difficile e talvolta impossibile tradurre in lingua straniera: così abbiamo il gruppo «Rinascimento», «Rinascita», «Rinascenza» (le due prime parole italiane la terza francesismo), ormai entrate nel circolo della cultura europea e mondiale perché se il fenomeno ebbe il massimo splendore in Italia, non fu però ristretto all’Italia.
Nasce nell’Ottocento il termine «Risorgimento» in senso politico, accompagnato da «riscossa nazionale» e «riscatto nazionale». Tutti esprimono il concetto, del ritorno a uno stato già esistito anteriormente, o di «ripresa» offensiva («riscossa») delle energie nazionali, o di liberazione da uno stato di servitù per ritornare alla primitiva autonomia (riscatto). Sono difficili da tradurre appunto perché strettamente legate alla tradizione letteraria‑nazionale di Roma imperiale o dei Comuni medioevali come periodi in cui il popolo italiano è «nato» o è «sorto», per cui la ripresa si chiama rinascimento o Risorgimento. Così il «riscuotersi» è legato all’idea dell’organismo vivo che cade in letargia e si «riscuote», ecc.
Q5 §137 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. Il caso dell’abate Turmel di Rennes. Nel libro L’Enciclica Pascendi e il modernismo, il padre Rosa dedica alcune pagine gustosissime al caso straordinario dell’abate Turmel, un modernista, che scriveva libri modernisti sotto varii pseudonimi e poi li confutava col suo vero nome. Dal 1908 al 1929 pare che il Turmel abbia continuato nel suo gioco dei pseudonimi, come avrebbe dimostrato il prof. L. Saltet, dell’Istituto cattolico di Tolosa in un lungo studio pubblicato nel «Bulletin de Littérature Ecclésiastique» di Tolosa, annata 1929. Il caso del Turmel è così caratteristico che varrà la pena di fare altre ricerche.
Q5 §138 Il culto degli Imperatori. Nella «Civiltà Cattolica» del 17 agosto e del 21 settembre 1929 è pubblicato un articolo del padre gesuita G. Messina L’apoteosi dell’uomo vivente e il Cristianesimo. Nella prima puntata il Messina esamina l’origine del culto dell’Imperatore fino ad Alessandro il Macedone; nella seconda puntata l’introduzione a Roma del culto imperiale e la resistenza dei primi cristiani fino all’editto di Costantino.
Scrive il Messina: «Nella primavera del 323 si mandarono (da Atene e Sparta) delegati ad Alessandro in Babilonia e questi si presentarono a lui, come era costume presentarsi agli dei, coronati di serti, riconoscendolo così come dio. L’ambizione di Alessandro era soddisfatta: egli era l’unico padrone del mondo e dio: la sua volontà unica legge. Partito come rappresentante dei Greci nella sua campagna contro i Persiani, ora sentiva che il suo ufficio era compiuto: non era più rappresentante di nessuno: davanti alla sua persona sollevata alla divinità, Greco o Macedone, Persiano o Egiziano erano ugualmente sudditi e dipendenti. Differenze di nazionalità e di costumi, pregiudizi di schiatta, tradizioni particolari dovevano scomparire e tutti i popoli dovevano essere condotti a sentirsi una cosa sola nell’ubbidienza di un solo monarca e nel culto della sua persona». Il culto dell’imperatore cioè è legato all’impero universale e al cosmopolitismo di cui l’impero è necessaria espressione.
Sarebbe interessante vedere se è stato tentato di trovare un nesso tra il culto dell’Imperatore e la posizione del Papa come vicario di Dio in terra; certo è che al Papa si tributano onoranze divine e lo si chiama «padre comune» come Dio.
Il Papato avrebbe fatto una mistione tra gli attributi del Pontefice Massimo e quelli dell’Imperatore divinizzato (attributi che per le popolazioni del primo periodo non dovevano essere sentiti come distinti per gli stessi imperatori). Così attraverso il Papato dovrebbe essere nato anche il diritto divino delle monarchie, riflesso del culto imperiale. La stessa necessità ha portato nel Giappone al culto del Mikado, diventato poi solennità civile e non più religiosa.
Si sarebbe verificato nel Cristianesimo ciò che si verifica nei periodi di Restaurazione in confronto ai periodi rivoluzionari: l’accettazione mitigata e camuffata dei principi contro cui si era lottato.
Q5 §139 Nozioni enciclopediche. Nella serie dei termini italiani «Rinascimento», «Risorgimento», ecc., si può mettere la parola, d’origine francese e indicante un fatto prevalentemente francese, di «Restaurazione».
La coppia «formare» e «riformare» non è così evidente, perché una cosa formata si può continuamente «riformare» senza che ci sia stata una «catastrofe» intermedia, ciò che invece è implicito in «Rinascimento», ecc., e in «Restaurazione»: la Chiesa Romana è stata riformata più volte dall’interno. Invece nella «Riforma» protestante c’è l’idea di rinascita e restaurazione della chiesa primitiva. Anche i cattolici parlano della «Riforma» della Chiesa fatta dal Concilio di Trento, ma solo i gesuiti si attengono scrupolosamente a questa nomenclatura; nella cultura laica, si parla di Riforma e Controriforma, cioè non è penetrato il convincimento che la Chiesa abbia subito una Riforma, ma semplicemente che abbia reagito contro la Riforma luterana.
Sarebbe interessante vedere se questo concetto è nato già dopo il Concilio di Trento o quando: poiché in esso è contenuto un giudizio implicito negativo.
Q5 §140 Americanismo. Un libro per lo meno curioso, espressione della reazione degli intellettuali provinciali all’americanismo è quello di C. A. Fanelli: L’Artigianato. Sintesi di un’economia corporativa, Spes editrice, Roma, 1929, in 8°, pp. XIX‑505, L. 30,00, di cui la «Civiltà Cattolica» del 17 agosto 1929 pubblica una recensione nell’articolo Problemi Sociali (che sarà del padre Brucculeri). È curioso il fatto che il padre gesuita difende la civiltà moderna (nella sua manifestazione industriale) contro il Fanelli. Riporto alcuni brani caratteristici del Fanelli citati dalla «Civiltà Cattolica»: «Il sistema (dell’industrialismo meccanico) presenta l’inconveniente di riassorbire per indiretta via, neutralizzandola, la massima parte dei materiali vantaggi che esso può offrire. Dei cavalli‑vapore installati, i tre quarti sono adibiti nei trasporti celeri, resi indispensabili dalla necessità di ovviare ai facili deperimenti che cagionano i forti concentramenti di merci. Della quarta parte, adibita alla concentrazione delle merci, circa la metà è impiegata nella produzione delle macchine, sì che, a somme fatte, di tutto l’enorme sviluppo meccanico che opprime il mondo col peso del suo acciaio, non altro che un ottavo dei cavalli installati viene impiegato nella produzione di manufatti e delle sostanze alimentari» (p. 205 del libro).
«L’Italiano, temperamento asistematico, geniale, creatore, avverso alle razionalizzazioni, non può adattarsi a quella metodicità della fabbrica, in cui solo è riposto il rendimento del lavoro in serie. Che anzi, l’orario di lavoro diviene per lui puramente nominale per lo scarso rendimento ch’egli dà in un lavoro sistematico. Spirito, eminentemente musicale, l’Italiano può accompagnarsi col solfeggio nel lavoro libero, attingendo da tale ricreazione nuove forze ed ispirazioni. Mente aperta, carattere vivace, cuore generoso, portato nella bottega... l’Italiano può esplicare le proprie virtù creative, a cui, del resto, si appoggia tutta l’economia della bottega. Sobrio come nessun altro popolo, l’Italiano sa attingere, nella indipendenza della vita di bottega, qualunque sacrifizio o privazione per far fronte alle necessità dell’arte, mentre mortificato nel suo spirito creatore dal lavoro squalificato della fabbrica, egli sperpera la paga nell’acquisto di un oblio e di una gioia che gli abbrevian l’esistenza» (p. 171 del libro).
Il libro del Fanelli dal punto di vista culturale corrisponde all’attività letteraria di quegli scrittori provinciali che ancora continuano a scrivere continuazioni, in ottava rima, alla Gerusalemme liberata, all’Orlando Furioso, ecc. È pieno settecentismo: lo stato di natura è sostituito dall’«artigianato» e dalla sua patriarcalità.
È curioso che simili scrittori, che combattono per l’incremento demografico, dimenticano che l’aumento della popolazione nel secolo scorso, è strettamente legato allo sviluppo del mercato mondiale. Il recensore nota giustamente che ormai l’artigianato è legato alla grande industria e ne dipende: esso riceve dalla grande industria materie prime semilavorate e utensili perfezionati.
Che l’operaio di fabbrica italiano dia una relativamente scarsa produzione può esser vero: ciò dipende (dal fatto) che l’industrialismo in Italia, abusando della massa crescente dei disoccupati (che l’emigrazione solo parzialmente equilibrava), è stato sempre un industrialismo di rapina, ha speculato più sui salari che sull’incremento tecnico; la proverbiale «sobrietà» degli stabilimenti significa semplicemente che non è stato creato un tenore di vita alimentare adeguato al consumo di energie domandato dal lavoro di fabbrica. Il tipo coreografico dell’Italiano è falso sotto tutti i rispetti: nelle categorie intellettuali sono gli italiani che hanno creato l’«erudizione», il lavoro paziente d’archivio: Muratori, Tiraboschi, Baronio, ecc., sono stati italiani e non tedeschi. Nell’artigianato esiste il lavoro a serie e standardizzato «tale e quale» che negli Stati Uniti: la differenza è di scala: l’artigiano produce mobili, aratri, roncole, coltelli, casette di contadini, stoffe, ecc., standardizzate sulla scala del villaggio, o del mandamento, del circondario, della provincia, al massimo della regione: l’industria americana ha la misura standard in un continente o nel mondo intero. L’artigiano produce sempre le stesse roncole, gli stessi carri, gli stessi finimenti da animali da tiro, ecc., per tutta la vita. L’artigianato a «creazione individuale» incessante è così minimo che comprende solo gli artisti nel senso stretto della parola (e ancora: i «grandi» artisti). Il libro del Fanelli può dare origine a paragrafi in varie rubriche: in «Passato e presente», in «Americanismo», in «Lorianismo».
Q5 §141 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. Cfr l’articolo La lunga crisi dell’«Action Française» nella «Civiltà Cattolica» del 7 settembre 1929. Si loda il libro La trop longue crise de l’Action Française di Mons. Sagot du Vauroux, évêque d’Agon, Parigi, ed. Bloud, 1929, opera che «riuscirà utilissima anche agli stranieri, i quali non riescono a comprendere le origini e meno ancora la persistenza, congiunta a tanta ostinazione, degli aderenti cattolici che li acceca sino a farli vivere e morire senza sacramenti, piuttosto che rinunziare alle odiose esorbitanze di un loro partito o dei suoi dirigenti increduli». La «Civiltà Cattolica» si giustifica, di non occuparsi più spesso della polemica dell’Action Française, e tra l’altro dice: «Oltre a ciò, la prolungata crisi non tocca l’Italia se non per riverbero, ossia per una lontana concomitanza ed analogia, che essa potrebbe avere con le tendenze generali paganeggianti dell’età moderna».
Questa è appunto la debolezza della posizione gesuitica contro l’Action Française, ed è una delle cause del furore fanatico di Maurras e dei suoi seguaci; questi sono persuasi che il Vaticano fa su di loro una esperienza «in corpore vili» che li ha posti nella condizione del ragazzetto che accompagnava sempre, una volta, il principe ereditario inglese e si pigliava le nerbate per conto delle sue capestrerie; da ciò Maurras e C. traggono la persuasione che l’assalto che hanno subito sia meramente politico, perché se fosse religioso dovrebbe essere universale non solo a parole, ma come identificazione o «punizione» anche negli altri paesi degli elementi individuali o di gruppo che sono, ideologicamente, sul loro stesso piano.
Altre indicazioni di «cattolici integrali»: il Bloc antirévolutionnaire di Félix Lacointe «degno amico del citato Boulin e dei suoi soci» (del Boulin e della sua «Revue Internationale des Sociétés secrètes» ho preso nota in altro paragrafo). Il Lacointe avrebbe pubblicato che il cardinale Rampolla era iscritto alla Massoneria o qualcosa di simile. (Al Rampolla si rimprovera ancora la politica del ralliement fatta da Leone XIII; ricordare a proposito del Rampolla che il veto al conclave contro la sua elezione al pontificato fu fatto dall’Austria, ma per domanda di Zanardelli: sul Rampolla e la sua posizione verso l’Italia dà elementi nuovi il Salata nel I° volume dei suoi Documenti diplomatici sulla questione romana).
Un elemento molto significativo del lavorio che la corrente gesuitica esplica in Francia per formare un partito centrista cattolico‑democratico è questo motivo ideologico‑storico: Chi è responsabile dell’apostasia del popolo francese? Solo gli intellettuali democratici che si richiamano al Rousseau? No. I più responsabili sono gli aristocratici e l’alta borghesia che hanno civettato con Voltaire: «... le rivendicazioni tradizionali (dei vecchi monarchici) del ritorno all’antico sono pure rispettabili, quantunque inattuabili, nelle condizioni presenti. E sono inattuabili anzitutto per colpa di tanta parte dell’aristocrazia e borghesia di Francia, poiché dalla corruzione e dall’apostasia di questa classe dirigente fino dal secolo XVII originò la corruzione e l’apostasia della massa popolare in Francia, avverandosi anche allora che regis ad exemplum totus componitur orbis. Il Voltaire era l’idolo di quella parte dell’aristocrazia corrotta e corrompitrice del suo popolo, alla cui fede e costumatezza procurando scandalose soluzioni, essa scavava a se medesima la fossa. E sebbene poi al sorgere del Rousseau con la sua democrazia sovversiva in opposizione all’aristocrazia volterriana, si fecero opposizione teorica le due correnti di apostasia, – come tra i due tristi corifei – che parevano muovere da contrari errori, confluirono in una stessa pratica ed esiziale conclusione: nell’ingrossare cioè il torrente rivoluzionario», ecc. ecc. Così oggi: Maurras e C. sono contro la democrazia del Rousseau e le «esagerazioni democratiche» («esagerazioni», si badi bene, solo «esagerazioni») del Sillon, ma sono «discepoli e ammiratori degli scritti del Voltaire». (Jacques Bainville ha curato una edizione di lusso di Voltaire e i gesuiti non lo dimenticheranno mai). Su questa argomentazione sulle origini dell’apostasia popolare in Francia la «Civiltà Cattolica» cita un articolo della «Croix» del 15‑16 agosto 1929: L’apostasie navrante de la masse populaire en France che si riferisce al libro Pour faire l’avenir, del padre Croizier dell’«Action populaire», edito nel 1929 dalle edizioni Spes di Parigi.
Tra i seguaci di Maurras e C., oltre ai conservatori e monarchici, la «Civiltà Cattolica» (sulle tracce del vescovo di Agen) rileva altri quattro gruppi: 1) gli snobisti (per le doti letterarie specialmente di Maurras); 2) gli adoratori della violenza o della maniera forte, «con la esagerazione dell’autorità, spinta verso il despotismo, sotto colore di resistenza allo spirito di insubordinazione, o sovvertimento sociale, dell’età contemporanea»; 3) i «falsi mistici», «creduli a vaticinii di straordinarie ristaurazioni, di conversioni meravigliose, o di provvidenziali missioni» assegnate proprio a Maurras e C. Questi fin dal tempo di Pio X, «imperterriti» scusano l’incredulità di Maurras, imputandola «al difetto della grazia», «quasi che non fosse data a tutti la grazia sufficiente per la conversione, né fosse imputabile a chi vi resiste il cadere e il persistere nella colpa». Sarebbero questi, pertanto, semi‑eretici, perché, per giustificare Maurras, ripeterebbero le posizioni giansenistiche o calviniste. Il quarto gruppo (il più pericoloso, secondo la «Civiltà Cattolica») sarebbe composto da così detti «integrali» (la «Civiltà Cattolica» osserva che il vescovo di Agen li chiama anche «integristi», «ma è notorio che essi non sono da confondere col partito politico, chiamato degli “integristi”, nella Spagna»). Questi «integrali», scrive la «Civiltà Cattolica», «anche in Italia non mancarono di favorire i positivisti e increduli dell’Action française, solo perché violenti contro il liberalismo e altre forme di errori moderni, senza avvertire che essi trascorrevano ad estremi opposti, del pari erronei e perniciosi, ecc.». «Così abbiamo veduto, anche in Italia, qualche loro foglio accennare appena, come di volo, alla condanna dell’Action Française, in cambio di pubblicarne i documenti e illustrarne il senso e le ragioni, indugiandosi invece sulla ristampa ed il commento della condanna del Sillon; quasi che i due moti fra loro contrari, ma del pari opposti alla dottrina cattolica, non potessero essere e non fossero egualmente riprovevoli. Cosa questa degna di nota, perché mentre quasi in ogni numero di siffatte pubblicazioni («Fede e Ragione»?) non manca qualche accusa o escandescenza contro autori cattolici, sembra che venga meno o lo spazio o la lena per una franca ed energica trattazione di condanna contro quelli dell’Action Française; anzi si ripetono spesso le calunnie, come quella di una pretesa piega a sinistra, ossia verso il liberalismo, popolarismo, falsa democrazia, contro chi non seguiva il loro modo di procedere».
(Nella corrente dei «cattolici integrali» bisogna mettere anche Henri Massis e la corrente dei «difensisti dell’Occidente»: ricordare le frecciate di padre Rosa contro il Massis nella risposta alla lettera di Ugo Ojetti).
Da questa nota si può prendere uno spunto per la rubrica «Passato e Presente».
Q5 §142 Romanzi filosofici, utopie, ecc. In questa serie di ricerche dovrà entrare la quistione del governo dei gesuiti nel Paraguay e della letteratura che suscitò. Il Muratori scrisse: Il Cristianesimo felice nelle Missioni dei Padri della Compagnia di Gesù. Nelle storie della Compagnia di Gesù si potrà trovare tutta la bibliografia in proposito.
La «Colonia di S. Leucio» istituita dai Borboni e di cui il Colletta parla con tanta simpatia, non sarebbe l’ultimo fiotto della popolarità dell’amministrazione dei gesuiti nel Paraguay?
Q5 §143 Funzione internazionale degli intellettuali italiani. Confrontare l’articolo La politica religiosa di Costantino Magno nella «Civiltà Cattolica» del 7 settembre 1929. Vi si parla di un libro di Jules Maurice, Constantin le Grand. L’origine de la civilisation chrétienne, Parigi, Ed. Spes (s.d.) dove sono esposti alcuni punti di vista interessanti sul primo contatto ufficiale tra Impero e Cristianesimo, utili per questa rubrica (cause storiche per cui il latino divenne lingua del cristianesimo occidentale dando luogo al Medio latino). Cfr anche il «profilo» di Costantino del Salvatorelli (ed. Formiggini).
Q5 §144 Nozioni enciclopediche. Come è nato nei pubblicisti della restaurazione il concetto di «tirannia della maggioranza». Concetto presso gli «individualisti» tipo Nietzsche, ma anche presso i cattolici. Secondo Maurras, la «tirannia della maggioranza» è ammissibile nei piccoli paesi, come la Svizzera, perché tra i cittadini svizzeri regna una certa uguaglianza di condizioni; è disastrosa (! sic) invece dove fra i cittadini, come in Francia, vi è molta disuguaglianza di condizioni.
Q5 §145 Passato e presente. Cristianesimo primitivo e non primitivo. Nella «Civiltà Cattolica» del 21 dicembre 1929, articolo I novelli B.B. Martiri Inglesi difensori del primato romano. Durante le persecuzioni di Enrico VIII «il B. Fisher fu a capo della resistenza, sebbene poi il clero, nella sua maggioranza, mostrasse una colpevole e illegittima sottomissione, promettendo con un atto, che fu detto “resa del clero”, di far dipendere dal re l’approvazione di qualsiasi legge ecclesiastica» (15 maggio 1532).
Quando Enrico impose il «giuramento di fedeltà» e volle essere riconosciuto capo della Chiesa «purtroppo molti del clero, dinanzi alla minaccia della perdita dei beni e della vita, cedettero, almeno in apparenza, ma con grave scandalo dei fedeli».
Q5 §146 Direzione politico‑militare della guerra del 1914. In alcuni paesi la formazione delle truppe scelte d’assalto è stata catastrofica, a quanto pare: si è mandato alla distruzione la parte combattiva dell’esercito, invece di tenerla come elemento «strutturale» del morale della massa dei soldati. Secondo il generale Krasnov (nel suo famigerato romanzo) questo appunto era successo in Russia già nel 1915. Questa osservazione può valere come correttivo critico delle recenti opinioni espresse dal generale tedesco von Seeckt sulle armate specializzate di mestiere, che sarebbero buone specialmente per l’offensiva.
Q5 §147 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. Sul fatto che la borghesia comunale non è riuscita a superare la fase corporativa e quindi non si può dire abbia creato uno Stato, poiché era Stato piuttosto la Chiesa e l’Impero, cioè che i Comuni non hanno superato il feudalismo, bisogna, prima di scrivere qualche cosa, leggere il libro di Gioacchino Volpe Il Medio Evo. Da un articolo di Riccardo Bacchelli nella «Fiera Letteraria» del 1° luglio 1928 (Le molte vite) tolgo questo brano: «Ma per non uscir nella preistoria, né da questo libro, nel Medioevo del Volpe si legge come il popolo dei Comuni sorge e vive nella situazione di privilegio sacrificato che gli fu fatta dalla Chiesa Universale e da quell’idea del Sacro Impero, che, imposta (?!) dall’Italia come sinonimo ed equivalente di umana civiltà all’Europa che tale la riconobbe e coltivò, impediva (!?) poi all’Italia il più (!) naturale sviluppo storico a nazione moderna». Bisognerà vedere se il Volpe autorizza queste... bizzarrie.
Q5 §148 Passato e presente. Inchieste sui giovani. L’inchiesta «sulla nuova generazione» pubblicata nella «Fiera Letteraria» dal 2 dicembre 1928 al 17 febbraio 1929. Non molto interessante. I professori d’università conoscono poco i giovani studenti. Il ritornello più frequente è questo: i giovani non si dedicano più alle ricerche e agli studi disinteressati, ma tendono al guadagno immediato. Agostino Lanzillo risponde: «Oggi specialmente noi non conosciamo l’animo dei giovani e i loro sentimenti. È difficile guadagnare il loro animo: essi tacciono sui problemi culturali sociali e morali, molto volentieri. È diffidenza o disinteresse?» («Fiera Letteraria», 9 dicembre 28). (Questa del Lanzillo è l’unica nota realistica dell’inchiesta). Nota ancora il Lanzillo: «... vi è una disciplina ferrea ed una situazione di pace esterna ed interna, che si sviluppa nel lavoro concreto e l’attivo, ma che non consente il disfrenarsi di opposte concezioni politiche o morali. Ai giovani manca la palestra per agitarsi, per manifestare forme esuberanti di passioni o di tendenze. Nasce e deriva da questo un’attitudine fredda e silenziosa che è una promessa, ma che contiene anche delle incognite». Nello stesso numero della «Fiera Letteraria» la risposta di Giuseppe Lombardo‑Radice: «V’è oggi fra i giovani scarsa pazienza per gli studi scientifici e storici; pochissimi affrontano un lavoro che richieda lunga preparazione e offra difficoltà di indagine. Vogliono, in generale, sbrigarsi degli studi; tendono soprattutto a collocarsi rapidamente, e distaccano l’animo dalle ricerche disinteressate, aspirando a guadagnare e repugnando alle carriere che loro paiono troppo lente. Malgrado tanta “filosofia” in giro, è povero il loro interesse speculativo; la loro cultura si vien facendo di frammenti; poco discutono, poco si dividono fra di loro in gruppi e cenacoli cui sia segnacolo una idea filosofica o religiosa. Il tono verso i grandi problemi è di scetticismo, o di rispetto affatto estrinseco per coloro che li prendono sul serio, o d’adozione passiva di un “verbo” dottrinale». «In generale, i meglio disposti spiritualmente sono gli studenti universitari più poveri» e «gli agiati sono, per lo più, irrequieti, insofferenti della disciplina degli studi, frettolosi. Non da loro verrà una classe spiritualmente capace di dirigere il nostro paese».
Queste del Lanzillo e del Lombardo‑Radice sono l’unica cosa seria di tutta l’inchiesta, alla quale hanno d’altronde partecipato quasi esclusivamente professori di lettere. La maggior parte ha risposto con «atti di fede», non con constatazioni obbiettive o ha confessato di non poter rispondere.
Q5 §149 Passato e presente. La scuola. Lo studio del latino è in piena decadenza. Il Missiroli, in alcuni articoli dell’«Italia Letteraria» della fine del 1929 ha dato una visione «sconfortante» dello studio del latino in Italia. L’«Italia Letteraria» ha aperto un’inchiesta sulla quistione: nella risposta del prof. Giuseppe Modugno (preside di Liceo e noto grecista, oltre che seguace della pedagogia gentiliana) si dice, dopo aver riconosciuto che è vera la decadenza del latino nelle scuole: «E la Riforma Gentile? quale influenza ha essa esercitato su un siffatto stato di cose?... sono un convinto ammiratore (della Riforma)». Ma «... uno strumento qualsiasi può essere ottimo, ma può non essere persona adatta chi l’adopera. Se quello strumento pertanto, fa male quel che fa e non consegue l’effetto cui è destinato, si deve perciò concludere che sia mal fatto?». Maraviglioso! Altra volta, affidare uno strumento «ottimo» alle persone inadatte, si chiamava astrattismo, antistoricismo, ecc.; si affermava che non esistono strumenti ottimi in sé, ma rispondenti al fine, adeguati alla situazione, ecc. Vedere tutto ciò che si è scritto, per esempio, contro il... parlamentarismo.
Q5 §150 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. Risorgimento. Nel Risorgimento si ebbe l’ultimo riflesso della «tendenza storica» della borghesia italiana a mantenersi nei limiti del «corporativismo»: il non aver risolto la quistione agraria è la prova di questo fatto. Rappresentanti di questa tendenza sono i moderati, sia neoguelfi (in essi – Gioberti – appare il carattere universalistico‑papale degli intellettuali italiani che è posto come premessa del fatto nazionale) sia i cavouriani (o economisti‑pratici, ma al modo dell’uomo del Guicciardini, cioè rivolti solo al loro «particulare»: da ciò il carattere della monarchia italiana). Ma le tracce dell’universalismo medioevale sono anche nel Mazzini, e determinano il suo fallimento politico; perché se al neoguelfismo successe nella corrente moderata il cavourismo, l’universalismo mazziniano nel Partito d'Azione non fu praticamente superato da nessuna formazione politica organica e invece rimase un fermento di settarismo ideologico e quindi di dissoluzione.
Q5 §151 Linguistica. Importanza dello scritto di Enrico Sicardi La lingua italiana in Dante, edito a Roma dalla Casa Ed. «Optima» con prefazione di Francesco Orestano. Ne ho letto la recensione di G. S. Gargàno (La lingua nei tempi di Dante e l’interpretazione della poesia) nel «Marzocco» del 14 aprile 1929. Il Sicardi insiste sulla necessità di studiare le «lingue» dei vari scrittori, se si vuole interpretare esattamente il loro mondo poetico. Non so se tutto ciò che il Sicardi scrive sia esatto e specialmente se sia possibile «storicamente» lo studio delle «particolari» lingue dei singoli scrittori, dato che manca un documento essenziale: una vasta testimonianza della lingua parlata nei tempi dei singoli scrittori. Tuttavia il richiamo metodologico del Sicardi è giusto e necessario (ricordare nel libro del Vossler, Idealismo e positivismo sullo studio della lingua, l’analisi estetica della favola di La Fontaine sul corvo e la volpe e l’erronea interpretazione di «son bec» dovuta all’ignoranza del valore storico di «son»).
Q5 §152 Utopie, romanzi filosofici, ecc. Il libro di Samuele Butler Erewhon tradotto da G. Titta Rosa, Casa Ed. Alberto Corticelli, Milano, 1928. Erewhon è l’anagramma della parola inglese Nowhere, «in nessun luogo», utopia. Il romanzo fu scritto nel 1872, è una satira della cultura del tempo: darwinismo, schopenhauerismo, ecc. (cfr la recensione di Adolfo Faggi, Erewhon nel «Marzocco» del 3 marzo 29).
Q5 §153 Letteratura popolare. Romanzi e poesie popolaresche di Ferdinando Russo (in dialetto napoletano).
Q5 §154 I nipotini di padre Bresciani. Cardarelli e la «Ronda». Nota di Luigi Russo su Cardarelli nella «Nuova Italia» dell’ottobre 1930. Il Russo appunto trova nel Cardarelli il tipo (moderno‑fossile) di ciò che fu l’abate Vito Fornari a Napoli in confronto del De Sanctis. Dizionario della Crusca. Controriforma, Accademia, reazione, ecc.
Sulla «Ronda» e sugli accenni alla vita pratica del 1920‑21 confrontare Lorenzo Montano, Il Perdigiorno, Edizione dell’Italiano, Bologna 1928 (sono raccolte nel volumetto le d’attualità del Montano pubblicate dalla «Ronda») .
Q5 §155 I nipotini di padre Bresciani. La«Fiera Letteraria» nel numero del 9 settembre 1928 pubblicò un manifesto Per un’unione letteraria europea firmato da quattro settimanali letterari: «Les Nouvelles Littéraires», di Parigi, «La Fiera Letteraria» di Milano, «Die Literarische Welt» di Berlino, «La Gaceta Literaria» di Madrid, in cui si annunziava una certa collaborazione europea tra i letterati aderenti a questi quattro giornali e quelli degli altri paesi europei, con convegni annuali, ecc. In seguito non se ne parlò più.
Q5 §156 Folklore. Una divisione o distinzione dei canti popolari formulata da Ermolao Rubieri: 1°) i canti composti dal popolo e per il popolo; 2°) quelli composti per il popolo ma non dal popolo; 3°) quelli scritti né dal popolo né per il popolo, ma da questo adottati perché conformi alla sua maniera di pensare e di sentire.
Mi pare che tutti i canti popolari si possano e si debbano ridurre a questa terza categoria, poiché ciò che contraddistingue il canto popolare, nel quadro di una nazione e della sua cultura, non è il fatto artistico, né l’origine storica, ma il suo modo di concepire il mondo e la vita, in contrasto colla società ufficiale: in ciò e solo in ciò è da ricercare la «collettività» del canto popolare, e del popolo stesso. Da ciò conseguono altri criteri di ricerca del folklore: che il popolo stesso non è una collettività omogenea di cultura, ma presenta delle stratificazioni culturali numerose, variamente combinate, che nella loro purezza non sempre possono essere identificate in determinate collettività popolari storiche: certo però il grado maggiore o minore di «isolamento» storico di queste collettività dà la possibilità di una certa identificazione.
Q5 §157 Sicilia. Negli «Studi Verghiani» diretti da Lina Perrone è stato pubblicato (nei primi numeri) un saggio di Giuseppe Bottai su Giovanni Verga politico, le cui conclusioni generali mi sembrano esatte: cioè, nonostante qualche apparenza superficiale, il Verga non fu mai né socialista, né democratico, ma «crispino» in senso largo (il «crispino» lo metto io, perché nel brano del Bottai da me letto perché pubblicato nell’«Italia Letteraria» del 13 ottobre 1929, non c’è questo accenno): in Sicilia gli intellettuali si dividono in due classi generali: crispini‑unitaristi e separatisti‑democratici, separatisti tendenziali, si capisce. Durante il processo Nasi articolo del Verga nel giornale «Sicilia» del 1° novembre 1907 «in cui si dimostrava la falsità della tesi tendente a sostenere che la rivoluzione siciliana del 48 fu d’indipendenza e non di unitarietà» (è da notare che nel 1907 era necessario combattere questa tesi). Nel 1920 un certo Enrico Messinco fondò (o voleva fondare?) un giornale «La Sicilia Nuova», «che intendeva propugnare l’autonomia siciliana»; invitò il Verga a collaborare e il Verga gli scrisse: «sono italiano innanzi tutto e perciò non autonomista». (Questo episodio del giornale del Messinco deve essere accertato).
Q5 §158 Lorianismo. L’altimetria, i buoni costumi e l’intelligenza. Nell’«utopia» di Ludovico Zuccolo Il Belluzzi o la Città felice ristampato da Amy Bernardy nelle «Curiosità letterarie» dell’ed. Zanichelli (che non è precisamente un’utopia, perché si parla della repubblica di S. Marino), si accenna già alla teoria loriana dei rapporti tra l’altimetria e i costumi degli uomini. Lo Zuccolo sostiene che «gli uomini di animo rimesso o di cervello ottuso si uniscono più facilmente a consultare degli affari comuni»: questa sarebbe la ragione della saldezza degli ordinamenti di Venezia, degli Svizzeri e di Ragusa, mentre gli uomini di natura vivace ed acuta come i fiorentini, sono portati alla sopraffazione, o a occuparsi «dei privati interessi senza punto occuparsi dei pubblici». Come allora spiegarsi che i Sanmarinesi, di natura vivace ed acuta abbiano tuttavia conservato per tanti secoli un governo popolare? Perché a S. Marino la sottigliezza d’aria, che rende ben composti e vigorosi i corpi, produce anche gli «spiriti puri e sinceri». È vero che lo Zuccolo parla anche delle ragioni economiche, cioè la mediocrità delle ricchezze individuali, per cui il più ricco ha «poco davantaggio» e al più povero non manca nulla. Questa eguaglianza è assicurata da buone leggi: proibizione dell’usura, inalienabilità della terra ecc.
Lo Zuccolo pare abbia scritto anche una «utopia» vera e propria, La Repubblica di Evandria, posta in una penisola agli antipodi dell’Italia, che, secondo il Gargàno («Marzocco» 2 febbraio 1930), Un utopista di senso pratico, avrebbe un legame con l’Utopia di T. Moro e avrebbe originato quindi il Belluzzi.
Q5 §159 Risorgimento. I primi giacobini italiani. Cfr Giulio Natali, Cultura e poesia in Italia nell’età napoleonica. Studii e saggi, Torino, Sten, 1930. (Lomonaco del Rapporto a Carnot ha un saggio speciale molto interessante).
Q5 §160 Rinascimento. È molto importante il libro di Giuseppe Toffanin, Che cosa fu l’umanesimo. Il Risorgimento dell’antichità classica nella coscienza degli italiani fra i tempi di Dante e la Riforma, Firenze, Sansoni (Biblioteca storica del Rinascimento). Il Toffanin coglie fino ad un certo punto il carattere reazionario e medioevale dell’umanismo: «Quel particolare stato d’animo e di cultura a cui in Italia, fra il tre e il cinquecento, si dà nome di umanesimo, fu una riscossa e rappresentò, per almeno due secoli, una barriera contro certa inquietudine eterodossa e romantica che era in germe prima nell’età comunale e prese poi il sopravvento nelle riforme. Esso fu spontanea conciliazione di discordanti elementi ideali, e accettazione di limiti antifilosofica per eccellenza: ma cotesta antifilosoficità, una volta pensata e accettata, è anch’essa una filosofia». Cfr l’articolo di Vittorio Rossi già analizzato, che in parte accetta la tesi del Toffanin, ma per combatterla meglio. Mi pare appunto che la quistione di ciò che fu l’umanesimo non può essere risolta che in un quadro più comprensivo della storia degli intellettuali italiani e della loro funzione in Europa. Il Toffanin ha scritto anche un libro sulla Fine dell’Umanesimo e il volume sul Cinquecento nella Collezione Vallardi.
Q5 §161 Nozioni enciclopediche. Ascaro. Così venivano chiamati i deputati delle maggioranze parlamentari senza programma e senza indirizzo, cioè deputati sempre pronti a defezionare. L’attributo era legato alle prime esperienze fatte in Eritrea di truppe indigene mercenarie. Così la parola crumiro è legata all’occupazione, da parte della Francia, della Tunisia fatta con il pretesto di respingere la tribù dei Krumiri che dalla Tunisia si spingeva in Algeria a fare delle razzie; sarebbe interessante vedere chi fece entrare la parola nel vocabolario dei sindacati operai.
QUADERNO 6
Q6 §1 Risorgimento. Avvenimenti del febbraio 1853 e moderati milanesi. Nell’articolo su Francesco Brioschi nel «Marzocco» del 6 aprile 1930 (capitolo del volume Rievocazioni dell’Ottocento), Luca Beltrami ricorda che il Brioschi fu accusato di aver firmato l’indirizzo di devozione a Francesco Giuseppe nel febbraio 1853 (dopo l’attentato di un calzolaio viennese). Il Brioschi non firmò (se c’è un Brioschi tra i firmatari, non si trattava dell’illustre professore dell’Università di Pavia, e futuro organizzatore del Politecnico). Il Beltrami annota: «e non sarebbe nemmeno da definire atto di cortigianeria quello dei funzionari del governo, “invitati” a firmare la protesta contro l’atto insano e incosciente di un calzolaio viennese». Però il Beltrami dimentica che l’indirizzo fu firmato dopo le repressioni di Milano e alla vigilia di Belfiore.
Q6 §2 I nipotini di padre Bresciani. Giulio Bechi. Morto il 28 agosto 1917 al fronte (cfr giornali del tempo: ne scrisse Guido Biagi nel «Marzocco»; cfr Profili e caratteri di Ermenegildo Pistelli, e Mario Puccioni, Militarismo ed italianità negli scritti di Giulio Bechi, nel «Marzocco» del 13 luglio 1930). Secondo il Puccioni: «La mentalità dei parlamentari sardi volle vedere in Caccia grossa solo un attacco spietato contro usi e persone e riuscì a fargli passare un guaio – così Giulio diceva con frase partenopea – di due mesi d’arresti nella fortezza di Belvedere». Il Bechi andò in Sardegna col 67° fanteria. La quistione del suo contegno nella repressione del brigantaggio, condotta come le spedizioni coloniali e del suo libro, il cui tono generale è caratteristico, fin dallo stesso titolo, è molto più complessa di quanto paia al Puccioni, il quale cerca di mettere in rilievo come il Bechi protestasse per l’abbandono in cui era lasciata la Sardegna e come esaltasse le virtù native dei Sardi.
Q6 §3 Nozioni enciclopediche. Il naso di Cleopatra. Cercare il senso esatto che Pascal dava a questa sua espressione divenuta tanto famosa (Pascal ne parla nelle Pensées) e il suo legame con le opinioni generali dello scrittore francese. (Caducità e frivolità della storia degli uomini, pessimismo giansenistico, ecc.).
Q6 §4 Letteratura popolare. Tentativi letterari delle nuove classi sociali. È stato tradotto in francese un libro di Oscar Maria Graf, Nous sommes prisonniers…, ed. Gallimard, 1930, che pare sia interessante e significativo per le classi popolari tedesche.
Q6 §5 Letteratura popolare. Romanzi d’appendice. Confrontare Henry Jagot, Vidocq, Berger‑Levrault edit., Parigi, 1930. Vidocq ha dato lo spunto al Vautrin di Balzac e ad Alessandro Dumas. (Lo si ritrova un po’ anche nel Jean Valjean di V. Hugo e specialmente nel Rocambole). Vidocq fu condannato a otto anni per falsa moneta, per una sua imprudenza. Venti evasioni, ecc. Nel 1812 entra nella polizia di Napoleone e per 15 anni comanda una squadra di poliziotti creata apposta per lui, diventa famoso per gli arresti sensazionali. È congedato da Luigi Filippo; fonda un’agenzia privata di detectives, ma fallisce. Poteva operare solo nella polizia regolare. Morto nel 1857. Ha lasciato le sue Memorie che non sono state scritte solo da lui, e in cui sono molte esagerazioni e vanterie.
Q6 §6 Risorgimento. L’Italia nel Settecento. Influenza francese in Italia nella politica, nella letteratura, nella filosofia, nell’arte, nei costumi. I Borboni regnano a Napoli e nel ducato di Parma. Sulle influenze francesi a Parma bisogna vedere le pubblicazioni minuziose di Henti Bédarida: Parme dans la politique française au XVIII e siècle, Paris, Alcan (cfr anche: Giuseppe Ortolani, Italie et France au XVIII e siècle. Mélanges de littérature et d’histoire publiés par l’Union intellectuelle franco‑italienne, Paris, Leroux) e altre due precedenti. Nella politica francese l’Italia, per la sua posizione geografica, è destinata ad assumere la funzione di elemento di equilibrio dinanzi alla crescente potenza dell’Austria: quindi la Francia da Luigi XIV a Luigi XVI tende ad esercitare un’azione di predominio, anticipando la politica di Napoleone III, anticipazione che si palesa nei ripetuti progetti o tentativi di federare gli Stati italiani a servizio della Francia.
(Questi elementi della politica francese sono da analizzare attentamente, per fissare il rapporto tra fattori internazionali e fattori nazionali nello sviluppo del Risorgimento).
Q6 §7 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. La borghesia medioevale e il suo rimanere nella fase economico‑corporativa. È da fissare in che consista concretamente l’indipendenza e l’autonomia di uno Stato e in che consistesse nel periodo dopo il Mille. Già oggi le alleanze, con l’egemonia di una grande potenza, rendono problematica la libertà d’azione ma specialmente la libertà di fissare la propria linea di condotta, di moltissimi Stati: questo fatto si doveva manifestare in modo molto più marcato dopo il Mille, data la funzione internazionale dell’Impero e del Papato e il monopolio degli eserciti detenuto dall’Impero.
Q6 §8 Risorgimento italiano. La repubblica partenopea. Cfr Antonio Manes, Un cardinale condottiere. Fabrizio Ruffo e la repubblica partenopea, Aquila, Vecchioni, 1930. Il Manes cerca di riabilitare il cardinale Ruffo (si potrebbe citare il fatto nel paragrafo di Passato e Presente in cui si citano queste riabilitazioni: Solaro della Margarita, ecc. e si parla del fatto che alcuni insegnanti «polemizzano» col Settembrini e trovano in lui molta «demagogia» contro il Borbone), addossando la responsabilità delle repressioni e degli spergiuri sul Borbone e Nelson. Pare che il Manes non sappia orientarsi troppo nel fissare le divisioni politiche e sociali nel Napoletano; ora parla di taglio netto tra nobiltà e clero da una parte e popolo dall’altra, ora questo taglio netto si riconfonde e si vedono nobili e clero nelle due parti. Poi addirittura dice che il Ruffo «assume un carattere tutt’affatto nazionale, se può essere usata questa parola di colore troppo moderno e contemporaneo» (e allora non erano nazionali i «patriotti» sterminati dalle bande dei sanfedisti?)
Sulla divisione della nobiltà e del clero dal popolo cfr il libro del Rodolico sull’Italia Meridionale e il suo articolo nel «Marzocco» n. 11 del 1926.
Q6 §9 I nipotini di padre Bresciani. Lina Pietravalle. Dalla recensione, dovuta a Giulio Marzot, del romanzo Le catene (A. Mondadori, Milano, 1930, pp. 320, L. 12) della Pietravalle: «A chi domanda con quale sentimento partecipa alla vita dei contadini, Felicia risponde: «Li amo come la terra, ma non mischierò la terra col mio pane». C’è dunque la coscienza di un distacco: si ammette che anche il contadino possa avere la sua dignità umana, ma lo si costringe entro i limiti della sua condizione sociale». Il Marzot ha scritto un saggio su Giovanni Verga ed è un critico talvolta intelligente.
Sarebbe da studiare questo punto: se il naturalismo francese non contenesse già in germe la posizione ideologica che poi ha grande sviluppo nel naturalismo o realismo provinciale italiano e specialmente nel Verga: il popolo della campagna è visto con «distacco», come «natura» estrinseca allo scrittore, come spettacolo naturale, ecc. È la posizione di Io e le belve di Hagenbeck. In Italia il motivo «naturalistico» si innestò in una posizione ideologica preesistente, come si vede nei Promessi Sposi del Manzoni, in cui esiste lo stesso «distacco» dagli elementi popolari, distacco appena velato da un benevolo sorriso ironico e caricaturale.
Q6 §10 Passato e presente. Nella «Critica» del 20 novembre 1930, in una recensione dei Feinde Bismarcks di Otto Westphal, B. Croce scrive che «il motivo del favore che incontrano i volumi» del Ludwig «e i molti altri simili ai suoi nasce da… un certo indebolimento e infrivolimento mentale, che la guerra ha prodotto nel mondo». Cosa può significare questa affermazione? Ad analizzarla, essa non significa nulla, proprio nulla. Mi pare che il fenomeno possa essere spiegato in modo più realistico: nel dopo guerra è affiorato al mondo della cultura e dell’interesse per la storia uno strato sociale abbastanza importante, del quale gli scrittori tipo Ludwig sono l’espressione letteraria. Il fenomeno Ludwig significa progresso o regresso intellettuale? Mi pare che indichi progresso, purché il giudizio sia inteso esattamente: i lettori attuali della «bellettristica storica» (secondo l’espressione del Croce) corrispondono a quegli elementi sociali che nel passato leggevano i romanzi storici, apprendevano la storia nei romanzi del Dumas, dell’Hugo, ecc. Perciò mi pare che ci sia stato «progresso», Perché si possa parlare di indebolimento mentale e di infrivolimento bisognerebbe che fosse sparita la storia degli storici, ma ciò non è: forse avviene il contrario, che cioè anche la storia seria sia oggi più letta, come dimostra, in Italia almeno, il moltiplicarsi delle collezioni storiche (cfr la collezione Vallecchi e della «Nuova Italia», per esempio). Anche i libri storici del Croce sono oggi più letti di quello che sarebbero stati prima della guerra: c’è oggi più interesse intellettuale per la politica e quindi per la storia negli strati piccolo borghesi, che immediatamente soddisfano le loro esigenze con la «bellettristica storica». Un fatto però è certo: che cioè nell’organizzazione della cultura, la statura relativa degli «storici serii» è diminuita per l’entrata in campo dei Ludwig e C.: il Croce esprime il rammarico per questo fatto, che rappresenta una «crisi d’autorità» nella sfera della scienza e dell’alta cultura. La funzione dei grandi intellettuali, se permane intatta, trova però un ambiente molto più difficile per affermarsi e svilupparsi: il grande intellettuale deve anch’egli tuffarsi nella vita pratica, diventare un organizzatore degli aspetti pratici della cultura, se vuole continuare a dirigere; deve democratizzarsi, essere più attuale: l’uomo del Rinascimento non è più possibile nel mondo moderno, quando alla storia partecipano attivamente e direttamente masse umane sempre più ingenti.
In realtà il fenomeno Ludwig e la «bellettristica storica» non sono novità del dopo guerra: questi fenomeni sono contenuti in nuce nel giornalismo, nel grande giornale popolare: precursori di Ludwig e C. sono gli articolisti di terza pagina, gli scrittori di bozzetti storici, ecc. Il fenomeno è dunque essenzialmente politico, pratico; appartiene a quella serie di movimenti pratici che il Croce abbraccia sotto la rubrica generale di «antistoricismo», che, analizzata da questo punto di vista, si potrebbe definire: – critica dei movimenti pratici che tendono a diventare storia, che non hanno ancora avuto il crisma del successo, che sono ancora episodi staccati e quindi «astratti», irrazionali, del movimento storico, dello sviluppo generale della storia mondiale. Si dimentica spesso (e quando il critico della storia in fieri dimentica questo, significa che egli non è storico, ma uomo politico in atto) che in ogni attimo della storia in fieri c’è lotta tra razionale e irrazionale, inteso per irrazionale ciò che non trionferà in ultima analisi, non diventerà mai storia effettuale, ma che in realtà è razionale anch’esso perché è necessariamente legato al razionale, ne è un momento imprescindibile; che nella storia, se trionfa sempre il generale, anche il «particulare» lotta per imporsi e in ultima analisi si impone anch’esso in quanto determina un certo sviluppo del generale e non un altro. Ma nella storia moderna, «particulare» non ha più lo stesso significato che aveva nel Machiavelli e nel Guicciardini, non indica più il mero interesse individuale, perché nella storia moderna l’«individuo» storico‑politico non è l’individuo «biologico» ma il gruppo sociale. Solo la lotta, col suo esito, e neanche col suo esito immediato, ma con quello che si manifesta in una permanente vittoria, dirà ciò che è razionale o irrazionale, ciò che è «degno» di vincere perché continua, a suo modo, e supera il passato.
L’atteggiamento pratico del Croce è un elemento per l’analisi e la critica del suo atteggiamento filosofico: ne è anzi l’elemento fondamentale: nel Croce filosofia e «ideologia» finalmente si identificano, anche la filosofia si mostra niente altro che uno «strumento pratico» di organizzazione e di azione: di organizzazione di un partito, anzi di una internazionale di partiti, e di una linea di azione pratica. Il discorso di Croce al Congresso di filosofia di Oxford è in realtà un manifesto politico, di una unione internazionale dei grandi intellettuali di ogni nazione, specialmente dell’Europa; e non si può negare che questo possa diventare un partito importante che può avere una funzione non piccola. Si potrebbe già dire, così all’ingrosso, che già oggi si verifica nel mondo moderno un fenomeno simile a quello del distacco tra «spirituale» e «temporale» nel Medio Evo: fenomeno molto più complesso di quello d’allora, di quanto è diventata più complessa la vita moderna. I raggruppamenti sociali regressivi e conservativi si riducono sempre più alla loro fase iniziale economica‑corporativa, mentre i raggruppamenti progressivi e innovatori si trovano ancora nella fase iniziale appunto economica‑corporativa; gli intellettuali tradizionali, staccandosi dal raggruppamento sociale al quale avevano dato finora la forma più alta e comprensiva e quindi la coscienza più vasta e perfetta dello Stato moderno, in realtà compiono un atto di incalcolabile portata storica: segnano e sanzionano la crisi statale nella sua forma decisiva. Ma questi intellettuali non hanno né l’organizzazione chiesastica, né qualcosa che le rassomigli e in ciò la crisi moderna è aggravata in confronto alla crisi medioevale che si svolse per parecchi secoli, fino alla Rivoluzione francese quando il raggruppamento sociale che dopo il Mille fu la forza motrice economica dell’Europa, poté presentarsi come «Stato» integrale, con tutte le forze intellettuali e morali necessarie e sufficienti per organizzare una società completa e perfetta. Oggi lo «spirituale» che si stacca dal «temporale» e se ne distingue come a se stante, è un qualcosa di disorganico, di discentrato, un pulviscolo instabile di grandi personalità culturali «senza Papa» e senza territorio. Questo processo di disintegrazione dello Stato moderno è pertanto molto più catastrofico del processo storico medioevale che era disintegrativo e integrativo nello stesso tempo, dato lo speciale raggruppamento che era il motore del processo storico stesso e dato il tipo di Stato esistito dopo il Mille in Europa, che non conosceva la centralizzazione moderna e si potrebbe chiamare più «federativo di classi dominanti» che Stato di una sola classe dominante.
È da vedere in quanto l’«attualismo» di Gentile corrisponde alla fase statale positiva, a cui invece fa opposizione il Croce. L’«unità nell’atto» dà la possibilità al Gentile di riconoscere come «storia» ciò che per il Croce è antistoria. Per il Gentile la storia è tutta storia dello Stato; per il Croce è invece «etico‑politica», cioè il Croce vuole mantenere una distinzione tra società civile e società politica, tra egemonia e dittatura; i grandi intellettuali esercitano l’egemonia, che presuppone una certa collaborazione, cioè un consenso attivo e volontario (libero), cioè un regime liberale‑democratico. Il Gentile pone la fase corporativo ‑ economica come fase etica nell’atto storico: egemonia e dittatura sono indistinguibili, la forza è consenso senz’altro: non si può distinguere la società politica dalla società civile: esiste solo lo Stato e naturalmente lo Stato‑governo, ecc.
La stessa posizione contrastante che, nella sfera filosofica, si verifica tra Croce e Gentile, si verifica nel campo dell’economia politica tra Einaudi e i discepoli di Gentile (cfr la polemica Einaudi‑Benini‑Spirito in «Nuovi Studi» del 1930); il concetto di cittadino‑funzionario dello Stato proprio dello Spirito discende direttamente dalla mancata divisione tra società politica e società civile, tra egemonia politica e governo politico‑statale, in realtà quindi dalla antistoricità o astoricità della concezione dello Stato che è implicita nella concezione dello Spirito, nonostante le sue affermazioni perentorie e i suoi sbraitamenti polemici. Lo Spirito non vuole riconoscere che per il fatto che ogni forma di proprietà è legata allo Stato, anche per gli economisti classici lo Stato interviene in ogni momento nella vita economica, che è un tessuto continuo di passaggi di proprietà. La concezione dello Spirito, concretamente, rappresenta un ritorno alla pura economicità, che egli rimprovera ai suoi contradditori.
È interessante notare che in questa concezione è contenuto l’«americanismo», poiché l’America non ha ancora superato la fase economica‑corporativa, attraversata dagli Europei nel Medio Evo, cioè non ha ancora creato una concezione del mondo e un gruppo di grandi intellettuali che dirigano il popolo nell’ambito della società civile: in questo senso è vero che l’America è sotto l’influsso Europeo, della storia europea. (Questa quistione della forma‑fase statale degli Stati Uniti è molto complessa, ma il nocciolo della quistione mi pare proprio questo).
Q6 §11 Nozioni enciclopediche. Libertà‑disciplina. Al concetto
di libertà si dovrebbe accompagnare quello di responsabilità che
genera la disciplina e non immediatamente la disciplina, che in
questo caso si intende imposta dal di fuori, come limitazione
coatta della libertà. Responsabilità contro arbitrio
individuale: è sola libertà quella «responsabile» cioè
«universale», in quanto si pone come aspetto individuale di una
«libertà» collettiva o di gruppo, come espressione individuale
di una legge.
Q6 §12 Stato e società regolata. Nelle nuove tendenze «giuridiche» rappresentate specialmente dai «Nuovi Studi» del Volpicelli e dello Spirito è da notare, come spunto critico iniziale, la confusione tra il concetto di Stato‑classe e il concetto di società regolata. Questa confusione è specialmente notevole nella memoria La libertà economica svolta dallo Spirito nella XIX Riunione della Società per il progresso delle Scienze tenuta a Bolzano nel settembre 1930 e stampata nei «Nuovi Studi» del settembre‑ottobre 1930. Finché esiste lo Stato‑classe non può esistere la società regolata, altro che per metafora, cioè solo nel senso che anche lo Stato‑classe è una società regolata. Gli utopisti, in quanto esprimevano una critica della società esistente al loro tempo, comprendevano benissimo che lo Stato‑classe non poteva essere la società regolata, tanto vero che nei tipi di società rappresentati dalle diverse utopie, s’introduce l’uguaglianza economica come base necessaria della riforma progettata: ora in questo gli utopisti non erano utopisti, ma concreti scienziati della politica e critici congruenti. Il carattere utopistico di alcuni di essi era dato dal fatto che ritenevano si potesse introdurre la uguaglianza economica con leggi arbitrarie, con un atto di volontà, ecc. Rimane però esatto il concetto, che si trova anche in altri scrittori di politica (anche di destra, cioè nei critici della democrazia, in quanto essa si serve del modello svizzero o danese per ritenere il sistema ragionevole in tutti i paesi) che non può esistere eguaglianza politica completa e perfetta senza eguaglianza economica: negli scrittori del Seicento questo concetto si ritrova, per esempio, in Ludovico Zuccolo e nel suo libro Il Belluzzi e credo anche in Machiavelli. Il Maurras ritiene che in Svizzera sia possibile quella certa forma di democrazia, appunto perché c’è una certa mediocrità delle fortune economiche, ecc.
La confusione di Stato‑classe e Società regolata è propria delle classi medie e dei piccoli intellettuali, che sarebbero lieti di una qualsiasi regolarizzazione che impedisse le lotte acute e le catastrofi: è concezione tipicamente reazionaria e regressiva.
Q6 §13 I comuni medioevali come fase economica‑corporativa dello sviluppo moderno. Il libro di Bernardino Barbadoro Le Finanze della repubblica fiorentina, Olschki, Firenze, 1929, L. 100. Nella recensione del libro del Barbadoro pubblicata nel «Pègaso» del luglio 1930, Antonio Panella ricorda il tentativo (incompiuto e difettoso) fatto da Giovanni Canestrini di pubblicare una serie di volumi sulla scienza e l’arte di Stato desunte dagli atti ufficiali della Repubblica di Firenze e dei Medici (nel 1862 uscì il primo e unico volume della serie promessa). La finanza del comune genovese fu trattata dal Sieveking, di Venezia dal Besta, dal Cessi, dal Luzzatto.
Il Barbadoro tratta ora della finanza fiorentina, cronologicamente giunge fino all’istituzione del Monte dopo la Signoria del Duca d’Atene, e per la materia comprende l’imposta diretta e il debito pubblico, cioè le basi essenziali della struttura economica del Comune (pare che il Barbadoro debba completare la trattazione, occupandosi delle imposte indirette).
Prima forma di tassazione, «il focatico»: essa risente ancora dei sistemi tributari feudali e sta a rappresentare il segno tangibile dell’affermarsi dell’autonomia del Comune, il quale si sostituisce ai diritti dell’Impero; forma più evoluta: l’«estimo», basato sulla valutazione globale della capacità contributiva del cittadino.
Sul sistema dell’imposta diretta come cespite principale di entrata reagisce l’interesse della classe dominante, che, come detentrice della ricchezza, tende a riversare i pesi fiscali sulla massa della popolazione con le imposte sul consumo; comincia allora la prima forma di debito pubblico, coi prestiti o anticipazioni che i ceti abbienti fanno per i bisogni dell’erario, assicurandosene il rimborso attraverso le gabelle. La lotta politica è caratterizzata dall’oscillazione tra «estimo» e imposta sul consumo: quando il Comune cade sotto una signoria forestiera (duca di Calabria e duca d’Atene) appare l’«estimo», mentre invece in certi momenti si giunge a ripudiare l’estimo in città (così nel 1315). Il regime signorile, sovrastando agli interessi delle classi sociali (così il Panella: ma realmente «rappresentando un certo equilibrio delle classi sociali, per cui il popolo riusciva a limitare lo strapotere delle classi ricche») può seguire un principio di giustizia distributiva e migliorare anche il sistema dell’imposta diretta, fino al 1427, agli albori del principato mediceo e al tramonto dell’oligarchia, in cui fu istituito il Catasto.
Questo libro del Barbadoro è indispensabile per vedere appunto come la borghesia comunale non riuscì a superare la fase economica‑corporativa, cioè a creare uno Stato «col consenso dei governati» e passibile di sviluppo. Lo sviluppo statale poteva avvenire solo come principato, non come repubblica comunale.
È interessante anche il libro per studiare l’importanza politica del debito pubblico, che si sviluppò per le guerre di espansione, cioè per assicurare alla borghesia un più ampio mercato e la libertà di transito. (Sarebbe da confrontare con ciò che Marx dice nel Capitale a proposito della funzione e dell’importanza del debito pubblico). Anche le conseguenze del debito pubblico sono interessanti: la classe abbiente che aveva creduto di trovare nei prestiti un mezzo per riversare sulla massa dei cittadini la parte maggiore dei pesi fiscali, si trovò punita dalla insolvenza del Comune che, coincidendo con la crisi economica, contribuì ad acuire il male e ad alimentare il dissesto del paese. Questa situazione portò al consolidamento del debito e alla sua irredimibilità (rendita perpetua e riduzione del saggio d’interesse) con la istituzione del Monte dopo la cacciata del Duca d’Atene e l’avvento al potere del popolo «minuto».
Q6 §14 Funzione internazionale degli intellettuali italiani. Monsignor Della Casa. Nella puntata del suo studio su La lirica del Cinquecento, pubblicata nella «Critica» del novembre 1930 B. Croce scrive sul Galateo: «... esso non ha niente di accademico e pesante ed è una serie di garbati avvertimenti sul modo gradevole di comportarsi in società e uno di quei libri iniziatori che l’Italia del Cinquecento dette al mondo moderno» (p. 410). È esatto dire che sia un libro «iniziatore» dato al «mondo moderno»? Chi è più «iniziatore» al «mondo moderno», il Casa e il Castiglione o Leon Battista Alberti? Chi si occupava dei rapporti fra cortigiani o chi dava consigli per l’edificazione del tipo del borghese nella società civile? Tuttavia occorre tener conto del Casa in questa ricerca ed è certamente giusto non considerarlo solo «accademico e pesante» (ma in questo giudizio del «mondo moderno» non è implicito un «distacco» ‑ e non un rapporto di iniziazione ‑ tra il Casa e il mondo moderno?)
Il Casa scrisse altre operette politiche, le orazioni e inoltre un trattatello in latino, De officiis inter potentiores et tenuiores amicos, «intorno al rapporto che corre tra gli amici potenti e inferiori, tra quelli che, stretti dal bisogno di vivere e di avvantaggiarsi, si danno a servire come cortigiani e coloro che li impiegano; rapporto che egli giudica, qual è, di carattere utilitario e non pretende convertirlo in legame regolato da una legge di giustizia, ma che si argomenta di far accettare da entrambe le parti e introdurvi qualche lume di bontà, con lo spiegare agli uni e agli altri la realtà delle loro rispettive posizioni e il tatto che esse richiedono».
Q6 §15 Nozioni enciclopediche. «Spesso ciò che la gente chiama intelligenza, non è che la facoltà di intendere le verità secondarie a scàpito delle verità fondamentali». «Cìò che maggiormente può farci disperati degli uomini è la frivolità». (Due aforismi di Ugo Bernasconi nel «Pègaso» dell’agosto 1930: Parole alla buona gente).
Questa intelligenza è chiamata anche «talento» genericamente ed è palese in quella forma di polemica superficiale, dettata dalla vanità di parere indipendenti e di non accettare l’autorità di nessuno, per cui si cerca di contrapporre, come obbiezioni, a una verità fondamentale, tutta una serie di verità parziali e secondarie.
La «frivolità» spesso è da vedere nella goffaggine seriosa: anzi si chiama «frivolìtà» in certi intellettuali e nelle donne ciò che in politica, per esempio, è appunto la goffaggine e il provincialismo meschino.
Q6 §16 I nipotini delpadre Bresciani. La cultura nazionale italiana. Nella Lettera a Umberto Fracchia sulla critica di Ugo Ojetti («Pègaso», agosto 1930) sono due osservazioni voli: 1) Ricorda l’Ojetti che il Thibaudet divide la critica in tre classi: quella dei critici di professione, quella degli stessi autori, e quella «des honnêtes gens», cioè del pubblico, che alla fine è la vera Borsa dei valori letterari, visto che in Francia esiste un pubblico largo ed attento a seguire tutte le vicende della letteratura. In Italia manca appunto la critica del pubblico, «manca la persuasione o, se si vuole, l’illusione che questi (lo scrittore) compia opera d’importanza nazionale anzi, i migliori, storica, perché, come ella (il Fracchia) dice, «ogni anno e ogni giorno che passa ha ugualmente la sua letteratura, e così è sempre stato, e così sarà sempre, ed è assurdo aspettare o pronosticare o invocare per domani ciò che oggi è. Ogni secolo, ogni porzione di secolo, ha sempre esaltato le proprie opere; è anzi stato portato se mai ad esagerarne l’importanza, la grandezza, il valore e la durata». Giusto, ma non in Italia ecc.» (Il Fracchia scrisse un articolo dopo un discorso di Gioachino Volpe alla seduta dell’Accademia in cui furono distribuiti dei premi: il Volpe aveva detto: «Non si vedono spuntare grandi opere pittoriche, grandi opere storiche, grandi romanzi. Ma chi guarda attentamente, vede nella presente letteratura forze latenti, aneliti all’ascesa, alcune buone e promettenti realizzazioni». Di questo discorso del Volpe darò le indicazioni precise in altra nota più oltre).
2) L’altra osservazione notevole dell’Ojetti è questa: «La scarsa popolarità della nostra letteratura passata, cioè dei nostri classici. È vero: nella critica inglese e francese si leggono spesso paragoni tra gli autori viventi e i classici, ecc. ecc.». Questa osservazione è fondamentale per un giudizio storico sulla presente cultura italiana; il passato non è vivente nel presente, non è un elemento essenziale del presente, cioè nella storia della cultura nazionale non c’è continuità e unità. L’affermazione di questa continuità ed unità è un’affermazione retorica o ha un valore di propaganda, è un atto pratico, in quanto la si vuol creare artificialmente, ma non è una realtà in atto. Il passato, la letteratura compresa, è visto come elemento di cultura scolastica, non come elemento di vita: ciò che poi significa che il sentimento nazionale e recente, se addirittura non si vuol dire che esso è in via di formazione, in quanto la letteratura in Italia non è mai stato un fatto nazionale, ma di carattere «cosmopolitico».
Q6 §17 Letteratura popolare. Il romanzo poliziesco. Cfr Aldo Sorani Conan Doyle e la fortuna del romanzo poliziesco, nel «Pègaso» dell’agosto 1930. Molto interessante per questo genere di letteratura e per le diverse specificazioni che essa ha avuto. Parlando del Chesterton e del suo poliziotto padre Brown, il Sorani però non tiene conto dell’atmosfera un po’ caricaturale delle novelle del Chesterton, che mi pare essenziale e che anzi è l’elemento artistico che nobilita la novella poliziesca del Chesterton quando, non sempre, l’espressione è riuscita perfetta. Nel suo articolo il Sorani riferisce su i diversi tentativi, specialmente anglosassoni e di maggior valore, per perfezionare tecnicamente il romanzo poliziesco. L’archetipo è Sherlock Holmes nelle sue due fondamentali caratteristiche: di scienziato‑poliziotto e di psicologo. I romanzieri perfezionano l’una o l’altra di queste caratteristiche o ambedue insieme. Il Chesterton ha appunto insistito sulla psicologia, nel gioco delle induzioni e deduzioni con padre Brown (che diventa l’eroe di una letteratura «apologetica» del cattolicismo romano contro lo «scientismo» protestantico del Conan Doyle, altro elemento culturale che il Sorani non accenna), ma pare che abbia ancora esagerato nella sua tendenza col tipo del poeta‑poliziotto Gabriel Gale.
Il Sorani schizza un quadro della inaudita fortuna del romanzo poliziesco in tutti gli ordini della società e cerca di identificarne la causa: sarebbe una manifestazione di rivolta contro la meccanicità e la standardizzazione della vita moderna, un modo di evadere dal tritume quotidiano. Naturalmente questa spiegazione si può applicare a tutte le forme di letteratura popolare: dal poema cavalleresco (e Don Chisciotte non cerca di evadere anch’egli, praticamente, dal tritume della vita quotidiana?) al romanzo d’appendice di vario genere. In ogni modo l’articolo del Sorani sarà indispensabile per una futura ricerca più organica su questa branca di letteratura popolare.
Il problema: perché è diffusa la letteratura poliziesca? è un aspetto determinato del problema più vasto: perché è diffusa la letteratura non‑artistica? Per ragioni pratiche (morali e politiche), indubbiamente, e questa risposta generica è la più precisa anche. Ma anche la letteratura artistica non si diffonde anch’essa per ragioni pratico‑politiche e morali, e solo mediatamente per ragioni artistiche? In realtà si legge un libro per impulsi pratici e si rilegge certi libri per ragioni artistiche: l’emozione estetica non è mai di prima lettura. Così avviene nel teatro, in cui l’emozione estetica è una «percentuale» minima dell’interesse dello spettatore, perché nel teatro giocano altri elementi, molti dei quali non sono di ordine intellettuale, ma di ordine fisiologico, come può essere l’«appello del sesso», ecc. In altri casi l’emozione estetica nel teatro non è data dall’opera letteraria, ma dall’interpretazione degli attori: in questi casi occorre però che l’opera letteraria non sia «difficile», ma piuttosto che sia «elementare», «popolare», nel senso che le passioni rappresentate siano le più profondamente umane e di immediata esperienza (vendetta d’onore, amor materno, ecc.) e quindi l’analisi si complica anche in questo caso. I grandi attori venivano applauditi nella Morte Civile, nella Gerla di papà Martin, ecc., ma non nelle complicate macchine psicologiche; nel primo caso l’applauso era senza riserve, nel secondo era freddo, destinato a separare l’attore amato dal pubblico, dal lavoro che sarebbe stato fischiato ecc.
Q6 §18 I nipotini di padre Bresciani. Il sentimento nazionale degli scrittori. Dalla Lettera a Piero Parini sugli scrittori sedentari di Ugo Ojetti nel «Pègaso» del settembre 1930: «Come mai noi italiani che abbiamo portato su tutta la terra il nostro lavoro e non soltanto il lavoro manuale, e che da Melbourne a Rio, da S. Francisco a Marsiglia, da Lima a Tunisi abbiamo dense colonie nostre, siamo i soli a non avere romanzi in cui i nostri costumi e la nostra coscienza siano rivelati in contrasto con la coscienza e i costumi di quelli stranieri fra i quali siamo capitati a vivere, a lottare, a soffrire, e talvolta anche a vincere? D’Italiani, in basso e in alto, manovali o banchieri, minatori o medici, camerieri o ingegneri, muratori o mercanti, se ne trovano in ogni angolo del mondo. La letteratissima letteratura nostra li ignora, anzi li ha sempre ignorati. Se non v’è romanzo o dramma senza un progrediente contrasto d’anime, quale contrasto più profondo e concreto di questo tra due razze, e la più antica delle due, la più ricca cioè d’usi e riti immemorabili, spatriata e ridotta a vivere senza altro soccorso che quello della propria energia e resistenza?». Né libri sugli italiani all’estero, ma neanche libri sugli stranieri (eccettuata la letteratura giornalistica).
Q6 §19 Nozioni enciclopediche. Sulla verità ossia sul dire la verità in politica. È opinione molto diffusa in alcuni ambienti (e questa diffusione è un segno della statura politica e culturale di questi ambienti) che sia essenziale dell’arte politica il mentire, il sapere astutamente nascondere le proprie vere opinioni e i veri fini a cui si tende, il saper far credere il contrario di ciò che realmente si vuole ecc. ecc. L’opinione è tanto radicata e diffusa che a dire la verità non si è creduti. Gli italiani in genere sono all’estero ritenuti maestri nell’arte della simulazione e dissimulazione, ecc. Ricordare l’aneddoto ebreo: «Dove vai?», domanda Isacco a Beniamino. «A Cracovia», risponde Beniamino. «Bugiardo che sei! Tu dici di andare a Cracovia perché io creda invece che tu vada a Lemberg; ma io so benissimo che vai a Cracovia: che bisogno c’è dunque di mentire?». In politica si potrà parlare di riservatezza, non di menzogna nel senso meschino che molti pensano: nella politica di massa dire la verità è una necessità politica, precisamente.
Q6 §20 Quistioni di linguistica. Giulio Bertoni. È stupefacente la recensione benevola che Natalino Sapegno ha pubblicato nel «Pègaso» del settembre 1930 di Linguaggio e Poesia («Bibliotheca» editrice, Rieti, 1930, L. 5). Il Sapegno non s’accorge che la teoria del Bertoni essere la nuova linguistica una «sottile analisi discriminativa delle voci poetiche da quelle strumentali» è tutt’altro che una novità perché si tratta del ritorno a una vecchissima concezione retorica e pedantesca, per cui si dividono le parole in «brutte» e «belle», in poetiche e non poetiche o antipoetiche ecc., così come si erano similmente divise le lingue in belle e brutte, civili o barbariche, poetiche e prosastiche ecc. Il Bertoni non aggiunge nulla alla linguistica, altro che vecchi pregiudizi, ed è maraviglioso che queste stoltezze gli siano passate per buone dal Croce e dagli allievi del Croce. Cosa sono le parole avulse e astratte dall’opera letteraria? Non più elemento estetico, ma elemento di storia della cultura e come tali il linguista le studia. E cos’è la giustificazione che il Bertoni fa dell’«esame naturalistico delle lingue, come fatto fisico e come fatto sociale»? Come fatto fisico? Cosa significa? Che anche l’uomo, oltre che elemento della storia politica deve essere studiato come fatto biologico? Che di una pittura si deve fare anche l’analisi chimica? ecc.? Che sarebbe utile esaminare quanto sforzo meccanico sia costato a Michelangelo lo scolpire il Mosè?
Che questi crociani non si accorgano di tutto questo è stupefacente e serve a indicare quale confusione il Bertoni abbia contribuito a diffondere in questo campo. Addirittura scrive il Sapegno che per questa indagine del Bertoni (sulla bellezza delle singole parole astratte: come se il vocabolo più «frusto e meccanicizzato» non riacquistasse nella concreta opera d’arte tutta la sua freschezza e ingenuità primitiva) «è difficile e delicata, ma non perciò meno necessaria: per essa la glottologia, meglio che scienza del linguaggio, rivolta a scoprire leggi più o meno fisse e sicure, si avvierà a diventare storia della lingua, attenta ai fatti particolari e al loro significato spirituale». E ancora: «Il nucleo di questo ragionamento (del Bertoni) è, come ognuno può vedere, un concetto tuttora vivo e fecondo dell’estetica crociana. Ma l’originalità del Bertoni consiste nell’averlo sviluppato ed arricchito per una concreta via, dal Croce soltanto additata, o magari iniziata, ma non mai seguita fino in fondo e di proposito», ecc. Se il Bertoni «rivive il pensiero crociano» ma anzi lo arricchisce, e il Croce si riconosce nel Bertoni, occorre dire che il Croce stesso deve essere riveduto e corretto: ma a me pare che il Croce sia stato solo molto indulgente col Bertoni, per non aver approfondito la quistione e per ragioni «didattiche».
Le ricerche del Bertoni sono in parte e sotto un certo aspetto un ritorno a vecchi sistemi etimologici: «sol quia solus est», come è bello che il «sole» contenga in sé implicita l’immagine della «solitudine» nell’immenso cielo e via via: «come è bello che in Puglia la libellula con le sue alucce in forma di Croce, sia detta la morte», e così via. Ricordare in uno scritto di Carlo Dossi la storiella del professore che spiega la formazione delle parole: «all’inizio cadde un frutto, facendo pum! ed ecco il «pomo», ecc. «E se fosse caduta una pera?» domanda il giovanetto Dossi.
Q6 §21 La funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. Su gli scrittori politici e moralisti del Seicento, rilevati dal Croce nel suo volume Storia dell’età barocca, cfr la recensione di Domenico Petrini (nel «Pègaso» dell’agosto 1930) Politici e moralisti del Seicento, del libro con lo stesso titolo Politici e moralisti del Seicento (Strada, Zuccolo, Settala, Accetto, Brignole Sale, Malvezzi), a cura di Benedetto Croce e Santino Caramella, Laterza, Bari, 1930, L. 25 (nella collezione «Scrittori d’Italia»).
Q6 §22 Gli inglesi e la religione. Da un articolo della «Civiltà Cattolica» del 4 gennaio 1930, L’opera della grazia in una recente conversione dall’anglicanismo, tolgo questa citazione dal libro di Vernon Johnson One Lord, one Faith (Un signore, una fede; Londra, Sheed and Ward, 1929; il Johnson è appunto il convertito): «L’inglese medio non pensa quasi mai alla questione dell’autorità nella sua religione. Egli accetta quella forma d’insegnamento della Chiesa anglicana, in cui è stato allevato, sia anglocattolica, sia latitudinarista, sia evangelica, e la segue sino al punto in cui comincia a non soddisfare ai suoi bisogni o viene in conflitto con la sua personale opinione. Perciò, essendo sostanzialmente onesto e sincero, non volendo professare più di quello che egli realmente crede, scarta tutto quello che non può accettare e si forma una religione personale sua propria». Lo scrittore della «Civiltà Cattolica» continua, forse parafrasando: «Egli (l’inglese medio) considera la religione come un affare esclusivamente privato tra Dio e l’anima; ed in tale atteggiamento, è estremamente cauto, diffidente e restio ad ammettere l’intervento di qualsiasi autorità. Onde va crescendo il numero di coloro che nella loro mente accolgono sempre più il dubbio: se veramente i Vangeli siano degni di fede, se la religione cristiana sia obbligatoria per tutto il mondo e se si possa conoscere con certezza quale fosse realmente la dottrina di Cristo. Quindi esita ad ammettere che Gesù Cristo fosse veramente Dio». E ancora: «... La maggiore di tutte (le difficoltà al ritorno degli Inglesi alla Chiesa Romana): l’amore per l’indipendenza in ogni inglese. Egli non ammette nessuna ingerenza, molto meno in religione e meno ancora da parte di uno straniero. Innato e profondamente radicato nel suo animo è l’istinto che l’indipendenza nazionale e l’indipendenza religiosa siano inseparabili. Egli sostiene che l’Inghilterra non accetterà mai una Chiesa governata da italiani».
Q6 §23 Passato e presente. I cattolici dopo il Concordato. È molto importante la risposta del Papa all’augurio natalizio del S. Collegio dei Cardinali pubblicata nella «Civiltà Cattolica» del 4 gennaio 1930. Nella «Civiltà Cattolica» del 18 gennaio è pubblicata l’Enciclica papale Quinquagesimo ante anno (per il cinquantesimo anno di Sacerdozio di Pio XI) dove è ripetuto che Trattato e Concordato sono inscindibili e inseparabili «o tutti e due restano, o ambedue necessariamente vengono meno». Questa affermazione reiterata del Papa ha un grande valore: essa forse è stata fatta e ribadita, non solo nei riguardi del governo italiano col quale i due atti sono stati compiuti, ma specialmente come salvaguardia nel caso di mutamento di governo. La difficoltà è nel fatto che cadendo il Trattato, il Papa dovrebbe restituire le somme che intanto sono state versate dallo Stato Italiano in virtù del Trattato: né avrebbe valore il cavillo possibile basato sulla legge delle guarentigie. Bisognerà vedere come mai nei bilanci dello Stato era impostata la somma che lo Stato aveva assegnato al Vaticano dopo le guarentigie, quando esisteva una diffida che tale obbligo veniva a cadere se entro i cinque anni dopo la legge, il Vaticano ne avesse rifiutato la riscossione.
Q6 §24 Nozioni enciclopediche. La società civile. Occorre distinguere la società civile come è intesa dallo Hegel e nel senso in cui è spesso adoperata in queste (cioè nel senso di egemonia politica e culturale di un gruppo sociale sull’intera società, come contenuto etico dello Stato) dal senso che le danno i cattolici, per i quali la società civile è invece la società politica o lo Stato, in confronto della società famigliare e della Chiesa. Dice Pio XI nella sua Enciclica sull’educazione («Civiltà Cattolica» del 1° febbraio 1930): «Tre sono le società necessarie, distinte e pur armonicamente congiunte da Dio, in seno alle quali nasce l’uomo: due società di ordine naturale, quali sono la famiglia e la società civile; la terza, la Chiesa, di ordine soprannaturale. Dapprima la famiglia, istituita immediatamente da Dio al fine suo proprio, che è la procreazione ed educazione della prole, la quale perciò ha la priorità di natura e quindi una priorità di diritti, rispetto alla società civile. Nondimeno, la famiglia è società imperfetta, perché non ha in sé tutti i mezzi per il proprio perfezionamento: laddove la società civile è società perfetta, avendo in sé tutti i mezzi al fine proprio che è il bene comune temporale, onde, per questo rispetto, cioè in ordine al bene comune, essa ha preminenza sulla famiglia, la quale raggiunge appunto nella società civile la sua conveniente perfezione temporale. La terza società, nella quale nasce l’uomo, mediante il Battesimo, alla vita divina della Grazia, è la Chiesa, società di ordine soprannaturale e universale, società perfetta, perché ha in sé tutti i mezzi al suo fine, che è la salvezza eterna degli uomini, e pertanto suprema nel suo ordine».
Per il cattolicismo, quella che si chiama «società civile» in linguaggio hegeliano, non è «necessaria», cioè è puramente storica o contingente. Nella concezione cattolica, lo Stato è solo la Chiesa, ed è uno Stato universale e soprannaturale: la concezione medioevale teoricamente è mantenuta in pieno.
Q6 §25 Passato e presente. L’enciclica del papa sull’educazione (pubblicata nella «Civiltà Cattolica» del 1° febbraio 1930): discussioni che ha sollevato, problemi che ha posto, teoricamente e praticamente. (Questo è un comma del paragrafo generale sulla quistione della scuola, o dell’aspetto scolastico del problema nazionale della cultura o della lotta per la cultura).
Q6 §26 I nipotini di padre Bresciani. Pirandello. Pirandello non appartiene a questa categoria di scrittori, tutt’altro. Lo noto qui per raggruppare insieme le di cultura letteraria. Su Pirandello occorrerà scrivere un saggio speciale, utilizzando tutte le da me scritte durante la guerra, quando Pìrandello era combattuto dalla critica, che era incapace persino di riassumere i suoi drammi (ricordare le recensioni dell’Innesto nei giornali torinesi dopo la prima rappresentazione e le profferte di colleganza fattemi da Nino Berrini) e suscitava le furie di una parte del pubblico. Ricordare che Liolà fu da Pirandello tolta dal repertorio per le dimostrazioni ostili dei giovani cattolici torinesi alla seconda replica. Cfr l’articolo della «Civiltà Cattolica» del 5 aprile 1930 Lazzaro ossia un mito di Luigi Pirandello.
L’importanza del Pirandello mi pare di carattere intellettuale e morale, cioè culturale, più che artistica: egli ha cercato di introdurre nella cultura popolare la «dialettica» della filosofia moderna, in opposizione al modo aristotelico‑cattolico di concepire l’«oggettività del reale». L’ha fatto come si può fare nel teatro e come può farlo il Pirandello stesso: questa concezione dialettica dell’oggettività si presenta al pubblico come accettabile, in quanto essa è impersonata da caratteri di eccezione, quindi sotto veste romantica, di lotta paradossale contro il senso comune e il buon senso. Ma potrebbe essere altrimenti? Solo così i drammi del Pirandello mostrano meno il carattere di «dialoghi filosofici», che tuttavia hanno abbastanza, poiché i protagonisti devono troppo spesso «spiegare e giustificare» il nuovo modo di concepire il reale; d’altronde il Pirandello stesso non sempre sfugge da un vero e proprio solipsismo, poiché la «dialettica» in lui è più sofistica che dialettica.
Q6 §27 I nipotini di padre Bresciani. Stracittà e strapaese. Confrontare nell’«Italia Letteraria» del 16 novembre 1930 la lettera aperta di Massimo Bontempelli a G. B. Angioletti con postilla di quest’ultimo (Il Novecentismo è vivo o è morto?). La lettera è stata scritta dal Bontempelli subito dopo la sua nomina ad Accademico e sprizza da ogni parola la soddisfazione dell’autore di poter dire d’aver «fatto mordere la polvere» ai suoi nemici, Malaparte e la banda dell’«Italiano». Questa polemica di Strapaese contro Stracittà, secondo il Bontempelli, era mossa da sentimenti oscuri e ignobili, cosa che si può accettare, a chi tenga conto dell’arrivismo dimostrato dal Malaparte in tutto il periodo dopo la guerra: era una lotta di un gruppetto di letterati «ortodossi» che si vedevano colpiti dalla «concorrenza sleale» dei letterati già scrittori del «Mondo», come il Bontempelli, l’Alvaro, ecc., e vollero dare un contenuto di tendenza ideologico‑artistico‑culturale alla loro resistenza ecc. Meschinità da una parte e dall’altra. La postilla dell’Angioletti è ancora più meschina della lettera del Bontempelli.
Q6 §28 Letteratura popolare. Nell’«Italia letteraria» del 9 novembre 1930 è riportato qualche brano di un articolo di Filippo Burzio (nella «Stampa» del 22 ottobre) sui Tre Moschettieri di Dumas. Il Burzio li considera una felicissima personificazione, come il Don Chisciotte o l’Orlando Furioso, del mito dell’avventura, «cioè di qualcosa di essenziale alla natura umana, che sembra gravemente e progressivamente straniarsi dalla vita moderna. Quanto più l’esistenza si fa razionale e organizzata, la disciplina sociale ferrea, il compito assegnato all’individuo preciso e prevedibile, tanto più il margine dell’avventura si riduce, come la libera selva di tutti fra i muretti soffocanti della proprietà privata... Il taylorismo è una bella cosa e l’uomo è un animale adattabile, però forse ci sono dei limiti alla sua meccanizzazione. Se a me chiedessero le ragioni profonde dell’inquietudine occidentale, risponderei senza esitare: la decadenza della fede e la mortificazione dell’avventura». «Vincerà il taylorismo o vinceranno i Moschettieri? Questo è un altro discorso e la risposta, che trent’anni fa sembrava certa, sarà meglio tenerla in sospeso. Se l’attuale civiltà non precipita, assisteremo forse a interessanti miscugli dei due».
La quistione è questa: che c’è sempre stata una parte di umanità la cui vita è stata sempre taylorizzata, e che questa umanità ha cercato di evadere dai limiti angusti dell’organizzazione esistente che la schiacciava, con la fantasia e col sogno. La più grande avventura, la più grande «utopia», che l’umanità ha creato collettivamente, la religione, non è un modo di evadere dal mondo terreno? E non è in questo senso che Marx parla di «oppio del popolo»? Adesso la quistione si «aggrava» per il fatto che la razionalizzazione della vita minaccia di colpire le classi medie e intellettuali in una misura inaudita: quindi preoccupazioni e scongiuri ed esorcismi. Ma il fenomeno è vecchio almeno come le religioni. Letteratura popolare come «oppio del popolo»: lo spunto è stato già annotato in altro quaderno a proposito del Conte di Montecristo.
Q6 §29 I nipotini di padre Bresciani. È da notare come in Italia il concetto di cultura sia prettamente libresco: i giornali letterari si occupano di libri o di chi scrive libri. Articoli di impressioni sulla vita collettiva, sui modi di pensare, sui «segni del tempo», sulle modificazioni che avvengono nei costumi, ecc., non se ne leggono mai. Differenza tra la letteratura italiana e le altre letterature. In Italia mancano i memorialisti e sono rari i biografi e gli autobiografi. Manca l’interesse per l’uomo vivente, per la vita vissuta. (Le Cose viste di Ugo Ojettì sono poi quel gran capolavoro di cui si è incominciato a parlare da quando Ojetti è stato direttore del «Corriere della Sera» e cioè dell’organismo letterario che paga meglio gli scrittori e dà più fama? Anche nelle Cose viste si parla specialmente di scrittori, da quelle che io ho letto anni fa, almeno. Si potrebbe rivedere). È un altro segno del distacco degli intellettuali italiani dalla realtà popolare‑nazionale.
Sugli intellettuali questa osservazione di Prezzolini (Mi pare…, p. 16) scritta nel 1920: «L’intellettuale da noi ha la pretesa di fare il parassita. Si considera come l’uccellino fatto per la gabbietta d’oro che dev’essere mantenuto a pastone e a chicchini di miglio. Lo sdegno che c’è ancora per tutto quello che somiglia al lavoro, le carezze che si fanno sempre alla concezione romantica di un estro che bisogna aspettare dal cielo, come la Pitia aspettava i suoi invasamenti, sono dei sintomi piuttosto puzzolenti di marcia interiore. Bisogna che gli intellettuali capiscano che i bei tempi per queste mascherate interessanti sono passati. Di qui a qualche anno non sarà permesso essere ammalati di letteratura o restare inutili». Gli intellettuali concepiscono la letteratura come una «professione» a sé, che dovrebbe «rendere» anche quando non si produce nulla immediatamente e dovrebbe dar diritto a una pensione. Ma chi stabilisce che Tizio è veramente un «letterato» e che la società può mantenerlo in attesa del «capolavoro»? Il letterato rivendica il diritto di stare in «ozio» («otium et non negotium»), di viaggiare, di fantasticare, senza preoccupazioni di carattere economico. Questo modo di pensare è legato al mecenatismo delle corti, male interpretato del resto, perché i grandi letterati del Rinascimento, oltre a scrivere, lavoravano in qualche modo (anche l’Ariosto, letterato per eccellenza, aveva incombenze amministrative e politiche): un’immagine del letterato del Rinascimento falsa e sbagliata. Oggi il letterato è professore e giornalista o semplice letterato (nel senso che tende a diventarlo, se è funzionario, ecc.).
Si può dire che la «letteratura» è una funzione sociale, ma che i letterati, presi singolarmente, non sono necessari alla funzione, sebbene ciò sembri paradossale. Ma è vero nel senso, che mentre le altre professioni sono collettive, e la funzione sociale si scompone nei singoli, ciò non avviene nella letteratura. La quistione è dell’«apprendissaggio»: ma si può parlare di «apprendissaggio» artistico letterario? La funzione intellettuale non può essere staccata dal lavoro produttivo generale neanche per gli artisti: se non quando essi hanno dimostrato di essere effettivamente produttivi «artisticamente». Né ciò nuocerà all’«arte», forse anzi le gioverà: nuocerà solo alla «bohème» artistica e non sarà un male, tutt’altro.
Q6 §30 Nozioni enciclopediche. L’affermazione che «non si può distruggere, senza creare» è molto diffusa. L’ho letta, già prima del 1914, nell’«Idea nazionale», che pure era un bric‑à‑brac di banalità e luoghi comuni. Ogni gruppo o gruppetto che crede di essere portatore di novità storiche (e si tratta di vecchierie con tanto di barba) si afferma dignitosamente distruttore‑creatore. Bisogna togliere la banalità all’affermazione divenuta banale. Non è vero che «distrugga» chiunque vuol distruggere. Distruggere è molto difficile, tanto difficile appunto quanto creare. Poiché non si tratta di distruggere cose materiali, si tratta di distruggere «rapporti» invisibili, impalpabili, anche se si nascondono nelle cose materiali. È distruttore‑creatore chi distrugge il vecchio per mettere alla luce, fare affiorare il nuovo che è divenuto «necessario» e urge implacabilmente al limitare della storia. Perciò si può dire che si distrugge in quanto si crea. Molti sedicenti distruttori non sono altro che «procuratori di mancati aborti», passibili del codice penale della storia.
Q6 §31 Passato e presente. Dal libro Mi pare… di Prezzolini: «L’irreligiosità moderna è una nuova freschezza di spirito, un atto morale, una liberazione. L’irreligiosità è una difficoltà, un carico, un obbligo, un dovere maggiore.
In questo senso ci rende nobili. È l’emulazione con la virtù passata. Noi, irreligiosi, possiamo e dobbiamo essere da tanto quanto gli uomini passati, religiosi. Anzi di più; o meglio: diversamente».
Q6 §32 relle di cultura indiana. Dall’intervista di F. Lefèvre con Aldous Huxley (nelle «Nouvelles Littéraires» del 1° novembre 1930): «Qu’est‑ce que vous pensez des révoltes et de tout ce qui se passe aux Indes? – Je pense qu’on y a commencé la civilisation du mauvais côté. On a créé des hautes universités, on n’a pas fondé d’écoles primaires. On a cru qu’il suffisait de donner des lumières à une caste et qu’elle pourrait ensuite élever les masses, mais je ne vois pas que les résultats obtenus aient été très heureux. Ces gens qui ont bénéficié de la civilisation occidentale sont tous chattryas ou brahmanes. Une fois instruits, ils demeurent sans travail et deviennent dangereux. Ce sont eux qui veulent prendre le gouvernement. C’est en visitant les Indes que j’ai le mieux compris la différence qu’il pouvait y avoir au moyen âge entre un vilain et un cardinal. L’Inde est un pays où la supériorité de droit divin est ancore acceptée par les intouchables qui reconnaissent eux‑mêmes leur indignité».
C’è qualcosa di vero, ma quanto poco. Come creare le scuole elementari per le masse indiane senza aver creato il personale adeguato: e per creare questo non bisognerà rivolgersi inizialmente alle classi intellettuali già esistenti? E poi, il solo fatto che dei gruppi intellettuali sono disoccupati, può creare una situazione come quella indiana? (Ricordare la famigerata teoria di Loria sugli intellettuali disoccupati). Questi intellettuali sono «isolati» o non sono piuttosto divenuti l’espressione delle classi medie e industriali che lo sviluppo economico ha prodotto nell’India?
Q6 §33 Gli intellettuali. Un ricco materiale da spigolare sulle concezioni diffuse tra gli intellettuali si potrà trovare nelle raccolte di interviste pubblicate nelle «Nouvelles Littéraires» da Frédéric Lefèvre col titolo Une heure avec…. Ne sono già usciti più volumi. In queste interviste non si trattano solo quistioni letterarie e artistiche, ma anche politiche, economiche, ecc., ideologiche in generale. Il modo di pensare è espresso con maggiore spontaneità ed evidenza che nei libri degli autori.
Q6 §34 Georges Renard. Morto nell’ottobre 1930. Era professore di Storia del Lavoro al Collège de France. Partecipò alla Comune. Ha diretto queste collezioni: Le Socialisme à l’œuvre, l’Histoire Universelle du Travail, la Bibliothèque Sociale des Métiers. Libro teorico: Le Régime Socialiste in cui difende la tradizione del socialismo francese contro Marx. Deve aver scritto un libro, Les Cités Imaginaires, sulla letteratura utopistica (ma forse era solo il tema del suo corso universitario per l’anno 30‑31, non tenuto per la morte); ma nei suoi libri molti accenni certamente. Sarà utile compilare una bibliografia completa del Renard, identificando quelle opere che hanno un’importanza scientifica e storica.
Q6 §35 Cultura italiana. Esiste un «razzismo» in Italia? Molti tentativi sono stati fatti, ma tutti di carattere letterario e astratto. Da questo punto di vista l’Italia si differenzia dalla Germania, quantunque tra i due paesi ci siano alcune somiglianze estrinseche interessanti: 1) La tradizione localistica e quindi il tardo raggiungimento dell’unità nazionale e statale. (Somiglianza estrinseca perché il regionalismo italiano ha avuto altre origini che quello tedesco: in Italia hanno contribuito due elementi principali: a) la rinascita delle razze locali dopo la caduta dell’Impero Romano; b) le invasioni barbariche prima, i domini stranieri dopo. In Germania i rapporti internazionali hanno influito, ma non con l’occupazione diretta di stranieri). 2) L’universalismo medioevale influì più in Italia che in Germania, dove l’Impero e la laicità trionfarono molto prima che in Italia, durante la Riforma. 3) Il dominio nei tempi moderni delle classi proprietarie della campagna, ma con rapporti molto diversi. Il tedesco sente più la razza che l’Italiano. Razzismo: il ritorno storico al romanesimo, poco sentito oltre la letteratura. Esaltazione generica della stirpe, ecc. Lo strano è che a sostenere il razzismo oggi (con l’Italia Barbara Arcitaliano e lo strapaesismo) sia Kurt Erich Suckert, nome evidentemente razzista e strapaesano; ricordare durante la guerra Arturo Foà e le sue esaltazioni della stirpe italica, altrettanto congruenti che nel Suckert.
Q6 §36 Lorianesimo. Trombetti e l’etrusco. Cfr Luigi Pareti, Alta vigilia del 1° Congresso Internazionale etrusco, «Marzocco» del 29 aprile 1928, e Pareti, Dopo il Congresso etrusco, «Marzocco», 13 maggio 1928, e Consensi e dissensi storici archeologici al Congresso Etrusco, «Marzocco», 20 maggio 1928.
A proposito delle ricerche linguistiche il Pareti scrive nel primo articolo: «Assicurati della precisione dei testi trascritti, e della completezza delle nostre raccolte, si potrà rielaborarli, in maniera non comune, per quanto concerne la linguistica. Poiché è ormai indispensabile, non solo condurre avanti i tentativi di interpretazione, ma procedere storicamente, considerando cioè i termini lessicali ed i fenomeni fonetici nello spazio e nel tempo: distinguendo quel ch’è antico dal recente, e individuando le differenze dialettali di ogni regione. Fissata questa base storico‑linguistica, sarà più facile e sicuro sia risalire dai termini e fenomeni più antichi, ai confronti con altre lingue che interessino per il problema delle parentele originarie; sia, all’opposto, discendere da alcune peculiarità dei dialetti etruschi nella loro ultima fase, avvicinando termini e fenomeni dialettali attuali. Altrettanto meticolosa ha da essere, naturalmente, l’indagine per sceverare i vari strati, utilizzabili storicamente, della toponomastica. Poiché, in teoria, per ogni nome, occorre rintracciare l’età e lo strato etnico a cui risale, è indispensabile che per ognuno di essi siano raccolte le più antiche testimonianze, e registrata la forma precisa iniziale, accanto alle posteriori deformazioni. E ciò per evitare la rischiosa comparazione di termini che si possono dimostrare imparagonabili, o per reale disformità fonetica, o per impossibilità cronologica. Di tutto il materiale vagliato sarà poi opportuno redigere lessici e carte topografiche, di comoda e perspicua consultazione». Questi articoli del Pareti sono molto ben fatti e danno un’idea perspicua delle attuali condizioni degli studi sugli Etruschi.
Q6 §37 Passato e presente. Sulle condizioni recenti della scuola e degli studi in Italia occorre vedere gli articoli di Mario Missiroli nell’«Italia Letteraria» del 1929.
Q6 §38 I nipotini di padre Bresciani. La lettera aperta di Umberto Fracchia a S. E. Gioachino Volpe è nell’«Italia Letteraria» del 22 giugno 1930 (cfr nota precedente): il discorso del Volpe all’Accademia è di quindici giorni prima. Brano tipico del Fracchia: «Solo un po’ più di coraggio, di abbandono, di fede basterebbero per trasformare l’elogio a denti stretti che Ella ha fatto della presente letteratura in un elogio aperto ed esplicito; per dire che la presente letteratura italiana ha forze non solo latenti, ma anche scoperte, visibili (!) le quali non aspettano (!) che di essere vedute e riconosciute da quanti le ignorano, ecc. ecc.». Il Volpe un po’ aveva «sul serio» parafrasato i versi giocosi del Giusti: «Eroi, eroi che fate voi? – Ponziamo il poi!», e il Fracchia si lamenta miserevolmente che non si riconoscono le ponzature già attuate.
Il Fracchia parecchie volte ha minacciato gli editori che stampano troppe traduzioni di misure legislative‑corporative di protezione per gli scrittori italiani. (Ricordare l’ordinanza del sottosegretario all’interno Bianchi, poi interpretata e di fatto ritirata e che era connessa a una campagna del Fracchia). Il ragionamento del Fracchia nella lettera al Volpe è impagabile: Ogni secolo, ogni frazione di secolo ha la sua letteratura, non solo, ma la esalta; tanto che le storie letterarie hanno dovuto mettere a posto molte opere esaltatissime e che oggi si riconosce non valgono nulla. (Questo è giusto, ma significa solo questo: che l’attuale periodo non sa interpretare il suo tempo, è staccato dalla vita, sicché neanche per «ragioni pratiche» vengono esaltate opere che poi magari saranno riconosciute artisticamente nulle e la cui «praticità» è stata superata; ma è vero che non ci siano opere molto lette? ci sono, ma sono straniere, o ci sarebbero, se fossero tradotte come il libro di Remarque, ecc.). Realmente il tempo presente non ha letteratura, perché la letteratura esistente, salvo rare eccezioni, non è legata alla vita popolare‑nazionale, ma a gruppi castali avulsi dalla vita, ecc. Il Fracchia si lamenta della critica, che si pone solo dal punto di vista dei grandi capolavori, che si è rarefatta nella perfezione delle teorie estetiche, ecc. Ma se i libri fossero criticati dal punto di vista del contenuto, si lamenterebbe lo stesso perché il suo contenuto non rappresenta che zero nel mondo della cultura, così come i libri della maggior parte degli scrittori attuali.
Non è vero che non esista in Italia una critica del pubblico (come scrive Ojetti nella lettera del «Pègaso» ricordata in altra nota); esiste, ma di un pubblico al quale piacciono ancora i romanzi di Dumas o i romanzi polizieschi stranieri, o di Carolina Invernizio. Questa critica è rappresentata dai direttori dei quotidiani e delle riviste popolari a grande tiratura e si manifesta nella scelta delle appendici; è rappresentata dagli editori e si manifesta nelle traduzioni di libri stranieri e non solo attuali, ma vecchi, molto vecchi; si manifesta nei repertori delle compagnie teatrali, ecc. Né si tratta di «esotismo» al cento per cento, perché in musica il pubblico vuole Verdi, e Puccini e Mascagni, che non hanno il corrispondente in prosa, evidentemente. E all’estero Verdi, Puccini, Mascagni sono preferiti dai pubblici stranieri ai loro stessi musicisti nazionali e attuali. C’è dunque distacco tra scrittori e pubblico e il pubblico cerca la sua letteratura all’estero e la sente più sua di quella nazionale. Questo è il problema. Perché se è vero che ogni secolo o frazione di secolo ha la sua letteratura non è sempre vero che questa letteratura si ritrovi nella stessa comunità nazionale: ogni popolo ha la sua letteratura ma questa può venirgli da un altro popolo, cioè il popolo in parola può essere subordinato all’egemonia intellettuale di altri popoli. Questo è spesso il paradosso più stridente per molte tendenze monopolistiche di carattere nazionalistico e repressivo: che, mentre fanno grandi piani di loro egemonie, non si accorgono di essere soggetti ad egemonie straniere, così come, mentre fanno piani imperialistici, in realtà sono oggetto di altri imperialismi, ecc. D’altronde non si sa se il centro dirigente politico non capisca benissimo la situazione di fatto e per accontentare i cervelli vuoti esalti il proprio imperialismo per non far sentire quello a cui si è soggetti di fatto.
Q6 §39 Nozioni enciclopediche. L’affermazione di Paolo Bourget fatta al principio della guerra (mi pare, perché forse anche prima) che i quattro pilastri dell’Europa erano: il Vaticano, lo Stato Maggiore prussiano, la Camera dei Lords inglesi, l’Accademia francese. Il Bourget dimenticava lo zarismo russo che era il maggiore pilastro, l’unico che avesse resistito durante la Rivoluzione francese e Napoleone e durante il 48.
Bisognerebbe vedere con esattezza dove e quando il Bourget fece tale affermazione e in che termini precisi. Forse il Bourget stesso ebbe vergogna di mettere in serie lo zarismo russo. Si potrebbe prendere lo spunto di questa proposizione del Bourget per trattare della funzione che ebbe la Russia nella storia europea: essa difese l’Europa occidentale dalle invasioni tartariche, fu un antemurale tra la civiltà europea e il nomadismo asiatico, ma questa funzione divenne presto reazionaria e conservativa. Con la sua sterminata popolazione composta di tante nazionalità, era sempre possibile alla Russia organizzare eserciti imponenti di truppe assolutamente inattaccabili dalla propaganda liberale da gettare contro i popoli europei: ciò avvenne nel 48, lasciando una sedimentazione ideologica che ancora operava nel 1914 (rullo compressore, i cosacchi, che distruggeranno l’Università di Berlino, ecc.). Molti non riescono a calcolare quale mutamento storico sia avvenuto in Europa nel 1917 e quale libertà abbiano conquistato i popoli occidentali.
Q6 §40 Passato e presente. Il governo inglese. Un articolo interessante di Ramsay Muir sul sistema di governo inglese è stato pubblicato nel fascicolo di novembre 1930 della «Nineteenth Century» (riportato nella «Rassegna settimanale della Stampa Estera», del 9 dicembre 1930)’. Il Muir sostiene che in Inghilterra non si può parlare di regime parlamentare, perché non esiste controllo del Parlamento sul governo e sulla burocrazia ma solo di una dittatura di partito e ancora di una dittatura inorganica perché il potere oscilla tra partiti estremi. Nel Parlamento la discussione non è quale dovrebbe essere, cioè discussione di Consiglio di Stato, ma discussione di partiti per contendersi il corpo elettorale alla prossima elezione con promesse da parte del governo, screditando il governo da parte dell’opposizione. Le deficienze del sistema di governo inglese si sono manifestate crudamente nel dopoguerra, per i grandi problemi di ricostruzione e di adattamento alla nuova situazione (ma anche alla vigilia della guerra: cfr caso Carson nell’Irlanda settentrionale. Il Carson traeva la sua audacia e la sicurezza d’impunità appunto dal sistema di governo, per cui le sue azioni sovversive sarebbero state sanate da un ritorno d conservatori al potere). Il Muir trova l’origine della dittatura di partito nel sistema elettorale senza ballottaggio e specialmente senza proporzionale; ciò rende difficile i compromessi e le opinioni medie (o almeno costringe i partiti a un opportunismo interno peggiore del compromesso parlamentare). Il Muir non osserva altri fenomeni: nello stesso governo, c’è un gruppo ristretto che domina sull’intero gabinetto e ancora c’è una personalità che esercita una funzione bonapartista.
Q6 §41 Religione. «Viaggiando, potrai trovare città senza mura e senza lettere, senza re e senza case (!), senza ricchezze e senza l’uso della moneta, prive di teatri e di ginnasi (palestre). Ma una città senza templi e senza dei, che non pratichi né preghiere, né giuramenti, né divinazioni, né i sacrifizi per impetrare i beni e deprecare i mali, nessuno l’ha mai veduta, né la vedrà mai». Plutarco, adv. Col., 31.
Definizione della religione del Turchi (Storia delle religioni, Bocca 1922): «La parola religione nel suo significato più ampio, denota un legame di dipendenza che riannoda l’uomo a una o più potenze superiori dalle quali sente di dipendere ed a cui tributa atti di culto sia individuali che collettivi». Cioè nel concetto di religione si presuppongono questi elementi costitutivi: 1° la credenza che esistano una o più divinità personali trascendenti le condizioni terrestri e temporali; 2° il sentimento degli uomini di dipendere da questi esseri superiori che governano la vita del cosmo totalmente; 3° l’esistenza di un sistema di rapporti (culto) tra gli uomini e gli dei. Salomone Reinach nell’Orpheus definisce la religione senza presupporre la credenza in potenze superiori: «Un insieme di scrupoli (tabù) che fanno ostacolo al libero esercizio delle nostre facoltà». Questa definizione è troppo ampia e può comprendere non solo le religioni ma anche qualsiasi ideologia sociale che tende a rendere possibile la convivenza e perciò ostacola (con scrupoli) il libero (o arbitrario) esercizio delle nostre facoltà.
Sarebbe da vedere anche se può chiamarsi «religione» una fede che non abbia per oggetto un dio personale, ma solo delle forze impersonali e indeterminate. Nel mondo moderno si abusa delle parole «religione» e «religioso» attribuendole a sentimenti che nulla hanno che vedere con le religioni positive. Anche il puro «teismo» non è da ritenersi una religione; manca in esso il culto, cioè un rapporto determinato fra l’uomo e la divinità.
Q6 §42 Tendenze della cultura italiana. Giovanni Cena. Sul Cena è molto interessante l’articolo di Arrigo Cajumi Lo strano caso di Giovanni Cena («Italia letteraria», 24 novembre 1929).
Del Cajumi sarà utile ricercare le raccolte di articoli; il Cajumi è molto capace nel trovare certi nessi nel mondo della cultura italiana. Del Cajumi occorre ricordare la quistione di Arrigo ed Enrico: Enrico segretario di redazione dell’«Italia Nostra» il settimanale dei neutralisti intellettuali del 1914‑15 e direttore dell’«Ambrosiano» nel periodo in cui l’«Ambrosiano» era controllato da Gualino; mi pare che nel giornale, come direttore responsabile, firmasse cav. o comm. Enrico Cajumi; Arrigo, scrittore di articoli letterari e di cultura nella «Stampa», corrispondente della «Stampa» da Ginevra, durante le sessioni della S.d.N., esaltatore della politica e dell’oratoria di Briand. Perché questo cambiamento di Arrigo in Enrico e di Enrico in Arrigo? Il Cajumi era in terz’anno della Università di Torino quando io ero in primo anno: era un giovane brillante come studente e come conversatore. Ricordare l’episodio di Berra, nel 18 o nel 19, cioè appena nella «Stampa» cominciò ad apparire la firma di Arrigo Cajumi; il Berra mi racconto d’aver incontrato Enrico Cajumi e di aver parlato con lui di questi articoli: il Cajumi si mostrava offeso che lo si potesse credere l’autore per l’Enrico‑Arrigo. Dall’Università di Torino il Cajumi si trasferì nel 12‑13 all’Università di Roma e divenne amico, oltre che allievo di Cesare De Lollis, specializzandosi nella letteratura francese. Che si tratti della stessa persona è dimostrato dall’attuale culto di Arrigo per il De Lollis e dal fatto che egli è del gruppo che ha continuato «La Cultura». Ancora: il Cajumi, col nome di Enrico, continuò a firmare l’«Ambrosiano» anche quando se ne era allontanato, credo per un ammutinamento della redazione; in un articolo della «Stampa» su Marco Ramperti, ricordava in questo tempo, di aver conosciuto personalmente il Ramperti durante una sua avventura giornalistica, e di averlo visto lavorare da vicino: ora il Ramperti era appunto il critico drammatico dell’«Ambrosiano». Adesso il Cajumi è impiegato presso la ditta Bemporad di Firenze e scrive solo articoli di riviste e di letteratura nella «Stampa» (credo) e nell’«Italia Letteraria».
Dall’articolo su Cena stralcio qualche brano: «Nato nel 1870, morto nel 1917, Giovanni Cena ci appare come una figura rappresentativa del movimento intellettuale che la parte migliore della nostra borghesia compì al rimorchio delle nuove idee che venivano di Francia e di Russia; con un apporto personalmente più amaro ed energico, causato dalle origini proletarie (! o contadine?) e dagli anni di miseria. Autodidatta uscito per miracolo dall’abbrutimento del lavoro paterno e del natìo paesello, Cena entrò inconsciamente nella corrente che in Francia – proseguendo una tradizione (!) derivata (!) da Proudhon via via (!) attraverso Vallès e i comunardi sino ai Quatre évangiles zoliani, all’affare Dreyfus, alle Università popolari di Daniel Halévy e che oggi continua in Guéhenno (!) (piuttosto in Pierre Dominique e in altri) – fu definita come l’andata al popolo (il Cajumi trasporta nel passato una parola d’ordine odierna, dei populisti; nel passato tra popolo e scrittori in Francia non ci fu mai scissione dopo la Rivoluzione francese e fino a Zola: la reazione simbolista scavò un fosso tra popolo e scrittori, tra scrittori e vita e Anatole France è il tipo più compiuto di scrittore libresco e di casta). Il nostro (Cena) veniva dal popolo, di qui l’originalità (!) della sua posizione, ma l’ambiente della lotta era sempre lo stesso, quello dove si affermò il socialismo di un Prampolini, Era la seconda generazione piccolo‑borghese dopo l’unità italiana (della prima ha scritto magistralmente la cronistoria Augusto Monti nei Sansoussî), estranea alla politica delle classi conservatrici dominanti, in letteratura più connessa al De Amicis o allo Stecchetti che al Carducci, lontana da d’Annunzio, e che preferirà formarsi su Tolstoi, considerato piuttosto come pensatore che quale artista, scoprirà Wagner, crederà vagamente ai simbolisti, alla poesia sociale (simbolisti e poesia sociale?), alla pace perpetua, insulterà i governanti perché poco idealisti, e non si ridesterà dai suoi sogni neppure per le cannonate del 1914» (un po’ di maniera e stiracchiato tutto ciò). «Cresciuto fra incredibili stenti, sapeva di essere anfibio, né borghese, né popolano: “Come mi facessi un’istruzione accademica e prendessi diplomi, è cosa che mi fa perdere spesso ogni calma a pensarci. E quando, pensandoci, sento che potrò perdonare, allora ho veramente il senso di essere un vittorioso”. “Sento profondamente che soltanto lo sfogo della letteratura e la fede nel suo potere di liberazione e di elevazione mi hanno salvato dal diventare un Ravachol” ».
Nel primo abbozzo degli Ammonitori il Cena immaginò che il suicida si gettasse sotto un’automobile reale, ma nell’edizione definitiva non mantenne la scena: «… Studioso di cose sociali, estraneo a Croce, a Missiroli, Jaurès, Oriani, alle vere esigenze del proletariato settentrionale che lui, contadino, non poteva sentire. Torinese, era ostile al giornale che rappresentava la borghesia liberale, anzi socialdemocratica. Di sindacalismo non v’è traccia, di Sorel manca il nome. Il modernismo non lo preoccupava». Questo brano mostra quanto sia superficiale la cultura politica del Cajumi. Il Cena è volta a volta popolano, proletario, contadino. La «Stampa» è socialdemocratica, anzi esiste una borghesia torinese socialdemocratica: il Cajumi imita in ciò certi uomini politici siciliani che fondavano partiti democratici sociali o addirittura laburisti e cade nel tranello di molti pubblicisti da ridere che hanno cucinato la parola socialdemocrazia in tutte le salse. Il Caiumi dimentica che a Torino la «Stampa» era, prima della guerra, a destra della «Gazzetta del Popolo», giornale democratico moderato. È poi grazioso l’accoppiamento Croce‑Missiroli‑Jaurès‑Oriani per gli studi sociali.
Nello scritto Che fare? il Cena voleva fondere i nazionalisti coi filosocialisti come lui; ma in fondo tutto questo socialismo piccolo borghese alla De Amicis non era un embrione di socialismo nazionale, o nazionalsocialismo, che ha cercato di farsi strada in tanti modi in Italia e che ha trovato nel dopoguerra un terreno propizio?
Q6 §43 Il Comune come fase economico‑corporativa dello Stato.
Nel 1400 lo spirito di iniziativa dei mercanti italiani era
caduto; si preferiva investire le ricchezze acquistate in beni
fondiari e avere un reddito certo dall’agricoltura, piuttosto
che arrischiarle nuovamente in viaggi o in investimenti
all’estero. Ma come si è verificata questa caduta? Gli elementi
che vi hanno contribuito sono parecchi: le lotte di classe
fierissime nelle città comunali, i fallimenti per insolvenza di
debitori regali (fallimento dei Bardi e Peruzzi), l’assenza di
un grande Stato che proteggesse i suoi cittadini all’estero:
cioè la causa fondamentale è nella stessa struttura dello Stato
comunale che non può svilupparsi in grande Stato territoriale.
Da allora si è radicato in Italia lo spirito retrivo per cui si
crede che sola ricchezza sicura è la proprietà fondiaria.
Bisognerà studiare bene questa fase, in cui i mercanti diventano
proprietari terrieri e vedere quali fossero i rischi inerenti
allo scambio e al commercio bancario.
Q6 §44 Sulla letteratura italiana. Cfr il saggio di G. A. Borgese Il senso della letteratura italiana nella Nuova Antologia del 1° gennaio 1930. «Un epiteto, un motto, non può riassumere lo spirito di un’epoca o di un popolo, ma giova qualche volta come riferimento o appiglio mnemonico. Per la letteratura francese si suol dire: grazia, ovvero: chiarezza, logica. Si potrebbe dire: cavalleresca lealtà dell’analisi. Diremmo per la letteratura inglese: lirismo dell’intimità; per la tedesca: audacia della libertà; per la russa: coraggio della verità. Le parole di cui possiamo servirci per la letteratura italiana sono quelle appunto che ci sono servite per questi ricordi visivi: maestà, magnificenza, grandezza». Insomma il Borgese trova che il carattere della letteratura italiana è «teologico‑assoluto‑metafisico‑antiromantico» ecc., e forse, il suo linguaggio da ierofante si potrebbe appunto tradurre nel giudizio in parole povere che la letteratura italiana è staccata dallo sviluppo reale del popolo italiano, è di casta, non sente il dramma della storia, non è cioè popolare‑nazionale.
Parla del libro del Bonghi: «L’autore e i suoi amici si accorsero presto, ma troppo tardi per correggere un titolo divenuto in breve tempo eccessivamente famoso, che il piccolo libro avrebbe dovuto intitolarsi piuttosto: perché la prosa italiana non sia popolare in Italia. Questo appunto è debole relativamente nella letteratura italiana: la prosa, o, meglio ancora che la prosa intesa come genere letterario e ritmo verbale, diremo il senso del prosaico: l’interesse, la curiosità osservatrice, l’amore paziente per la vita storica e contingente quale si svolge sotto i nostri occhi, per il mondo nel suo divenire, per l’attuazione drammatica e progressiva del divino».
È interessante poco prima un brano sul De Sanctis e il rimprovero buffo: «Vedeva vivere la letteratura italiana da più di sei secoli e le chiedeva di nascere». In realtà il De Sanctis voleva che la «letteratura» si rinnovasse perché si erano rinnovati gli italiani, perché sparito il distacco tra letteratura e vita ecc. È interessante osservare che il De Sanctis è progressista anche oggi nei confronti dei tanti Borgesi della critica attuale.
«La sua limitata popolarità della letteratura italiana, il singolare e quasi aristocratico e appartato genere di fortuna che le toccò per tanto tempo, non si spiega soltanto (!) con la sua inferiorità: si spiega più completamente (!) con le sue altezze (! altezze mescolate con inferiorità!), con l’aria rarefatta in cui si sviluppò. Non‑popolarità è come dire non-divulgazione; conseguenza che discende dalla premessa: odi profanum vulgus et arceo. Tutt’altro che popolana e profana, questa letteratura nacque sacra, con un poema, che il suo stesso poeta chiamò sacro (sacro perché parla di Dio, ma quale argomento più popolare di Dio? E nella Divina Commedia non si parla solo di Dio ma anche dei diavoli e della loro “nuova cennamella”) ecc. ecc.». «Il destino politico, che, togliendo all’Italia libertà e potenza materiale, ne fece quello che biblicamente, leviticamente, si chiamerebbe un popolo di sacerdoti».
Il saggio conchiude, meno male, che il carattere della letteratura italiana può cambiare, anzi deve cambiare ecc. ma ciò è stonato con il complesso del saggio stesso.
Q6 §45 Passato e presente. Un pensiero del Guicciardini: «Quanto s’ingannano coloro che ad ogni parola allegano e’ Romani. Bisognerebbe avere una città condizionata come era la loro, e poi governarsi secondo quello esempio; il quale, a chi ha le qualità disproporzionate, è tanto disproporzionato quanto sarebbe volere che un asino facesse il corso di un cavallo». (È nei Ricordi?; cercare e controllare).
Franco Ciarlantini nel 1929 (forse in «Augustea») ha domandato agli scrittori italiani se essi pensino che, per far valere la cultura italiana nel mondo, convenga piuttosto l’apologia senza riserve o la critica sincera. Problema caratteristico.
Q6 §46 La funzione dello zarismo in Europa. Cfr la lettera al
conte Vimercati di Cavour (del 4 gennaio 1861) pubblicata da A.
Luzio nella Nuova Antologia del 16 gennaio 1930 (I carteggi
cavouriani). Cavour, dopo aver esposto i suoi accordi con
l’emigrazione ungherese per la preparazione di un’insurrezione
in Ungheria e nei paesi slavi dell’Impero austriaco, cui avrebbe
seguito un attacco italiano per la liberazione delle Venezie,
continua: «Depuis lors deux événements ont profondément modifié
la situatìon. Les conférences de Varsovie et les concessions
successives de l’Empereur d’Autriche. Si, comme il est à
craindre, l’Empereur de Russie s’est montré disposé à Varsovie à
intervenir en Hongrie dans le cas où une insurrection éclaterait
dans ce pays, il est évident qu’un mouvement ne pourrait avoir
lieu avec chance de succès qu’autant que la France serait
disposée à s’opposer par la force à l’intervention Russe», ecc.
ecc. Questo articolo del Luzio è anche interessante perché
accenna alle mutilazioni subite dai documenti del Risorgimento
nelle pubblicazioni di storia e nelle raccolte di materiali. Il
Luzio doveva essere già all’Archivio di Stato di Torino (o
all’Archivio reale) quando fu perquisita l’abitazione del prof.
Bollea per la pubblicazione di lettere del D’Azeglio che pure
non importavano quistioni diplomatiche (si era in guerra proprio
contro l’Austria e la Germania). Sarebbe interessante sapere se
il Luzio protestò allora per la perquisizione e i sequestri o se
non fu lui a consigliarli alla questura di Torino.
Q6 §47 Passato e presente. Ricordare il libretto di un certo
Ghezzi o Ghersi forse Raoul? da me ricevuto alla fine del 23 o
agli inizi del 24 (stampato a Torino) in cui si difendeva
l’atteggiamento di Agnelli specialmente, ma anche di altri
industriali nel 21‑22, si spiegava l’organizzazione finanziaria
della «Stampa» e della «Gazzetta del Popolo» ecc. Era scritto
molto male letterariamente ma conteneva alcuni dati interessanti
sulla organizzazione della vita industriale torinese.
Q6 §48 Ritratto del contadino italiano. Cfr Fiabe e leggende popolari del Pitré (p. 207), una novellina popolare siciliana, alla quale (secondo D. Bulferetti nella «Fiera Letteraria» del 29 gennaio 1928) corrisponde una xilografia di vecchie stampe veneziane, in cui si vede Iddio impartire dal cielo questi ordini: al papa: tu prega, all’imperatore: tu proteggi, al contadino: e tu affatica.
Lo spirito delle novelline popolari dà la concezione che di se stesso e della sua posizione nel mondo il contadino si è rassegnato ad assorbire dalla religione.
Q6 §49 Americanismo. Ancora Babbitt. Il piccolo borghese europeo ride di Babbitt e quindi ride dell’America, che sarebbe popolata di 120 milioni di Babbitt. Il piccolo borghese non può uscire da se stesso, comprendere se stesso come l’imbecille non può comprendere di essere imbecille (senza dimostrare con ciò di essere un uomo intelligente) per cui sono imbecilli quelli che non sanno di esserlo e sono piccoli borghesi i filistei che non sanno di esserlo. Il piccolo borghese europeo ride del particolare filisteismo americano, ma non si accorge del proprio, non sa di essere il Babbitt europeo, inferiore al Babbitt del romanzo del Lewis, in quanto questo cerca di evadere, di non essere più Babbitt; il Babbitt europeo non lotta col suo filisteismo ma ci si crogiola e crede che il suo verso, e il suo qua‑qua da ranocchio infisso nel pantano sia un canto da usignolo. Nonostante tutto, Babbitt è il filisteo di un paese in movimento, il piccolo borghese europeo è il filisteo di paesi conservatori, che imputridiscono nella palude stagnante del luogo comune della grande tradizione e della grande cultura. Il filisteo europeo crede di aver scoperto l’America con Cristoforo Colombo e che Babbitt sia un pupazzo per il suo divertimento di uomo gravato da millenni di storia. Intanto nessuno scrittore europeo è stato capace di rappresentarci il Babbitt europeo, cioè di dimostrarsi capace di autocritica: appunto è imbecille e filisteo solo chi sa di non esserlo.
Q6 §50 Machiavelli. Fortuna «pratica» di Machiavelli: Carlo V lo studiava. Enrico IV. Sisto V ne fece un sunto. Caterina de’ Medici lo portò in Francia e se ne ispirò forse per la lotta contro gli Ugonotti e la strage di S. Bartolomeo. Richelieu, ecc. Cioè Machiavelli servì realmente gli Stati assoluti nella loro formazione, perché era stato l’espressione della «filosofia dell’epoca» europea più che italiana.
Q6 §51 L’assedio di Firenze del 1529‑30. Rappresenta la conclusione della lotta tra fase corporativa‑economica della storia di Firenze e Stato moderno (relativamente). Le polemiche tra gli storici a proposito del significato dell’assedio (cfr polemica tra Antonio Panella e Aldo Valori, conclusa con la capitolazione scientifica del Valori, nel «Marzocco» e la sua meschina «vendetta» giornalistica nella «Critica Fascista»: della polemica accennerò in seguito) dipendono dal non saper apprezzare queste due fasi e ciò per la retorica sul Comune medioevale: che Maramaldo possa essere stato rappresentante del progresso storico e Ferrucci storicamente un retrivo, può spiacere moralmente, ma storicamente può e deve essere sostenuto.
Q6 §52 Machiavelli. Machiavelli come figura di transizione tra lo Stato corporativo repubblicano e lo Stato monarchico assoluto. Non sa staccarsi dalla repubblica ma capisce che solo un monarca assoluto può risolvere i problemi dell’epoca. Questo dissidio tragico della personalità umana Machiavellica (dell’uomo Machiavelli) sarebbe da vedere.
Q6 §53 Nozioni enciclopediche. La vecchia massima inglese: «no representation without labour» ricordata da Augur (Britannia, quo vadis?, Nuova Antologia 16 gennaio 1930) per sostenere che bisognerebbe togliere il voto ai disoccupati per risolvere il problema della disoccupazione (cioè perché si formi un governo che riduca al minimo il fondo della disoccupazione): quando è stata praticata, da chi, come? e come la si intendeva?
Q6 §54 Su l’impero inglese. Funzione del re d’Inghilterra come nesso politico imperiale: cioè del Consiglio privato della Corona, e specialmente del Comitato giuridico del Consiglio privato, che non soltanto accoglie i reclami contro le decisioni delle Alte Corti dei Dominions, ma anche giudica le controversie tra i membri dello stesso Impero. Questo Comitato è il più forte legame organizzativo dell’Impero. Lo Stato libero d’Irlanda e l’Africa del Sud aspirano a sottrarsi al Comitato giuridico. Gli uomini politici responsabili non sanno come sostituirlo. Augur è favorevole alla massima libertà interna nell’Impero: chiunque può uscirne, ma ciò, secondo lui, dovrebbe anche voler dire che chiunque può domandare di entrarvi: egli prevede che il Commonwealth può diventare un organismo mondiale dopo però che siano chiarite le relazioni dell’Inghilterra con gli altri paesi, e specialmente con gli Stati Uniti (Augur sostiene l’egemonia inglese nell’Impero, dell’Inghilterra propriamente detta, data, anche in regime di uguaglianza, dal peso economico e culturale).
Q6 §55 Passato e presente. Arturo Calza, il «Farmacista» del «Giornale d’Italia» con Bergamini e Vettori. Cominciò a scrivere nella Nuova Antologia con lo pseudonimo di Diogene Laerzio le sue melense e zuppificatrici; poi apparve il suo nome vero di Arturo Calza. Nella Nuova Antologia del 1° febbraio 1930 scrisse una delle solite tetramente sciocche: La «questione dei giovani» e il manifesto dell’«Universalismo»; fu attaccato da «Critica fascista» che ricordò il suo passato bergaminiano e il sen. Tittoni pensò bene di disfarsene sui due piedi. La rubrica almeno fu abolita, sostituita da brevi riassunti di articoli di rivista che per la scempiaggine potrebbero essere anche scritti dal Calza: sono firmati XXX, ma forse sono dovuti al Marchetti‑Ferranti.
(Il Calza scrisse l’ultima nota nella Nuova Antologia del 16 febbraio seguente: vedere quando apparve l’attacco della «Critica Fascista»).
Q6 §56 I nipotini di padre Bresciani. Filippo Crispolti. Ho già notato in altro paragrafo come il Crispolti non esiti a porre se stesso come paradigma per giudicare il dolore del Leopardi. Nel suo articolo Ombre di romanzi manzoniani il Manzoni diventa paradigma per autogiudicare il romanzo effettivamente scritto dal Crispolti Il duello e un altro romanzo Pio X che poi non fu scritto. L’arroganza del Crispolti è persino ridicola: i Promessi sposi trattano di un «impedimento brutale ad un matrimonio», il Duello del Crispolti tratta del duello; ambedue si riferiscono al dissidio che esiste nella società tra l’adesione al Vangelo che condanna la violenza, e l’uso brutale della violenza. C’è una differenza tra il Manzoni e il Crispolti; il Manzoni proveniva dal giansenismo, il Crispolti è un gesuita laico; il Manzoni era un liberale e un democratico del cattolicesimo (sebbene di tipo aristocratico) ed era favorevole alla caduta del potere temporale; il Crispolti era un reazionario nerissimo e lo è rimasto; se si staccò dagli intransigenti papalini e accettò di essere senatore è stato solo perché voleva che i cattolici diventassero il partito ultradestro della nazione.
È interessante la trama del romanzo non scritto Pio X solo perché riferisce alcune difficoltà obbiettive che si presentano nella convivenza a Roma di due potenze come la monarchia e il papa, riconosciuto come sovrano già dalle guarentigie. Ogni uscita del papa dal Vaticano per attraversare Roma domanda: 1) ingenti spese statali per l’apparato d’onore dovuto al papa; 2) è una minaccia di guerra civile perché bisogna obbligare i partiti progressivi a non fare dimostrazioni e implicitamente pone la quistione se questi partiti possano mai andare al potere col loro programma, cioè interferisce sulla sovranità dello Stato sinistramente.
Q6 §57 Poesia così detta sociale italiana. Rapisardi. Cfr l’articolo molto interessante di Nunzio Vaccalluzzo La poesia di Mario Rapisardi nella Nuova Antologia del 16 febbraio 1930. Il Rapisardi fu fatto passare per materialista e anzi per materialista storico. È ciò vero? O non piuttosto fu egli un «mistico» del naturalismo e del panteismo? Però legato al popolo, specialmente al popolo siciliano, alle miserie del contadino siciliano ecc.
L’articolo del Vaccalluzzo può servire per iniziare uno studio sul Rapisardi anche per le indicazioni che dà. Procurarsi un prospetto delle opere del Rapisardi, ecc. Importa specialmente la raccolta Giustizia che, dice il Vaccalluzzo, l’aveva cantata come poeta proletario (!), «più con veemenza di parole che di sentimento»: ma appunto questa Giustizia è poesia da democratico‑contadino, secondo i miei ricordi.
Q6 §58 Storia del giornalismo italiano. Quali giornali italiani
hanno pubblicato supplementi del tipo dei giornali inglesi e di
quelli tedeschi? L’esempio classico è il «Fanfulla della
Domenica» del «Fanfulla», e dico classico perché il supplemento
aveva una sua personalità e autorità propria. I tipi di
supplemento come la «Domenica del Corriere» o la «Tribuna
illustrata» sono un’altra cosa e a mala pena si possono chiamare
supplementi. La «Gazzetta del Popolo» fece dei tentativi di
«pagine» dedicate a un solo argomento ed ebbe la «Gazzetta
letteraria» ed oggi l’«Illustrazione del Popolo». Il tentativo
più organico fu fatto dal «Tempo» di Roma nel 1919‑20 con veri e
propri supplementi come quello «economico» e quello «sindacale»,
per l’Italia assai bene riuscito. Così ha avuto fortuna il
«Giornale d’Italia agricolo». Un quotidiano ben fatto e che
tenda a introdursi attraverso i supplementi anche dove
difficilmente penetrerebbe come quotidiano dovrebbe avere una
serie di supplementi mensili, di formato diverso da quello del
quotidiano ma col titolo del quotidiano seguito dalla speciale
materia che vuole trattare.
I supplementi principali dovrebbero essere almeno: 1) letterario, 2) economico industriale sindacale, 3) agricolo. Nel letterario dovrebbe essere trattata anche la filosofia, l’arte, il teatro. Il più difficile da farsi è quello agrario: tecnico‑agrario o politico agrario per i contadini più intelligenti? Questo secondo tipo dovrebbe avvicinarsi a un settimanale politico, cioè riassumere tutta la politica della settimana e in più avere una parte specificatamente agricola (non del tipo della «Domenica dell’Agricoltore»): sarebbe agricolo solo nel senso principale che è destinato ai contadini che non leggono i quotidiani, quindi tipo «Amico delle famiglie» più parte tecnica agricola più popolare. Supplemento sportivo ecc.
Il supplemento letterario dovrebbe avere anche la parte scolastica, ecc. Tutto di diverso formato, secondo il contenuto, e mensili. (Il letterario come l’«Ordine Nuovo» settimanale ecc., agrario come «Amico delle famiglie», economico come «Times» letterario ecc.),
Q6 §59 Italia meridionale. Sull’abbondanza dei paglietta nell’Italia Meridionale ricordare l’aneddoto di Innocenzo XI che domandò al marchese di Carpio di fornirgli 30 000 maiali e ne ebbe la risposta che non era in grado di compiacerlo, ma che se a Sua Santità fosse accaduto di aver bisogno di 30 000 avvocati, era sempre al fatto di servirlo.
Q6 §60 Le quistioni navali. Differenza tra gli armamenti terrestri e quelli marittimi: quelli marittimi sono difficilmente nascondibili; ci possono essere fabbriche d’armi e munizioni segrete, non ci possono essere cantieri segreti né incrociatori fabbricati in segreto. La «visibilità», la possibilità di calcolare tutto il potenziale navale, fa nascere le quistioni di prestigio, cioè trova la sua massima espressione nella flotta di guerra, quindi le lotte per la parità tra due potenze. Esempio classico: Inghilterra e Stati Uniti. In ultima analisi la base della flotta, come di tutto l’apparato militare è posta nella potenzialità produttiva e in quella finanziaria dei vari paesi, ma le quistioni vengono poste su basi «razionalistiche». L’Inghilterra mette in vista la sua posizione insulare e la necessità vitale per lei di mantenere permanentemente i collegamenti con i domini per l’approvvigionamento della sua popolazione, mentre l’America è un continente che basta a se stesso, ha due oceani uniti dal canale di Panama ecc. Ma perché uno Stato dovrebbe rinunziare alle sue superiorità strategiche geografiche, se queste gli danno condizioni favorevoli per l’egemonia mondiale? Perché l’Inghilterra dovrebbe avere una certa egemonia su una serie di paesi, basata su certe sue tradizionali condizioni favorevoli di superiorità, se gli Stati Uniti possono essere superiori all’Inghilterra ed assorbirla con tutto l’Impero, se possibile? Non c’è nessuna «razionalità» in queste cose, ma solo quistioni di forza e la figura del sor Panera che vuole infilzare l’avversario acquiescente è ridicola in tutti i casi.
Q6 §61 Federico II. Cfr Raffaello Morghen, Il tramonto della potenza sveva e la più recente storiografia, Nuova Antologia del 16 marzo 1930. Riporta alcuni recenti dati bibliografici su Federico II. Dal punto di vista del «senso» della storia italiana esposto nei paragrafi sui comuni medioevali e sulla funzione cosmopolita degli intellettuali italiani è interessante il volumetto di Michelangelo Schipa Sicilia e l’Italia sotto Federico II, Napoli, Società Napoletana di storia patria, 1929. (Naturalmente se è vero che lo Schipa «sembra sdegnarsi» con i Comuni e col Papa che resistettero a Federico, ciò è antistorico, ma si dimostra come il Papa si opponesse all’unificazione dell’Italia e come i Comuni non uscissero dal Medioevo).
Il Morghen cade in altro errore quando scrive che al tempo delle lotte tra Federico e il Papato (i Comuni) «si protendono ansiosi e impazienti verso l’avvenire ecc.»; «è l’Italia la quale si appresta a dare al mondo una nuova civiltà essenzialmente laica e nazionale quanto più la precedente era stata universalistica e chiesastica».
Sarebbe difficile al Morghen giustificare questa affermazione in altro modo che citando dei libri come il Principe. Ma che i libri siano una nazione e non solamente un elemento di cultura, ci vuole molta retorica per sostenerlo.
Fu Federico II ancora legato al Medio Evo? Certamente. Ma è anche vero che se ne staccava: la sua lotta contro la Chiesa, la sua tolleranza religiosa, l’essersi servito di tre civiltà: ebraica, latina, araba, e aver cercato di amalgamarle lo pone fuori del Medio Evo. Era un uomo del suo tempo, ma egli davvero poteva fondare una società laica e nazionale e fu più italiano che tedesco, ecc. Il problema va veduto interamente e anche questo articolo del Morghen può servire.
Q6 §62 I nipotini di padre Bresciani. Il De Sanctis in qualche parte scrive che egli, prima di scrivere un saggio o fare una lezione su un canto di Dante, per esempio, leggeva parecchie volte ad alta voce il canto, lo studiava a memoria ecc. ecc. Ciò si ricorda per sostenere l’osservazione che l’elemento artistico di un’opera non può essere, eccettuate rare occasioni (e si vedrà quali), gustato a prima lettura, spesso neppure dai grandi specialisti come era il De Sanctis. La prima lettura dà solo la possibilità di introdursi nel mondo culturale e sentimentale dello scrittore, e neanche questo è sempre vero, specialmente per gli scrittori non contemporanei, il cui mondo culturale e sentimentale è diverso dall’attuale: una poesia di un cannibale sulla gioia di un lauto banchetto di carne umana, può essere concepita come bella, e domandare per essere artisticamente gustata, senza pregiudizi «extraestetici», un certo distacco psicologico dalla cultura odierna. Ma l’opera d’arte contiene anche altri elementi «storicistici» oltre al determinato mondo culturale e sentimentale, ed è il linguaggio, inteso non solo come espressione puramente verbale, quale può essere fotografato in un certo tempo e luogo dalla grammatica, ma come un insieme di immagini e modi di esprimersi che non rientrano nella grammatica. Questi elementi appaiono più chiaramente nelle altre arti.
La lingua giapponese appare subito diversa dalla lingua italiana, non così il linguaggio della pittura, della musica e delle arti figurative in genere: eppure esistono anche queste differenze di linguaggio ed esse sono tanto più appariscenti quanto più dalle manifestazioni artistiche degli artisti si scende alle manifestazioni artistiche del folklore in cui il linguaggio di queste arti è ridotto all’elemento più autoctono e primordiale (ricordare l’aneddoto del disegnatore che fa il profilo di un negro e gli altri negri scherniscono il ritrattato perché il pittore gli ha riprodotto «solo mezza faccia»). Esiste però, dal punto di vista culturale e storico, una grande differenza tra l’espressione linguistica della parola scritta e parlata e le espressioni linguistiche delle altre arti. Il linguaggio «letterario» è strettamente legato alla vita delle moltitudini nazionali e si sviluppa lentamente e solo molecolarmente; se si può dire che ogni gruppo sociale ha una sua «lingua», tuttavia occorre notare (salvo rare eccezioni) che tra la lingua popolare e quella delle classi colte c’è una continua aderenza e un continuo scambio. Ciò non avviene per i linguaggi delle altre arti, per i quali, si può notare che attualmente si verificano due ordini di fenomeni: 1) in essi sono sempre vivi, per lo meno in quantità enormemente maggiore che per la lingua letteraria, gli elementi espressivi del passato, si può dire di tutto il passato; 2) in essi si forma rapidamente una lingua cosmopolita che assorbe gli elementi tecnico‑espressivi di tutte le nazioni che volta per volta producono grandi pittori, scrittori, musicisti, ecc. Wagner ha dato alla musica elementi linguistici che tutta la letteratura tedesca non ha dato in tutta la sua storia, ecc. Ciò avviene perché il popolo partecipa scarsamente alla produzione di questi linguaggi, che sono propri di una élite internazionale ecc., mentre può abbastanza rapidamente (e come collettività, non come singoli) giungere alla loro comprensione. Tutto ciò per indicare che realmente il «gusto» puramente estetico, se può chiamarsi primario come forma e attività dello spirito, non è tale praticamente, in senso cronologico, cioè.
È stato detto da taluno (per esempio da Prezzolini, nel volumetto Mi pare…) che il teatro non può dirsi un’arte ma uno svago di carattere meccanicistico. Ciò perché gli spettatori non possono gustare esteticamente il dramma rappresentato, ma si interessano solo all’intrigo ecc. (o qualcosa di simile). L’osservazione è falsa nel senso che, nella rappresentazione teatrale, l’elemento artistico non è dato solo dal dramma nel senso letterario, il creatore non è solo lo scrittore: l’autore interviene nella rappresentazione teatrale con le parole e con le didascalie che limitano l’arbitrio dell’attore e del régisseur, ma realmente nella rappresentazione l’elemento letterario diventa occasione a nuove creazioni artistiche, che da complementari e critico‑interpretative stanno diventando sempre più importanti: l’interpretazione dell’autore singolo e il complesso scenico creato dal régisscur. È giusto però che solo la lettura ripetuta può far gustare il dramma così come l’autore l’ha prodotto.
La conclusione è questa: un’opera d’arte è tanto più «artisticamente» popolare quanto più il suo contenuto morale, culturale, sentimentale è aderente alla moralità, alla cultura, ai sentimenti nazionali, e non intesi come qualcosa di statico, ma come un’attività in continuo sviluppo. L’immediata presa di contatto tra lettore e scrittore avviene quando nel lettore l’unità di contenuto e forma ha la premessa di unità del mondo poetico e sentimentale: altrimenti il lettore deve incominciare a tradurre la «lingua» del contenuto nella sua propria lingua: si può dire che si forma la situazione come di uno che ha imparato l’inglese in un corso accelerato Berlitz e poi legge Shakespeare; la fatica della comprensione letterale, ottenuta con il continuo sussidio di un mediocre dizionario, riduce la lettura a un esercizio scolastico pedantesco e nulla più.
Q6 §63 Diritto romano o diritto bizantino? Il «diritto» romano consisteva essenzialmente in un metodo di creazione del diritto, nella risoluzione continua della casistica giurisprudenziale. I bizantini (Giustiniano) raccolsero la massa dei casi di diritto risolti dall’attività giuridica concreta dei Romani, non come documentazione storica, ma come codice ossificato e permanente. Questo passaggio da un «metodo» a un «codice» permanente può anche assumersi come la fine di un’età, il passaggio da una storia in continuo e rapido sviluppo, a una fase storica relativamente stagnante. La rinascita del «diritto romano», cioè, della codificazione bizantina del metodo romano di risolvere le quistioni di diritto, coincide con l’affiorare di un gruppo sociale che vuole una «legislazione» permanente, superiore agli arbitri dei magistrati (movimento che culmina nel «costituzionalismo») perché solo in un quadro permanente di «concordia discorde», di lotta entro una cornice legale che fissi i limiti dell’arbitrio individuale, può sviluppare le forze implicite nella sua funzione storica.
Q6 §64 I nipotini di padre Bresciani. «L’arte è educatrice in quanto arte, ma non in quanto arte educatrice», perché in tal caso è nulla, e il nulla non può educare. Certo, sembra che tutti concordemente desideriamo un’arte che somigli a quella del Risorgimento e non, per esempio, a quella del periodo dannunziano; ma, in verità, se ben si consideri, in questo desiderio non c’è il desiderio di un’arte a preferenza di un’altra, sì bene di una realtà morale a preferenza di un’altra. Allo stesso modo chi desideri che uno specchio rifletta una bella anziché una brutta persona, non si augura già uno specchio che sia diverso da quello che ha innanzi, ma una persona diversa». (Croce, Cultura e Vita morale, pp. 169‑70; cap. Fede e programmi del 1911).
«Quando un’opera di poesia o un ciclo di opere poetiche si è formato, è impossibile proseguire quel ciclo con lo studio e con l’imitazione e con le variazioni intorno a quelle opere; per questa via si ottiene solamente la cosiddetta scuola poetica, il servum pecus degli epigoni. Poesia non genera poesia; la partenogenesi non ha luogo; si richiede l’intervento dell’elemento maschile, di ciò che è reale, passionale, pratico, morale. I più alti critici di poesia ammoniscono, in questo caso, di non ricorrere a ricette letterarie, ma, com’essi dicono, di «rifare l’uomo». Rifatto l’uomo, rinfrescato lo spirito, sorta una nuova vita di affetti, da essa sorgerà, se sorgerà, una nuova poesia». (B. Croce, Cultura e Vita morale, pp. 241‑42; capitolo Troppa filosofia del 1922).
Questa osservazione può essere propria del materialismo storico. La letteratura non genera letteratura ecc., cioè le ideologie non creano ideologie, le superstrutture non generano superstrutture altro che come eredità di inerzia e di passività: esse sono generate, non per «partenogenesi» ma per l’intervento dell’elemento «maschile» – la storia – l’attività rivoluzionaria che crea il «nuovo uomo», cioè nuovi rapporti sociali.
Da ciò si deduce anche questo: che il vecchio «uomo», per il cambiamento, diventa anch’esso «nuovo», poiché entra in nuovi rapporti, essendo stati quelli primitivi capovolti. Donde il fatto che, prima che il «nuovo uomo» creato positivamente abbia dato poesia, si possa assistere al «canto del cigno» del vecchio uomo rinnovato negativamente: e spesso questo canto del cigno è di mirabile splendore; il nuovo vi si unisce al vecchio, le passioni vi si arroventano in modo incomparabile ecc. (Non è forse la Divina Commedia un po’ il canto del cigno medioevale, che pure anticipa i nuovi tempi e la nuova storia?)
Q6 §65 Giornalismo. Ciò che Napoleone III disse del giornalismo durante la sua prigionia in Germania al giornalista inglese Mels‑Cohn (cfr Paul Guériot, La captivité de Napoléon III en Allemagne, pp. 250, Parigi, Perrin). Napoleone avrebbe voluto fare del giornale ufficiale un foglio modello, da mandare gratuitamente a ogni elettore, con la collaborazione delle penne più illustri del tempo e con le informazioni più sicure e più controllate da ogni parte del mondo. La polemica, esclusa, sarebbe rimasta confinata nei giornali particolari ecc.
La concezione del giornale di Stato è logicamente legata alle strutture governative illiberali (cioè a quelle in cui la società civile si confonde con la società politica), siano esse dispotiche o democratiche (ossia in quelle in cui la minoranza oligarchica pretende essere tutta la società, o in quelle in cui il popolo indistinto pretende e crede di essere veramente lo Stato). Se la scuola è di Stato, perché non sarà di Stato anche il giornalismo, che è la scuola degli adulti?
Napoleone argomentava partendo dal concetto che se è vero l’assioma giuridico che l’ignoranza delle leggi non è scusa per l’imputabilità, lo Stato deve gratuitamente tenere informati i cittadini di tutta la sua attività, deve cioè educarli: argomento democratico che si trasforma in giustificazione dell’attività oligarchica. L’argomento però non è senza pregio: esso può essere «democratico» solo nelle società in cui la unità storica di società civile e società politica è intesa dialetticamente (nella dialettica reale e non solo concettuale) e lo Stato è concepito come superabile dalla «società regolata»: in questa società il partito dominante non si confonde organicamente col governo, ma è strumento per il passaggio dalla società civile‑politica alla «società regolata», in quanto assorbe in sé ambedue, per superarle (non per perpetuarne la contraddizione), ecc.
A proposito del regime giornalistico sotto Napoleone III, ricordare l’episodio del prefetto di polizia che ammonisce un giornale perché in un articolo sui concimi non era fissato risolutamente quale concime era il migliore: ciò, secondo il prefetto, contribuiva a lasciare nell’incertezza il pubblico ed era perciò biasimevole e degno di richiamo da parte della polizia.
Q6 §66 Machiavelli. Gino Arias, Il pensiero economico di Niccolò Machiavelli. (Negli «Annali di Economia» dell’Università Bocconi del 1928 (o 27?).
Q6 §67 Cultura italiana. Valentino Piccoli. Del Piccoli sarà utile ricordare la nota Un libro per gli immemori (nei «Libri del giorno» dell’ottobre 1928) in cui recensisce il libro di Mario Giampaoli 1919, (Roma‑Milano, Libreria del Littorio, in 16°, pp. 335 con 40 illustrazioni fuori testo, L. 15). Il Piccoli adopera per il Giampaoli gli stessi aggettivi che adopera per Dante, per Leopardi e per qualsiasi grande scrittore che egli passa il tempo a coprire delle sue allumacature. Ricorre spesso l’aggettivo «austero», ecc., «pagine d’antologia», ecc.
Q6 §68 Alfredo Oriani. Floriano Del Secolo, Contributo alla biografia di Oriani. Con lettere inedite, nel «Pègaso» dell’ottobre 1930.
Appare l’Oriani nella così detta «tragedia» della sua vita intellettuale di «genio» incompreso dal pubblico nazionale, di apostolo senza seguaci ecc. Ma fu poi Oriani «incompreso», o si trattava di una sfinge senza enigmi, di un vulcano che eruttava solo topolini? E adesso è Oriani diventato «popolare», «maestro di vita», ecc.? Molto si pubblica su di lui, ma l’edizione nazionale delle sue opere è comprata e letta? C’è da dubitarne. Oriani e Sorel (in Francia). Ma Sorel è stato enormemente più attuale di Oriani. Perché Oriani non riuscì a formarsi una scuola, un gruppo di discepoli, perché non organizzò una rivista? Voleva essere «riconosciuto» senza sforzo da parte sua (oltre ai lamenti presso gli amici più intimi). Mancava di volontà, di attitudini pratiche, e voleva influire sulla vita politica e morale della nazione. Ciò che lo rendeva antipatico a molti doveva essere appunto questo giudizio istintivo che si trattava di un velleitario che voleva essere pagato prima d’aver compiuto l’opera, che voleva esser riconosciuto «genio», «capo», «maestro», per un diritto divino da lui affermato perentoriamente. Certo Oriani deve essere avvicinato al Crispi come psicologia e a tutto uno strato di intellettuali italiani, che, in certi rappresentanti più bassi, cade nel ridicolo e nella farsa intellettuale.
Q6 §69 Caporetto. Sul libro del Volpe Ottobre 1917. Dall’Isonzo al Piave, cfr la recensione di Antonio Panella nel «Pègaso» dell’ottobre 1930. La recensione è benevola ma superficiale. Caporetto fu essenzialmente un «infortunio militare»; che il Volpe abbia dato, con tutta la sua autorità di storico e di uomo politico, a questa formula il valore di un luogo comune soddisfa molta gente che sentiva tutta l’insufficienza storica e morale (l’abbiezione morale) della polemica su Caporetto come «crimine» dei disfattisti o come «sciopero militare». Ma è troppa la compiacenza per la validità di questo nuovo luogo comune, perché non debba esserci una reazione, che d’altronde è più difficile di quella al precedente luogo comune, come appare dalla critica fatta dall’Omodeo al libro del Volpe. «Assolti» i soldati, la massa militare esecutiva e strumentale («l’outil tactique élémentaire» come Anatole France fa dire a un generale dei soldati), si sente che il processo non è finito: la polemica tra il Volpe e l’Omodeo sugli «ufficiali di complemento» è interessante come indizio. Pare, dall’Omodeo, che il Volpe misconosca l’apporto bellico degli ufficiali di complemento, cioè della piccola borghesia intellettuale e quindi indirettamente indichi questa come responsabile dell’«infortunio», pur di salvare la classe superiore, che è già messa al sicuro dalla parola «infortunio». La responsabilità storica deve essere cercata nei rapporti generali di classe in cui soldati, ufficiali di complemento e stati maggiori occupano una posizione determinata, quindi nella struttura nazionale, di cui sola responsabile è la classe dirigente appunto perché dirigente (vale anche qui l’«ubi maior, minor cessat»). Ma questa critica, che sarebbe veramente feconda, anche dal punto di vista nazionale, brucia le dita.
Q6 §70 Risorgimento. Niccolò Rodolico, La prima giovinezza di Carlo Alberto, nel «Pègaso» del novembre 1930. (Del Rodolico è annunziato, presso il Le Monnier, un libro su Carlo Alberto Principe di Carignano, del quale l’articolo di «Pègaso» è forse un estratto). Da studiare l’elaborazione, che avviene nella classe politica piemontese, durante l’impero napoleonico, ma specialmente dopo la sua caduta, del gruppo che si stacca dai conservatori municipalisti per indicare alla dinastia un compito di unificazione nazionale, gruppo che avrà la sua massima estrinsecazione nei neoguelfi del 48. Carattere dinastico e non nazionale di questo nuovo gruppo (di cui il De Maistre è elemento volissimo): politica furbesca, più che machiavellica, di esso, che però diventerà la politica prevalente dei dirigenti fino al 70 e anche dopo: sua debolezza organica che si mostra specialmente nel nodo 48‑49 e che è legata a questa politica di furberia meschina e angusta.
Q6 §71 Linguistica. Antonio Pagliaro, Sommario di linguistica arioeuropea. Fasc. I: Cenni storici e quistioni teoriche, Libreria di Scienze e Lettere del dott. G. Bardi, Roma, 1930 (nelle «Pubblicazioni della Scuola di Filologia Classica dell’Università di Roma, Serie seconda: Sussidi e materiali, II, I»). Sul libro del Pagliaro cfr la recensione di Goffredo Coppola nel «Pègaso» del novembre 1930.
Il libro è indispensabile per vedere i progressi fatti dalla linguistica in questi ultimi tempi. Mi pare ci sia molto di cambiato (a giudicare dalla recensione) ma che tuttavia non sia stata trovata la base in cui collocare gli studi linguistici. L’identificazione di arte e lingua, fatta dal Croce ha permesso un certo progresso e ha permesso di risolvere alcuni problemi e di dichiararne altri inesistenti o arbitrari, ma i linguisti, che sono essenzialmente storici, si trovano dinanzi l’altro problema: è possibile la storia delle lingue all’infuori della storia dell’arte e ancora è possibile la storia dell’arte?
Ma i linguisti precisamente studiano le lingue in quanto non sono arte, ma «materiale» dell’arte, in quanto prodotto sociale, in quanto espressione culturale di un dato popolo ecc. Queste quistioni non sono risolte, o lo sono con un ritorno alla vecchia rettorica rimbellettata (cfr Bertoni).
Per il Perrotto (anche per il Pagliaro?), l’identificazione tra arte e lingua ha condotto a riconoscere come insolubile (o arbitrario?) il problema dell’origine del linguaggio, che significherebbe domandarsi perché l’uomo è uomo (linguaggio = fantasia, pensiero): mi pare che non sia molto preciso; il problema non può risolversi per mancanza di documenti e quindi è arbitrario: si può fare, oltre un certo limite storico, della storia ipotetica, congetturale e sociologica, ma non storia «storica». Questa identificazione permetterebbe anche di determinare ciò che nella lingua è errore, cioè non lingua. «Errore è la creazione artificiale, razionalistica, voluta, che non s’afferma perché nulla rivela, che è particolare all’individuo fuori della sua società». Mi pare che allora si dovrebbe dire che lingua = storia e non lingua = arbitrio. Le lingue artificiali sono come i gerghi: non è vero che siano assolutamente non lingue perché sono in qualche modo utili: hanno un contenuto storico‑sociale molto limitato. Ma ciò avviene anche tra dialetto e lingua nazionale‑letteraria. Eppure anche il dialetto è lingua‑arte.
Ma tra il dialetto e la lingua nazionale‑letteraria qualcosa è mutato: precisamente l’ambiente culturale, politico‑morale‑sentimentale. La storia delle lingue è storia delle innovazioni linguistiche, ma queste innovazioni non sono individuali (come avviene nell’arte) ma sono di un’intera comunità sociale che ha innovato la sua cultura, che ha «progredito» storicamente: naturalmente anch’esse diventano individuali, ma non dell’individuo‑artista, dell’individuo ‑ elemento storico‑culturale completo determinato.
Anche nella lingua non c’è partenogenesi, cioè la lingua che produce altra lingua, ma c’è innovazione per interferenze di culture diverse ecc., ciò che avviene in modi molto diversi e ancora avviene per intere masse di elementi linguistici, e avviene molecolarmente (per esempio: il latino ha come «massa» innovato il celtico delle Gallie, e ha invece influenzato il germanico «molecolarmente», cioè imprestandogli singole parole o forme ecc.). L’interferenza e l’influenza «molecolare» può avvenire nello stesso seno di una nazione, tra diversi strati ecc.; una nuova classe che diventa dirigente innova come «massa»; il gergo dei mestieri ecc. cioè delle società particolari, innovano molecolarmente. Il giudizio artistico in queste innovazioni ha il carattere del «gusto culturale», non del gusto artistico, cioè per la stessa ragione per cui piacciono le brune o le bionde e mutano gli «ideali» estetici, legati a determinate culture.
Q6 §72 Risorgimento. Su Melchiorre Gioia cfr la bibliografia (degli scritti del Gioia) pubblicata da Angelo Ottolini nei «Libri del Giorno» del gennaio 1929 (Il centenario di Melchiorre Gioia). Il primo libro del Gioia è una dissertazione del 1796 presentata a un concorso bandito dall’Istituto della Repubblica Cisalpina sul quesito «Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità dell’Italia». Il Gioia sostiene «la repubblica una e indivisibile»; la sua dissertazione fu premiata, ma bisognerebbe vedere in quanto essa è solo una elaborazione puramente ideologica della formula giacobina. Nel 1815 pubblica Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa.
Q6 §73 I nipotini di padre Bresciani. Cfr l’articolo Dell’interesse di Carlo Linati nei «Libri del giorno» del febbraio 1929. Il Linati si domanda in che consista quel «quid» per cui i libri interessano e finisce col non trovare una risposta. Ed è certo che una risposta precisa non si può trovare, nel senso almeno che intende il Linati, il quale vorrebbe trovare il «quid» per essere in grado o per mettere gli altri in grado di scrivere libri interessanti. Il Linati dice che il problema in questi ultimi tempi è diventato «scottante» ed è vero, come è naturale che sia. C’è stato un certo risveglio di sentimenti nazionalistici: è spiegabile che si ponga il problema del perché i libri italiani non siano letti, del perché essi siano ritenuti «noiosi» e «interessanti» invece quelli stranieri, ecc. Il risveglio nazionalistico fa sentire che la letteratura italiana non è «nazionale» nel senso che non è popolare e che si subisce come popolo l’egemonia straniera. Onde programmi, polemiche, tentativi, che non riescono però in nulla. Sarebbe necessaria una critica spietata della tradizione e un rinnovamento culturale‑morale da cui dovrebbe nascere una nuova letteratura. Ma ciò appunto non può avvenire per la contraddizione ecc.: risveglio nazionalistico ha assunto il significato di esaltazione del passato. Marinetti è diventato accademico e lotta contro la tradizione della pastasciutta.
Q6 §74 Caporetto. Cfr il libro del gen. Alberto Baldini sul generale Diaz (Diaz, in 8°, pp. 263, Barbèra ed., L. 15, 1929). Il generale Baldini pare critichi implicitamente Cadorna e cerchi di dimostrare che Diaz ebbe una importanza molto maggiore di quanto non gli sia riconosciuta.
In questa polemica sul significato di Caporetto bisognerebbe fissare alcuni punti chiari e precisi:
1) Caporetto fu un fatto puramente militare? Questa spiegazione pare ormai acquisita agli storici della guerra, ma essa è basata su un equivoco. Ogni fatto militare è anche un fatto politico e sociale. Subito dopo la sconfitta si cercò di diffondere la convinzione che le responsabilità politiche di Caporetto fossero da ricercare nella massa militare, cioè nel popolo e nei partiti che ne erano l’espressione politica. Questa tesi è oggi universalmente respinta, anche ufficialmente. Ma ciò non vuol dire che Caporetto perciò solo diventi puramente militare, come si tende a far credere, come se fattore politico fosse solo il popolo, cioè i responsabili della gestione politico‑militare. Anche se fosse dimostrato (come invece si esclude universalmente) che Caporetto sia stato uno «sciopero militare», ciò non vorrebbe dire che la responsabilità politica debba essere accollata al popolo ecc. (dal punto di vista giudiziario può spiegarsi, ma il punto di vista giudiziario è un atto di volontà unilaterale tendente a integrare col terrorismo l’insufficienza governativa): storicamente, cioè dal punto di vista politico più alto, la responsabilità sarebbe sempre dei governanti, e della loro incapacità a prevedere che determinati fatti avrebbero potuto portare allo sciopero militare e quindi a provvedere a tempo, con misure adeguate (sacrifici di classe) a impedire una tale possibile emergenza. Che ai fini immediati di psicologia della resistenza, in caso di forza maggiore, si affermi che «occorre rompere i reticolati coi denti» è comprensibile, ma che si abbia la convinzione che in ogni caso i soldati debbano rompere i reticolati coi denti, perché così vuole l’astratto dovere militare, e si trascuri di provvederli delle tenaglie, è criminoso. Che si abbia la convinzione che la guerra non si fa senza vittime umane è comprensibile, ma che non si tenga conto che le vite umane non debbono essere sacrificate inutilmente, è criminoso ecc. Questo principio, dal rapporto militare si estende al rapporto sociale. Che si abbia la convinzione, e la si sostenga senza limitazioni, che la massa militare debba fare la guerra e sopportarne tutti i sacrifizi, è comprensibile, ma che si ritenga che ciò avverrà in ogni caso senza tener conto del carattere sociale della massa militare e senza venire incontro alle esigenze di questo carattere, è da semplicioni, cioè da politici incapaci.
2) Così la responsabilità, se è esclusa quella della massa militare, non può neanche essere del capo supremo, cioè di Cadorna, oltre certi limiti, cioè oltre i limiti segnati dalle possibilità di un capo supremo, della tecnica militare, e delle attribuzioni politiche che un capo supremo ha in ogni caso. Cadorna ha avuto gravi responsabilità, certamente, sia tecniche che politiche, ma queste ultime non possono essere state decisive. Se Cadorna non ha capito la necessità di un «governo politico determinato» delle masse comandate e non le ha esposte al governo, è certo responsabile, ma non quanto il governo e in generale quanto la classe dirigente, di cui, in ultima analisi, ha espresso la mentalità e la comprensione politica. Il fatto che non ci sia stata una analisi obbiettiva dei fattori che hanno determinato Caporetto e un’azione concreta per eliminarli, dimostra «storicamente» questa responsabilità estesa.
3) L’importanza di Caporetto nel decorso dell’intera guerra. La tendenza attuale tende a diminuire il significato di Caporetto e a farne un semplice episodio del quadro generale. Questa tendenza ha un significato politico e avrà delle ripercussioni politiche nazionali e internazionali: dimostra che non si vogliono eliminare i fattori generali che hanno determinato la sconfitta, ciò che ha un peso nel regime delle alleanze e nelle condizioni che saranno fatte al paese nel caso di una nuova combinazione bellica, poiché le critiche di se stessi che non si vogliono fare nel campo nazionale per evitare determinate conseguenze necessarie all’indirizzo politico‑sociale, saranno fatte indubbiamente dagli organismi responsabili degli altri paesi in quanto l’Italia è presunta poter far parte di alleanze belliche. Gli altri paesi, nei calcoli in vista di alleanze, dovranno tener conto di nuovi Caporetto e vorranno dei premi di assicurazione, cioè vorranno l’egemonia anche oltre certi limiti.
4) L’importanza di Caporetto nel quadro della guerra mondiale. È data anche dai mezzi forniti al nemico (tutti i magazzini di viveri e di munizioni ecc.) che permisero una più lunga resistenza, e la necessità imposta agli alleati di ricostituire questi depositi con turbamento di tutti i servizi e piani generali.
È vero che in tutte le guerre e anche in quella mondiale, si ebbero altri fatti simili a Caporetto. Ma occorre vedere (all’infuori della Russia) se ebbero la stessa importanza assoluta e relativa, se ebbero cause simili o paragonabili, se ebbero conseguenze simili o paragonabili per la posizione politica del paese il cui esercito subì la sconfitta. Dopo Caporetto l’Italia, materialmente (per gli armamenti, per gli approvvigionamenti, ecc.) cadde in balia degli alleati, la cui attrezzatura economica non era paragonabile per efficienza. L’assenza di autocritica significa non volontà di eliminare le cause del male ed è quindi un sintomo di grave debolezza politica.
Q6 §75 Passato e presente. Dovrebbe essere una massima di governo cercare di elevare il livello della vita materiale del popolo oltre un certo livello. In questo indirizzo non è da ricercare uno speciale motivo «umanitario» e neppure una tendenza «democratica»: anche il governo più oligarchico e reazionario dovrebbe riconoscere la validità «obbiettiva» di questa massima, cioè il suo valore essenzialmente politico (universale nella sfera della politica, nell’arte di conservare e accrescere la potenza dello Stato). Ogni governo non può prescindere dall’ipotesi di una crisi economica e specialmente non può prescindere dall’ipotesi di essere costretto a fare una guerra, cioè a dover superare la massima crisi cui può essere sottoposta una compagine statale e sociale. E poiché ogni crisi significa un arretramento del tenore di vita popolare, è evidente che occorre la preesistenza di una zona di arretramento sufficiente perché la resistenza «biologica» e quindi psicologica del popolo non crolli al primo urto con la nuova realtà. Il grado di potenza reale di uno Stato deve essere pertanto misurato anche alla stregua di questo elemento, che è poi coordinato agli altri elementi di giudizio sulla solidità strutturale di un paese. Se infatti le classi dominanti di una nazione non sono riuscite a superare la fase economica‑corporativa che le porta a sfruttare le masse popolari fino all’estremo consentito dalle condizioni di forza, cioè a ridurle solo alla vegetatività biologica, è evidente che non si può parlare di potenza dello Stato, ma solo di mascheratura di potenza. Mi pare sia importante in questo esame di un punto essenziale di arte politica evitare sistematicamente ogni accenno extrapolitico (in senso tecnico, cioè fuori della sfera tecnicamente politica), cioè umanitario, o di una determinata ideologia politica (non perché l’«umanitarismo» non sia anch’esso una politica, ecc.). Per questo paragrafo è indispensabile ricorrere all’articolo del prof. Mario Camis pubblicato nel fascicolo gennaio‑febbraio della «Riforma Sociale» del 1926.
Q6 §76 La funzione europea dello zarismo nel secolo XIX . Il principe di Bülow nelle sue Memorie racconta di essersi trovato da Bethmann‑Holwegg subito dopo la dichiarazione di guerra della Germania alla Russia nell’agosto 1914. Bethmann, interrogato perché avesse cominciato dal dichiarare la guerra alla Russia, rispose: «Per aver subito dalla mia parte i socialdemocratici». Bülow fa a questo proposito alcune osservazioni sulla psicologia di Bethmann‑Holwegg, ma ciò che importa dal punto di vista di questa rubrica è la sicurezza del Cancelliere di poter avere dalla sua parte la socialdemocrazia contro lo zarismo russo; il Cancelliere sfruttava abilmente la tradizione del 48, ecc., del «gendarme d’Europa».
Q6 §77 Individui e nazioni. A proposito della quistione delle glorie nazionali legate alle invenzioni di singoli individui geniali, le cui scoperte e invenzioni non hanno però avuto applicazione o riconoscimento nel paese d’origine si può ancora osservare: che le invenzioni e le scoperte possono essere e sono spesso infatti casuali, non solo, ma che i singoli inventori possono essere legati a correnti culturali e scientifiche che hanno avuto origine e sviluppo in altri paesi, presso altre nazioni. Perciò una invenzione o scoperta perde il carattere individuale e casuale e può essere giudicata nazionale quando: l’individuo è strettamente e necessariamente collegato a una organizzazione di cultura che ha caratteri nazionali o quando l’invenzione è approfondita, applicata, sviluppata in tutte le sue possibilità dall’organizzazione culturale della nazione d’origine. Fuori di queste condizioni non rimane che l’elemento «razza» cioè una entità imponderabile e che d’altronde può essere rivendicato da tutti i paesi e che in ultima analisi si confonde con la così detta «natura umana». Si può dunque chiamare nazionale l’individuo che è conseguenza della realtà concreta nazionale e che inizia una fase determinata dell’operosità pratica o teorica nazionale. Bisognerebbe poi mettere in luce che una nuova scoperta che rimane cosa inerte non è un valore: l’«originalità» consiste tanto nello «scoprire» quanto nell’«approfondire» e nello «sviluppare» e nel «socializzare», cioè nel trasformare in elemento di civiltà universale: ma appunto in queti campi si manifesta l’energia nazionale, che è collettiva, che è l’insieme dei rapporti interni di una nazione.
Q6 §78 Il Risorgimento italiano. Quando si deve porre l’inizio del movimento storico che ha preso il nome di Risorgimento italiano? Le risposte sono diverse e contradditorie, ma in generale esse si raggruppano in due serie: 1) di quelli che vogliono sostenere l’origine autonoma del movimento nazionale italiano e addirittura sostengono che la Rivoluzione francese ha falsificato la tradizione italiana e l’ha deviata; 2) e di quelli che sostengono che il movimento nazionale italiano è strettamente dipendente dalla Rivoluzione francese e dalle sue guerre.
La quistione storica è turbata da interferenze sentimentali e politiche e da pregiudizi di ogni genere. È già difficile far capire al senso comune che un’Italia come quella che si è formata nel 70 non era mai esistita prima e non poteva esistere: il senso comune è portato a credere che ciò che oggi esiste sia sempre esistito e che l’Italia sia sempre esistita come nazione unitaria, ma sia stata soffocata da forze estranee, ecc. Numerose ideologie hanno contribuito a rafforzare questa credenza, alimentata dal desiderio di apparire eredi del mondo antico, ecc.; queste ideologie, d’altronde, hanno avuto un ufficio notevole come terreno di organizzazione politica e culturale, ecc.
Mi pare che bisognerebbe analizzare tutto il movimento storico partendo da diversi punti di vista, fino al momento in cui gli elementi essenziali dell’unità nazionale si unificano e diventano una forza sufficiente per raggiungere lo scopo, ciò che mi pare avvenga solo dopo il 48. Questi elementi sono negativi (passivi) e positivi (attivi), nazionali e internazionali. Un elemento abbastanza antico è la coscienza dell’«unità culturale», che è esistita fra gli intellettuali italiani almeno dal 1200 in poi, cioè da quando si è sviluppata una lingua letteraria unificata (il volgare illustre di Dante): ma è questo un elemento senza efficacia diretta sugli avvenimenti storici, sebbene sia il più sfruttato dalla retorica patriottica, né d’altronde esso coincide o è l’espressione di un sentimento nazionale concreto e operante. Altro elemento è la coscienza della necessità dell’indipendenza della penisola italiana dall’influenza straniera, molto meno diffuso del primo, ma certo politicamente più importante e storicamente più fecondo di risultati pratici; ma anche di questo elemento non deve essere esagerata l’importanza e il significato e specialmente la diffusione e la profondità. Questi due elementi sono proprii di piccole minoranze di grandi intellettuali, e mai si sono manifestati come espressione di una diffusa e compatta coscienza nazionale unitaria.
Condizioni per l’unità nazionale: 1) esistenza di un certo equilibrio delle forze internazionali che fosse la premessa della unità italiana. Ciò si verificò dopo il 1748, dopo cioè la caduta della egemonia francese e l’esclusione assoluta dell’egemonia spagnola austriaca, ma sparì nuovamente dopo il 1815: tuttavia il periodo dal 1748 al 1815 ebbe una grande importanza nella preparazione dell’unità, o meglio per lo sviluppo degli elementi che dovevano condurre all’unità. Tra gli elementi internazionali occorre considerare la posizione del papato, la cui forza nell’ambito italiano era legata alla forza internazionale: il regalismo e il giuseppinismo, cioè la prima affermazione liberale e laica dello Stato, sono elementi essenziali per la preparazione dell’unità. Da elemento negativo e passivo, la situazione internazionale diventa elemento attivo dopo la Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, che allargano l’interesse politico e nazionale alla piccola borghesia e ai piccoli intellettuali, che danno una certa esperienza militare e creano un certo numero di ufficiali italiani. La formula: «repubblica una e indivisibile» acquista una certa popolarità e, nonostante tutto, il partito d’azione ha origine dalla Rivoluzione francese e dalle sue ripercussioni in Italia; questa formula si adatta in «Stato unico e indivisibile», in monarchia unica e indivisibile, accentrata ecc.
L’unità nazionale ha avuto un certo sviluppo e non un altro e di questo sviluppo fu motore lo Stato piemontese e la dinastia Savoia. Occorre perciò vedere quale sia stato lo svolgimento storico in Piemonte dal punto di vista nazionale. Il Piemonte aveva avuto interesse dal 1492 in poi (cioè nel periodo delle preponderanze straniere) a che ci fosse un certo equilibrio interno fra gli Stati italiani, come premessa dell’indipendenza (cioè del non‑influsso dei grandi Stati stranieri): naturalmente lo Stato piemontese avrebbe voluto essere l’egemone in Italia, almeno nell’Italia settentrionale e centrale, ma non riuscì: troppo forte era Venezia, ecc.
Lo Stato piemontese diventa motore reale dell’unità dopo il 48, dopo cioè la sconfitta della destra e del centro politico piemontese e l’avvento dei liberali con Cavour. La destra: Solaro della Margarita, cioè i «nazionalisti piemontesi esclusivisti» o municipalisti (l’espressione «municipalismo» dipende dalla concezione di una unità italiana latente e reale, secondo la retorica patriottica); il centro: Gioberti e i neoguelfi. Ma i liberali di Cavour non sono dei giacobini nazionali: essi in realtà superano la destra del Solaro, ma non qualitativamente, perché concepiscono l’unità come allargamento dello Stato piemontese e del patrimonio della dinastia, non come movimento nazionale dal basso, ma come conquista regia. Elemento più propriamente nazionale è il Partito d'Azione, ecc. (Vedi altre ).
Sarebbe interessante e necessario raccogliere tutte le affermazioni sulla quistione dell’origine del Risorgimento in senso proprio cioè del moto che portò all’unità territoriale e politica dell’Italia, ricordando che molti chiamano Risorgimento anche il risveglio delle forze «indigene» italiane dopo il Mille, cioè il moto che portò ai Comuni e al Rinascimento. Tutte queste quistioni sulle origini hanno la loro ragione per il fatto che l’economia italiana era molto debole, e il capitalismo incipiente: non esisteva una forte e diffusa classe di borghesia economica, ma invece molti intellettuali e piccoli borghesi, ecc. Il problema non era tanto di liberare le forze economiche già sviluppate dalle pastoie giuridiche e politiche antiquate, quanto di creare le condizioni generali perché queste forze economiche potessero nascere e svilupparsi sul modello degli altri paesi. La storia contemporanea offre un modello per comprendere il passato italiano: esiste oggi una coscienza culturale europea ed esiste una serie di manifestazioni di intellettuali e uomini politici che sostengono la necessità di una unione europea: si può anche dire che il processo storico tende a questa unione e che esistono molte forze materiali che solo in questa unione potranno svilupparsi: se fra x anni questa unione sarà realizzata la parola «nazionalismo» avrà lo stesso valore archeologico che l’attuale «municipalismo».
Altro fatto contemporaneo che spiega il passato è la «non resistenza e non cooperazione» sostenuta da Gandhi: esse possono far capire le origini del cristianesimo e le ragioni del suo sviluppo nell’Impero Romano. Il tolstoismo aveva le stesse origini nella Russia zarista, ma non divenne una «credenza popolare» come il gandhismo: attraverso Tolstoi anche Gandhi si riallaccia al cristianesimo primitivo, rivive in tutta l’India una forma di cristianesimo primitivo, che il mondo cattolico e protestante non riesce neppure più a capire. Il rapporto tra Gandhismo e Impero Inglese è simile a quello tra cristianesimo‑ellenismo e impero romano. Paesi di antica civiltà, disarmati e tecnicamente (militarmente) inferiori, dominati da paesi tecnicamente sviluppati (i Romani avevano sviluppato la tecnica governativa e militare) sebbene come numero di abitanti trascurabili. Che molti uomini che si credono civili siano dominati da pochi uomini ritenuti meno civili ma materialmente invincibili, determina il rapporto cristianesimo primitivo ‑ gandhismo. La coscienza dell’impotenza materiale di una gran massa contro pochi oppressori porta all’esaltazione dei valori puramente spirituali ecc., alla passività, alla non resistenza, alla cooperazione, che però di fatto è una resistenza diluita e penosa, il materasso contro la pallottola.
Anche i movimenti religiosi popolari del Medio Evo, francescanesimo, ecc., rientrano in uno stesso rapporto di impotenza politica delle grandi masse di fronte a oppressori poco numerosi ma agguerriti e centralizzati: gli «umiliati e offesi» si trincerano nel pacifismo evangelico primitivo, nella nuda «esposizione» della loro «natura umana» misconosciuta e calpestata nonostante le affermazioni di fraternità in dio padre e di uguaglianza ecc. Nella storia delle eresie medioevali Francesco ha una sua posizione individuale ben distinta: egli non vuole lottare, cioè egli non pensa neppure a una qualsiasi lotta, a differenza degli altri innovatori (Valdo, ecc. e gli stessi francescani). La sua posizione è ritratta in un aneddoto raccontato dagli antichi testi francescani. «Ad un teologo domenicano che gli chiede come si debba intendere il verbo di Ezechia “se non manifesterete all’empio la sua iniquità, io chiederò conto a voi della sua anima”, così risponde Francesco: “il servo di Dio deve comportarsi nella sua vita e nel suo amore alla virtù così che con la luce del buon esempio e l’unzione della parola riesca di rimprovero a tutti gli empi; e così avverrà, credo, che lo splendore della vita di lui e l’odore della sua buona fama annunzieranno ai tristi la loro iniquità…”» (Cfr Antonio Viscardi, Francesco d’Assisi e la legge della povertà evangelica, nella «Nuova Italia» del gennaio 1931).
Q6 §79 Riviste tipo. Dilettantismo e disciplina. Necessità di una critica interna severa e rigorosa, senza convenzionalismi e mezze misure. Esiste una tendenza del materialismo storico che solletica e favorisce tutte le cattive tradizioni della media cultura italiana e sembra aderire ad alcuni tratti del carattere italiano: l’improvvisazione, il «talentismo», la pigrizia fatalistica, il dilettantismo scervellato, la mancanza di disciplina intellettuale, l’irresponsabilità e la slealtà morale e intellettuale. Il materialismo storico distrugge tutta una serie di pregiudizi e di convenzionalità, di falsi doveri, di ipocrite obbligazioni: ma non perciò giustifica che si cada nello scetticismo e nel cinismo snobistico. Lo stesso risultato aveva avuto il Machiavellismo, per una arbitraria estensione o confusione tra la «morale» politica e la «morale» privata, cioè tra la politica e l’etica, confusione che non esisteva certo nel Machiavelli, tutt’altro, poiché anzi la grandezza del Machiavelli consiste nell’aver distinto la politica dall’etica. Non può esistere associazione permanente e con capacità di sviluppo che non sia sostenuta da determinati principii etici, che l’associazione stessa pone ai suoi singoli componenti in vista della compattezza interna e dell’omogeneità necessarie per raggiungere il fine. Non perciò questi principii sono sprovvisti di carattere universale. Così sarebbe se l’associazione avesse fine in se stessa, fosse cioè una setta o un’associazione a delinquere (in questo solo caso mi pare si possa dire che politica ed etica si confondono, appunto perché il «particulare» è elevato a «universale»). Ma un’associazione normale concepisce se stessa come aristocrazia, una élite, un’avanguardia, cioè concepisce se stessa come legata da milioni di fili a un dato raggruppamento sociale e per il suo tramite a tutta l’umanità. Pertanto questa associazione non si pone come un qualche cosa di definitivo e di irrigidito, ma come tendente ad allargarsi a tutto un raggruppamento sociale, che anch’esso è concepito come tendente a unificare tutta l’umanità. Tutti questi rapporti danno carattere tendenzialmente universale all’etica di gruppo che dev’essere concepita come capace di diventare norma di condotta di tutta l’umanità. La politica è concepita come un processo che sboccherà nella morale, cioè come tendente a sboccare in una forma di convivenza in cui politica e quindi morale saranno superate entrambe. (Da questo punto di vista storicistico può solo spiegarsi l’angoscia di molti sul contrasto tra morale privata e morale pubblica-politica: essa è un riflesso inconsapevole e sentimentalmente acritico delle contraddizioni della attuale società, cioè dell’assenza di uguaglianza dei soggetti morali).
Ma non può parlarsi di élite‑aristocrazia‑avanguardia come di una collettività indistinta e caotica; in cui, per grazia di un misterioso spirito santo o di altra misteriosa e metafisica deità ignota, cali la grazia dell’intelligenza, della capacità, dell’educazione, della preparazione tecnica ecc.; eppure questo modo di concepire è comune. Si riflette in piccolo ciò che avveniva su scala nazionale, quando lo Stato era concepito come qualcosa di astratto dalla collettività dei cittadini, come un padre eterno che avrebbe pensato a tutto, provveduto a tutto ecc.; da ciò l’assenza di una democrazia reale, di una reale volontà collettiva nazionale e quindi, in questa passività dei singoli, la necessità di un dispotismo più o meno larvato della burocrazia. La collettività deve essere intesa come prodotto di una elaborazione di volontà e pensiero collettivo raggiunto attraverso lo sforzo individuale concreto, e non per un processo fatale estraneo ai singoli: quindi obbligo della disciplina interiore e non solo di quella esterna e meccanica. Se ci devono essere polemiche e scissioni, non bisogna aver paura di affrontarle e superarle: esse sono inevitabili in questi processi di sviluppo ed evitarle significa solo rimandarle a quando saranno precisamente pericolose o addirittura catastrofiche, ecc.
Q6 §80 I nipotini di padre Bresciani. Répaci. Osservare il suo carattere di linguaiolo che pare si sia ancor più sviluppato in questi ultimi tempi, come appare dalle ultime novelle, per es. Guerra di fanciulli. Le parolette infilzate a serie, l’uso di ribobolerie toscane per racconti di ambiente calabrese fanno l’effetto più buffo: e ancora, come diventa meccanico il tentativo fatto dall’esterno di costruire novelle «psicoanalitiche» quando invece si è spinti da un superficiale impulso del pittoresco folcloristico!
Q6 §81 Egemonia (società civile) e divisione dei poteri. La divisione dei poteri e tutta la discussione avvenuta per la sua realizzazione e la dogmatica giuridica nata dal suo avvento, sono il risultato della lotta tra la società civile e la società politica di un determinato periodo storico, con un certo equilibrio instabile delle classi, determinato dal fatto che certe categorie d’intellettuali (al diretto servizio dello Stato, specialmente burocrazia civile e militare) sono ancora troppo legate alle vecchie classi dominanti. Si verifica cioè nell’interno della società quello che il Croce chiama il «perpetuo conflitto tra Chiesa e Stato», in cui la Chiesa è presa a rappresentare la società civile nel suo insieme (mentre non ne è che un elemento gradatamente meno importante) e lo Stato ogni tentativo di cristallizzare permanentemente un determinato stadio di sviluppo, una determinata situazione. In questo senso la Chiesa stessa può diventare Stato e il conflitto può manifestarsi tra Società civile laica e laicizzante e Stato‑Chiesa (quando la Chiesa è diventata una parte integrante dello Stato, della società politica monopolizzata da un determinato gruppo privilegiato che si aggrega la Chiesa per sostenere meglio il suo monopolio col sostegno di quella zona di società civile rappresentata dalla Chiesa). Importanza essenziale della divisione dei poteri per il liberalismo politico ed economico: tutta l’ideologia liberale, con le sue forze e le sue debolezze, può essere racchiusa nel principio della divisione dei poteri e appare quale sia la fonte della debolezza del liberalismo: è la burocrazia, cioè la cristallizzazione del personale dirigente che esercita il potere coercitivo e che a un certo punto diventa casta. Onde la rivendicazione popolare della eleggibilità di tutte le cariche, rivendicazione che è estremo liberalismo e nel tempo stesso sua dissoluzione (principio della Costituente in permanenza ecc.; nelle Repubbliche l’elezione a tempo del capo dello Stato dà una soddisfazione illusoria a questa rivendicazione popolare elementare).
Unità dello Stato nella distinzione dei poteri: il Parlamento più legato alla società civile, il potere giudiziario tra Governo e Parlamento, rappresenta la continuità della legge scritta (anche contro il Governo). Naturalmente tutti e tre i poteri sono anche organi dell’egemonia politica, ma in diversa misura: 1) Parlamento; 2) Magistratura; 3) Governo. È da notare come nel pubblico facciano specialmente impressione disastrosa le scorrettezze della amministrazione della giustizia: l’apparato egemonico è più sensibile in questo settore, al quale possono ricondursi anche gli arbitri della polizia e dell’amministrazione politica.
Q6 §82 Passato e presente. Società politica e civile. Polemica intorno alle critiche di Ugo Spirito all’economia tradizionale. Nella polemica ci sono molti sottintesi e presupposti ideologici che si evita di discutere, almeno finora, da parte degli «economisti» e anche da parte dello Spirito, a quanto pare. È evidente che gli economisti non vogliono discutere la concezione dello Stato dello Spirito, ma è proprio questa la radice del dissenso. Lo Spirito, d’altronde, non vuole o esita a spingerli e incalzarli su questo terreno, perché la conseguenza sarebbe di suscitare una discussione politica generale e di far apparire l’esistenza di più partiti nello stesso partito, uno dei quali, collegato strettamente con sedicenti senza partito: apparirebbe esistere un partito degli scienziati e dell’alta cultura. Da parte degli scienziati, d’altronde, sarebbe facile dimostrare tutta l’arbitrarietà delle proposizioni dello Spirito, e della sua concezione dello Stato, ma essi non vogliono uscire da certi limiti, che raramente trascendono l’indulgenza e la cortesia personale. Quello che è comico è la pretensione dello Spirito, che gli economisti gli costruiscano una scienza economica secondo il suo punto di vista. Ma nella polemica dello Spirito non tutto è da buttar via: ci sono alcune esigenze reali, affogate nella farragine delle parole «speculative». L’episodio perciò è da notare come un momento della lotta culturale‑politica. Nell’esposizione occorre appunto partire dalla concezione dello Stato propria dello Spirito e dell’idealismo gentiliano, che è ben lungi dall’essere stata fatta propria dallo «Stato» stesso, cioè dalle classi dominanti e dal personale politico più attivo, cioè non è per nulla diventata (tutt’altro!) elemento di una politica culturale governativa. A ciò si oppone il Concordato (si oppone implicitamente, s’intende) ed è nota l’avversione del Gentile al Concordato, espressa nel 1928 (cfr articoli nel «Corriere della Sera» e discorsi di quel tempo); occorre tener conto del discorso di Paolo Orano alla Camera (confrontare), nel 1930, tanto più significativo se si tien conto che Paolo Orano spesso ha parlato alla Camera in senso «ufficioso». Da tener conto anche della breve ma violenta critica del libro dello Spirito (Critica dell’Economia liberale) pubblicata nella «Rivista di Politica Economica» (dicembre 1930) da A. De Pietri Tonelli, dato che la rivista è emanazione degli industriali italiani (cfr la direzione: nel passato era organo dell’Associazione delle Società Anonime). Ancora: all’Accademia è stato chiamato P. Jannaccone, noto economista ortodosso, che ha demolito lo Spirito nella «Riforma Sociale» (dicembre 1930). Cfr anche la Postilla del Croce nella «Critica» del gennaio 1931. Dalle pubblicazioni dello Spirito apparse nei «Nuovi Studi» appare come le sue tesi sono finora state accettate integralmente solo da… Massimo Fovel, noto avventuriero della politica e dell’economia. Tuttavia allo Spirito si lascia fare la voce grossa e si danno incarichi di fiducia (dal ministro Bottai, credo, che ha fondato l’«Archivio di Studi corporativi» con ampia partecipazione dello Spirito e C.).
La concezione dello Stato nello Spirito non è molto chiara e rigorosa. Talvolta sembra sostenga addirittura che prima che egli diventasse «la filosofia», nessuno abbia capito nulla dello Stato e lo Stato non sia esistito o non fosse un «vero» Stato ecc. Ma siccome vuol essere storicista, quando se ne ricorda, ammette che anche nel passato sia esistito lo Stato, ma che ormai tutto è cambiato e lo Stato (o il concetto dello Stato) è stato approfondito e posto su «ben altre» basi speculative che nel passato e poiché «quanto più una scienza è speculativa tanto più è pratica», così pare che queste basi speculative debbano ipso facto diventare basi pratiche e tutta la costruzione reale dello Stato mutare perché lo Spirito ne ha mutato le basi speculative (naturalmente non lo Spirito uomo empirico, ma Ugo Spirito ‑ Filosofia). Confrontare Critica dell’economia liberale, p. 180: «Il mio saggio sul Pareto voleva essere un atto di fede e di buona volontà: di fede in quanto con esso volevo iniziare lo svolgimento del programma dei “Nuovi Studi” e cioè il raccostamento e la collaborazione effettiva della filosofia e della scienza», e le illazioni sono lì: filosofia = realtà, quindi anche scienza e anche economia, cioè Ugo Spirito = sole raggiante di tutta la filosofia‑realtà, che invita gli scienziati specialisti a collaborare con lui, a lasciarsi riscaldare dai suoi raggi‑principi, anzi a essere i suoi raggi stessi per diventare «veri» scienziati, cioè «veri» filosofi.
Poiché gli scienziati non vogliono lasciarsi fare e solo qualcuno si lascia indurre a entrare in rapporto epistolare con lui ecco che lo Spirito li sfida nel suo terreno, e se non accettano ancora, sorride sardonicamente e trionfalmente: non accettano la sfida perché hanno paura o qualcosa di simile. Lo Spirito non può supporre che gli scienziati non vogliono occuparsi di lui perché non ne vale la pena e perché hanno altro da fare. Poiché egli è la «filosofia» e filosofia = scienza ecc., quegli scienziati non sono «veri» scienziati, anzi la «vera» scienza non è mai esistita ecc.
Volpicelli e Spirito, direttori dei «Nuovi Studi», i Bouvard e Pécuchet della filosofia, della politica, dell’economia, del diritto, della scienza, ecc. ecc. Quistione fondamentale: l’utopia di Spirito e Volpicelli consiste nel confondere lo Stato con la società regolata, confusione che si verifica per una puramente «razionalistica» concatenazione di concetti: individuo = società (l’individuo non è un «atomo», ma l’individuazione storica dell’intera società), società = Stato, dunque individuo = Stato. Il carattere che differenzia questa «utopia» dalle utopie tradizionali e dalle ricerche, in generale, dell’«ottimo stato» è che Spirito e Volpicelli danno come già esistente questa loro «fantastica» entità, esistente ma non riconosciuta da altri che da loro, depositari della «vera verità», mentre gli altri (specialmente gli economisti e in generale gli scienziati di scienze sociali) non capiscono nulla, sono nell’«errore», ecc. Per quale «coda del diavolo» avvenga che solo Spirito e Volpicelli posseggano questa verità e gli altri non la vogliano possedere, non è stato ancora spiegato dai due, ma appare qua e là un barlume dei mezzi con cui i due ritengono che la verità dovrà essere diffusa e diventare autocoscienza: è la polizia (ricordare il discorso Gentile a Palermo nel 24). Per ragioni politiche è stato detto alle masse: «ciò che voi aspettavate e vi era stato promesso dai ciarlatani, ecco, esiste già», cioè la società regolata, l’uguaglianza economica, ecc. Spirito e Volpicelli (dietro Gentile, che però non è così sciocco come i due) hanno allargato l’affermazione, e l’hanno «speculata», «filosofizzata», sistemata, e si battono come leoni impagliati contro tutto il mondo, che sa bene cosa pensare di tutto ciò. Ma la critica di questa «utopia» domanderebbe ben altra critica, avrebbe ben altre conseguenze che la carriera più o meno brillante dei due Aiaci dell’«attualismo» e allora assistiamo alla giostra attuale. In ogni modo è ben meritato che il mondo intellettuale sia sotto la ferula di questi due pagliacci, come fu ben meritato che l’aristocrazia milanese sia rimasta tanti anni sotto il tallone della triade. (La sottoscrizione per le nozze di donna Franca, potrebbe essere paragonata con l’atto di omaggio a Francesco Giuseppe nel 1853: da Francesco Giuseppe a donna Franca indica la caduta della aristocrazia milanese»). Bisognerebbe anche osservare come la concezione di Spirito e Volpicelli sia un derivato logico delle più scempie e «razionali» teorie democratiche. Ancora essa è legata alla concezione della «natura umana» identica e senza sviluppo come era concepita prima di Marx per cui tutti gli uomini sono fondamentalmente uguali nel regno dello Spirito (= in questo caso allo Spirito Santo e a Dio padre di tutti gli uomini).
Questa concezione è espressa nella citazione che Benedetto Croce fa nel capitolo A proposito del positivismo italiano (in Cultura e Vita morale, p. 45) da «una vecchia dissertazione tedesca»: «Omnis enim Philosophia, cum ad communem hominum cogitandi facultatem revocet, per se democratica est; ideoque ab optimatibus non iniuria sibi existimatur perniciosa». Questa «comune facoltà di pensare» diventata «natura umana», ha dato luogo a tante utopie di cui si riscontra traccia in tante scienze che partono dal concetto dell’uguaglianza perfetta fra gli uomini ecc.
Q6 §83 Intellettuali italiani. Cfr P. H. Michel, La Pensée de L. B. Alberti (1404‑1472). Collection de littérature générale, 40 franchi, Ed. Les Belles Lettres, Parigi.
Q6 §84 Passato e presente. Continuità e tradizione. Un aspetto della quistione accennata a p. 33 «Dilettantismo e disciplina», dal punto di vista del centro organizzativo di un raggruppamento è quello della «continuità» che tende a creare una «tradizione» intesa, naturalmente, in senso attivo e non passivo come continuità in continuo sviluppo, ma «sviluppo organico». Questo problema contiene in nuce tutto il «problema giuridico», cioè il problema di assimilare alla frazione più avanzata del raggruppamento tutto il raggruppamento: è un problema di educazione delle masse, della loro «conformazione» secondo le esigenze del fine da raggiungere. Questa appunto è la funzione del diritto nello Stato e nella Società; attraverso il «diritto» lo Stato rende «omogeneo» il gruppo dominante e tende a creare un conformismo sociale che sia utile alla linea di sviluppo del gruppo dirigente. L’attività generale del diritto (che è più ampia dell’attività puramente statale e governativa e include anche l’attività direttiva della società civile, in quelle zone che i tecnici del diritto chiamano di indifferenza giuridica, cioè nella moralità e nel costume in genere) serve a capire meglio, concretamente, il problema etico, che in pratica è la corrispondenza «spontaneamente e liberamente accolta» tra gli atti e le omissioni di ogni individuo, tra la condotta di ogni individuo e i fini che la società si pone come necessari, corrispondenza che è coattiva nella sfera del diritto positivo tecnicamente inteso, ed è spontanea e libera (più strettamente etica) in quelle zone in cui la «coazione» non è statale, ma di opinione pubblica, di ambiente morale ecc. La continuità «giuridica» del centro organizzativo non deve essere di tipo bizantino‑napoleonico, cioè secondo un codice concepito come perpetuo, ma romano‑anglosassone, cioè la cui caratteristica essenziale consiste nel metodo, realistico, sempre aderente alla concreta vita in perpetuo sviluppo. Questa continuità organica richiede un buon archivio, bene attrezzato e di facile consultazione, in cui tutta l’attività passata sia facilmente riscontrabile e «criticabile». Le manifestazioni più importanti di questa attività non sono tanto le «decisioni organiche» quanto le circolari esplicative e ragionate (educative).
C’è il pericolo di «burocratizzarsi», è vero, ma ogni continuità organica presenta questo pericolo, che occorre vigilare. Il pericolo della discontinuità, dell’improvvisazione, è ancora più grande. Organo, «il bollettino» che
[...] tre sezioni principali: 1) articoli direttivi; 2) decisioni e circolari; 3) critica del passato, cioè richiamo continuo dal presente al passato, per mostrare le differenziazioni e le precisazioni e per giustificarle criticamente.
Q6 §85 Il comune medioevale come fase economico‑corporativa dello Stato moderno. Dante e Machiavelli. Bisogna liberare la dottrina politica di Dante da tutte le superstrutture posteriori, riducendola alla sua precisa significazione storica. Che, per l’importanza avuta da Dante come elemento della cultura italiana, le sue idee e le sue dottrine abbiano avuto efficacia di suggestione per stimolare e sollecitare il pensiero politico nazionale, è una quistione: ma bisogna escludere che tali dottrine abbiano avuto un valore genetico proprio, in senso organico. Le soluzioni passate di determinati problemi aiutano a trovare la soluzione dei problemi attuali simili, per l’abito critico culturale che si crea nella disciplina dello studio, ma non si può mai dire che la soluzione attuale dipenda geneticamente dalle soluzioni passate: la genesi di essa è nella situazione attuale e solo in questa. Questo criterio non è assoluto, cioè non deve essere portato all’assurdo: in tal caso si cadrebbe nell’empirismo: massimo attualismo, massimo empirismo. Bisogna saper fissare le grandi fasi storiche, che nel loro insieme hanno posto determinati problemi, e fin dall’inizio del loro sorgere ne hanno accennato gli elementi di soluzione. Così direi che Dante chiude il Medio Evo (una fase del Medio Evo), mentre Machiavelli indica che una fase del Mondo Moderno è già riuscita a elaborare le sue quistioni e le soluzioni relative in modo già molto chiaro e approfondito. Pensare che Machiavelli geneticamente dipenda o sia collegato a Dante è sproposito storico madornale. Così è puro romanzo intellettuale la costruzione attuale dei rapporti tra Stato e Chiesa (vedi F. Coppola) sullo schema dantesco «della Croce e dell’Aquila». Tra il Principe del Machiavelli e l’Imperatore di Dante non c’è connessione genetica, e tanto meno tra lo Stato Moderno e l’Impero medioevale. Il tentativo di trovare una connessione genetica tra le manifestazioni intellettuali delle classi colte italiane delle varie epoche, costituisce appunto la «retorica» nazionale: la storia reale viene scambiata con le larve della storia. (Con ciò non si vuol dire che il fatto non ha significato: non ha significato scientifico, ecco tutto. È un elemento politico; è meno ancora, è un elemento secondario e subordinato di organizzazione politica e ideologica di piccoli gruppi che lottano per l’egemonia culturale e politica).
La dottrina politica di Dante mi pare doversi ridurre a mero elemento della biografia di Dante (ciò che in nessun modo si potrebbe dire e fare per il Machiavelli), non nel senso generico che in ogni biografia l’attività intellettuale del protagonista è essenziale e che importa non solo ciò che il biografato fa, ma anche ciò che pensa e fantastica. Ma nel senso che tale dottrina non ha avuto nessuna efficacia e fecondità storico‑culturale, come non poteva averne ed è importante solo come elemento dello sviluppo personale di Dante dopo la sconfitta della sua parte e il suo esilio da Firenze. Dante subisce un processo radicale di trasformazione delle sue convinzioni politiche‑cittadine, dei suoi sentimenti, delle sue passioni, del suo modo di pensare generale. Questo processo ha come conseguenza di isolarlo da tutti. È vero che il suo nuovo orientamento può chiamarsi «ghibellinismo» solo per modo di dire: in ogni caso sarebbe un «nuovo ghibellinismo», superiore al vecchio ghibellinismo, ma superiore anche al guelfismo: in realtà si tratta non di una dottrina politica, ma di un’utopia politica, che si colora di riflessi del passato, e più di tutto si tratta del tentativo di organizzare come dottrina ciò che era solo materiale poetico in formazione, in ebullizione, fantasma poetico incipiente che avrà la sua perfezione nella Divina Commedia, sia nella «struttura» come continuazione del tentativo (adesso versificato) di organizzare in dottrina i sentimenti, sia nella «poesia» come invettiva appassionata e dramma in atto. Al disopra delle lotte interne comunali, che erano un alternarsi di distruzioni ed estermini, Dante sogna una società superiore al Comune, superiore sia alla Chiesa che appoggia i Neri come al vecchio impero che appoggiava i ghibellini, sogna una forma che imponga una legge superiore alle parti ecc. È un vinto della guerra delle classi che sogna l’abolizione di questa guerra sotto il segno di un potere arbitrale. Ma il vinto, con tutti i rancori, le passioni, i sentimenti del vinto, è anche un «dotto» che conosce le dottrine e la storia del passato. Il passato gli offre lo schema romano augusteo e il suo riflesso medioevale, l’Impero romano della nazione germanica. Egli vuol superare il presente, ma con gli occhi rivolti al passato. Anche il Machiavelli aveva gli occhi al passato, ma in ben altro modo di Dante ecc.
Q6 §86 Fase economica‑corporativa dello Stato. Il Guicciardini segna un passo indietro nella scienza politica di fronte al Machiavelli. Il maggiore «pessimismo» del Guicciardini significa solo questo. Il Guicciardini ritorna a un pensiero politico puramente italiano, mentre il Machiavelli si era innalzato a un pensiero europeo. Non si comprende il Machiavelli se non si tiene conto che egli supera l’esperienza italiana nell’esperienza europea (internazionale in quell’epoca): la sua «volontà» sarebbe utopistica, senza l’esperienza europea. La stessa concezione della «natura umana» diventa per questo fatto diversa nei due. Nella «natura umana» del Machiavelli è compreso l’«uomo europeo» e questo uomo in Francia e in Ispagna ha effettualmente superato la fase feudale disgregata nella monarchia assoluta: dunque non è la «natura umana» che si oppone a che in Italia sorga una monarchia assoluta unitaria, ma condizioni transitorie che la volontà può superare. Il Machiavelli è «pessimista» (o meglio «realista») nel considerare gli uomini e i moventi del loro operare; il Guicciardini non è pessimista, ma scettico e gretto.
Paolo Treves (cfr Il realismo politico di Francesco Guicciardini, in «Nuova Rivista Storica», novembre‑dicembre 1930) commette molti errori nei giudizi sul Guicciardini e Machiavelli. Non distingue bene «politica» da «diplomazia», ma proprio in questa non distinzione è la causa dei suoi errati apprezzamenti. Nella politica infatti l’elemento volitivo ha un’importanza molto più grande che nella diplomazia. La diplomazia sanziona e tende a conservare le situazioni create dall’urto delle politiche statali; è creativa solo per metafora o per convenzione filosofica (tutta l’attività umana è creativa). I rapporti internazionali riguardano un equilibrio di forze in cui ogni singolo elemento statale può influire molto debolmente: Firenze poteva influire rafforzando se stessa, per esempio, ma questo rafforzamento, se pure avesse migliorato la sua posizione nell’equilibrio italiano ed europeo non poteva certo essere pensato come decisivo per capovolgere l’insieme dell’equilibrio stesso. Perciò il diplomatico, per lo stesso abito professionale, è portato allo scetticismo e alla grettezza conservatrice.
Nei rapporti interni di uno Stato, la situazione è incomparabilmente più favorevole all’iniziativa centrale, a una volontà di comando, così come la intendeva il Machiavelli. Il giudizio dato dal De Sanctis del Guicciardini è molto più realistico di quanto il Treves creda. È da porre la domanda perché il De Sanctis fosse meglio preparato del Treves a dare questo giudizio storicamente e scientificamente più esatto. Il De Sanctis partecipò a un momento creativo della storia politica italiana, a un momento in cui l’efficienza della volontà politica, rivolta a suscitare forze nuove ed originali e non solo a calcolare su quelle tradizionali, concepite come impossibili di sviluppo e di riorganizzazione (scetticismo politico guicciardinesco), aveva mostrato tutta la sua potenzialità non solo nell’arte di fondare uno Stato dall’interno ma anche di padroneggiare i rapporti internazionali, svecchiando i metodi professionali e abitudinari della diplomazia (con Cavour). L’atmosfera culturale era propizia a una concezione più comprensivamente realistica della scienza e dell’arte politica. Ma anche senza questa atmosfera era impossibile al De Sanctis di comprendere Machiavelli? L’atmosfera data dal momento storico arricchisce i saggi del De Sanctis di un pathos sentimentale che rende più simpatico e appassionante l’argomento, più artisticamente espressiva e cattivante l’esposizione scientifica, ma il contenuto logico della scienza politica potrebbe essere stato pensato anche nei periodi di peggiore reazione. Non è forse la reazione anch’essa un atto costruttivo di volontà? E non è atto volontario la conservazione? Perché dunque sarebbe «utopistica» la volontà del Machiavelli perché rivoluzionaria e non utopistica la volontà di chi vuol conservare l’esistente e impedire il sorgere e l’organizzarsi di forze nuove che turberebbero e capovolgerebbero l’equilibrio tradizionale? La scienza politica astrae l’elemento «volontà» e non tiene conto del fine a cui una volontà determinata è applicata. L’attributo di «utopistico» non è proprio della volontà politica in generale, ma delle particolari volontà che non sanno connettere il mezzo al fine e pertanto non sono neanche volontà, ma velleità, sogni, desideri, ecc.
Lo scetticismo del Guicciardini (non pessimismo dell’intelligenza, che può essere unito a un ottimismo della volontà nei politici realistici attivi) ha diverse origini: 1) l’abito diplomatico, cioè di una professione subalterna, subordinata, esecutivo‑burocratica che deve accettare una volontà estranea (quella politica del proprio governo o principe) alle convinzioni particolari del diplomatico (che può, è vero, sentire quella volontà come propria, in quanto corrisponde alle proprie convinzioni, ma può anche non sentirla: l’essere la diplomazia divenuta necessariamente una professione specializzata, ha portato a questa conseguenza, di poter staccare il diplomatico dalla politica dei governi mutevoli ecc.), quindi scetticismo e, nell’elaborazione scientifica, pregiudizi extrascientifici; 2) le convinzioni stesse del Guicciardini che era conservatore, nel quadro generale della politica italiana, e perciò teorizza le proprie opinioni, la propria posizione politica, ecc.
Gli scritti del Guicciardini sono più segno dei tempi, che scienza politica, e questo è il giudizio del De Sanctis; come segno dei tempi e non saggio di storia della scienza politica è lo scritto di Paolo Treves.
Q6 §87 Armi e religione. Affermazione del Guicciardini che per la vita di uno Stato due cose sono assolutamente necessarie: le armi e la religione. La formula del Guicciardini può essere tradotta in varie altre formule, meno drastiche: forza e consenso, coercizione e persuasione, Stato e Chiesa, società politica e società civile, politica e morale (storia etico‑politica del Croce), diritto e libertà, ordine e disciplina, o, con un giudizio implicito di sapore libertario, violenza e frode. In ogni caso nella concezione politica del Rinascimento la religione era il consenso e la Chiesa era la Società civile, l’apparato di egemonia del gruppo dirigente, che non aveva un apparato proprio, cioè non aveva una propria organizzazione culturale e intellettuale, ma sentiva come tale l’organizzazione ecclesiastica universale. Non si è fuori del Medio Evo che per il fatto che apertamente si concepisce e si analizza la religione come «instrumentum regni».
Da questo punto di vista è da studiare l’iniziativa giacobina dell’istituzione del culto dell’«Ente supremo», che appare pertanto come un tentativo di creare identità tra Stato e società civile, di unificare dittatorialmente gli elementi costitutivi dello Stato in senso organico e più largo (Stato propriamente detto e società civile) in una disperata ricerca di stringere in pugno tutta la vita popolare e nazionale, ma appare anche come la prima radice dello Stato moderno laico, indipendente dalla Chiesa, che cerca e trova in se stesso, nella sua vita complessa, tutti gli elementi della sua personalità storica.
Q6 §88 Stato gendarme ‑ guardiano notturno, ecc. È da meditare questo argomento: la concezione dello Stato gendarme ‑ guardiano notturno, ecc. (a parte la specificazione di carattere polemico: gendarme, guardiano notturno, ecc.) non è poi la concezione dello Stato che sola superi le estreme fasi «corporative‑economiche»? Siamo sempre nel terreno della identificazione di Stato e Governo, identificazione che appunto è un ripresentarsi della forma corporativa‑economica, cioè della confusione tra società civile e società politica, poiché è da notare che nella nozione generale di Stato entrano elementi che sono da riportare alla nozione di società civile (nel senso, si potrebbe dire, che Stato = società politica + società civile, cioè egemonia corazzata di coercizione). In una dottrina dello Stato che concepisca questo come possibile tendenzialmente di esaurimento e di risoluzione della società regolata, l’argomento è fondamentale. L’elemento Stato‑coercizione si può immaginare esaurentesi mano a mano che si affermano elementi sempre più cospicui di società regolata (o Stato etico o società civile). Le espressioni di Stato etico o di società civile verrebbero a significare che quest’«immagine» di Stato senza Stato era presente ai maggiori scienziati della politica e del diritto in quanto si ponevano nel terreno della pura scienza (= pura utopia, in quanto basata sul presupposto che tutti gli uomini sono realmente uguali e quindi ugualmente ragionevoli e morali, cioè passibili di accettare la legge spontaneamente, liberamente e non per coercizione, come imposta da altra classe, come cosa esterna alla coscienza). Occorre ricordare che l’espressione di guardiano notturno per lo Stato liberale è di Lassalle, cioè di uno statalista dogmatico e non dialettico. (Cfr bene la dottrina di Lassalle su questo punto e sullo Stato in generale, in contrasto col marxismo). Nella dottrina dello Stato-società regolata, da una fase in cui Stato sarà uguale Governo, e Stato si identificherà con società civile, si dovrà passare a una fase di Stato ‑ guardiano notturno, cioè di una organizzazione coercitiva che tutelerà lo sviluppo degli elementi di società regolata in continuo incremento, e pertanto riducente gradatamente i suoi interventi autoritari e coattivi. Né ciò può far pensare a un nuovo «liberalismo», sebbene sia per essere l’inizio di un’era di libertà organica.
Q6 §89 Politica e diplomazia. Cavour. (Cfr nota a p. 38 bis su
Machiavelli e Guicciardini). Aneddoto riportato da Ferdinando
Mattini in Confessioni e
Ricordi, 1859-1892 (ed. Treves, 1928), pp. 150‑51: per
Crispi, il Cavour non doveva essere considerato come un elemento
di prima linea nella storia del Risorgimento, ma solo Vittorio
Emanuele, Garibaldi e Mazzini. «Il Cavour? Che cosa fece il
Cavour? Niente altro che diplomatizzare la rivoluzione…» Il
Martini annota: «Non osai dirlo, ma pensai: E scusate se è
poco!» Mi pare che il Crispi e il Martini seguano due ordini
diversi di pensieri. Il Crispi intende riferirsi agli elementi
attivi, ai «creatori» del movimento nazionale rivoluzione, cioè
ai politici propriamente detti. Pertanto la diplomazia è per lui
attività subalterna e subordinata: il diplomatico non crea nuovi
nessi storici, ma lavora a far sanzionare quelli che il politico
ha creato: Talleyrand non può essere paragonato con Napoleone.
In realtà il Crispi ha torto, ma non per ciò che il Martini crede. Il Cavour non fu solo un diplomatico, ma anzi essenzialmente un politico «creatore», solo che il suo modo di «creare» non era da rivoluzionario, ma da conservatore: e in ultima analisi non il programma di Mazzini e di Garibaldi, ma quello di Cavour trionfò. Né si capisce come il Crispi ponga accanto Vittorio Emanuele a Mazzini e Garibaldi; Vittorio Emanuele sta con Cavour ed è attraverso Vittorio Emanuele che Cavour domina Garibaldi e anche Mazzini. E certo che Crispi non avrebbe potuto riconoscere giusta questa analisi per «l’affetto che l’intelletto lega»; la sua passione settaria era ancor viva, come rimase viva sempre in lui, pur nelle mutazioni radicali delle sue posizioni politiche. D’altronde neanche il Martini avrebbe mai ammesso (almeno in pubblico) che Cavour sia stato essenzialmente un «pompiere», o si potrebbe dire «un termidoriano preventivo» poiché né in Mazzini né in Garibaldi né in Crispi stesso c’era la stoffa dei giacobini del Comitato di Salute Pubblica. Come ho notato altrove Crispi era un temperamento giacobino, non un «giacobino politico‑economico», cioè non aveva un programma il cui contenuto potesse essere paragonato a quello dei giacobini e neppure la loro feroce intransigenza. D’altronde: c’erano in Italia alcune delle condizioni necessarie per un movimento come quello dei giacobini francesi? La Francia da molti secoli era una nazione egemonica: la sua autonomia internazionale era molto ampia. Per l’Italia niente di simile: essa non aveva nessuna autonomia internazionale. In tali speciali condizioni si capisce che la diplomazia fosse concretamente superiore alla politica creativa, fosse la «sola politica creativa». Il problema non era di suscitare una nazione che avesse il primato in Europa e nel mondo, o uno Stato unitario che strappasse alla Francia l’iniziativa civile, ma di rappezzare uno Stato unitario purchessia. I grandi programmi di Gioberti e di Mazzini dovevano cedere al realismo politico e all’empirismo di Cavour. Questa assenza di «autonomia internazionale» è la ragione che spiega molta storia italiana e non solo delle classi borghesi. Si spiega anche così il perché di molte vittorie diplomatiche italiane, nonostante la debolezza relativa politica‑militare: non è la diplomazia italiana che vince come tale, ma si tratta di abilità nel saper trarre partito dall’equilibrio delle forze internazionali: è un’abilità subalterna, tuttavia fruttuosa. Non si è forti per sé, ma nessun sistema internazionale sarebbe il più forte senza l’Italia.
A proposito del giacobinismo di Crispi è anche interessante il capitolo Guerra di successione dello stesso libro del Martini (pp. 209‑24, specialmente p. 224). Dopo la morte di Depretis i settentrionali non volevano la successione di Crispi siciliano. Già Presidente del Consiglio, Crispi si sfoga col Martini, proclama il suo unitarismo ecc., afferma che non esistono più regionalismi ecc. Sembra questa una dote positiva di Crispi: mi pare invece giusto il giudizio contrario. La debolezza di Crispi fu appunto di legarsi strettamente al gruppo settentrionale, subendone il ricatto, e di avere sistematicamente sacrificato il Meridione, cioè i contadini, cioè di non avere osato, come i giacobini osarono, di posporre agli interessi corporativi del piccolo gruppo dirigente immediato, gli interessi storici della classe futura, risvegliandone le energie latenti con una riforma agraria. Anche il Crispi è un termidoriano preventivo, cioè un termidoriano che non prende il potere quando le forze latenti sono state messe in movimento, ma prende il potere per impedire che tali forze si scatenino: un «fogliante» era nella Rivoluzione francese un termidoriano in anticipo, ecc.
Sarà da ricercare attentamente se nel periodo del Risorgimento sia apparso almeno qualche accenno di un programma in cui l’unità della struttura economico‑sociale italiana sia stata vista in questo modo concreto: ho l’impressione che stringi, stringi, il solo Cavour ebbe una concezione di tal genere, cioè nel quadro della politica nazionale, pose le classi agrarie meridionali come fattore primario, classi agrarie e non contadine naturalmente, cioè blocco agrario diretto da grandi proprietari e grandi intellettuali. Sarà bene da studiare perciò il volume speciale dei carteggi cavourriani dedicato alla «Quistione meridionale». (Altro da studiare a questo riguardo: Giuseppe Ferrari, prima e dopo il 60: dopo il 60 i discorsi parlamentari sui fatti del Mezzogiorno).
Q6 §90 Psicologia e politica. Specialmente nei periodi di crisi finanziaria si sente molto parlare di «psicologia» come di causa efficiente di determinati fenomeni marginali. Psicologia (sfiducia), panico, ecc. Ma cosa significa in questo caso «psicologia»? E una pudica foglia di fico per indicare la «politica», cioè una determinata situazione politica. Poiché di solito per «politica» s’intende l’azione delle frazioni parlamentari, dei partiti, dei giornali e in generale ogni azione che si esplica secondo una direttiva palese e predeterminata, si dà il nome di «psicologia» ai fenomeni elementari di massa, non predeterminati, non organizzati, non diretti palesemente, i quali manifestano una frattura nell’unità sociale tra governati e governanti. Attraverso queste «pressioni psicologiche» i governati esprimono la loro sfiducia nei dirigenti e domandano che siano mutate le persone e gli indirizzi dell’attività finanziaria e quindi economica. I risparmiatori non investono risparmi e disinvestono da determinate attività che appaiono particolarmente rischiose, ecc.: si accontentano di interessi minimi e anche di interessi zero; qualche volta preferiscono perdere addirittura una parte del capitale per mettere al sicuro il resto.
Può bastare l’«educazione» per evitare queste crisi di sfiducia generica? Esse sono sintomatiche appunto perché «generiche» e contro la «genericità» è difficile educare una nuova fiducia. Il succedersi frequente di tali crisi psicologiche indica che un organismo è malato, cioè che l’insieme sociale non è più in grado di esprimere dirigenti capaci. Si tratta dunque di crisi politiche e anzi politico‑sociali del raggruppamento dirigente.
Q6 §91 Funzionari e funzioni. Cosa significa, dal punto di vista dei «funzionari e delle funzioni», il distacco tra i prezzi all’ingrosso e quelli al minuto? Che esiste un «esercito» di funzionari che si mangia la differenza sulle spalle e consumatore e del produttore. E che significano i fallimenti saliti a cifre iperboliche? Che i «concorsi» per questo esercito di funzionari vanno male assai: e sono «concorsi» di un tipo speciale: i «bocciati» distruggono una massa ingente di ricchezza e sono bocciati solo «pro tempore»: anche se «bocciati» riprendono a funzionare e a distruggere nuova ricchezza. Quanti di tali funzionari esistono? Essi stessi si creano le funzioni, si assegnano lo stipendio e mettono da parte la pensione.
Q6 §92 Passato e presente. Nel «19», rivista fascista diretta a Milano da Mario Giampaoli, è stato pubblicato nel 1927 (o prima o dopo; lessi l’articolo nel carcere di Milano) un articoluccio di Antonio Aniante, da cui appariva che l’Aniante, con qualche altro siciliano, aveva preso sul serio il programma, nato nel cervello di alcuni intellettuali sardi (C. Bell. e qualche altro: ricordo che Em. Lu. cercava di fare dimenticare l’episodio ridendone) di creare uno Stato federale mediterraneo che avrebbe dovuto comprendere: la Catalogna, le Baleari, Corsica e Sardegna, la Sicilia e Candia. L’Aniante ne scrive con un fare scemo da ammazzasette e bisogna far la tara nel suo racconto: per es. è credibile che egli sia stato mandato all’estero (a Parigi, mi pare) per incontrarsi con altri «congiurati»? E chi l’avrebbe mandato? E chi avrebbe dato i soldi?
Q6 §93 Nozioni encìclopediche. Teocrazia, cesaropapismo, ierocrazia. Non sono la stessa precisa cosa: 1) teocrazia, unita all’idea del comando per grazia di Dio; 2) cesaropapismo: l’imperatore è anche capo della religione, sebbene il carattere laico‑militare predomini in lui; 3) ierocrazia è il governo dei religiosi, cioè nel comando predomina il carattere sacerdotale: quella del papa è una ierocrazia.
Q6 §94 Cultura italiana. Sentimento nazionale, non popolare‑nazionale (cfr disperse), cioè un sentimento puramente «soggettivo», non legato a realtà, a fattori, a istituzioni oggettive. È perciò ancora un sentimento da «intellettuali», che sentono la continuità della loro categoria e della loro storia, unica categoria che abbia avuto una storia ininterrotta.
Un elemento oggettivo è la lingua, ma essa in Italia si alimenta poco, nel suo sviluppo, dalla lingua popolare che non esiste (eccetto in Toscana), mentre esistono i dialetti. Altro elemento è la coltura, ma essa è troppo ristretta ed ha carattere di casta: i ceti intellettuali sono piccolissimi e angusti. I partiti politici: erano poco solidi e non avevano vitalità permanente ma entravano in azione solo nel periodo elettorale. I giornali: non coincidevano coi partiti che debolmente, e poco letti. La Chiesa era l’elemento popolare‑nazionale più valido ed esteso, ma la lotta tra Chiesa e Stato ne faceva un elemento di disgregazione più che di unità e oggi le cose non sono molto cambiate perché tutta l’impostazione del problema morale‑popolare è cambiato. La monarchia. – Il parlamento. – L’università e la scuola. – La città. – Organizzazioni private come la massoneria. – L’Università popolare. – L’esercito. – I sindacati operai. – La scienza (verso il popolo, – i medici, i veterinari, le cattedre ambulanti, gli ospedali). – Il teatro. – Il libro.
Q6 §95 Cultura italiana. Regionalismo. Cfr Leonardo Olschki, Kulturgeografie Italiens, in «Preussische Jahrbücher» gennaio 1927, pp. 19‑36. Il «Leonardo» del febbraio 1927 lo giudica: «Vivace e assai ben fatto studio del regionalismo italiano, dei suoi aspetti presenti e delle sue origini storiche».
Q6 §96 Riviste‑tipo. Economia. Rassegna di studi economici italiani. 1) L’Italia nell’economia mondiale. Opere generali in cui l’economia italiana è confrontata e inserita nell’economia mondiale. Libri tipo: Mortara, Prospettive economiche; Annuario economico della Società delle Nazioni; pubblicazioni della Dresdner Bank sulle forze economiche mondiali, ecc. Libri sulla Bilancia commerciale, sull’esportazione ed importazione, sui prestiti internazionali, sulle rimesse degli emigranti (e quindi sull’emigrazione e suoi caratteri), sul turismo internazionale in Italia e suo significato economico, sui trattati commerciali, sulle crisi economiche mondiali e suoi riflessi in Italia, sulla flotta marittima e introito dei noli, sui porti franchi, sul protezionismo e liberismo, sul commercio di transito e suoi risultati per l’economia italiana, quindi sui porti e loro hinterland non italiano (Genova e la Svizzera, Trieste e i Balcani, ecc.), pesca nei mari non italiani, cartelli e trusts internazionali e loro effetti per l’Italia, Banche e loro espansione all’estero (Banca Commerciale all’estero, Banco di Roma all’estero, ecc.), capitale straniero in Italia e capitale italiano all’estero.
2) Attrezzatura economica e produzione nazionale. Libri d’insieme sulla produzione italiana e sulla politica economica italiana, sul regime delle imposte, sulla distribuzione regionale tra industria e agricoltura e attività economiche minori; distribuzione delle grandi zone economiche nazionali e loro caratteristiche: Italia settentrionale, Italia centrale, Mezzogiorno, Sicilia, Sardegna.
3) Studi sulle economie regionali (Piemonte, Lombardia, ecc.).
4) Studi sulle economie provinciali o di zone provinciali. Pubblicazioni delle Camere di Commercio, dei Consorzi Agrari e dei Consigli Provinciali di Economia; pubblicazioni delle Banche locali, Bollettini Municipali per i capoluoghi di provincia, Studi di singoli studiosi, Pubblicazioni di Osservatori Economici come quello di Palermo per la Sicilia o quello di Bari per le Puglie, ecc. La Rassegna deve avere carattere attuale, ma nelle singole parti deve avere anche carattere storico, cioè è bene accennare a studi ormai superati, ecc. A questa Rassegna può seguire o precedere un’altra Rassegna sugli studi e le scuole di scienza economica e le pubblicazioni periodiche di economia e di politica economica, e sulle personalità di singoli scienziati morti e viventi.
Q6 §97 Passato e presente. Grande ambizione e piccole ambizioni. Può esistere politica, cioè storia in atto, senza ambizione? «L’ambizione» ha assunto un significato deteriore e spregevole per due ragioni principali: 1) perché è stata confusa l’ambizione (grande) con le piccole ambizioni; 2) perché l’ambizione ha troppo spesso condotto al più basso opportunismo, al tradimento dei vecchi principii e delle vecchie formazioni sociali che avevano dato all’ambizioso le condizioni per passare a servizio più lucrativo e di più pronto rendimento. In fondo anche questo secondo motivo si può ridurre al primo: si tratta di piccole ambizioni, poiché hanno fretta e non vogliono aver da superare soverchie difficoltà o troppo grandi difficoltà, o correre troppo grandi pericoli.
È nel carattere di ogni capo di essere ambizioso, cioè di aspirare con ogni sua forza all’esercizio del potere statale. Un capo non ambizioso non è un capo, ed è un elemento pericoloso per i suoi seguaci: egli è un inetto o un vigliacco. Ricordare l’affermazione di Arturo Vella: «Il nostro partito non sarà mai un partito di governo», cioè sarà sempre partito di opposizione: ma che significa proporsi di stare sempre all’opposizione? Significa preparare i peggiori disastri, perché se l’essere all’opposizione è comodo per gli oppositori, non è «comodo» (a seconda, naturalmente, delle forze oppositrici e della loro natura) per i dirigenti del governo, i quali a un certo punto dovranno porsi il problema di spezzare e spazzare l’opposizione. La grande ambizione, oltre che necessaria per la lotta, non è neanche spregevole moralmente, tutt’altro: tutto sta nel vedere se l’«ambizioso» si eleva dopo aver fatto il deserto intorno a sé, o se il suo elevarsi è condizionato consapevolmente dall’elevarsi di tutto uno strato sociale e se l’ambizioso vede appunto la propria elevazione come elemento dell’elevazione generale.
Di solito si vede la lotta delle piccole ambizioni (del proprio particulare) contro la grande ambizione (che è indissolubile dal bene collettivo). Queste osservazioni sull’ambizione possono e devono essere collegate con altre sulla così detta demagogia.
Demagogia vuol dire parecchie cose: nel senso deteriore significa servirsi delle masse popolari, delle loro passioni sapientemente eccitate e nutrite, per i propri fini particolari, per le proprie piccole ambizioni (il parlamentarismo e l’elezionismo offrono un terreno propizio per questa forma particolare di demagogia, che culmina nel cesarismo e nel bonapartismo coi suoi regimi plebiscitari). Ma se il capo non considera le masse umane come uno strumento servile, buono per raggiungere i propri scopi e poi buttar via, ma tende a raggiungere fini politici organici di cui queste masse sono il necessario protagonista storico, se il capo svolge opera «costituente» costruttiva, allora si ha una «demagogia» superiore; le masse non possono non essere aiutate a elevarsi attraverso l’elevarsi di singoli individui e di interi strati «culturali».
Il «demagogo» deteriore pone se stesso come insostituibile, crea il deserto intorno a sé, sistematicamente schiaccia ed elimina i possibili concorrenti, vuole entrare in rapporto con le masse direttamente (plebiscito, ecc., grande oratoria, colpi di scena, apparato coreografico fantasmagorico: si tratta di ciò che il Michels ha chiamato «capo carismatico»). Il capo politico dalla grande ambizione invece tende a suscitare uno strato intermedio tra sé e la massa, a suscitare possibili «concorrenti» ed eguali, a elevare il livello di capacità delle masse, a creare elementi che possano sostituirlo nella funzione di capo. Egli pensa secondo gli interessi della massa e questi vogliono che un apparecchio di conquista o di dominio non si sfasci per la morte o il venir meno del singolo capo, ripiombando la massa nel caos e nell’impotenza primitiva. Se è vero che ogni partito è partito di una sola classe, il capo deve poggiare su di questa ed elaborarne uno stato maggiore e tutta una gerarchia; se il capo è di origine «carismatica», deve rinnegare la sua origine e lavorare a rendere organica la funzione della direzione, organica e coi caratteri della permanenza e continuità.
Q6 §98 I costumi e le leggi. È opinione molto diffusa e anzi è opinione ritenuta realistica e intelligente che le leggi devono essere precedute dal costume, che la legge è efficace solo in quanto sanziona i costumi. Questa opinione è contro la storia reale dello sviluppo del diritto, che ha domandato sempre una lotta per affermarsi e che in realtà è lotta per la creazione di un nuovo costume. Nell’opinione su citata esiste un residuo molto appariscente di moralismo intruso nella politica.
Si suppone che il diritto sia espressione integrale dell’intera società, ciò che è falso: invece espressione più aderente della società sono quelle regole di condotta che i giuristi chiamano «giuridicamente indifferenti» e la cui zona cambia coi tempi e con l’estensione dell’intervento statale nella vita dei cittadini. Il diritto non esprime tutta la società (per cui i violatori del diritto sarebbero esseri antisociali per natura, o minorati psichici), ma la classe dirigente, che «impone» a tutta la società quelle norme di condotta che sono più legate alla sua ragion d’essere e al suo sviluppo. La funzione massima del diritto è questa: di presupporre che tutti i cittadini devono accettare liberamente il conformismo segnato dal diritto, in quanto tutti possono diventare elementi della classe dirigente; nel diritto moderno cioè è implicita l’utopia democratica del secolo XVIII.
Qualche cosa di vero tuttavia esiste nell’opinione che il costume deve precedere il diritto: infatti nelle rivoluzioni contro gli Stati assoluti, esisteva già come costume e come aspirazione una gran parte di ciò che poi divenne diritto obbligatorio: è con il nascere e lo svilupparsi delle disuguaglianze che il carattere obbligatorio del diritto andò aumentando, così come andò aumentando la zona dell’intervento statale e dell’obbligazionismo giuridico. Ma in questa seconda fase, pur affermando che il conformismo deve essere libero e spontaneo, si tratta di ben altro: si tratta di reprimere e soffocare un diritto nascente e non di conformare.
L’argomento rientra in quello più generale della diversa posizione che hanno avuto le classi subalterne prima di diventare dominanti. Certe classi subalterne devono avere un lungo periodo di intervento giuridico rigoroso e poi attenuato, a differenza di altre; c’è differenza anche nei modi: in certe classi l’espansività non cessa mai, fino all’assorbimento completo della società; in altre, al primo periodo di espansione succede un periodo di repressione. Questo carattere educativo, creativo, formativo del diritto è stato messo poco in luce da certe correnti intellettuali: si tratta di un residuo dello spontaneismo, del razionalismo astratto che si basa su un concetto della «natura umana» astrattamente ottimistico e facilone. Un altro problema si pone per queste correnti: quale deve essere l’organo legislativo «in senso lato», cioè la necessità di portare le discussioni legislative in tutti gli organismi di massa: una trasformazione organica del concetto di «referendum», pur mantenendo al governo la funzione di ultima istanza legislativa.
Q6 §99 Concetto di grande potenza. (Cfr altre precedenti). Secondo il capo del governo italiano: «Sono le marine da guerra che classificano le grandi potenze». È da notare che le marine a guerra possono essere misurate in ogni momento col sistema matematico assoluto, ciò che non può avvenire per gli eserciti terrestri. Ricordare l’epigramma di Anatole France: «Tutti gli eserciti sono i primi del mondo, ma per la marina è il numero delle navi che conta».
Q6 §100 Passato e presente. Industriali e agrari. Tutta la storia passata, dal nascere di una certa industria in poi, è caratterizzata da un difficile e complicato sforzo di dividere il reddito nazionale tra industriali e agrari, sforzo complicato dall’esistenza di una relativamente vasta categoria di medi e piccoli proprietari terrieri non coltivatori ma abitanti in città (nelle cento città), divoratori parassitari di rendita agraria. Poiché il sistema così costruito (protezionismo industriale e protezionismo agricolo) non può non essere insufficiente, esso si regge sul basso tenor di vita delle grandi masse, per la mancanza di materie prime (che non permette un grande sviluppo industriale) e per l’impossibilità di risparmio notevole, perché i margini sono inghiottiti dai ceti parassitari e manca l’accumulazione (nonostante il basso tenor di vita delle grandi masse). Così si spiega anche lo stento in cui vivono certe industrie esportatrici, come la seta, che si avvantaggerebbe enormemente dal basso prezzo dei viveri e potrebbe entrare in vittoriosa concorrenza con la Francia, alla quale l’Italia cede la materia prima (i bozzoli). Calcolare quanti bozzoli sono venduti all’estero e quanti trasformati in Italia e calcolare la differenza che passa tra l’esportazione della seta lavorata e quella dei bozzoli grezzi. Altro calcolo per lo zucchero, che è più protetto del grano, ecc. Analisi delle industrie d’esportazione che potrebbero nascere o svilupparsi sia nella città che nell’agricoltura senza il sistema doganale vigente. Quando l’assenza di materie prime assurge a motivo di politica militarista e nazionalista (non certo imperialista, che è grado più sviluppato dello stesso processo) è naturale domandarsi se le materie prime esistenti sono bene sfruttate, perché altrimenti non si tratta di politica nazionale (cioè di una intera classe) ma di una oligarchia parassitaria e privilegiata, cioè non si tratta di politica estera, ma di politica interna di corruzione e di deperimento delle forze nazionali.
Q6 §101 Cultura italiana. Borghesia primitiva. Per lo studio della formazione e del diffondersi dello spirito borghese in Italia (lavoro tipo Groethuysen), cfr anche i Sermoni di Franco Sacchetti (vedi ciò che ne scrive il Croce nella «Critica» del marzo 1931 (Il Boccaccio e Franco Sacchetti).
Q6 §102 Passato e presente. Contadini e vita della campagna. Elementi direttivi per una ricerca: condizioni materiali di vita: abitazione, alimentazione, alcoolismo, pratiche igieniche, abbigliamento, movimento demografico (mortalità, natalità, mortalità infantile, nuzialità, nascite illegittime, inurbamento, frequenza dei reati di sangue e altri reati non economici, litigiosità giudiziaria per quistioni di proprietà ipoteche, subaste per imposte non pagate, movimento della proprietà terriera, inventario agricolo, costruzioni di case rurali, reati di carattere economico, frodi, furti, falsi ecc., inurbamento di donne per servizi domestici emigrazione, popolazione passiva famigliare). Orientamento della psicologia popolare nei problemi della religione e della politica, frequenza scolastica dei fanciulli, analfabetismo delle reclute e delle donne.
Q6 §103 Risorgimento. Quando comincia il Risorgimento? Cfr Arrigo Solmi, L’unità fondamentale della storia italiana, Bologna, Zanichelli 1927, pp. 58, L. 6. Su questo scritto cfr Francesco Collotti, Pretesti oratori, nel «Leonardo» del 20 maggio 1927, la risposta del Solmi nel «Leonardo» del 20 agosto successivo e la nota di L. Russo alla risposta. Il Solmi trova nella «città» questa unità fondamentale ed è certo notevole il fatto che in molte città autonome si verifichino simultaneamente le stesse riforme (non conosco il libretto del Solmi e non so quindi come egli spieghi questo fatto precisamente). È da vedere a questo proposito il libretto di Carlo Cattaneo, La Città considerata come principio ideale delle istorie italiane, a cura di G. A. Belloni, pp. 140, L. 8, Vallecchi, Firenze: il Solmi ha preso dal Cattaneo il suo principio? D’altronde cosa significa «città»? Non significa forse «borghesia», ecc.?
Q6 §104 Giornalismo. Il tipo di settimanale provinciale che era diffuso tradizionalmente in Italia, coltivato specialmente dai cattolici e dai socialisti, rappresentava adeguatamente le condizioni culturali della provincia (villaggio e piccola città). Nessun interesse per la vita internazionale (altro che come curiosità e stranezza), poco interesse per la stessa vita nazionale, se non in quanto legata agli interessi locali, specialmente elettorali; tutto l’interesse per la vita locale, anche per i pettegolezzi e le minuzie. Grande importanza per la polemica personale (di carattere gaglioffesco e provinciale; far apparire stupido, ridicolo, disonesto l’avversario, ecc.). L’informazione ridotta solo alle corrispondenze dai vari villaggi. Commenti politici generici che presupponevano la informazione data dai quotidiani, che i lettori del settimanale non leggevano e si supponeva appunto non leggessero (perciò si faceva per loro il settimanale).
Il redattore di questi settimanali era di solito un intellettuale mediocre, pretenzioso e ignorante, pieno di cavilli e di sofismi banali. Riassumere il quotidiano sarebbe stato per lui una «vergogna»: pretendeva fare un settimanale tutto di articoli di fondo e di pezzi «brillanti», e inventare teorie con tanto di barba in economia, in politica, in filosofia.
Proprio in Italia, data la infelice disposizione geografica e l’assenza di un centro politico e intellettuale nazionale, avrebbe invece dovuto aver fortuna il tipo di settimanale inglese («Observer», «Times Sunday», ecc.) che è redatto sul tipo del quotidiano: cioè ogni settimana informa i lettori che non leggono il giornale, o vogliono avere, ogni settimana, un quadro riassuntivo della vita di tutta la settimana. Questo tipo inglese è da studiare e adattare teoricamente alle condizioni italiane. Esso dovrebbe (settimanale, bisettimanale) sostituire il quotidiano in larghe zone dove il quotidiano non avrebbe le premesse sufficienti (Napoli, Firenze, Palermo, ecc.; in generale nei capoluoghi di regione e anche di provincia non industriali: ricordare esempi come Biella, Como, Tortona, che volevano il settimanale benché industriali e consumatori di giornali. Così Alessandria, Cuneo, Fossano, ecc. In Italia il settimanale così redatto avrebbe lo stesso ufficio dei tanti piccoli quotidiani provinciali tedeschi e svizzeri).
Q6 §105 Riviste‑tipo. Tradizione e sue sedimentazioni psicologiche. Che il libertarismo generico (cfr concetto tutto italiano di «sovversivo») sia molto radicato nelle tradizioni popolari, si può studiare attraverso un esame della poesia e dei discorsi di P. Gori, che poeticamente (!) può essere paragonato (subordinatamente) al Cavallotti. C’è nel Gori tutto un modo di pensare e di esprimersi che sente di sagrestia e di eroismo di cartone. Tuttavia quei modi e quelle forme, lasciate diffondere senza contrasto e senza critica, sono penetrate molto profondamente nel popolo e hanno costituito un gusto (e forse lo costituiscono ancora).
Q6 §106 Giornalismo. Capocronista. Difficoltà di creare dei buoni capi cronisti, cioè dei giornalisti tecnicamente preparati a comprendere ed analizzare la vita organica di una grande città, impostando in questo quadro (senza pedanteria, ma anche non superficialmente e senza «brillanti» improvvisazioni) ogni singolo problema mano mano che diventa d’attualità. Ciò che si dice del capocronista può estendersi a tutta una serie d’attività pubbliche: un buon capocronista dovrebbe avere la preparazione tecnica sufficiente e necessaria per diventare podestà o anche prefetto, o presidente (effettivo) di un Consiglio provinciale d’economia tipo attuale; e, dal punto di vista giornalistico, dovrebbe corrispondere al corrispondente locale di una grande città (e via via, in ordine di competenza e di ampiezza decrescente dei problemi, delle medie, piccole città e dei villaggi).
In generale, le funzioni di un giornale dovrebbero essere equiparate a corrispondenti funzioni dirigenti della vita amministrativa e da questo punto di vista dovrebbero essere impostate le scuole di giornalismo, se si vuole che tale professione esca dallo stadio primitivo e dilettantesco in cui oggi si trova, diventi qualificata e abbia una compiuta indipendenza, cioè il giornale sia in grado di offrire al pubblico informazioni e giudizi non legati a interessi particolari. Se un capocronista informa il pubblico «giornalisticamente», come si dice, ciò significa che il capocronista accetta senza critica e senza giudizio indipendente informazioni e giudizi, attraverso interviste o tuyaux, di persone che intendono servirsi del giornale per promuovere determinati interessi particolari.
Dovrebbero esistere due tipi di capocronaca: 1) il tipo organico e 2) il tipo di più spiccata attualità. Col tipo organico, per dare un punto di vista comprensivo, dovrebbe essere possibile compilare dei volumi sugli aspetti più generali e costanti della vita di una città, dopo aver depurato gli articoli di quegli elementi d’attualità che devono esistere sempre in ogni pubblicazione giornalistica; ma per intendersi, in questi articoli «organici» l’elemento di attualità deve essere subordinato e non principale. Questi articoli organici perciò non devono essere molto frequenti. Il capocronista studia l’organismo urbano nel suo complesso e nella sua generalità, per avere la sua qualifica professionale (solo limitatamente, un capocronista può cambiare di città: la sua superiore qualifica non può non essere legata a una determinata città): i risultati originali, o utili in generale, di questo studio organico, è giusto che non siano completamente disinteressati, che non siano solo premessa, ma si manifestino anche immediatamente, cogliendo uno spunto di attualità. La verità è che il lavoro di un capocronista è altrettanto vasto di quello di un redattore capo, o di un caposervizio in una organizzazione giornalistica con divisione del lavoro organica. In una scuola di giornalismo occorrerebbe avere una serie di monografie su grandi città e sulla loro vita complessa. Il solo problema dell’approvvigionamento di una grande città è tale da assorbire molto lavoro e molta attività (su altre branche d’attività di un capocronista ho scritto altre ). Cfr il libro di W. P. Hedden, How great cities are fed, Boston, Heath, 1929, Doll. 2.80, recensito nel «Giornale degli Economisti» del gennaio 1931. Lo Hedden prende in esame l’approvvigionamento di alcune città degli Stati Uniti, specialmente di New‑York.
Q6 §107 Passato e presente. Giolitti e Croce. Si può osservare, e bisognerà documentare cronologicamente come Giolitti e Croce, uno nell’ordine della politica attuale, l’altro nell’ordine della politica culturale e intellettuale, abbiano commesso gli stessi e precisi errori. L’uno e l’altro non compresero dove andava la corrente storica e praticamente aiutarono ciò che poi avrebbero voluto evitare e cercarono di combattere. In realtà, come Giolitti non comprese quale mutamento aveva portato nel meccanismo della vita politica italiana l’ingresso delle grandi masse popolari, così Croce non capì, praticamente, quale potente influsso culturale (nel senso di modificare i quadri direttivi intellettuali) avrebbero avuto le passioni immediate di queste masse. Da questo punto di vista è da vedere la collaborazione del Croce alla «Politica» di F. Coppola (anche il De Ruggiero vi collaborò nello stesso periodo): come mai il Croce, che aveva assunto un determinato atteggiamento verso Coppola e C. nel periodo 1914‑15 con gli articoli dell’«Italia Nostra» e della «Critica» (e il Coppola era specialmente preso di mira dalle relle di «Italia Nostra» scritte, mi pare, dal De Lollis) poté nel 1919‑20 dare a questo gruppo l’appoggio della sua collaborazione, proprio con articoli in cui il sistema liberale era criticato e limitato? ecc. ecc.
Q6 §108 Letteratura popolare. Cfr il numero della «Cultura» del 1931 dedicato a Dostojevskij. In un articolo del Pozner si sostiene giustamente che i romanzi di Dostojevskij sono derivati (culturalmente) dai romanzi tipo Sue, ecc. Questa «derivazione» è utile tener presente per svolgere questa rubrica sulla letteratura popolare in quanto mostra come un certo tipo «culturale» di letteratura (motivi, interessi morali, sensibilità ideologia, ecc.) può avere una doppia espressione: quella meccanica (tipo Sue) e quella «lirica» (Dostojevskij); i contemporanei non si accorgono che si tratta di manifestazione deteriore per certe manifestazioni, come avvenne per il Sue che fu letto da tutte le classi e «commoveva» anche le persone di coltura mentre poi decadde a «scrittore letto dal popolo». (La «prima lettura» dà sensazioni puramente, o quasi, «culturali» o di contenuto e il «popolo» è lettore di prima lettura, per l’«ideologia»).
Su questo stesso argomento: Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, in 160, pp. x-505, Milano‑Roma, Soc. Ed. La Cultura, L. 40, e la recensione di L. F. Benedetto nel «Leonardo» del marzo 1931. Mi pare da questa recensione (il libro non l’ho letto) che il Praz non abbia fatto con esattezza la distinzione tra i vari gradi di cultura, onde alcune obbiezioni del Benedetto, che d’altronde non coglie il nesso esatto della questione storica.
Q6 §109 Passato e presente. L’individuo e lo Stato. Come la situazione economica è mutata a «danno» del vecchio liberalismo: è vero che ogni cittadino conosce i suoi affari meglio di chiunque altro nelle attuali condizioni? è vero che avviene, nelle attuali condizioni, una selezione secondo i meriti? «Ogni cittadino», in quanto non può conoscere e specialmente non può controllare le condizioni generali in cui gli affari si svolgono data l’ampiezza del mercato mondiale e la sua complessità, in realtà non conosce neanche i propri affari: necessità delle grandi organizzazioni industriali, ecc. Inoltre lo Stato, col regime sempre più gravoso delle imposte, colpisce i cittadini propri, ma non può colpire i cittadini delle altre nazioni (meno tassate, o con regimi di tasse che distribuiscono diversamente le imposte); i grandi Stati, che devono avere grandi spese per servizi pubblici imponenti (compresi esercito, marina, ecc.) colpiscono di più i cittadini propri (si aggiunge la disoccupazione sussidiata, ecc.). Ma l’intervento dello Stato con le tariffe doganali crea una nuova base? Lo Stato, con le tariffe «sceglie» tra i cittadini quelli da proteggere anche se non «meritevoli», ecc., scatena una lotta tra i gruppi per la divisione del reddito nazionale, ecc.
Q6 §110 Machiavelli e Guicciardini. Nel libro di Clemenceau, Grandeurs et misères d’une victoire, Plon, 1930, nel capitolo «Les critiques de l’escalier» sono contenute alcune delle osservazioni generali da me fatte nella nota sull’articolo di Paolo Treves, Il realismo politico di Guicciardini: per es. la distinzione tra politici e diplomatici. I diplomatici sono stati formati (dressés) per l’esecuzione, non per l’iniziativa, dice Clemenceau, ecc. Il capitolo è tutto di polemica contro Poincaré che aveva rimproverato il non impiego dei diplomatici nella preparazione del trattato di Versailles. Clemenceau, da puro uomo d’azione, da puro politico, è estremamente sarcastico contro Poincaré, il suo spirito avvocatesco, le sue illusioni che si possa creare la storia coi cavilli, coi sotterfugi, con le abilità formali, ecc. «La diplomatie est instituée plutôt pour le maintien des inconciliables que pour l’innovation des imprévus. Dans le mot “diplomate” il y a la racine double, au sens de plier». (È vero però che questo concetto di doppio non si riferisce ai «diplomatici» ma ai «diplomi» che i diplomatici conservavano e aveva un significato materiale, di foglio piegato).
Q6 §111 Letteratura popolare. Romanzi d’appendice. Cfr Servais Étienne, Le genre romanesque en France depuis l’apparition de la «Nouvelle Héloise» jusqu’aux approches de la Révolution, ed. Armand Colin; Reginald W. Hartland, Le Roman terrifiant ou «Roman noir» de Walpole à Anne Radcliffe, et son influence sur la littérature française jusqu’en 1860 (ed. Champion), e Walter Scott et le «Roman frénétique» (ed. Champion).
L’affermazione del Pozner registrata in una nota precedente, che il romanzo di Dostojevskij sia romanzo «d’avventure» è probabilmente derivata da uno studio di Jacques Rivière sul «romanzo d’avventure» (forse uscito nella «N.R.F.»), che significherebbe «una vasta rappresentazione di azioni che sono insieme drammatiche e psicologiche» così come l’hanno concepito Balzac, Dostojevskij, Dickens e Giorgio Eliot.
Su Le style du roman‑feuilleton ha scritto un saggio André Moufflet nel «Mercure de France» del 1° febbraio 1931.
Q6 §112 Passato e presente. L’utopia crociana. Cfr la nota in cui si ricorda la collaborazione data dal Croce negli anni 19‑20‑21 (vedere) alla «Politica» del Coppola, in contraddizione con l’atteggiamento che verso Coppola, la sua ideologia e la sua particolare forma mentis, aveva assunto nel 15 l’«Italia Nostra». Da questo si può vedere e giudicare il carattere «utopistico» della attività teorica e pratica del Croce, dico «utopistico» nel senso che le conseguenze che dipendono dall’atteggiamento del Croce sono contrarie alle sue «intenzioni» quali risultano dall’atteggiamento successivo verso queste conseguenze.
Il Croce crede di fare della «scienza pura», della pura «storia», della pura «filosofia», ma in realtà fa dell’«ideologia», offre strumenti pratici di azione a determinati gruppi politici; poi si maraviglia che essi non siano stati «compresi» come «scienza pura» ma «distolti» dal loro fine proprio che era puramente scientifico. Cfr per es. nel volume Cultura e vita morale i due capitoli: «Fissazione filosofica» a p. 296 e il capitolo «Fatti politici e interpretazioni storiche» a p. 270.
A p. 296 il Croce protesta contro il famoso discorso del Gentile tenuto a Palermo nel 1924: «Ma, se in un certo luogo del pianeta che si chiama Terra, i cittadini di uno Stato che prima avevano l’uso di dibattere i loro affari mercè quei «modi di forza» che sono la critica e l’oratoria e l’associazione e la votazione e altri siffatti, hanno adottato l’altro uso di ricorrere al bastone o al pugnale, e c’è tra essi di coloro che rimpiangono il vecchio costume e si adoperano a far cessare il nuovo che qualificano come selvaggio, quale mai parte adempie il filosofo che, intervenendo nella contesa, sentenzia che ogni forza, e perciò anche quella del bastone e del pugnale, è forza spirituale?» ecc. ecc. (la continuazione è interessante e deve essere citata, se del caso); ma egli stesso a p. 270 aveva scritto: «Fare poesia è un conto e fare a pugni è un altro, mi sembra; e chi non riesce nel primo mestiere, non è detto che non possa riuscire benissimo nel secondo, e nemmeno che la eventuale pioggia di pugni non sia, in certi casi, utilmente ed opportunamente somministrata». Così scrisse il Croce nel 1924: è probabile che il Gentile nel 24 abbia proprio voluto filosofare quell’«utilmente ed opportunamente» e ai pugni abbia aggiunto il bastone e magari il pugnale. Né il Croce arriverà solo fino ai «pugni» e non oltre (d’altronde anche coi pugni si ammazza, e c’è anzi una misura di pubblica sicurezza contro i «pugni proibiti»).
Il Gentile ha posto in linguaggio «attualistico» la proposizione crociana basata sulla distinzione di logica e di pratica; per il Croce ciò è grossolano, ma intanto così avviene sempre ed è una bella pretesa quella di volere essere intesi alla perfezione e di giustificarsi per non essere stato compreso. Si può confrontare in altri capitoli ciò che il Croce ha scritto sull’intolleranza, sull’inquisizione, ecc. e vedere i suoi diversi stati d’animo: dai punti esclamativi, che egli diceva essere anch’essi mezzi da Santa Inquisizione per premere sull’altrui volontà, è dovuto ritornare al bastone e al pugnale che si è visto riapparire dinanzi come mezzi di persuasione della verità.
Q6 §113 Risorgimento. Campagna e città. Pare che da questo punto di vista sia interessante il saggio di Carlo Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle istorie italiane pubblicato da G. A. Belloni presso l’edit. Vallecchi (1930 o 31). Il saggio era apparso a puntate nel «Crepuscolo» del 1858 e non fu mai raccolto nelle opere del Cattaneo curate dal Bertani, da Gabriele Rosa e dalla Mario. Secondo il Belloni il concetto esposto dal Cattaneo della necessità dell’unione tra città e campagna per il Risorgimento italiano era già stato affermato dal Romagnosi. Potrebbe il Cattaneo averlo preso anche dalla letteratura francese democratica del tempo, che seguiva la tradizione giacobina (cfr per es. I Misteri del Popolo del Sue che ebbero tanta diffusione anche in Italia). In ogni caso il fatto importante sarebbe stato non di esprimere quel concetto, ma di dargli un’espressione politica italiana immediata, ciò che appunto mancò e anzi fu voluto evitare sistematicamente dai partiti democratici del Risorgimento.
Q6 §114 Risorgimento. Cfr per alcuni episodi il libro di F. Martini, Confessioni e Ricordi (1859‑1892), Treves, Milano, 1928. Del libro sono interessanti alcuni capitoli: il primo «Per cominciare e per finire» è interessante per l’atteggiamento politico dei moderati toscani nel 1859 che non è stato solo un mero fatto di psicologia da descrivere bonariamente, come fa il Martini, ma un netto atteggiamento politico, legato a convinzioni e a una linea precisa, come dimostrano i documenti recentemente pubblicati (cfr articolo di Panella nel «Marzocco» e polemica col Puccioni). I moderati toscani non volevano la fine del granducato, erano federalisti reazionari. Gli episodi di abulia militare in Toscana nel 59 non sono solo da collegare con la «psicologia» del popolo toscano, come fa il Martini: fu un sabotaggio della guerra nazionale o per lo meno una forma di «neutralità» sabotatrice. Lo scarso numero dei «volontari» fu una conseguenza della cattiva volontà dei moderati.
Anche l’importanza dell’intervento francese nel 59 è messa più in rilievo da questi fatti: come, dalle parole testuali del Martini, è posta in rilievo l’assenza completa di coscienza e orgoglio nazionale nei moderati, i quali dicevano che l’«imperatore deve l’ar lui la guerra», cioè che non l’Italia deve liberarsi da sé, ma la Francia deve liberare l’Italia. Si capisce come nella tradizione burocratica francese della politica estera si siano formate certe convinzioni e si sia costituita una linea nei riguardi dell’apprezzamento del personale dirigente italiano.
Altro capitolo interessante è «Parlamentum indoctum», dove si possono trovare spunti sulla preparazione intellettuale di molti uomini politici del tempo. Il Martini bonariamente giustifica l’ignoranza crassa di uomini come Nicotera, affermando che le congiure e l’ergastolo non avevano loro lasciato il tempo di studiare. Certo la vita del Nicotera non era fatta per permettere studi «regolari»; ma il Settembrini fu anch’egli all’ergastolo e pure non perse il tempo. Qualche meridionale, seccato dalla letteratura retorica contro i Borboni (già prima della guerra, ricordo un articolo di Oreste Mosca nella «Vela latina» di F. Russo) scrisse che in Piemonte (con 5 milioni di abitanti) c’erano 5 ergastoli come a Napoli con 10 milioni di abitanti, per cui, o in Piemonte c’era più reazione, o c’era più delinquenza; in ogni caso Napoli non ci faceva poi tanto cattiva figura. Detto in forma paradossale, il fatto è giusto: negli ergastoli napoletani i patriotti stavano relativamente meglio che negli ergastoli piemontesi dove dominarono i gesuiti per molto tempo e una burocrazia militare e civile ben più fiscale e «regolamentatrice» di quella napoletana. Gli ergastolani non avevano la catena ai piedi ed erano in compagnia: la loro condanna era «psicologicamente e moralmente» più grave di quella ai lavori forzati a tempo, ma non «materialmente»: la gravità consisteva che molti ergastolani erano stati condannati a morte, avevano «realmente» creduto di stare per essere giustiziati e poi, all’ultimo momento, furono graziati: per altro, l’ergastolo non poteva essere ritenuto veramente tale da uomini politici che non potevano ritenere che il regime borbonico sarebbe durato quanto la loro vita. Ciò sia detto senza togliere nulla alla valutazione dei loro patimenti. Di fatto essi «potevano studiare», ma alcuni lo fecero (Settembrini, per es.), altri no (Nicotera, per es.) e quindi la ragione addotta dal Martini, per non essere universale, non è valida. La ragione deve essere ricercata altrove e cioè nella scarsa coscienza di classe rivoluzionaria di molti di quegli uomini e dei doveri che spettavano a ogni elemento di tale classe; cioè scarsa passione politica da non confondersi col fanatismo e settarismo, che invece abbondavano.
Su Vittorio Emanuele II il Martini racconta a pp. 152-153 questo aneddoto riferitogli da Quintino Sella: Nell’ottobre 1870 Vittorio Emanuele ricevette a Palazzo Pitti la deputazione romana che gli portava il plebiscito di Roma. Presenti Lanza e Sella. Il Sella gli disse: «Vostra Maestà deve essere oggi molto lieta». Vittorio Emanuele rispose: «Ca staga ciutu; am resta nen aut che tireme un coulp de revolver; per l’on c’am resta da vive ai sarà pi nen da piè». Perciò il Sella chiamava Vittorio Emanuele «l’ultimo dei conquistatori».
Q6 §115 I nipotini di padre Bresciani. Angelo Gatti. Suo romanzo Ilia e Alberto pubblicato nel 1931 (vedi): romanzo autobiografico. Il Gatti si è convertito al cattolicismo gesuitico. Tutta la chiave, il nodo centrale del romanzo, è in questo fatto: Ilia, donna sana, riceve in bocca gocciole di saliva di un tubercolotico, per uno starnuto o un colpo di tosse (o che so io – non ho letto il romanzo, ma solo delle recensioni) o altro; diventa tubercolotica e muore.
Mi pare strano e puerile che il Gatti abbia insistito su questo particolare meccanico ed esterno, che pure nel romanzo deve essere importante, se un recensore ci si è trattenuto. Ricorda le solite sciocchezze che le comari dicono per spiegare le infezioni. Forse Ilia stava sempre a bocca aperta dinanzi alla gente che le tossiva e le starnutava sul viso in tramvai e nelle calche dove si sta pigiati? E come ha potuto accertare che proprio quella sia stata la causa del contagio? O si tratta di un ammalato che a bella posta infettava la gente sana? È veramente strabiliante che il Gatti si sia servito di questa ficelle per il suo romanzo.
Q6 §116 Il Rinascimento (Fase economica‑corporativa della storia italiana). Origini della letteratura e della poesia volgare. Vedere gli studi di Ezio Levi su Uguccione da Lodi e i primordi della poesia italiana e altri studi posteriori (1921) su gli antichi poeti lombardi, con l’edizione delle rime, commento e piccole biografie. Il Levi sostiene che si tratta di un «fenomeno letterario», «accompagnato da un movimento di pensiero» e rappresentante «il primo affermarsi della nuova coscienza italiana, in contrapposizione alla età medioevale, pigra e sonnolenta» (cfr S. Battaglia, Gli studi sul nostro duecento letterario, nel «Leonardo» del febbraio 1927). La tesi del Levi è interessante e deve essere approfondita. Naturalmente come tesi di storia della cultura e non di storia dell’arte. Il Battaglia scrive che «il Levi scambia questa modesta produzione rimata, che serba i caratteri e gli atteggiamenti di evidente natura popolare, per un fenomeno letterario» ed è possibile che il Levi, come spesso avviene in tali casi, esageri l’importanza artistica di questi scrittori; ma che significa ciò? E che significa la «natura popolare» contrapposta alla «letteraria»?
Quando una nuova civiltà sorge, non è naturale che essa assuma forme «popolari» e primitive, che siano uomini «modesti» ad esserne i portatori? E ciò non è tanto più naturale in tempi quando la cultura e la letteratura erano monopolio di caste chiuse? Ma poi, al tempo di Uguccione da Lodi, ecc., anche nel ceto colto, esistevano grandi artisti e letterati? Il problema posto dal Levi è interessante perché le sue ricerche tendono a dimostrare che i primi elementi del Rinascimento non furono di origine aulica o scolastica, ma popolare, e furono espressione di un movimento generale culturale religioso (patarino) di ribellione agli istituti medioevali, chiesa e impero. La statura poetica di questi scrittori lombardi non sarà stata molto alta, la loro importanza storico-culturale non è perciò diminuita.
Altro pregiudizio sia del Battaglia che del Levi è che nel Duecento debba cercarsi e trovarsi l’origine di una «nuova, civiltà italiana»; una ricerca di tal genere è puramente retorica e segue interessi pratici moderni. La nuova civiltà non è «nazionale», ma di classe e assumerà forma «comunale» e locale non unitaria, non solo «politicamente», ma neanche «culturalmente». Nasce «dialettale» pertanto e dovrà aspettare la maggior fioritura del 300 toscano per unificarsi, fino a un certo punto, linguisticamente. L’unità culturale non era un dato esistente precedentemente, tutt’altro; esisteva una «universalità europeo‑cattolica» culturale e la nuova civiltà reagisce a questo universalismo, di cui l’Italia era la base, con i dialetti locali e col portare in primo piano gli interessi pratici dei gruppi borghesi municipali. Ci troviamo quindi in un periodo di disfacimento e disgregazione del mondo culturale esistente, in quanto le forze nuove non si inseriscono in questo mondo, ma vi reagiscono contro sia pure inconsapevolmente e rappresentano elementi embrionali di una nuova cultura. Lo studio delle eresie medioevali diventa necessario (Tocco, Volpe, ecc.). Lo studio del Battaglia, Gli studi sul nostro duecento letterario, «Leonardo», gennaio‑febbraio‑marzo 1927, è utile per i richiami bibliografici, ecc.
Q6 §117 Passato e presente. «Una resistenza che si prolunga troppo in una piazza assediata è demoralizzante di per se stessa. Essa implica sofferenze, fatiche, privazioni di riposo, malattie e la imminenza continua non già del pericolo acuto che tempra, ma del pericolo cronico che abbatte». Carlo Marx, Quistione Orientale, articolo del 14 settembre 1855 (Opere politiche, tomo VIII, p. 22).
Q6 §118 Il Rinascimento. Origini (cfr nota p. 50 bis). Si confondono due momenti della storia: 1) la rottura con la civiltà medioevale, il cui documento più importante fu l’apparizione dei volgari; 2) l’elaborazione di un «volgare illustre», cioè il fatto che si raggiunse una certa centralizzazione fra i gruppi intellettuali, cioè, meglio, tra i letterati di professione. In realtà i due momenti, pur essendo collegati, non si saldarono completamente. I volgari incominciano ad apparire per ragioni religiose (giuramenti militari, testimonianze di carattere giuridico per fissare diritti di proprietà, prestate da contadini che non conoscevano il latino), frammentariamente, casualmente: che in volgare si scrivano opere letterarie, qualunque sia il loro valore, è ancora un fatto nuovo, è il fatto realmente importante. Che tra i volgari locali, uno, quello toscano, raggiunga una egemonia, è un altro fatto ancora, che però occorre limitare: esso non è accompagnato da una egemonia politico‑sociale, e perciò rimane confinato a un puro fatto letterario. Che il volgare scritto appaia in Lombardia come prima manifestazione di una certa portata, è fatto da mettere in grande rilievo; che sia legato al patarinismo è fatto anch’esso molto importante. In realtà la borghesia nascente impone i propri dialetti, ma non riesce a creare una lingua nazionale: se questa nasce, è confinata ai letterati e questi vengono assorbiti dalle classi reazionarie, dalle corti, non sono «letterati borghesi», ma aulici. E non avviene questo assorbimento senza contrasto. L’Umanesimo dimostra che il «latino» è molto forte, ecc. Un compromesso culturale, non una rivoluzione, ecc.
Q6 §119 Risorgimento. Tradizioni militari del Piemonte. Non esistevano in Piemonte fabbriche di armi: le armi dovevano tutte essere comprate all’estero. Come «tradizione» militare non c’è male. Su questo argomento sarà bene fare delle ricerche. Le armi che Carlo Alberto mandò al Sonderbund svizzero, e che sguarnirono il Piemonte prima del 48, furono vendute e a quanto o regalate? Il Piemonte ci perdette? Quando fu impiantata la prima fabbrica d’armi?
Nel discorso di Cavour al Senato del 23 maggio 1851 si dice appunto che non esistono fabbriche e che si spera, dopo il ribasso del prezzo del ferro che sarà determinato dalla politica liberista (trattato con l’Inghilterra) che fabbriche di armi potranno nascere.
Q6 §120 Riviste‑tipo. L’essere evolutivo finale. Aneddoto del corso di storia della filosofia del prof. D’Ercole e dell’«essere evolutivo finale». Per quarant’anni non parlò che della filosofia cinese e di Lao‑tse: ogni anno «nuovi allievi» che non avevano sentito le lezioni dell’anno precedente e quindi occorreva ricominciare. Così tra le generazioni di allievi «l’essere evolutivo finale» diventò una leggenda.
In certi movimenti culturali, che arruolano i loro elementi tra chi inizia solo allora la propria vita culturale, per il rapido estendersi del movimento stesso che conquista sempre nuovi adepti, e perché i già conquistati non hanno autoiniziativa culturale, non pare possibile uscire mai dall’abc. Questo fatto ha gravi ripercussioni nell’attività giornalistica in generale, quotidiani, settimanali, riviste, ecc.; pare che non si debba mai superare un certo livello. D’altronde, il non tener conto di questo ordine di esigenze, spiega il lavoro di Sisifo delle così dette «piccole riviste», che si rivolgono a tutti e a nessuno e a un certo punto diventano veramente del tutto inutili. L’esempio più tipico è stato quello della «Voce», che a un certo punto si scisse in «Lacerba» «La Voce» e l’«Unità» con la tendenza in ognuna a scindersi all’infinito. Le redazioni, se non sono legate a un movimento disciplinato di base, tendono, o a diventare conventicole di «profeti disarmati», o a scindersi secondo i movimenti incomposti e caotici che si determinano tra i diversi gruppi e strati di lettori.
Bisogna quindi riconoscere apertamente che le riviste di per sé sono sterili, se non diventano la forza motrice e formatrice di istituzioni culturali a tipo associativo di massa, cioè non a quadri chiusi. Ciò deve dirsi anche per le riviste di partito; non bisogna credere che il partito costituisca di per sé l’«istituzione» culturale di massa della rivista. Il partito è essenzialmente politico e anche la sua attività culturale è attività di politica culturale: le «istituzioni» culturali devono essere non solo di «politica culturale», ma di «tecnica culturale». Esempio: in un partito ci sono degli analfabeti e la politica culturale del partito è la lotta contro l’analfabetismo. Un gruppo per la lotta contro l’analfabetismo non è ancora precisamente una «scuola per analfabeti»; in una scuola per analfabeti si insegna a leggere e a scrivere; in un gruppo per la lotta contro l’analfabetismo si predispongono tutti i mezzi più efficaci per estirpare l’analfabetismo dalle grandi masse della popolazione di un paese, ecc.
Q6 §121 Giornalismo. Albert Rival, Le journalisme appris en 18 leçons, Albin Michel, 1931, L. 3,50. In quattro parti: 1) Storia del giornalismo: Origini del giornalismo. I grandi giornalisti. 2) Come si fa un giornale: Redazione. Impressione: composizione, correzione, impaginazione, clichérie, tiratura. 3) Qualità richieste a un giornalista: Cos’è un giornalista? Attitudini richieste. Qualità richieste. La donna può aspirare al giornalismo? 4) Lo stile del giornalista: Stile in generale. Generi di stile. Della composizione. La descrizione. Come non bisogna scrivere. L’articolo d’informazione. Il grande reportage: come vien fatto. L’articolo di fondo. L’articolo polemico. Organizzazione d’un giornale. (Schema elementare e difettoso. Manca l’accenno ai diversi tipi di giornali, ecc.).
Q6 §122 Riviste‑tipo. Rassegne. Rassegne su argomenti di giurisprudenza che interessano determinati movimenti. Per esempio: il concetto di «impiegato» secondo la giurisprudenza italiana, il concetto di «mezzadro», di «capotecnico», ecc., ciò che significa: quale posizione hanno, nella giurisprudenza italiana, le figure economiche di «impiegato», di «mezzadro», di «capotecnico», ecc. e per quali ragioni teorico‑pratiche?
Le collezioni di riviste come «Il Foro italiano», ecc., con le sentenze pubblicate e gli articoli scritti da specialisti che le commentano, dovrebbero essere attentamente compulsate, per vedere quando certe quistioni si pongono e per quali ragioni, come si sviluppano, a quale sistemazione giungono (se giungono), ecc. In fondo anche questo è un aspetto (e molto importante) della storia del lavoro, cioè il riflesso giuridico‑legislativo del movimento storico reale: vedere come questo riflesso si atteggi significa studiare un aspetto della reazione statale al movimento stesso, ecc. Accanto alle sentenze e agli articoli di queste riviste tecniche, bisognerebbe vedere le altre pubblicazioni di diritto (libri, riviste, ecc.), che in questi ultimi anni si sono moltiplicate in modo impressionante, anche se la qualità è scadente.
Q6 §123 Passato e presente. Osservazioni sulla crisi 29‑30‑?. Cfr numero di «Economia» del marzo 1931 dedicato a La depressione economica mondiale: i due articoli di P. Jannaccone e di Gino Arias. Lo Jannaccone osserva che «la causa prima» (! sic) della crisi «è un eccesso, non un difetto di consumo», cioè che siamo di fronte a una profonda e, assai probabilmente, non passeggera perturbazione dell’equilibrio dinamico fra la quota consumata e la quota risparmiata del reddito nazionale e il ritmo della produzione necessario per mantenere in un tenore di vita, immutato o progrediente, una popolazione che aumenta a un determinato saggio di incremento netto. La rottura di tale equilibrio può verificarsi in più modi: espansione della quota di reddito consumata a danno di quella risparmiata e reinvestita per la produzione futura; diminuzione del saggio di produttività dei capitali, aumento del saggio di incremento netto della popolazione. A un certo punto, cioè, il reddito medio individuale da crescente diviene costante e da costante progressivamente decrescente: scoppiano a questo punto le crisi, la diminuzione del reddito medio porta a una contrazione anche assoluta del consumo e per riflesso a ulteriori riduzioni della produzione, ecc. La crisi mondiale, così, sarebbe crisi di risparmio e «il rimedio sovrano per arginarla, senza che si abbassi il saggio d’incremento (netto) della popolazione, sta nell’aumentare la quota di reddito destinata al risparmio e alla formazione di capitali nuovi. Questo è l’ammonimento di alto valore morale che sgorga dai ragionamenti della scienza economica».
Le osservazioni dello Jannaccone sono indubbiamente acute: l’Arias ne trae però delle conclusioni puramente tendenziose e in parte imbecilli. Ammessa la tesi dello Jannaccone è da domandare: a che cosa è da attribuire l’eccesso di consumo? Si può provare che le masse lavoratrici abbiano aumentato il loro tenore di vita in tale proporzione da rappresentare un eccesso di consumo? Cioè il rapporto tra salari e profitti è diventato catastrofico per i profitti? Una statistica non potrebbe dimostrare questo neppure per l’America. L’Arias «trascura» un elemento «storico» di qualche importanza: non è avvenuto che nella distribuzione del reddito nazionale attraverso specialmente il commercio e la borsa, si sia introdotta, nel dopoguerra (o sia aumentata in confronto del periodo precedente), una categoria di «prelevatori» che non rappresenta nessuna funzione produttiva necessaria e indispensabile, mentre assorbe una quota di reddito imponente? Non si bada che il «salario» è sempre legato necessariamente a un lavoro (bisognerebbe distinguere però il salario o la mercede che assorbe la categoria di lavoratori addetti al servizio delle categorie sociali improduttive e assolutamente parassitarie), (ci sono inoltre lavoratori infermi o disoccupati che vivono di pubblica carità o di sussidi) e il reddito assorbito dal salariato è identificabile quasi al centesimo. Mentre è difficile identificare il reddito assorbito dai non‑salariati che non hanno una funzione necessaria e indispensabile nel commercio e nell’industria. Un rapporto tra operai «occupati» e il resto della popolazione darebbe l’immagine del peso «parassitario» che grava sulla produzione. Disoccupazione di non‑salariati: essi non sono passibili di statistica, perché «vivono» in qualche modo di mezzi propri, ecc. Nel dopoguerra la categoria degli improduttivi parassitari in senso assoluto e relativo è cresciuta enormemente ed è essa che divora il risparmio. Nei paesi europei essa è ancora superiore che in America, ecc. Le cause della crisi non sono quindi «morali» (godimenti, ecc.) né politiche, ma economico‑sociali, cioè della stessa natura della crisi stessa: la società crea i suoi propri veleni, deve far vivere delle masse (non solo di salariati disoccupati) di popolazione che impediscono il risparmio e rompono così l’equilibrio dinamico.
Q6 §124 Croce e la critica letteraria. L’estetica di Croce sta diventando normativa, sta diventando una «rettorica»? Bisognerebbe aver letto la sua Aesthetica in nuce (che è l’articolo sull’estetica dell’ultima edizione dell’Encyclopedia Britannica). Un’affermazione di essa dice che compito precipuo dell’estetica moderna ha da essere «la restaurazione e difesa della classicità contro il romanticismo, del momento sintetico e formale e teoretico, in cui è il proprio dell’arte, contro quello affettivo, che l’arte ha per istituto di risolvere in sé». Questo brano mostra quali siano le preoccupazioni «morali» del Croce, oltre che le sue preoccupazioni estetiche, cioè le sue preoccupazioni «culturali» e quindi «politiche». Si potrebbe domandare se l’estetica, come scienza, possa avere altro compito oltre quello di elaborare una teoria dell’arte e della bellezza, dell’espressione. Qui estetica significa «critica in atto» in «concreto», ma la critica in atto non dovrebbe solo criticare, cioè fare la storia dell’arte in concreto, delle «espressioni artistiche individuali»?
Q6 §125 Riviste‑tipo. Storia e «progresso». La storia ha raggiunto un certo stadio; pare che perciò sia antistorico ogni movimento che appare in contrasto con quel certo stadio, in quanto «riproduce» uno stadio precedente; in questi casi si arriva a parlare di reazione, ecc. La quistione nasce dal non concepire la storia come storia di classi. Una classe ha raggiunto un certo stadio, ha costruito una certa forma di vita statale: la classe dominata, che insorge, in quanto spezza questa realtà acquisita, è perciò reazionaria?
Stati unitari, movimenti autonomisti; lo Stato unitario è stato un progresso storico, necessario, ma non perciò si può dire che ogni movimento tendente a spezzare gli Stati unitari sia antistorico e reazionario; se la classe dominata non può raggiungere la sua storicità altro che spezzando questi involucri, significa che si tratta di «unità» amministrative militari‑fiscali, non di «unità» moderne; può darsi che la creazione di tale unità moderna domandi che sia spezzata l’unità «formale» precedente, ecc. Dove esiste più unità moderna: nella Germania «federale» o nella «Spagna» unitaria di Alfonso e dei proprietari‑generali‑gesuiti? ecc. Questa osservazione può essere estesa a molte altre manifestazioni storiche, per esempio al grado di «cosmopolitismo» raggiunto nei diversi periodi dello sviluppo culturale internazionale. Nel 700 il cosmopolitismo degli intellettuali è stato «massimo», ma quanta frazione dell’insieme sociale esso toccava? E non si trattava in gran parte di una manifestazione egemonica della cultura e dei grandi intellettuali francesi?
È certo tuttavia che ogni classe dominante nazionale è più vicina alle altre classi dominanti, come cultura e costumi, che non avvenga tra classi subalterne, anche se queste sono «cosmopolite» per programma e destinazione storica. Un gruppo sociale può essere «cosmopolita» per la sua politica e la sua economia e non esserlo per i costumi e anche per la cultura (reale).
Q6 §126 Riviste‑tipo. Serie di guide o manualetti per il lettore di giornali (e per il lettore in generale). Come si legge un listino di borsa, un bilancio di società industriale, ecc. (Non lunghi e solo i dati schematici fondamentali). Il riferimento dovrebbe essere il lettore medio italiano, che in generale è poco informato di queste nozioni, ecc.
L’insieme di questi manualetti potrebbe formare una collezione popolare di primo grado, che potrebbe svilupparsi in una seconda collezione di «secondo grado» di testi più complessi e comprensivi, ecc. – ambedue di tipo scolastico e compilati come sussidio a ipotetiche lezioni – e le due collezioni dovrebbero essere come introduttive alle collezioni dei testi scientifici di cultura generale e alle collezioni per specialisti. Cioè quattro collezioni: due scolastiche e due generali, graduate in più e meno elementari ognuna nel suo genere.
Q6 §127 Quistioni industriali. Nella «Revue des Deux Mondes» del 15 novembre 1930 è pubblicata la memoria letta all’Accademia di Scienze morali e politiche di Parigi da Eugenio Schneider, il capo della ditta del Creusot su Les relations entre patrons et ouvriers. Les délégués de corporation. La memoria è molto importante, specialmente per il mio assunto. Come a Torino, lo Schneider (per fini diversi, di disgregazione) ha organizzato le delegazioni come «delegati professionali» (corporation). Ma i delegati non formano un corpo deliberante e non hanno un comitato direttivo, ecc. Tuttavia il tentativo dello Schneider è di primo ordine, ecc. Analizzarlo. Cercare altre pubblicazioni in proposito.
Q6 §128 Centralismo organico ecc. Lo Schneider cita queste parole di Foch: «Commander n’est rien. Ce qu’il faut, c’est bien comprendre ceux avec qui on a affaire et bien se faire comprendre d’eux. Le bien comprendre, c’est tout le secret de la vie...». Tendenza a separare il «comando» da ogni altro elemento e a farne un «toccasana» di nuovo genere. E ancora occorre distinguere tra il «comando» espressione di diversi gruppi sociali: da gruppo a gruppo l’arte del comando e il suo modo di esplicarsi muta di molto, ecc. Il centralismo organico, col comando caporalesco e «astrattamente» concepito, è legato a una concezione meccanica della storia e del movimento, ecc.
Q6 §129 Passato e presente. La politica di D’Annunzio. Sono interessanti alcune pagine del volume Per l’Italia degli Italiani, Milano, «Bottega di Poesia», 1923. In un punto ricorda la sua tragedia La Gloria e se ne richiama per la sua politica verso i contadini che devono «regnare» perché sono i «migliori». Concetti politici reali neanche uno: frasi ed emozioni, ecc.
A proposito delle 2000 lire date per gli affamati della carestia del 1921 cerca, in fondo, di farle dimenticare, presentando l’offerta come un tratto di politica «machiavellica»: avrebbe dato per ringraziare di aver liberato il mondo da un’illusione, ecc. Si potrebbe studiare la politica di D’Annunzio come uno dei tanti ripetuti tentativi di letterati (Pascoli, ma forse bisogna risalire a Garibaldi) per promuovere un nazionalsocialismo in Italia (cioè per condurre le grandi masse all’«idea» nazionale o nazionalista‑imperialista).
Q6 §130 Nozioni enciclopediche. Congiuntura. Origine dell’espressione: serve a capire meglio il concetto. In italiano = fluttuazione economica. Legata ai fenomeni del dopoguerra molto rapidi nel tempo. (In italiano il significato di «occasione economica favorevole o sfavorevole» rimane alla parola «congiuntura»; differenza tra «situazione» e «congiuntura»: la congiuntura sarebbe il complesso dei caratteri immediati e transitori della situazione economica, e per questo concetto bisognerebbe allora intendere i caratteri più fondamentali e permanenti della situazione stessa. Lo studio della congiuntura quindi legato più strettamente alla politica immediata, alla «tattica» e all’agitazione, mentre la «situazione» alla «strategia» e alla propaganda, ecc.)
Q6 §131 Passato e presente. Caratteri. Etica e politica. È da notare la virulenza di certe polemiche tra uomini politici per il loro carattere personalistico e moralistico. Se si vuole diminuire o annientare l’influsso politico di una personalità o di un partito, non si tenta di dimostrare che la loro politica è inetta o nociva, ma che determinate persone sono canaglie, ecc., che non c’è «buona fede», che determinate azioni sono «interessate» (in senso personale e privato), ecc. È una prova di elementarietà del senso politico, di livello ancor basso della vita nazionale; è dovuto al fatto che realmente esiste un vasto ceto che «vive» della politica in «mala fede» cioè senza avere convinzioni; è legato alla miseria generale, per cui facilmente si crede che un atto politico è dovuto a cause pecuniarie, ecc. «Inetto ma galantuomo», modi di dire curiosi in politica: si riconosce uno inetto, ma poiché lo si crede «galantuomo», ci si affida a lui; ma «inetto» in politica non corrisponde a «briccone» in morale? È vero che le conseguenze di queste campagne moralistiche lasciano di solito il tempo che trovano, se non sono uno strumento per determinare l’opinione pubblica popolare ad accettare una determinata «liquidazione» politica, o a domandarla, ecc.
Q6 §132 Storia delle classi subalterne. Su alcuni aspetti del movimento del 1848 in Italia, in quanto riflettono le teorie degli utopisti francesi, cfr Petruccelli della Gattina, La rivoluzione di Napoli nel 1848, 2a ed., 1912, a cura di Francesco Torraca; Mondaini, I moti politici del 48; G. De Ruggiero, Il pensiero politico meridionale.
Q6 §133 Per una nuova letteratura (arte) attraverso una nuova cultura. Cfr nel volume di B. Croce, Nuovi saggi sulla letteratura italiana del seicento (1931), il capitolo in cui parla delle accademie gesuitiche di poesia e le ravvicina alle «scuole di poesia» create in Russia (il Croce avrà preso lo spunto dal solito Fülöp‑Miller). Ma perché non le avvicina alle botteghe di pittura e di scultura del 400‑500? Erano anche quelle «accademie gesuitiche»? E perché ciò che si faceva per la pittura e la scultura non potrebbe farsi per la poesia? Il Croce non tiene conto dell’elemento sociale che «vuole avere» una propria poesia, elemento «senza scuola», cioè che non si è impadronito della «tecnica» e dello stesso linguaggio: in realtà si tratta di una «scuola» per adulti, che educa il gusto e crea il sentimento «critico» in senso largo. Un pittore che «copia» un quadro di Raffaello fa «accademia gesuitica»? Egli nel modo migliore «si cala» nell’arte di Raffaello, cerca di ricrearsela, ecc. E perché non potrebbero farsi esercizi di versificazione fra operai? Non servirà ciò a educare l’orecchio alla musicalità del verso, ecc..
Q6 §134 Letteratura popolare. Romanzo d’appendice. Cfr ciò che ho scritto a proposito del Conte di Montecristo come modello esemplare di romanzo d’appendice. Il romanzo d’appendice sostituisce (e favorisce nel tempo stesso) il fantasticare dell’uomo del popolo, è un vero sognare ad occhi aperti. Si può vedere ciò che sostengono Freud e i psicanalisti sul sognare ad occhi aperti. In questo caso si può dire che nel popolo il fantasticare è dipendente dal «complesso di inferiorità» (sociale) che determina lunghe fantasticherie sull’idea di vendetta, di punizione dei colpevoli dei mali sopportati, ecc. Nel Conte di Montecristo ci sono tutti gli elementi per cullare queste fantasticherie e per quindi propinare un narcotico che attutisca il senso del male, ecc.
Q6 §135 Passato e presente. Il fordismo. A parte il fatto che gli alti salari non rappresentano nella pratica industriale del Ford ciò che Ford teoricamente vuol far loro significare (cfr sul significato essenziale degli alti salari come mezzo per selezionare una maestranza adatta al fordismo sia come metodo di produzione e di lavoro, sia come sistema commerciale e finanziario: necessità di non avere interruzioni nel lavoro, quindi open shop, ecc.) è da notare: in certi paesi di capitalismo arretrato e di composizione economica in cui si equilibrano la grande industria moderna, l’artigianato, la piccola e media cultura agricola e il latifondismo, le masse operaie e contadine non sono considerate come un «mercato». Il mercato per l’industria è pensato all’estero, e in paesi arretrati dell’estero, dove sia più possibile la penetrazione politica per la creazione di colonie e di zone d’influenza. L’industria, col protezionismo interno e i bassi salari, si procura mercati all’estero con un vero e proprio dumping permanente.
Paesi dove esiste nazionalismo, ma non una situazione «nazionale-popolare», dove cioè le grandi masse popolari sono considerate come il bestiame. Il permanere di tanto ceto artigianesco industriale in alcuni paesi non è appunto legato al fatto che le grandi masse contadine non sono considerate un mercato per la grande industria, la quale ha prevalentemente un mercato estero? E la così detta rinascita o difesa dell’artigianato non esprime appunto la volontà di mantenere questa situazione ai danni dei contadini più poveri, ai quali è precluso ogni progresso?
Q6 §136 Organizzazione delle società nazionali. Ho notato altra volta che in una determinata società nessuno è disorganizzato e senza partito, purché si intendano organizzazione e partito in senso largo e non formale. In questa molteplicità di società particolari, di carattere duplice, naturale e contrattuale o volontario, una o più prevalgono relativamente o assolutamente, costituendo l’apparato egemonico di un gruppo sociale sul resto della popolazione (o società civile), base dello Stato inteso strettamente come apparato governativo‑coercitivo.
Avviene sempre che le singole persone appartengano a più di una società particolare e spesso a società che essenzialmente sono in contrasto fra loro. Una politica totalitaria tende appunto: 1) a ottenere che i membri di un determinato partito trovino in questo solo partito tutte le soddisfazioni che prima trovavano in una molteplicità di organizzazioni, cioè a rompere tutti i fili che legano questi membri ad organismi culturali estranei; 2) a distruggere tutte le altre organizzazioni o a incorporarle in un sistema di cui il partito sia il solo regolatore. Ciò avviene: 1) quando il partito dato è portatore di una nuova cultura e si ha una fase progressiva; 2) quando il partito dato vuole impedire che un’altra forza, portatrice di una nuova cultura, diventi essa «totalitaria»; e si ha una fase regressiva e reazionaria oggettivamente, anche se la reazione (come sempre avviene) non confessi se stessa e cerchi di sembrare essa portatrice di una nuova cultura.
Luigi Einaudi, nella «Riforma Sociale» del maggio‑giugno 1931, recensisce un volume francese Les sociétés de la nation. Étude sur les éléments constitutifs de la nation française, di Etienne Martin ‑ Saint‑Léon (vol. di pp. 415, Ed. Spes, 17, rue Soufflot, Parigi 1930, frs. 45) dove una parte di queste organizzazioni sono studiate, ma solo quelle che esistono formalmente. (Per es., i lettori di un giornale formano o no una organizzazione?, ecc.). In ogni modo, se l’argomento fosse trattato, vedere il libro e anche la recensione dell’Einaudi.
Q6 §137 Concetto di Stato. Che il concetto comune di Stato sia unilaterale e conduca a errori madornali si può dimostrare parlando del recente libro di Daniele Halévy Decadenza della libertà di cui ho letto una recensione nelle «Nouvelles Littéraires». Per Halévy «Stato» è l’apparato rappresentativo ed egli scopre che i fatti più importanti della storia francese dal 70 ad oggi non sono dovuti ad iniziative degli organismi politici derivanti dal suffragio universale, ma o da organismi privati (società capitalistiche, Stato maggiore, ecc.) o da grandi funzionari sconosciuti al paese, ecc. Ma cosa significa ciò se non che per Stato deve intendersi oltre all’apparato governativo anche l’apparato «privato» di egemonia o società civile. È da notare come da questa critica dello «Stato» che non interviene, che è alla coda degli avvenimenti, ecc., nasce la corrente ideologica dittatoriale di destra, col suo rafforzamento dell’esecutivo, ecc. Bisognerebbe però leggere il libro dell’Halévy per vedere se anch’egli è entrato in questa via: non è difficile in linea di principio, dati i suoi precedenti (simpatie soreliane, per Maurras, ecc.).
Q6 §138 Passato e presente. Passaggio dalla guerra manovrata (e dall’attacco frontale) alla guerra di posizione anche nel campo politico. Questa mi pare la quistione di teoria politica la più importante, posta dal periodo del dopo guerra e la più difficile ad essere risolta giustamente. Essa è legata alle quistioni sollevate dal Bronstein [Trotsky n.d.c.], che in un modo o nell’altro, può ritenersi il teorico politico dell’attacco frontale in un periodo in cui esso è solo causa di disfatta. Solo indirettamente questo passaggio nella scienza politica è legato a quello avvenuto nel campo militare, sebbene certamente un legame esista ed essenziale. La guerra di posizione domanda enormi sacrifizi a masse sterminate di popolazione; perciò è necessaria una concentrazione inaudita dell’egemonia e quindi una forma di governo più «intervenzionista», che più apertamente prenda l’offensiva contro gli oppositori e organizzi permanentemente l’«impossibilità» di disgregazione interna: controlli d’ogni genere, politici, amministrativi, ecc., rafforzamento delle «posizioni» egemoniche del gruppo dominante, ecc. Tutto ciò indica che si è entrati in una fase culminante della situazione politico‑storica, poiché nella politica la «guerra di posizione», una volta vinta, è decisiva definitivamente. Nella politica cioè sussiste la guerra di movimento fino a quando si tratta di conquistare posizioni non decisive e quindi non sono mobilizzabili tutte le risorse dell’egemonia e dello Stato, ma quando, per una ragione o per l’altra, queste posizioni hanno perduto il loro valore e solo quelle decisive hanno importanza, allora si passa alla guerra d’assedio, compressa, difficile, in cui si domandano qualità eccezionali di pazienza e di spirito inventivo. Nella politica l’assedio è reciproco, nonostante tutte le apparenze e il solo fatto che il dominante debba fare sfoggio di tutte le sue risorse dimostra quale calcolo esso faccia dell’avversario.
Q6 §139 Conflitto tra Stato e Chiesa come categoria eterna storica. Cfr a questo proposito il capitolo corrispondente di Croce nel suo libro sulla politica. Si potrebbe aggiungere che, in un certo senso, il conflitto tra «Stato e Chiesa» simbolizza il conflitto tra ogni sistema di idee cristallizzate, che rappresentano una fase passata della storia, e le necessità pratiche attuali. Lotta tra conservazione e rivoluzione, ecc., tra il pensato e il nuovo pensiero, tra il vecchio che non vuol morire e il nuovo che vuol vivere, ecc.
Q6 §140 Passato e presente. Il Cattolicismo italiano. A proposito della quistione di una possibile riforma protestante in Italia è da notare la «scoperta» fatta nel luglio-agosto 1931 (dopo l’enciclica sull’Azione Cattolica) di ciò che è realmente il cattolicismo da parte di alcune riviste italiane (specialmente notevole l’articolo editoriale di «Critica fascista» sull’Enciclica). Questi cattolici hanno scoperto con grande stupore e senso di scandalo che cattolicismo è uguale a «papismo». Questa scoperta non deve aver fatto molto piacere in Vaticano: essa è un potenziale protestantesimo, come tale è l’avversione a ogni ingerenza papale nella vita interna nazionale e il considerare e proclamare il papato un «potere straniero». Queste conseguenze del Concordato devono essere state sorprendenti per i «grandi» politici del Vaticano.
Q6 §141 Sul sentimento nazionale. L’editore Grasset ha pubblicato un gruppo di Lettres de jeunesse dell’allora capitano Lyautey. Le lettere sono del 1883 e il Lyautey era allora monarchico, devoto al conte di Chambord; il Lyautey apparteneva alla grande borghesia che era strettamente alleata all’aristocrazia. Più tardi, morto il conte di Chambord e dopo l’azione di Leone XIII per il ralliement, il Lyautey si unì al movimento di Albert de Mun che seguì le direttive di Leone XIII, e così divenne un alto funzionario della Repubblica, conquistò il Marocco, ecc.
Il Lyautey era ed è rimasto un nazionalista integrale, ma ecco come concepiva nell’83 la solidarietà nazionale: a Roma aveva conosciuto il tedesco conte von Dillen, capitano degli ulani, e così ne scrisse al suo amico Antoine de Margerie: «Un gentleman, d’une éducation parfaite, de façons charmantes, ayant en toutes choses, religion, politique, toutes nos idées. Nous parlons la même langue et nous nous entendons à merveille. Que veux‑tu? J’ai au coeur, une haine féroce, celle du désordre, de la revolution. Je me sens, certes, plus près de tous ceux qui la combattent, de quelque nationalité qu’ils soient, que de tels de nos compatriotes avec qui je n’ai pas une idée commune et que je regarde comme des ennemis publics».
Q6 §142 Passato e presente. La Corsica. Nell’«Italia Letteraria» del 9 agosto 1931 è pubblicato un articolo di Augusto Garsia Canti d’amore e di morte nella terra dei Corsi. Il Garsia pare sia stato recentemente in Corsica con Umberto Biscottini che notoriamente organizza a Livorno tutta l’attività irredentistica in Corsica (edizione corsa del «Telegrafo», «Giornale di Politica e di Letteratura», libri, zibaldoni, ecc.). Dall’articolo del Garsia appare che si stampa da poco tempo una rivista «31‑47», «che riporta molti articoli dell’edizione speciale fatta per i corsi del giornale “Il Telegrafo” e introdotta clandestinamente nell’isola». Anche da Raffaello Giusti di Livorno è ora edito l’«Archivio storico di Corsica», che usci nel 25 a Milano e la cui direzione più tardi fu assunta da Gioacchino Volpe. Il «Giornale di Politica e di Letteratura» non può entrare in Francia (quindi in Corsica).
L’irredentismo italiano in Italia è sufficientemente diffuso; non so quanto in Corsica. C’è in Corsica il movimento della «Muvra» e del Partito Corso d’Azione, ma essi non vogliono uscire dai quadri francesi e tanto meno riunirsi all’Italia; vogliono tutt’al più una larga autonomia e partecipano al movimento autonomista francese (Bretagna, Alsazia, Lorena, ecc.). Ricordare l’avvocatino veneto che incontrai in treno nel 1914; era abbonato alla Muvra, all’«Archivio storico di Corsica», leggeva romanzi di autori corsi (per es. Pierre Dominique, che per lui era un rinnegato). Sosteneva la rivendicazione non solo della Corsica, ma anche di Nizza e della Savoia.
Anche il comm. Belloni, vice‑questore di Roma, quando nel settembre 1925 mi fece una perquisizione domiciliare di quattro ore, mi parlò a lungo di queste rivendicazioni. Il veterinario di Ghilarza, prima della guerra, dott. Nessi, brianzolo, rivendicava anche il Delfinato, Lione compresa, e trovava ascolto fra i piccoli intellettuali sardi che sono francofobi estremisti per ragioni economiche (la guerra di tariffe con la Francia dopo il 1889) e per ragioni nazionalistiche (i Sardi sostengono che neanche Napoleone ha potuto conquistare la Sardegna e la festa di S. Efisio a Cagliari non è altro che la riproduzione della vittoria dei Sardi sui francesi del 1794 con l’intera distruzione della flotta francese (40 fregate) e di un corpo di sbarco di 4000 uomini.
Q6 §143 Guido Calogero, Il neohegelismo nel pensiero italiano contemporaneo (Croce, ma specialmente il Gentile), Nuova Antologia, 16 agosto 1930.
Q6 §144 G. Pascoli e Davide Lazzaretti. Nella «Nota per gli alunni» che precede l’antologia Sul limitare, il Pascoli, accennando alla pubblicazione di Giacomo Barzellotti sul Lazzaretti così scrive: «Io ho sentito dalla lettura del libro elevarsi il mio pensiero all’avvenire così dubbioso della nostra civiltà. Il secolo è finito: che ci porterà il secolo ventesimo? La pace tra i popoli, la pace tra le classi, la pace della coscienza? o la lotta e la guerra? Ebbene, codesto barrocciaio commosso da un nuovo impulso di fede viva, che cade nel suo sangue, e cotesto pensatore (il Barzellotti), coscienza e mente dei nostri tempi, che lo studia, lo narra, lo compiange, mi sembrano come un simbolo: l’umanità sapiente che piange e ammonisce, col petto alto e col capo chino, tra la sicurezza del suo pensiero e la pietà del suo sentimento, sull’altra umanità, su quella che delira e muore».
Questo brano interessa: 1) per il pensiero politico del Pascoli nel 1899‑900. 2) Per mostrare l’efficacia ideologica della morte del Lazzaretti. 3) Per vedere quali rapporti il Pascoli voleva tra gli intellettuali e il popolo.
Q6 §145 Storia degli intellettuali italiani. Giovanni B. Botero. Cfr Il numero come forza nel pensiero di Giovanni Botero di Emilio Zanette, nella «Nuova Antologia» del 1° settembre del 1930. È un articolo superficiale e di tipo giornalistico‑d’occasione. Il significato dell’importanza data da Botero al «fatto» della popolazione non ha lo stesso valore di quello che può avere attualmente. Il Botero è uno degli scrittori del tempo della Controriforma più tipicamente cosmopoliti e a‑italiani. Egli parla dell’Italia come di qualsiasi altro paese e i suoi problemi politici non lo interessano specificatamente. Critica la «boria» degli Italiani che si considerano superiori ad altri paesi e dimostra infondata tale pretesa. È da studiare per tanti rispetti (ragion di Stato, machiavellismo, tendenza gesuitica, ecc.). Il Gioda ha scritto sul Botero: più recentemente saggi, ecc. Per questo articolo lo Zanette potrebbe entrare nel paragrafo degli «Italiani meschini».
Q6 §146 Storia degli intellettuali italiani. Gli ebrei. Cfr Yoseph Colombo, Lettere inedite del p. Hyacinthe Loyson, «Nuova Antologia», 1° settembre 1930. Si parla del rabbino livornese Benamozegh, della sua concezione dell’ebraismo in rapporto al cristianesimo, dei suoi scritti, dei suoi rapporti col Loyson; si accenna all’importanza della comunità ebraica di Livorno come centro di cultura rabbinica, ecc.
Q6 §147 Popolarità della letteratura italiana. «Nuova Antologia», 1° ottobre 1930: Ercole Reggio, Perché la letteratura italiana non è popolare in Europa. «La poca fortuna che incontrano, presso di noi, libri italiani anche illustri, a paragone con quella di tanti libri stranieri, dovrebbe farci persuasi che le ragioni della scarsa popolarità della nostra letteratura in Europa sono probabilmente le stesse che la rendono poco popolare da noi; e che perciò, tutto sommato, non ci sarà nemmeno da chiedere agli altri quello che noi, per i primi, non ci attendiamo in casa nostra. A detta anche d’italianizzanti, di simpatizzanti stranieri, la nostra letteratura manca in massima di qualità modeste e necessarie, di ciò che s’indirizza all’uomo medio, all’uomo degli economisti (?!); ed è in ragione delle sue prerogative, di quanto ne costituisce l’originalità, come il merito, ch’essa non tocca né potrà mai toccare alla popolarità delle altre grandi letterature europee». Il Reggio accenna al fatto che invece le arti figurative italiane (dimentica la musica) sono popolari in Europa e si domanda: o esiste un abisso tra la letteratura e le altre arti italiane, e questo abisso sarebbe impossibile da spiegare, oppure il fatto deve essere spiegato con ragioni secondarie, extrartistiche, cioè mentre le arti figurative (e la musica) parlano un linguaggio europeo e universale, la letteratura ha i suoi limiti nei confini della lingua nazionale. Non mi pare che l’obbiezione regga: 1) perché c’è stato un periodo storico in cui anche la letteratura italiana fu popolare in Europa (Rinascimento) oltre alle arti figurative e anzi insieme a queste: cioè l’intera cultura italiana fu popolare. 2) Perché in Italia, oltre alla letteratura, non sono popolari neanche le arti figurative (sono popolari invece Verdi, Puccini, Mascagni ecc.). 3) Perché la popolarità delle arti figurative italiane in Europa è relativa: si limita agli intellettuali e in alcune altre zone della popolazione europea, è popolare perché legata a ricordi classici o romantici; non come arte. 4) Invece la musica italiana è popolare tanto in Europa come in Italia.
L’articolo del Reggio continua sui binari della solita retorica, quantunque qua e là contenga osservazioni sagaci.
Q6 §148 Il genio nella storia. Nello scritto inedito di Niccolò Tommaseo Pio IX e Pellegrino Rossi pubblicato da Teresa Lodi nel «Pègaso» dell’ottobre 1931 si legge a proposito di Pio IX (p. 407): «E fosse stato anco un genio, gli conveniva trovare aiutatori ed interpreti; perché l’uomo che sorge solo, solo si rimane, e cade assai volte o deserto o calpesto. In ogni educazione e privata e pubblica importa conoscere lo strumento che s’ha tra mani, e chiedergli quel suono ch’ei può dare, e non altro; e prima d’ogni cosa saperlo suonare». Dello stesso Tommaseo: «Io non entro nelle cose private dell’uomo se non quanto aiutino a spiegare le pubbliche»; la proposizione è giusta, anche se il Tommaseo non vi si sia attenuto quasi mai.
Q6 §149 Storia degli intellettuali italiani. Su L. B. Alberti cfr il libro di Paul‑Henry Michel, Un ideal humain au XV siècle. La pensée de L. B. Alberti (1404‑1472), in 8°, pp. 649, Parigi, Soc. Ed. «Les Belles lettres», 1930. Analisi minuziosa del pensiero di L. B. Alberti, ma, a quanto pare da qualche recensione, non sempre esatta, ecc.
Edizione Utet del Novellino curata da Letterio di Francia, il quale ha accertato che il nucleo originale della raccolta sarebbe stato composto negli ultimi anni del secolo XIII da un borghese ghibellino.
Ambedue i libri dovrebbero essere analizzati per la ricerca già accennata del come sia riflesso nella letteratura il passaggio dall’economia medioevale all’economia borghese dei Comuni e quindi alla caduta, in Italia, dello spirito di intrapresa economica e alla restaurazione cattolica.
Q6 §150 Passato e presente. Sulla marcia su Roma vedere il numero di «Gioventù Fascista» pubblicato per il nono anniversario (1931) con articoli molto interessanti di De Bono e Balbo. Balbo, tra l’altro, scrive: «Mussolini agì. Se non lo avesse fatto, il movimento fascista avrebbe perpetuato per decenni la guerriglia civile e non è escluso che altre forze, che militavano, come le nostre, al di fuori della legge dello Stato, ma con finalità anarchiche e distruttive, avrebbero finito per giovarsi della neutralità e dell’impotenza statale per compiere più tardi il gesto di rivolta da noi tentato nell’ottobre del ’22. In ogni modo è certo che senza la Marcia su Roma, cioè senza la soluzione rivoluzionaria, il nostro movimento sarebbe andato incontro a quelle fatali crisi di stanchezza, di tendenze e di indisciplina, che erano state la tomba dei vecchi partiti». C’è qualche inesattezza: lo Stato non era «neutrale ed impotente» come si è soliti dire, appunto perché il movimento fascista ne era il principale sostegno in quel periodo; né ci poteva essere «guerra civile» tra lo Stato e il movimento fascista, ma solo un’azione violenta sporadica per mutare la direzione dello Stato e riformarne l’apparato amministrativo. Nella guerriglia civile il movimento fascista fu in linea con lo Stato, non contro lo Stato, altro che per metafora e secondo la forma esterna della legge.
Q6 §151 Azione cattolica. Santificazione di Roberto Bellarmino, segno dei tempi e del creduto impulso di nuova potenza della Chiesa cattolica; rafforzamento dei gesuiti, ecc. Il Bellarmino condusse il processo contro Galileo e redasse gli otto motivi che portarono Giordano Bruno al rogo. Santificato il 29 giugno 1930; ma ha importanza non questa data, ma la data in cui fu iniziato il processo di santificazione. Cfr la Vita di Galileo del Banfi (ed. La Cultura) e la recensione di G. De Ruggiero nella «Critica» in cui si documentano le gherminelle gesuitiche in cui il Galilei rimase impigliato. Il Bellarmino è autore della formula del potere indiretto della Chiesa su tutte le sovranità civili. La festa di Cristo re (istituita nel 1925 o 26?) per l’ultima domenica di ottobre di ogni anno.
Q6 §152 Storia degli intellettuali italiani. Il processo di Galileo, di Giordano Bruno, ecc. e l’efficacia della Controriforma nell’impedire lo sviluppo scientifico in Italia. Sviluppo delle scienze nei paesi protestanti o dove la Chiesa era meno immediatamente forte che in Italia. La Chiesa avrebbe contribuito alla snazionalizzazione degli intellettuali italiani in due modi: positivamente, come organismo universale che preparava personale a tutto il mondo cattolico, e negativamente, costringendo ad emigrare quegli intellettuali che non volevano sottomettersi alla disciplina controriformistica.
Q6 §153 Carattere popolare nazionale della letteratura italiana. Goldoni. Perché il Goldoni è popolare anche oggi? Goldoni è quasi «unico» nella tradizione letteraria italiana. I suoi atteggiamenti ideologici: democratico prima di aver letto Rousseau e della Rivoluzione francese. Contenuto popolare delle sue commedie: lingua popolare nella sua espressione, mordace critica dell’aristocrazia corrotta e imputridita.
Conflitto Goldoni ‑ Carlo Gozzi. Gozzi reazionario. Le sue Fiabe, scritte per dimostrare che il popolo accorre alle più insulse strampalerie, e che invece hanno successo: in verità anche le Fiabe hanno un contenuto popolare, sono un aspetto della cultura popolare o folclore, in cui il meraviglioso e l’inverosimile (presentato come tale in un mondo fiabesco) è parte integrante. (Fortuna delle Mille e una notte anche oggi, ecc.).
Q6 §154 I sansimoniani. La forza espansiva dei sansimoniani. È da ricordare l’osservazione di Goethe nelle Memorie (cfr) scritte nel 1828: «Questi signori del “Globe”... sono penetrati da uno stesso spirito. In Germania un giornale simile sarebbe impossibile. Noi siamo solamente dei particolari; non si può pensare ad una intesa; ognuno ha l’opinione della sua provincia, della sua città, del suo proprio individuo e ci vorrà molto tempo prima che si creino dei sentimenti comuni».
Q6 §155 Passato e presente. Politica e arte militare. Tattica delle grandi masse e tattica immediata di piccoli gruppi. Rientra nella discussione sulla guerra di posizione e quella di movimento, in quanto si riflette nella psicologia dei grandi capi (strateghi) e dei subalterni. È anche (se si può dire) il punto di connessione tra la strategia e la tattica, sia in politica che nell’arte militare. I singoli individui (anche come componenti di vaste masse) sono portati a concepire la guerra istintivamente, come «guerra di partigiani» o «guerra garibaldina» (che è un aspetto superiore della «guerra di partigiani»). Nella politica l’errore avviene per una inesatta comprensione di ciò che è lo Stato (nel significato integrale: dittatura + egemonia), nella guerra si ha un errore simile, trasportato nel campo nemico (incomprensione non solo del proprio Stato, ma anche dello Stato nemico).
L’errore nell’uno e nell’altro caso è legato al particolarismo individuale, di municipio, di regione che porta a sottovalutare l’avversario e la sua organizzazione di lotta.
Q6 §156 Sul capitalismo antico o meglio sull’industrialismo antico è da leggere l’articolo di G. C. Speziale Delle navi di Nemi e dell’archeologia navale nella Nuova Antologia del 1° novembre 1930 (polemica col prof. Giuseppe Lugli che scrisse nel «Pègaso»; articoli in giornali quotidiani dello stesso tempo). L’articolo dello Speziale è molto interessante, ma pare che egli esageri nell’importanza data alle possibilità industriali nell’antichità (cfr la quistione sul capitalismo antico discussa nella «Nuova Rivista Storica»). Manca, mi pare, allo Speziale la nozione esatta di ciò che era la «macchina» nel mondo classico e quello che è oggi (questa osservazione vale specialmente per Barbagallo e C.). Le «novità» su cui insiste lo Speziale non escono ancora dalla definizione che della macchina dava Vitruvio, cioè di ordigni atti a facilitare il movimento e il trasporto di corpi pesanti (vedere con esattezza la definizione di Vitruvio) e perciò non sono che novità relative: la macchina moderna è ben altra cosa: essa non solo «aiuta» il lavoratore ma lo «sostituisce»: che anche le «macchine» di Vitruvio continuino ad esistere accanto alle «moderne» e che in quella direzione i romani potessero essere giunti a una certa perfezione, ancora ignota, può darsi e non maraviglia, ma in ciò non c’è nulla di «moderno» nel senso proprio della parola, che è stato stabilito dalla «rivoluzione» industriale, cioè dall’invenzione e diffusione di macchine che «sostituiscono» il lavoro umano precedente.
Q6 §157 Romanzi filosofici, utopie, ecc. Controriforma e utopie: desiderio di ricostruire la civiltà europea secondo un piano razionale. Altra origine e forse la più frequente: modo di esporre un pensiero eterodosso, non conformista e ciò specialmente prima della Rivoluzione francese. Dalle Utopie sarebbe derivata quindi la moda di attribuire a popoli stranieri le istituzioni che si desidererebbero nel proprio paese, o di far la critica delle supposte istituzioni di un popolo straniero per criticare quelle del proprio paese. Così dalle Utopie sarebbe nata anche la moda di esaltare i popoli primitivi, selvaggi (il buon selvaggio) presunti essere più vicini alla natura. (Ciò si ripeterebbe nell’esaltazione del «contadino», idealizzato, da parte dei movimenti populisti). Tutta questa letteratura ha avuto non piccola importanza nella storia della diffusione delle opinioni politico‑sociali fra determinate masse e quindi nella storia della cultura.
Si potrebbe osservare che questa letteratura politica «romanzata» reagisce alla letteratura «cavalleresca» in decadenza (Don Chisciotte, Orlando Furioso, Utopia di Tommaso Moro, Città del sole) e indica quindi il passaggio dall’esaltazione di un tipo sociale feudale all’esaltazione delle masse popolari genericamente, con tutti i suoi bisogni elementari (nutrirsi, vestirsi, ripararsi, riprodursi) ai quali si cerca di dare razionalmente una soddisfazione. Si trascura nello studio di questi scritti di tener conto delle impressioni profonde che dovevano lasciare, spesso per generazioni, le grandi carestie e le grandi pestilenze, che decimavano e stremavano le grandi masse popolari: questi disastri elementari, accanto ai fenomeni di morbosità religiosa, cioè di passività rassegnata, destavano anche sentimenti critici «elementari», quindi spinte a una certa attività che appunto trovavano la loro espressione in questa letteratura utopistica, anche parecchie generazioni dopo che i disastri erano avvenuti, ecc.
Q6 §158 Storia delle classi subalterne. Cfr l’articolo di Armando Cavalli, Correnti messianiche dopo il ’70, Nuova Antologia del 16 novembre 1930. Il Cavalli si è occupato anche altre volte di argomenti simili (vedere i suoi articoli nelle riviste di Gobetti, «Rivoluzione Liberale» e «Baretti» e altrove) sebbene con molta superficialità. In questo articolo accenna a Davide Lazzaretti, alle Bande di Benevento, ai movimenti repubblicani (Barsanti) e internazionalisti in Romagna e nel Mezzogiorno. Chiamare «correnti messianiche» è esagerato, perché si tratta di fatti singoli e isolati, che dimostrano più la «passività» delle grandi masse rurali che non una loro vibrazione per sentirsi attraversate da «correnti». Così il Cavalli esagera l’importanza di certe affermazioni «protestantiche» o «riforrnatrici in generale» della religione che si verificano non solo dopo il 70, ma anche prima, da parte di R. Bonghi e altri liberali (è noto che la «Perseveranza» prima del 70 credeva di far pressione sul papato con queste minacce di una adesione italiana al protestantesimo) e il suo errore è mostruoso quando pare che voglia porre sullo stesso piano queste affermazioni riformatrici e Davide Lazzaretti. La conclusione è giusta formalmente: dittatura della destra, esclusione dalla vita politica dei partiti repubblicano e clericale, indifferenza del governo per la miseria delle masse agricole.
Il concetto di «ideale» formatosi nelle masse di sinistra; nella sua vacuità formale, serve bene a caratterizzare la situazione: non fini e programmi politici concreti e definiti, ma uno stato d’animo vago e oscillante che trovava il suo appagamento in una vuota formula, perché vuota capace di contenere ogni cosa la più disparata. La parola «ideale» è complementare a quella di «sovversivo»: è la formula utile per fare delle frasi ai piccoli intellettuali che formavano l’organizzazione di sinistra. L’«ideale» è un residuo del mazzinianismo popolare in cui si innesta il bakuninismo, e si trascinò fino ai tempi più moderni, mostrando così che una vera direzione politica delle masse non si era formata.
Q6 §159 Risorgimento. Cfr Emanuele Librino, Agostino Depretis prodittatore in Sicilia (Documenti inediti sulla Spedizione dei Mille: lettere di Garibaldi, Cavour, Farini, Crispi, Bixio e Bertani), Nuova Antologia del 16 dicembre 1930. Quistione dell’annessione immediata: lotte tra partito d’azione e moderati. Di fronte al partito d’azione che non volle fare appello ai contadini, vittoria della politica di Cavour che trovò i suoi alleati nei latifondisti che volevano l’annessione immediata. Si trovano accenni interessanti a questo proposito: richieste di carabinieri sardi, ecc. I latifondisti non volevano restare sotto la minaccia di un movimento popolare per le terre ed erano diventati unitari spasimanti. (L’articolo deve essere messo insieme al libro di Crispi sui Mille).
Q6 §160 Sulla morale. Nella breve introduzione a un gruppo di lettere inedite del Diderot a Grimm e a Madame d’Epinay («Revue des Deux Mondes» del 15 febbraio 1931), André Babelon scrive del Diderot:
«Diderot, qui éprouvait pour la postérité le même respect que d’autres pour l’immortalité de l’âme...» .
Q6 §161 Risorgimento. Garibaldi. Cfr Emanuele Librino, L’attività politica di Garibaldi nel 1861, Nuova Antologia, 16 febbraio 1931. Pubblica una piccola nota di Garibaldi al generale Medici in cui si dice che la ragione principale del conflitto con Cavour è questa: Cavour vuole un governo costituzionale tipo francese, con un esercito stanziale che potrà essere impiegato contro il popolo; Garibaldi vuole un governo all’inglese, senza esercito stanziale, ma con la nazione armata. Tutto qui il contrasto Cavour-Garibaldi? Si può vedere la scarsezza di capacità politica del Garibaldi e la non sistematicità delle sue opinioni.
Q6 §162 Passato e presente. Caratteri italiani. Si osserva da alcuni con compiacimento, da altri con sfiducia e pessimismo, che il popolo italiano è «individualista»: alcuni dicono «dannosamente», altri «fortunatamente», ecc. Questo «individualismo», per essere valutato esattamente, dovrebbe essere analizzato, poiché esistono diverse forme di «individualismo», più progressive, meno progressive, corrispondenti a diversi tipi di civiltà e di vita culturale. Individualismo arretrato, corrispondente a una forma di «apoliticismo» che corrisponde oggi all’antico «anazionalismo»: si diceva una volta «Venga Francia, venga Spagna, purché se magna», come oggi si è indifferenti alla vita statale, alla vita politica dei partiti, ecc.
Ma questo «individualismo» è proprio tale? Non partecipare attivamente alla vita collettiva, cioè alla vita statale (e ciò significa solo non partecipare a questa vita attraverso l’adesione ai partiti politici «regolari») significa forse non essere «partigiani», non appartenere a nessun gruppo costituito? Significa lo «splendido isolamento» del singolo individuo, che conta solo su se stesso per creare la sua vita econornica e morale? Niente affatto. Significa che al partito politico e al sindacato economico «moderni», come cioè sono stati elaborati dallo sviluppo delle forze produttive più progressive, si «preferiscono» forme organizzative di altro tipo, e precisamente del tipo «malavita», quindi le cricche, le camorre, le mafie, sia popolari, sia legate alle classi alte. Ogni livello o tipo di civiltà ha un suo «individualismo», cioè ha una sua peculiare posizione e attività del singolo individuo nei suoi quadri generali. Questo «individualismo» italiano (che poi è più o meno accentuato e dominante secondo i settori economico‑sociali del territorio) è proprio di una fase in cui i bisogni più immediati economici non possono trovare soddisfazione regolare permanentemente (disoccupazione endemica fra i lavoratori rurali e fra i ceti intellettuali piccoli e medi). La ragione di questo stato di cose ha origini storiche lontane, e del mantenersi di tale situazione è responsabile il gruppo dirigente nazionale.
Si pone il problema storico‑politico: una tale situazione puo essere superata coi metodi dell’accentramento statale (scuola, legislazione, tribunali, polizia) che tenda a livellare la vita secondo un tipo nazionale? cioè per un’azione che scenda dall’alto e che sia risoluta ed energica? Intanto si pone la quistione del come formare il gruppo dirigente che esplichi una tale azione: attraverso la concorrenza dei partiti e dei loro programmi economici e politici? attraverso l’azione di un gruppo che eserciti il potere monopolisticamente? Nell’un caso e nell’altro è difficile superare l’ambiente stesso, che si rifletterà nel personale dei partiti, o nella burocrazia al servizio del gruppo monopolistico, poiché se è pensabile la selezione secondo un tipo di pochi dirigenti, è impossibile una tale selezione «preventiva» delle grandi masse di individui che costituiscono tutto l’apparato organizzativo (statale ed egemonico) di un grande paese. Metodo della libertà, ma non inteso in senso «liberale»: la nuova costruzione non può che sorgere dal basso, in quanto tutto uno strato nazionale, il più basso economicamente e culturalmente, partecipi ad un fatto storico radicale che investa tutta la vita del popolo e ponga ognuno, brutalmente, dinanzi alle proprie responsabilità inderogabili.
Il torto storico della classe dirigente è stato quello di aver impedito sistematicamente che un tal fenomeno avvenisse nel periodo del Risorgimento e di aver fatto ragion d’essere della sua continuità storica il mantenimento di una tale situazione cristallizzata, dal Risorgimento in poi.
Q6 §163 Passato e presente. Le encicliche papali. Un esame critico‑letterario delle encicliche papali. Esse sono per il 90% un centone di citazioni generiche e vaghe, il cui scopo pare essere quello di affermare in ogni occasione la continuità della dottrina ecclesiastica dagli Evangeli ad oggi. In Vaticano devono avere uno schedario formidabile di citazioni per ogni argomento: quando si deve compilare un’enciclica, si comincia con il fissare preventivamente le schede contenenti la dose necessaria di citazioni: tante dall’Evangelio, tante dai padri della Chiesa, tante dalle precedenti encicliche. L’impressione che se ne ottiene è di grande freddezza. Si parla della carità, non perché ci sia un tal sentimento verso gli uomini attuali, ma perché così ha detto Matteo, e Agostino, e il «nostro predecessore di felice memoria», ecc. Solo quando il papa scrive o parla di politica immediata, si sente un certo calore.
Q6 §164 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. Vedere l’effetto che nell’equilibrio delle forze cattoliche ha avuto la crisi religiosa in Ispagna. In Ispagna la lotta anticlericale ha avuto come principale bersaglio i gesuiti, ma mi pare che appunto in Ispagna avrebbero dovuto essere forti gli integralisti, e che i gesuiti dovevano essere un contrappeso a queste forze: il tentativo di accordo tra il Vaticano e Alcalà Zamora, troncato dalla Costituente, doveva appunto tendere a mettere in valore la politica gesuitica, eliminando o sacrificando gli integralisti (Segura, ecc.). Ma la situazione spagnola era complicata dal fatto che i gesuiti svolgevano un’attività capitalistica rilevante: essi dominavano alcune società importanti tranviarie e d’altro genere (verificare l’esattezza di questi accenni). In Ispagna i gesuiti avevano una tradizione particolare: loro lotta contro l’Inquisizione e i domenicani (vedere che significato ebbe questa lotta; cfr il libro del Lea sull’Inquisizione di Spagna).
Q6 §165 Nozioni enciclopediche. Scienza e scientifico. Il Dubreuil, nel libro Standards nota giustamente che l’aggettivo «scientifico» tanto usato per accompagnare le parole: Direzione scientifica del lavoro, Organizzazione scientifica, ecc., non ha il significato pedantesco e minaccioso che molti gli attribuiscono, ma non spiega poi esattamente come debba essere inteso. In realtà scientifico significa «razionale» e più precisamente «razionalmente conforme al fine» da raggiungere, cioè di produrre il massimo col minimo sforzo, di ottenere il massimo di efficienza economica, ecc. razionalmente scegliendo e fissando tutte le operazioni e gli atti che conducono al fine.
L’aggettivo «scientifico» è oggi adoperato estensivamente, ma sempre il suo significato può essere ridotto a quello di «conforme al fine», in quanto tale «conformità» sia razionalmente (metodicamente) ricercata dopo un’analisi minutissima di tutti gli elementi (fino alla capillarità) costitutivi e necessariamente costitutivi (eliminazione degli elementi emotivi compresa nel calcolo).
Q6 §166 Passato e presente. Apoliticità. Aldo Valori, nel «Corriere della Sera» del 17 novembre 1931, pubblica un articolo (L’Esercito di una volta) sul libro di Emilio De Bono Nell’esercito italiano prima della guerra (Mondadori, 1931) che deve essere interessante, e riporta questo brano: «Si leggeva poco, poco i giornali, poco i romanzi, poco il “Giornale ufficiale” e le circolari di servizio… Nessuno si occupava di politica. Io, per esempio, mi ricordo di non aver mai badato alle crisi ministeriali, di aver saputo per puro caso il nome del Presidente del Consiglio… Ci interessavano i periodi elettorali perché davano diritto a dodici giorni di licenza per andare a votare. L’ottanta per cento però si godeva la licenza e non guardava le urne neppure in fotografia». E il Valori osserva: «Può parere un’esagerazione e invece non è. Astenersi dalla politica non voleva dire estraniarsi dalla vita della Nazione, ma dagli aspetti più bassi della lotta fra partiti. Così comportandosi, l’Esercito rimase immune dalla degenerazione di molti altri pubblici istituti e costituì la grande riserva delle forze dell’ordine; il che era il modo più sicuro per giovare, anche politicamente, alla Nazione».
Questa situazione, per essere apprezzata, deve essere paragonata alle aspirazioni del Risorgimento per rispetto all’Esercito, di cui si può vedere un’espressione nel libro di Giulio Cesare Abba dedicato ai soldati, libro divenuto ufficiale, premiato, ecc. ecc. [Giuseppe Cesare Abba, Uomini e soldati. Letture per l'esercito e pel popolo, Zanichelli, Bologna 1890. L’Abba, con la sua corrente, pensava all’Esercito come a un istituto che doveva inserire le forze popolari nella vita nazionale e statale, in quanto l’Esercito rappresentava la nazione in armi, la forza materiale su cui poggiava il costituzionalismo e la rappresentanza parlamentare, la forza che doveva impedire i colpi di Stato e le avventure reazionarie: il soldato doveva diventare il soldato‑cittadino, e l’obbligo militare non doveva essere concepito come un servizio, ma invece attivamente, come l’esercizio di un diritto, della libertà popolare armata. Utopie, evidentemente, perché, come appare dal libro del De Bono, si ricadde nell’apoliticismo, quindi l’esercito non fu che un nuovo tipo di esercito professionale e non di esercito nazionale, poiché questo e niente altro significa l’apoliticismo. Per le «forze dell’ordine» questo stato di cose era l’ideale: quanto meno il popolo partecipava alla vita politica statale, tanto più queste forze erano forze. Ma come giudicare dei partiti che continuavano il Partito d’Azione! E ciò che si dice dell’esercito si può estendere a tutto il personale impiegato dall’apparato statale, burocrazia, magistratura, polizia, ecc. Un’educazione «costituzionale» del popolo non poteva essere fatta dalle forze dell’ordine: essa era compito del Partito d'Azione, che fallì completamente ad esso; anzi fu un elemento per rincalzare l’atteggiamento delle forze dell’ordine.
Per ciò che riguarda il De Bono è da osservare che verso il 18‑19 le opinioni del De Bono a proposito dei rapporti tra politica ed esercito non erano precisamente le stesse di ora: le sue militari nel «Mondo» e una sua pubblicazione di quel tempo, in cui era vivo il ricordo degli insegnamenti dati dalla rotta di Caporetto, sarebbero da rivedere.
Q6 §167 Nozioni enciclopediche. Bog e bogati. È stato osservato in qualche posto che le relazioni tra Bog e bogati sono una coincidenza fortuita dello sviluppo linguistico di una determinata cultura nazionale. Ma il fatto non è esatto. Nelle lingue neo‑latine è apparso il vocabolo germanico «ricco» a turbare il rapporto che in latino esisteva tra «deus» «dives» e «divites» «divitia» (dovizia, dovizioso, ecc.). In un articolo di Alessandro Chiappelli, Come s’inquadra il pensiero filosofico nell’economia del mondo, (Nuova Antologia del 1° aprile 1931) si possono spulciare elementi per mostrare che in tutto il mondo occidentale, a differenza di quello asiatico (India), la concezione di Dio è strettamente connessa con la concezione di proprietà e di proprietario: «… (il) concetto di proprietà come è il centro di gravità e la radice di tutto il nostro sistema giuridico, così è l’ordito di tutta la nostra struttura civile e morale. Persino il nostro concetto teologico è foggiato spesso su questo esemplare, e Dio è rappresentato talora come il grande proprietario del mondo. La ribellione contro Dio nel Paradiso perduto del Milton, come già nel poema di Dante, è figurata come il temerario tentativo di Satana o di Lucifero di spodestare l’onnipotente e di deporlo dal suo altissimo trono. Un acuto collaboratore, anzi il direttore, un tempo, dell’«Hibbert Journal» (Jacks, The Universe as Philosopher, in «Hibbert Journal», oct. 1917, p. 26) narrava d’aver assistito ad una conferenza in cui la prova dell’esistenza di Dio era ricavata dalla necessità di postulare un proprietario o possessore del mondo. Come si può mai credere che una proprietà sì vasta, sì eletta e fruttifera non appartenga ad alcuno? È in sostanza la stessa domanda che fa, parlando a sé medesimo, nel sublime monologo, il Pastore errante nell’Asia del Leopardi. Che ci sia stata o no, una prima causa del mondo, può rimaner dubbio. Ma la necessità di un primo possessore deve apparire manifesta e indubitabile». Il Chiappelli dimentica che anche nel Credo Dio è detto «creatore e signore (dominus: padrone, proprietario) del cielo e della terra».
Q6 §168 Letteratura popolare. Cfr Alberto Consiglio, Populismo e nuove tendenze della letteratura francese, Nuova Antologia, 1° aprile 1931. Il Consiglio prende le mosse dall’inchiesta delle «Nouvelles Littéraires» sul «Romanzo operaio e contadino» (nei mesi luglio‑agosto 1930). L’articolo è da rileggere, quando l’argomento volesse esser trattato organicamente. La tesi del Consiglio (più o meno esplicita e consapevole) è questa: di fronte al crescere della potenza politica e sociale del proletariato e della sua ideologia, alcune sezioni dell’intellettualismo francese reagiscono con questi movimenti «verso il popolo». L’avvicinamento al popolo significherebbe quindi una ripresa del pensiero borghese che non vuole perdere la sua egemonia sulle classi popolari e che, per esercitare meglio questa egemonia, accoglie una parte dell’ideologia proletaria. Sarebbe un ritorno a forme «democratiche» più sostanziali del corrente «democratismo» formale.
È da vedere se anche un fenomeno di questo genere non sia molto significativo e importante storicamente e non rappresenti una fase necessaria di transizione e un episodio dell’«educazione popolare» indiretta. Una lista delle tendenze «populiste» e una analisi di ciascuna di esse sarebbe interessante: si potrebbe «scoprire» una di quelle che Vico chiama «astuzie della natura», cioè come un impulso sociale, tendente a un fine, realizzi il suo contrario.
Q6 §169 Giornalismo. Cfr Luigi Villari, Giornalismo britannico di ieri e di oggi, «Nuova Antologia», 1° maggio 1931.
Q6 §170 Passato e presente. Governi e livelli culturali nazionali. Ogni governo ha una politica culturale e può difenderla dal suo punto di vista e dimostrare di aver innalzato il livello culturale nazionale. Tutto sta nel vedere quale sia la misura di questo livello. Un governo può organizzare meglio l’alta cultura e deprimere la cultura popolare, e ancora: dell’alta cultura può organizzare meglio la sezione riguardante la tecnologia e le scienze naturali, paternalisticamente mettendo a sua disposizione somme di denaro come prima non si faceva, ecc. Il criterio di giudizio può essere solo questo: un sistema di governo è repressivo o espansivo? e anche questo criterio deve essere precisato: un governo repressivo per alcuni aspetti, è espansivo per altri? Un sistema di governo è espansivo quando facilita e promuove lo sviluppo dal basso in alto, quando eleva il livello di cultura nazionale‑popolare e tende quindi possibile una selezione di «cime intellettuali» su più vasta area. Un deserto con un gruppo di alte palme è sempre un deserto: anzi è proprio àel deserto avere delle piccole oasi con gruppi di alte palme.
Q6 §171 Risorgimento. Un centro di propaganda intellettuale per l’organizzazione e la «condensazione» del gruppo intellettuale dirigente della borghesia italiana del Risorgimento è quello costituito dal Vieusseux in Firenze, col Gabinetto letterario e le pubblicazioni periodiche: l’«Antologia», l’«Archivio Storico Italiano», il «Giornale Agrario», la «Guida dell’Educatore». Manca una pubblicazione tecnico‑industriale, come il «Politecnico» di Carlo Cattaneo (che nascerà, non a caso, a Milano). Le iniziative del Vieusseux indicano quali fossero i problemi più importanti che interessavano gli elementi più progressivi del tempo: la scuola e l’istruzione pubblica, l’industria agricola, la cultura letteraria e storica. È vero che l’«Antologia» riassumeva tutte queste attività, ma sarà da vedere se in essa ebbe molta importanza (o quale) la tecnologia industriale. Manca anche un’attività specializzata di «economia politica». (Bisogna vedere se in quel tempo esistevano per l’economia politica e per la tecnologia riviste specializzate negli altri paesi, specialmente Inghilterra e Francia, o se esse venivano trattate e divulgate solo con libri. Il saggio di economia politica e di tecnologia è forse più tardo anche in questi paesi). Cfr sul movimento del Vieusseux: Francesco Baldasseroni, Il Rinnovamento civile in Toscana, Firenze, Olschki, 1931.
Q6 §172 Letteratura popolare. Cfr Antonio Baldini, Stonature di cinquant’anni fa: la Farlalla petroliera, Nuova Antologia, 16 giugno 1931. «La Farfalla», fondata da Angelo Sommaruga a Cagliari e dopo due anni trasportata a Milano (verso il 1880). Il periodico finì col diventare la rivista di un gruppo di «artisti… proletari». Vi scrissero Paolo Valera e Filippo Turati. Valera dirigeva allora «La Plebe» (quale? vedere) e scriveva i suoi romanzi: Milano sconosciuta e Gli scamiciati, séguito alla Milano sconosciuta. Vi scrivevano Cesario Testa, che dirigeva l’«Anticristo», e Ulisse Barbieri. La stessa impresa editoriale della «Farfalla» pubblicava una «Biblioteca naturalista» e una «Biblioteca socialista». Almanacco degli Atei per il 1881. Zola, Vallès, di Goncourt, romanzi sui bassi fondi, galere, postriboli, ospedali, strade (Lumpenproletariat), anticlericalismo, ateismo, naturalismo (Stecchetti «poeta civile»). G. Aurelio Costanzo, Gli eroi della soffitta (da ragazzi, in casa, avendo visto il libro, pensavamo che si parlasse di lotte fra i topi). Carducci dell’Inno a Satana, ecc. Stile barocco come quello di Turati (ricordare i suoi versi riportati da Schiavi nell’antologia Fiorita di canti sociali): «Budda, Socrate, Cristo han detto il vero: – Per Satanasso un infedel vel giura. – Vivono i morti e strangolarli è vano». (Questo «episodio» di vita «artistica» milanese potrà essere studiato e ricostruito a titolo di curiosità e anche non senza un interesse critico ed educativo). Sulla «Farfalla» del periodo cagliaritano ha scritto Raffa Garzia, Per la storia del nostro giornalismo letterario, in «Glossa Perenne», febbraio 1929.
Q6 §173 Azione Cattolica. Cfr «Civiltà Cattolica» del 19 aprile
1930: Azione Cattolica e Associazioni religiose. Riporta una
lettera del card. Pacelli e il riassunto di un discorso del
Papa. Nel marzo precedente il Segretario del P.N.F. aveva
diramato una circolare sulla non incompatibilità per la
contemporanea partecipazione all’Azione Cattolica e al P.N.F.1
Q6 §174 Chiesa Cattolica. Atlas Hierarchicus. Descriptio geographica et statistica Sanctae Romanae Ecclesiae tum Orientis, tum Occidentis juxta statum praesentem. Consilio et hortatu Sanctae Sedis Apostolicae, elaboravit P. Carulus Streit, Paderbornae, 1929 (Casa Ed. di S. Bonifacio, Paderborn). Sulla seconda edizione cfr «Civiltà Cattolica», 7 giugno 1930; sulla prima edizione «Civiltà Cattolica», 1914, vol. III, p. 69. Contiene tutti i dati sulla struttura mondiale della Chiesa Cattolica. Tra la prima e la seconda edizione le variazioni avvenute per la guerra nel numero del personale chiericale può essere interessante. (In Ispagna i preti, per esempio, sono aumentati in questo periodo, in Italia invece pare siano diminuiti, per ricrescere probabilmente dopo il Concordato e gli aumenti di prebende, ecc.).
Q6 §175 Azione Cattolica. Per l’attività in Francia cfr Les nouvelles conditions de la vie industrielle, Semaines Sociales de France, XXI Session, 1929, Parigi, 1930, in 8°, pp. 574. Sarebbe interessante vedere quali argomenti hanno trattato le Settimane Sociali nei vari paesi e perché certe quistioni non sono mai trattate in certi paesi, ecc.
Q6 §176 Passato e presente. Il Memorandum storico-politico di Clemente Solaro della Margarita è stato ristampato nel 1930 (Torino, Bocca, pp. XX, 488, L. 20) per cura del «Centro di Studi monarchici» di Torino. Da chi sarà costituito questo centro? È forse una continuazione dell’«Associazione monarchica» di Giuseppe Brunati e C.? Ricordare che questa associazione aveva per organo il settimanale «Il Sovrano» che si pubblicava a Milano; verso il 1925 vi fu scissione e il Brunati pubblicò a Torino un settimanale «Il Sabaudo», che pubblicava degli articoli molto curiosi per gli operai (si giunse a pubblicare che solo il sovrano poteva realizzare il comunismo o qualcosa di questo genere).
Q6 §177 Storia degli intellettuali italiani. Cfr Angelo Scarpellini, La Battaglia intorno al latino nel settecento in «Glossa Perenne», 1929. (Riassume i termini della lotta combattuta nel 700 pro e contro lo studio del latino e specialmente l’uso di esso nelle scritture, che è la quistione fondamentale dal punto di vista di un rivolgimento nell’attitudine e nei rapporti dei ceti intellettuali verso il popolo).
Q6 §178 Nozioni enciclopediche. Teopanismo. Termine usato dai gesuiti per esempio per indicare una caratteristica della religione induista (ma teopanismo non significa panteismo? oppure si adopera per indicare una particolare concezione religioso‑mitologica, per distinguerla dal «panteismo» filosofico‑superiore?) Cfr «Civiltà Cattolica», 5 luglio 1930 (articolo «L’Induismo», pp. 17‑18):
«Per l’induismo non vi ha differenza sostanziale tra Dio, uomo, animale e pianta: tutto è Dio, non solo nella credenza delle classi inferiori, presso le quali siffatto panteismo è concepito animisticamente, ma anche presso le alte classi e le persone colte, nella cui maniera di pensare l’essenza divina si rivela, in senso teopanistico, come mondo delle anime e delle cose visibili. Benché in sostanza sia lo stesso errore, nondimeno, nella maniera di concepirlo ed esprimerlo, si distingue il panteismo, che immagina il mondo come un essere assoluto, oggetto di culto religioso: “il tutto è Dio”, dal teopanismo, che concepisce Dio come la realtà spirituale-reale, da cui emanano tutte le cose: “Dio diventa tutto”, necessariamente, incessantemente, senza principio e senza fine. Il teopanismo è (accanto a pochi sistemi dualistici) la maniera più comune della filosofia induista, di concepire Dio e il mondo».
Q6 §179 Passato e presente. La scuola professionale. Nel novembre 1931 si è svolta alla Camera dei Deputati un’ampia discussione sull’insegnamento professionale e in essa tutti gli elementi teorici e pratici per lo studio del problema sono affiorati in modo abbastanza perspicuo e organico. Tre tipi di scuola: 1) professionale, 2) media tecnica, 3) classica. La prima per gli operai e contadini, la seconda per i piccoli borghesi, la terza per la classe dirigente.
La quistione si è svolta sull’argomento se le scuole professionali devono essere strettamente pratiche e fine a se stesse, tanto da non dare possibilità di passaggio non solo alla scuola classica ma neanche a quella tecnica. La larghezza di vedute è consistita nell’affermazione che deve essere data la possibilità del passaggio alla scuola tecnica (il passaggio a quella classica è stato escluso a priori da tutti). (Il problema è legato all’organico militare: un soldato può diventare sottufficiale? e se il soldato può diventare sottufficiale, può diventare ufficiale subalterno, ecc.? e a ogni organico in generale: nella burocrazia, ecc.).
Sarebbe interessante ricostruire la storia delle scuole professionali e tecniche nelle discussioni parlamentari e nelle discussioni dei principali Consigli municipali, dato che alcune delle maggiori scuole professionali sono state fondate dai Municipi oppure da lasciti privati, amministrati o controllati o integrati sui bilanci municipali. Lo studio delle scuole professionali collegato alla coscienza delle necessità della produzione e dei suoi sviluppi. Scuole professionali agrarie: un capitolo molto importante: molte iniziative private (ricordare le scuole Faina nell’Abruzzo e in Italia Centrale). Scuole agrarie specializzate (per la vinicultura, ecc.). Scuole agrarie per medi e piccoli proprietari, per creare cioè capi azienda o direttori d’azienda: ma è esistito un tipo di scuola agraria professionale, cioè diretta alla creazione dell’operaio agrario specializzato?
Q6 §180 Nozioni enciclopediche. «Scientifico». Che cosa è «scientifico»? L’equivoco intorno ai termini «scienza» e «scientifico» è nato da ciò che essi hanno assunto il loro significato da un gruppo determinato di scienze e precisamente dalle scienze naturali e fisiche. Si chiamò «scientifico» ogni metodo che fosse simile al metodo di ricerca e di esame delle scienze naturali, divenute le scienze per eccellenza, le scienze‑feticcio. Non esistono scienze per eccellenza e non esiste un metodo per eccellenza, «un metodo in sé». Ogni ricerca scientifica si crea un metodo adeguato, una propria logica, la cui generalità e universalità consiste solo nell’essere «conforme al fine». La metodologia più generica e universale non è altro che la logica formale o matematica, cioè l’insieme di quei congegni astratti del pensiero che si sono venuti scoprendo, depurando, raffinando attraverso la storia della filosofia e della cultura. Questa metodologia astratta, cioè la logica formale, è spregiata dai filosofi idealisti ma erroneamente: il suo studio corrisponde allo studio della grammatica, cioè corrisponde non solo a un approfondimento delle esperienze passate di metodologia del pensiero (della tecnica del pensiero), a un assorbimento della scienza passata, ma è una condizione per lo sviluppo ulteriore della scienza stessa.
Studiare il fatto per cui la «logica» formale è diventata sempre più una disciplina legata alle scienze matematiche – Russell in Inghilterra, Peano in Italia – fino ad essere elevata, come dal Russell, alla pretesa di «sola filosofia» reale. Il punto di partenza potrebbe essere preso dall’affermazione di Engels in cui «scientifico» è contrapposto a «utopistico»; il sottotitolo della «Critica Sociale» del Turati ha lo stesso significato che in Engels? Certo no; per Turati «scientifico» si avvicina al significato di «metodo proprio alle scienze fisiche» (il sottotitolo sparì a un certo punto: vedere quando; certo già nel 1917) e anche questo in senso molto generico e tendenzioso.
Q6 §181 Chiesa cattolica. Santi e beati. La Congregazione dei Riti ha pubblicato (cfr «Corriere della Sera» del 2 dicembre 1931) il catalogo ufficiale delle cause di beatificazione e canonizzazione che sono attualmente in corso. Il precedente catalogo era uscito 10 anni fa e contava 328 processi; l’attuale ne conta 551. Nell’elenco l’Italia figura con 271 cause, la Francia con 116, ecc. Sarebbe interessante esaminare, ai fini di una statistica politico‑sociale, i cataloghi di un periodo di tempo un po’ lungo e distribuire i processi per nazioni, per condizioni sociali, ecc. Bisognerebbe tener conto di varie condizioni: chi propone le cause, come, ecc. Se ne potrebbero trarre dei criteri della politica che il Vaticano segue in queste faccende e dei cambiamenti che una tale politica ha subito nel tempo.
Q6 §182 Cattolici integrali, gesuiti e modernisti. Giovanni Papini. Dalla recensione del libro su Sant’Agostino di Giovanni Papini, pubblicata dalla «Civiltà Cattolica» del 19 luglio 1930 (p. 155), appare che i cattolici integrali si sono schierati contro il Papini: «Le invettive del Tilgher erano poi superate da quelle di uno scrittore anonimo e di una notoria «Agenzia» clandestina, che le passava ai giornali di vario colore, come noi sappiamo: e sebbene si ammantasse di cattolicismo «integrale», essa non aveva certo né la fede né gli interessi delle anime fra le sue prime sollecitudini; molto meno poteva o può rappresentare, con quei suoi metodi di critica, una porzione qualsiasi dei veri e schietti cattolici. Del bollore di quello zelo critico e della sincerità di quelle invettive non avevano dunque le persone saggie da occuparsi; molto meno da edificarsi. E il Papini ha fatto molto bene a non curarsi di loro; ed anche i suoi amici a non darvi peso».
La recensione dev’essere del padre Rosa come appare dalla grammatica alquanto sbilenca e da preziosità come quella di un’«Agenzia» che è notoria ma è anche clandestina. Il Papini, così difeso dai gesuiti e attaccato dagli integrali, non essendo modernista, deve essere senza dubbio di errore catalogato fra i gesuiti.
Q6 §183 Azione Cattolica. Per la preistoria dell’Azione Cattolica cfr nella «Civiltà Cattolica» del 2 agosto 1930 l’articolo: Cesare D’Azeglio e gli albori della stampa cattolica in Italia. Per «stampa cattolica» si intende «stampa dei cattolici militanti» fra il laicato, all’infuori della «stampa» cattolica in senso stretto ossia espressione dell’organizzazione ecclesiastica.
Nel «Corriere d’Italia» dell’8 luglio 1926 è apparsa una lettera di Filippo Crispolti che dev’essere molto interessante, nel senso che il Crispolti «faceva osservare che chi volesse ricercare i primi impulsi di quel movimento donde uscì anche in Italia la schiera dei «cattolici militanti», cioè l’innovazione che nel campo nostro ne produsse ogni altra, dovrebbe prendere le mosse da quelle singolari società piemontesi, dette “Amicizie”, che furono fondate o animate dall’abate Pio Brunone Lanteri». Il Crispolti cioè riconosce che l’Azione Cattolica è una innovazione e non già, come sempre dicono le encicliche papali, una attività sempre esistita dagli Apostoli in poi. Essa è una attività strettamente legata, come reazione, all’illuminismo francese, al liberalismo, ecc. e all’attività degli Stati moderni per la separazione dalla Chiesa, cioè alla riforma intellettuale e morale laicistica ben più radicale (per le classi dirigenti) della Riforma protestante; attività cattolica che si configura specialmente dopo il 48, cioè con la fine della Restaurazione e della Santa Alleanza.
Il movimento per la stampa cattolica, di cui parla la «Civiltà Cattolica», legato al nome di Cesare D’Azeglio è interessante anche per l’atteggiamento del Manzoni al riguardo: si può dire che il Manzoni comprese il carattere reazionario dell’iniziativa del D’Azeglio e si rifiutò elegantemente di collaborarvi, eludendo le aspettazioni del D’Azeglio con l’invio della famosa lettera sul Romanticismo, che, scrive la «Civiltà Cattolica», «dato il motivo che la provocò, può considerarsi come una dichiarazione di principii. Evidentemente il vessillo letterario non era che lo schermo di altre idee, di altri sentimenti, che li divideva», e cioè il diverso atteggiamento nel problema della difesa della religione.
L’articolo della «Civiltà Cattolica» è essenziale per lo studio della preparazione dell’Azione Cattolica.
Q6 §184 Nozioni enciclopediche. Reliquie dell’organizzazione corporativa medioevale: 1) La compagnia della Caravana a Genova tra i lavoratori del porto; su di essa deve esistere una certa letteratura; 2) A Ravenna esiste ancora la così detta «Casa Matha», reliquia di una «Schola piscatoria» che risalirebbe a prima dell’anno Mille. Matha deriverebbe dal greco mahkeis, «stuoia», e ricorderebbe le capanne di stuoia di canne palustri dove trovavano riparo i primi pescatori della Ravenna bizantina. Della «Società degli Uomini della Casa Matha» tratterebbe uno storico Bard: l’annalista ravennate Agnello ricorderebbe la Schola piscatoria per il 733 (ma è la stessa?); L. A. Muratori la menzionerebbe per il 943 (ma è la stessa cosa?). La Società degli Uomini della Casa Matha ha statuti che rimontano al 1304: il presidente si chiama «Primo Massaro». Nel 1887 furono rinnovati gli Statuti che abolirono le cerimonie religiose con cui si aprivano le adunanze. Una norma statutaria fissa che appena aperta l’adunanza si chiudano le porte per impedire a ritardatari (che saranno multati) di sopraggiungere e ai presenti di allontanarsi prima della fine dei lavori. Oggi i soci si dividono in «ordinari» e del «grembiule» (pescivendoli e pescatori) e sono in tutto 150. Oggi la Società amministra una scuola nautica che assorbe la maggior parte delle rendite sociali, ma continua l’opera di assistenza.
Una ricerca sulla lingua delle organizzazioni operaie prima della costituzione della C.G.L.: il termine «console» per esempio, ecc. che era mantenuto nei primi «fasci» operai del Partito operaio, ecc.
Q6 §185 Nozioni enciclopediche. Consiglio di Stato. Doppio significato del termine. In Italia il Consiglio di Stato ha preso il significato di organismo giudiziario per gli affari amministrativi. Ma non a questo significato si riferiscono i pubblicisti inglesi quando polemizzano sulla quistione se il Parlamento (Camera dei deputati) possa e debba trasformarsi in un Consiglio di Stato: essi si riferiscono alla quistione del parlamentarismo come regime dei partiti o al parlamentarismo che debba essere ridotto a un corpo legislativo in regime puramente costituzionale, con l’equilibrio dei poteri rotto a profitto della corona o del potere esecutivo in generale, cioè ridotto alla funzione dei Consigli di Stato in regime di assolutismo monarchico o dittatoriale di destra. In Italia una traccia del vecchio istituto del Consiglio di Stato lo si può trovare nel Senato, che non è una Camera dell’aristocrazia (come in Inghilterra), non è elettivo sia pure in forme indirette come in Francia e altrove, ma è nominato dal potere esecutivo tra gente ligia al potere di una forza determinata per arginare l’espansione democratica e l’intervento popolare negli affari.
Q6 §186 Azione Cattolica. In Ispagna. Cfr M. De Burgos y Mazo, El problema social y la democracia cristiana. Nel 1929 è uscita la Parte prima, Tomo V (?), di pp. 790, a Barcellona, ed. L. Gili. Dev’essere un’opera mastodontica. Questo Tomo V della prima parte costa pesete 18,70.
Q6 §187 Azione Cattolica. Stati Uniti. È interessante la corrispondenza dagli Stati Uniti pubblicata nella «Civiltà Cattolica» del 20 settembre 1930. I cattolici ricorrono spesso all’esempio degli Stati Uniti per ricordare la loro compattezza e il loro fervore religioso in confronto dei protestanti divisi in tante sette e continuamente rosi dalla tendenza a cadere nell’indifferentismo o nell’areligiosità, onde l’imponente numero di cittadini che nei censimenti dichiarano di essere senza religione. Pare però, da questa corrispondenza, che, anche tra i cattolici, l’indifferentismo non sia scarso. Si riportano i dati pubblicati in una serie di articoli pubblicati dalla «rinomata» «Ecclesiastical Review» di Philadelphia pubblicati nei mesi precedenti: un parroco afferma che il 44% dei suoi fedeli rimase, per tutta una lunga serie di anni, interamente sconosciuto, nonostante gli sforzi fatti ripetutamente e da parte sua e dai suoi assistenti ecclesiastici, per arrivare ad un esatto censimento. Con tutta sincerità ammette che circa una metà del gregge restò del tutto estraneo alle sue cure, né altro contatto si ebbe fuori di quello che può dare una irregolare frequenza alla messa ed ai sacramenti. Sono fatti, a detta degli stessi parroci, che si avverano in pressoché tutte le parrocchie degli Stati Uniti.
I cattolici mantengono a loro spese 7664 scuole parrocchiali frequentate da 2 201 942 alunni sotto la guida di religiosi d’ambo i sessi. Rimangono altri 2 750 000 alunni (cioè più del 50%) che «o per infingardaggine dei genitori o per lontananza di luogo sono costretti a frequentare le scuole governative, areligiose, dove non si ode mai una parola su Dio, sui doveri verso il Creatore e neppure sull’esistenza di un’anima immortale».
Un elemento di indifferentismo è dato dai matrimoni misti: «il 20% delle famiglie validamente congiunte in matrimonio misto tralasciano la Messa, se il padre non appartiene alla fede cattolica; ma qualora la madre non sia cattolica, la statistica dà il 40%. Di più, questi genitori trascurano totalmente la educazione cristiana della prole». Si cercò di restringere questi matrimoni misti e anche di proibirli; ma le condizioni «peggiorarono» perché i «recalcitranti» in questi casi abbandonarono la chiesa (con la prole) contraendo unioni «invalide»; questi casi sono il 61% se il padre è «eretico», il 94% se «eretica» è la madre. Perciò si largheggiò: rifiutando la dispensa di matrimonio misto a donne cattoliche si ha una perdita del 58%, se si dà la dispensa la perdita è «solo» del 16%.
Appare quindi che il numero dei cattolici negli Stati Uniti è solo un numero statistico, da censimenti, cioè più difficilmente uno di origine cattolica dichiara di essere senza religione, a differenza di quelli d’origine protestante. Più ipocrisia, insomma. Da questo si può giudicare l’esattezza e la sincerità delle statistiche nei paesi a maggioranza cattolica.
Q6 §188 Azione Cattolica. Sulle origini dell’Azione Cattolica cfr l’articolo La fortuna del La Mennais e le prime manifestazioni d’Azione Cattolica in Italia («Civiltà Cattolica» del 4 ottobre 1930: è la prima parte dell’articolo; la continuazione appare molto più tardi, come sarà notato), che si riallaccia al precedente articolo su Cesare D’Azeglio ecc. La «Civiltà Cattolica» parla di «quell’ampio moto d’azione e di idee che si manifestò, in Italia come negli altri paesi cattolici di Europa, durante il periodo corso tra la prima e la seconda rivoluzione (1821‑1831), quando furono seminati alcuni di quei germi (se buoni o malvagi non diremo), che dovevano poi dare i loro frutti in tempi più maturi». Ciò significa che il primo moto di Azione Cattolica sorse per l’impossibilità della Restaurazione di essere realmente tale, cioè di ricondurre le cose nei quadri dell’Ancien Régime. Come il legittimismo così anche il cattolicismo, da posizioni integrali e totalitarie nel campo della cultura e della politica, diventano partiti in contrapposto di altri partiti e, di più, partiti in posizione di difesa e di conservazione, quindi costretti a fare molte concessioni agli avversari per meglio sostenersi. Del resto questo è il significato di tutta la Restaurazione come fenomeno complessivo europeo e in ciò consiste il suo carattere fondamentalmente «liberale».
L’articolo della «Civiltà Cattolica» pone un problema essenziale: se il Lamennais è all’origine dell’Azione Cattolica, questa origine non contiene il germe del posteriore cattolicismo liberale, il germe che, sviluppandosi in seguito, darà il Lamennais seconda maniera? È da notare che tutte le innovazioni nel seno della Chiesa quando non sono dovute a iniziativa del centro, hanno in sé qualcosa di ereticale e finiscono con assumere esplicitamente questo carattere finché il centro reagisce energicamente, scompigliando le forze innovatrici, riassorbendo i tentennanti ed escludendo i refrattari. È notevole che la Chiesa non ha mai avuto molto sviluppato il senso dell’autocritica come funzione centrale; ciò nonostante la tanto vantata sua adesione alle grandi masse dei fedeli. Perciò le innovazioni sono sempre state imposte e non proposte e accolte solo obtorto collo. Lo sviluppo storico della Chiesa è avvenuto per frazionamento (le diverse compagnie religiose sono in realtà frazioni assorbite e disciplinate come «ordini religiosi»). Altro fatto della Restaurazione: i governi fanno concessioni alle correnti liberali a spese della Chiesa e dei suoi privilegi e questo è un elemento che crea la necessità di un partito della Chiesa ossia dell’Azione Cattolica.
Lo studio delle origini dell’Azione Cattolica porta così a uno studio del Lamennaisismo e della sua diversa fortuna e diffusione.
Q6 §189 Lorianesimo. Il 12 dicembre 1931, nel culmine della crisi mondiale, Achille Loria discute al Senato una sua interrogazione: se il ministero dell’interno «non ritenga opportuno evitare gli spettacoli di equilibrismo che non adempiono a nessuna funzione educativa, mentre sono troppo frequentemente occasione di sciagure mortali». Dalla risposta dell’on. Arpinati pare che «gli spettacoli di equilibrismo appartengano a quelle attività improduttive che il sen. Loria ha analizzato nel Trattato di Economia», e quindi la quistione, secondo il Loria, potrebbe essere un contributo alla soluzione della crisi economica. Si potrebbe fare dello spirito a buon mercato sugli spettacoli di equilibrismo del Loria stesso, che non gli hanno procurato finora nessuna sciagura mortale.
Q6 §190 Cultura sud‑americana. Cfr l’articolo Il protestantesimo degli Stati Uniti e l’Evangelizzazione protestante nell’America latina nella «Civiltà Cattolica» del 18 ottobre 1930. L’articolo è interessante e istruttivo per apprendere come lottano tra loro cattolici e protestanti: naturalmente i cattolici presentano le missioni protestanti come l’avanguardia della penetrazione economica e politica degli Stati Uniti e lottano contro sollevando il sentimento nazionale. Lo stesso rimprovero fanno i protestanti ai cattolici, presentando la Chiesa e il papa come potenze terrene che si ammantano di religione, ecc.
Q6 §191 America e massoneria. Cfr lo studio: La Massoneria americana e la riorganizzazione della Massoneria in Europa, pubblicato nella «Civiltà Cattolica» del 1° novembre 1930 e 3 gennaio 1931. Lo studio è molto interessante e pare abbastanza oggettivo. La situazione internazionale attuale della Massoneria, con le sue lotte interne eredità della guerra (Francia contro Germania), risalta in modo chiaro. Dopo la guerra fu fondata l’«Association Maçonnique Internationale» con sede a Ginevra, per impulso della massoneria franco‑belga, il cui scopo era di riorganizzare le forze. Il primo problema era di ricondurre la massoneria tedesca e anglosassone sotto la guida della massoneria franco-belga, sotto il patrocinio della massoneria americana. Sull’A.M.I. il padre Pirri (che è lo scrittore di quistioni massoniche della «Civiltà Cattolica») ha pubblicato un opuscolo di estratti dalla rivista. Pare che l’A.M.I. sia fallita completamente, e gli americani abbiano ritirato il loro patrocinio alla Francia. A questa iniziativa i tedeschi risposero ampliando le basi di una «Esperanto Framasona» esistente già prima della guerra e riorganizzata come «Universala Framasona Ligo» (Allgemeine Freimaurerliga), che sulla base della diffusione dell’Esperanto volle creare un nuovo tipo di massoneria agnostica nelle quistioni di religione e di politica (la Massoneria francese è illuministica e democratica). La Massoneria americana pare aiuti ora i massoni tedeschi (di Germania e Austria) contro il Grande Oriente francese. Ossian Lang, massone americano, viaggia continuamente in Europa per questo lavoro di organizzazione. (Ricordare che la massoneria americana è molto ricca e può finanziare queste iniziative. La «Ligo» si diffonde in tutta Europa: essa pare si mostri più conciliante e tollerante verso il Cattolicismo della vecchia massoneria tipo francese. Su questo atteggiamento che dette luogo a un incontro di tre rappresentanti della «Ligo» col gesuita padre Gruber, studioso di quistioni massoniche, la «Civiltà Cattolica» si diffonde e di questa parte occorre ricordarsi, perché ha un certo valore per la storia della cultura. Rito Simbolico e Rito Scozzese: pare che il Rito Simbolico sia più forte nei paesi latini e il Rito Scozzese nei paesi anglosassoni, quindi tutta questa attività americana porterebbe a rafforzare la Massoneria di Rito Scozzese.
Q6 §192 Storia degli intellettuali italiani. Cfr G. Masi, La struttura sociale delle fazioni politiche fiorentine ai tempi di Dante, Firenze, Olschki, 1930, in 8°, pp. 32.
Q6 §193 Azione Cattolica. Spagna. Cfr N. Noguer S. J., La acciòn católica en la teorìa y en la práctica en España y en el extraniero, Madrid, «Razón y Fe», in 16°, pp. 240‑272, 8 pesete.
Q6 §194 Passato e presente. La riforma Gentile e la religione nelle scuole. Cfr l’articolo L’ignoto e la religione naturale secondo il senator Gentile, nella «Civiltà Cattolica» del 6 dicembre 1930. Si esamina la concezione del Gentile sulla religione, ma naturalmente gli si è grati per aver introdotto l’insegnamento della religione nella scuola.
Q6 §195 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. Il caso Turmel. Cfr l’articolo La catastrofe del caso Turmel e i metodi del modernismo critico, nella «Civiltà Cattolica» del 6 dicembre 1930. Lo scritto è molto importante e il caso Turmel è di sommo interesse nella quistione. Questo Turmel, pur rimanendo sacerdote, per oltre venti anni, con svariatissimi pseudonimi, scrisse articoli e libri di carattere eterodosso, fino ad essere apertamente ateistici. Nel 1930 i gesuiti riuscirono a smascherarlo e a farlo dichiarare scomunicato vitando: nel decreto del Santo Uffizio è contenuta la lista delle sue pubblicazioni e dei suoi pseudonimi. La sua attività ha del romanzesco. Risulta così che dopo la crisi modernistica, nell’organizzazione ecclesiastica si formarono delle formazioni segrete: oltre a quella dei gesuiti (che d’altronde non sono omogenei e concordi, ma hanno avuto un’ala modernistica – il Tyrrell era gesuita – e una integralista – il cardinale Billot era integralista) esisteva ed esisterà ancora una formazione segreta integralista e una modernista. La identificazione del Turmel coi suoi pseudonimi ha anch’essa qualcosa di romanzesco: indubbiamente il centro gesuitico aveva teso intorno a lui una vasta tela che andò restringendosi mano mano fino a imprigionarlo. Appare che il Turmel aveva delle protezioni nelle Congregazioni romane, ciò che dimostra che i modernisti non sono tutti stati identificati, nonostante il giuramento, ma operano segretamente ancora. Turmel aveva scritto articoli e libri con quindici pseudonimi: Louis Coulange, Henri Delafosse, Armand Dulac, Antoine Dupin, Hippolyte Gallerand, Guillaume Herzog, André Lagard, Robert Lawson, Denys Lenain, Paul Letourneur, Goulven Lézurec, Alphonse Michel, Edmond Perrin, Alexis Vanbeck, Siouville. Avveniva che il Turmel con un pseudonimo confutasse o lodasse articoli e libri scritti con altro pseudonimo, ecc. Collaborava alla rivista «Revue d’histoire des religions» e alla collezione «Christianisme» diretta dal Couchoud presso l’editore Rieder.
È da tener conto anche di un altro articolo pubblicato nella «Civiltà Cattolica» del 20 dicembre 1930: Lo spirito dell’«Action Française» a proposito di «intelligenza» e di «mistica», dove si parla del volume di Jean Héritier Intelligence et Mystique (Parigi, Librairie de France, 1930, in 8°, pp. 230) nella collezione «Les Cahiers d’Occident» che si propone di diffondere i principi sulla difesa dell’occidente secondo lo spirito del noto libro di Henri Massis. Per i gesuiti il Massis e le sue teorie sono sospette: d’altronde è notorio il contatto tra il Massis e Maurras. Il movimento del Massis è da porre tra quelli del «cattolicismo integrale» o del forcaiolismo cattolico. (Anche il movimento dell’Action Française è da porre tra quelli sostenuti dall’integralismo). In Francia la nascita dell’integralismo è da connettere col movimento del Ralliement propugnato da Leone XIII: sono integralisti quelli che disobbediscono a Leone XIII e ne sabotano l’iniziativa. La lotta di Pio X contro il Combismo sembra dar loro ragione e Pio X è il loro papa, come è il papa di Maurras. In appendice al volume dell’Héritier sono stampati articoli di altri scrittori che trattano del Ralliement e sostengono anche nelle quistioni di storia religiosa la tesi del Maurras sull’anarchismo dissolvente del cristianesimo giudaico e sulla romanizzazione del cattolicismo.
Q6 §196 Politica del Vaticano. Malta. Cfr nella «Civiltà Cattolica» del 20 dicembre 1930: Nel decimo anno della diarchia maltese. La «Civiltà Cattolica» chiama diarchia o doppio governo la posizione politica creata a Malta nel 1921 con la concessione di una costituzione per cui, pur rimanendo all’Inghilterra la sovranità, il governo veniva affidato ai cittadini. Interpretazione evidentemente tendenziosa, ma utile ai cattolici per impostare le loro agitazioni contro l’Inghilterra protestante e impedire che i cattolici perdano la supremazia a Malta.
Q6 §197 Gli intellettuali. Alla Università di Madrid, Eugenio D’Ors sta (1931) svolgendo un largo corso di conferenze su La scienza e la storia della Cultura che, da alcuni cenni pubblicati nelle «Nouvelles Littéraires» del 31 Ottobre 1931 pare debba essere una enorme sociologia del fatto culturale o della civiltà. Il corso sarà pubblicato in volumi, certamente.
Q6 §198 Passato e presente. «Sollecitare i testi». Cioè far dire ai testi, per amor di tesi, più di quanto i testi realmente dicono. Questo errore di metodo filologico si verifica anche all’infuori della filologia, in tutte le analisi e gli esami delle manifestazioni di vita. Corrisponde, nel diritto penale, a vendere a meno peso e di differente qualità da quelli pattuiti, ma non è ritenuto crimine, a meno che non sia palese la volontà di ingannare: ma la trascuratezza e l’incompetenza non meritano sanzione, almeno una sanzione intellettuale e morale se non giudiziaria?
Q6 §199 Risorgimento. La Costituzione spagnola del 12. Perché i primi liberali italiani (nel 21 e dopo) scelsero la costituzione spagnola come loro rivendicazione? Si trattò solamente di un fenomeno di mimetismo e quindi di primitività politica? O di un fenomeno di pigrizia mentale? Senza trascurare completamente l’influenza di questi elementi, espressione della immaturità politica e intellettuale e quindi dell’astrattismo dei ceti dirigenti della borghesia italiana, occorre non cadere nel giudizio superficiale che tutte le istituzioni italiane siano importate dall’estero meccanicamente e sovrapposte a un contenuto nazionale refrattario. Intanto occorre distinguere tra Italia meridionale e il resto d’Italia: la rivendicazione della Carta Spagnola nasce nell’Italia meridionale ed è ripresa in altre parti d’Italia per la funzione che ebbero i profughi napoletani nel resto d’Italia dopo la caduta della Repubblica partenopea. Ora le necessità politico‑sociali dell’Italia meridionale erano davvero molto diverse che quelle della Spagna? L’acuta analisi fatta dal Marx della Carta spagnola (cfr lo scritto sul generale Espartero nelle opere politiche) e la dimostrazione chiara dell’essere quella Carta l’espressione esatta di necessità storiche della società spagnola e non un’applicazione meccanica dei principi della Rivoluzione francese, inducono a credere che la rivendicazione napoletana fosse più «storicistica» di quanto paia. Bisognerebbe riprendere quindi l’analisi di Marx, confrontare con la costituzione siciliana del 12 e con i bisogni meridionali: il confronto potrebbe continuare con lo Statuto albertino.
Q6 §200 Intellettuali italiani. Perché ad un certo punto la maggioranza dei cardinali fu composta di italiani e i papi furono sempre scelti tra italiani? Questo fatto ha una certa importanza nello sviluppo intellettuale nazionale italiano e qualcuno potrebbe anche vedere in esso l’origine del Risorgimento. Esso certamente fu dovuto a necessità interne di difesa e sviluppo della Chiesa e della sua indipendenza di fronte alle grandi monarchie straniere europee, tuttavia la sua importanza nei riflessi italiani non è perciò diminuita. Se positivamente il Risorgimento può dirsi incominci con l’inizio delle lotte tra Stato e Chiesa, cioè con la rivendicazione di un potere governativo puramente laico, quindi col regalismo e il giurisdizionalismo (onde l’importanza del Giannone), negativamente è anche certo che le necessità di difesa della sua indipendenza portarono la Chiesa a cercare sempre più in Italia la base della sua supremazia e negli italiani il personale del suo apparato organizzativo. È da questo inizio che si svilupperanno le correnti neoguelfe del Risorgimento, attraverso le diverse fasi (quella del Sanfedismo italiano per esempio) più o meno retrive e primitive.
Questa nota perciò interessa oltre la rubrica degli intellettuali anche quella del Risorgimento e quella delle origini dell’Azione Cattolica «italiana».
Nello sviluppo di una classe nazionale, accanto al processo della sua formazione nel terreno economico, occorre tener conto del parallelo sviluppo nei terreni ideologico, giuridico, religioso, intellettuale, filosofico, ecc.: si deve dire anzi che non c’è sviluppo sul terreno economico, senza questi altri sviluppi paralleli. Ma ogni movimento della «tesi» porta a movimenti della «antitesi» e quindi a «sintesi» parziali e provvisorie. Il movimento di nazionalizzazione della Chiesa in Italia è imposto non proposto: la Chiesa si nazionalizza in Italia in forme ben diverse da ciò che avviene in Francia col gallicanismo, ecc. In Italia la Chiesa si nazionalizza in modo «italiano», perché deve nello stesso tempo rimanere universale: intanto nazionalizza il suo personale dirigente e questo vede sempre più l’aspetto nazionale della funzione storica dell’Italia come sede del Papato.
Q6 §201 I nipotini di padre Bresciani. Bruno Cicognani. Il romanzo Villa Beatrice. Storia di una donna, pubblicato nel «Pègaso» del 1931. Il Cicognani appartiene al gruppo di scrittori cattolici fiorentini: Papini, Enrico Pea, Domenico Giuliotti. Villa Beatrice può chiamarsi il romanzo della filosofia neoscolastica di padre Gemelli, il romanzo del «materialismo» cattolico, un romanzo della «psicologia sperimentale» tanto cara ai neoscolastici e ai gesuiti? Confronto tra romanzi psicoanalitici e il romanzo di Cicognani. È difficile dire in che cosa la dottrina e la religiosità del cattolicismo contribuiscano alla costruzione del romanzo (dei caratteri del dramma): nella conclusione, l’intervento del prete è esteriore, il risveglio religioso in Beatrice è solamente affermato, e i mutamenti nella protagonista potrebbero anche solo essere giustificati da ragioni fisiologiche. Tutta la personalità, se può parlarsi di personalità, di Beatrice, è descritta minuziosamente come un fenomeno di storia naturale, non è rappresentata artisticamente: il Cicognani «scrive bene», nel senso volgare della parola, come «scriverebbe bene» un trattato del gioco degli scacchi. Beatrice è «descritta» come la freddezza sentimentale impersonificata e tipizzata. Perché essa è «incapace» di amare e di entrare in relazione affettiva con chiunque altro (anche la madre e il padre) in un modo esasperato e da decalcomania? Ella è fisiologicamente imperfetta negli organi genitali, soffre fisiologicamente nell’abbraccio e non potrebbe partorire? Ma questa imperfezione intima (e perché la natura non la costruì brutta esteriormente, indesiderabile ecc.? Contraddizione della natura!) è dovuta al fatto che ella soffre di cuore. Il Cicognani crede che fin dallo stato di ovulo fecondato il nuovo essere che eredita una malattia organica si prepara alla difesa contro l’attacco futuro del male: ecco che l’ovulo‑Beatrice, nata con il cuore debole, si costruisce un organo sessuale imperfetto che la farà repugnare dall’amore e da ogni emotività ecc. ecc. Tutta questa teoria è del Cicognani, è il quadro generale del romanzo: naturalmente Beatrice non è cosciente di questa determinazione della sua esistenza psichica; essa non opera perché crede di essere così, ma opera perché è così all’infuori della sua coscienza: in realtà la sua coscienza non è rappresentata, non è un motore che spieghi il dramma. Beatrice è un «pezzo anatomico» non una donna.
Il Cicognani non evita le contraddizioni, perché pare che talvolta Beatrice soffra di dover essere fredda, come se questa sofferenza non fosse essa stessa una «passione» che potrebbe precipitare il mal di cuore; pare quindi che solo l’unione sessuale e il concepimento col parto siano pericolosi «per la natura», ma allora la natura avrebbe dovuto provvedere altrimenti alla «salvaguardia» dell’ovaia di Beatrice: avrebbe dovuto costruirla «sterile» o meglio «fisiologicamente» incapace di unione sessuale. Tutto questo pasticcio Ugo Ojetti ha esaltato come il raggiungimento da parte del Cicognani della «classicità artistica».
Il modo di pensare del Cicognani potrebbe essere incoerente ed egli potrebbe aver scritto tuttavia un bel romanzo: ma questo appunto non è il caso.
Q6 §202 Il Concordato. Quando incominciarono le trattative per il Concordato? Il discorso del 1° gennaio 1926 si riferiva al Concordato?. Le trattative dovrebbero avere fasi varie, di maggiore o minore ufficiosità, prima di entrare nella fase ufficiale, diplomatica: perciò l’inizio di esse può essere spostato ed è naturale la tendenza a spostarle per farne apparire più rapido il decorso. Nella «Civiltà Cattolica» del 19 dicembre 1931 a p. 548 (nota bibliografica sul libro: Wilfred Parsons, The Pope and Italy, Washington, Tip. Ed. The America Press, 1929, in 16°, pp. 134: il Parsons è direttore della rivista «America») si dice: «in fine rievoca fedelmente la storia delle trattative, che dal 1926 si protrassero fino all’anno 1929».
Q6 §203 Passato e presente. Lo Stato e i funzionari. Un’opinione diffusa è questa: che mentre per i cittadini l’osservanza delle leggi è un obbligo giuridico, per lo «Stato» l’osservanza è solo un obbligo morale, cioè un obbligo senza sanzioni punitive per l’evasione. Si pone la quistione: che cosa si intende per «Stato», cioè chi ha solo l’obbligo «morale» di osservare la legge e non si finisce mai di constatare quanta gente crede di non avere obblighi «giuridici» e di godere dell’immunità e dell’impunità. Questo «stato d’animo» è legato a un costume o ha creato un costume? L’una cosa e l’altra sono vere. Cioè lo Stato, in quanto legge scritta permanente, non è stato mai concepito (e fatto concepire) come un obbligo oggettivo e universale.
Questo modo di pensare è legato alla curiosa concezione del «dovere civico» indipendente dai «diritti», come se esistessero doveri senza diritti e viceversa: questa concezione è legata appunto all’altra della non obbligatorietà giuridica delle leggi per lo Stato, cioè per i funzionari e agenti statali i quali pare abbiano troppo da fare per obbligare gli altri perché rimanga loro tempo di obbligare se stessi.
Q6 §204 Passato e presente. Un detto popolare: L’amore del tarlo. Ricordare anche il proverbio inglese: Con cento lepri non si fa un cavallo, con cento sospetti non si fa una prova.
Q6 §205 Nozioni enciclopediche. Azione diretta. Diversi significati secondo le tendenze politiche e ideologiche. Significato degli «individualisti» e degli «economisti», con significati intermedi. Il significato degli «economisti» o sindacalisti di varie tendenze (riformisti, ecc.) è quello che ha dato la stura ai vari significati, fino a quello dei puri «criminali».
Q6 §206 Quistioni scolastiche. Cfr l’articolo Il facile e il difficile di Metron nel «Corriere della Sera» del 7 gennaio 1932. Metron fa due osservazioni interessanti (riferendosi ai corsi d’ingegneria e agli esami di Stato per gli ingegneri): 1) Che durante il corso l’insegnante parla per cento e lo studente assorbe per uno o due. 2) Che negli esami di Stato i candidati sanno rispondere alle quistioni «difficili» e falliscono nelle quistioni «facili». Metron non analizza però esattamente le ragioni di questi due problemi e non indica nessun rimedio «tendenziale». Mi pare che le due deficienze siano legate al sistema scolastico delle lezioni‑conferenze senza «seminario» e al carattere tradizionale degli esami che ha creato una psicologia tradizionale degli esami. Appunti e dispense. Gli appunti e le dispense si fermano specialmente sulle quistioni «difficili»: nell’insegnamento stesso si insiste sul «difficile», nell’ipotesi di una attività indipendente dello studente per le «cose facili». Quanto più si avvicinano gli esami tanto più si riassume la materia del corso, fino alla vigilia, quando si «ripassano» solo appunto le quistioni più difficili: lo studente è come ipnotizzato dal difficile, tutte le sue facoltà mnemoniche e la sua sensibilità intellettuale si concentrano sulle quistioni difficili, ecc. Per l’assorbimento minimo: il sistema delle lezioni‑conferenze porta l’insegnante a non ripetersi o a ripetersi il meno possibile: le quistioni sono così presentate solo entro un quadro determinato, ciò che le rende unilaterali per lo studente. Lo studente assorbe uno o due del cento detto dall’insegnante; ma se il cento è formato di cento unilateralità diverse, l’assorbimento non può essere che molto basso. Un corso universitario è concepito come un libro sull’argomento: ma si può diventare colti con la lettura di un solo libro? Si tratta quindi della quistione del metodo nell’insegnamento universitario: all’Università si deve studiare o studiare per saper studiare? Si devono studiare «fatti» o il metodo per studiare i «fatti»? La pratica del «seminario» dovrebbe appunto integrare e vivificare l’insegnamento orale.
Q6 §207 Letteratura popolare. Il Guerin Meschino. Nel «Corriere della Sera» del 7 gennaio 1932 è pubblicato un articolo firmato Radius con questi titoli: I classici del popolo. Guerino detto il Meschino. Il sopratitolo I classici del popolo è vago e incerto: il Guerino, con tutta una serie di libri simili (I Reali di Francia, Bertoldo, storie di briganti, storie di cavalieri, ecc.) rappresenta una determinata letteratura popolare, la più elementare e primitiva, diffusa tra gli strati più arretrati e «isolati» del popolo: specialmente nel Mezzogiorno, nelle montagne, ecc. I lettori del Guerino non leggono Dumas o i Miserabili e tanto meno Sherlock Holmes. A questi strati corrisponde un determinato folclore e un determinato «senso comune».
Radius ha solo leggiucchiato il libro e non ha molta dimestichezza con la filologia. Egli dà di Meschino un significato cervellotico: «il nomignolo fu appioppato all’eroe per via della sua grande meschinità genealogica»: errore colossale che muta tutta la psicologia popolare del libro e muta il rapporto psicologico‑sentimentale dei lettori popolari verso il libro. Appare subito che Guerino è di stirpe regia, ma la sua sfortuna lo fa diventare «servo», cioè «meschino» come si diceva nel Medio Evo e come si trova in Dante (nella Vita Nova, ricordo perfettamente). Si tratta dunque di un figlio di re, ridotto in ischiavitù, che riconquista, coi suoi propri mezzi e con la sua volontà, il suo rango naturale: c’è nel «popolo» più primitivo questo ossequio tradizionale alla nascita che diventa «affettuoso» quando la sfortuna colpisce l’eroe e diventa entusiasmo quando l’eroe riconquista, contro la sfortuna, la sua posizione sociale.
Guerino come poema popolare «italiano»: è da notare, da questo punto di vista, quanto sia rozzo e incondito il libro, cioè come non abbia subito nessuna elaborazione e perfezionamento, dato l’isolamento culturale del popolo, lasciato a se stesso. Forse per questa ragione si spiega l’assenza di intrighi amorosi, l’assenza completa di erotismo nel Guerino.
Il Guerino come «enciclopedia popolare»: da osservare quanto debba essere bassa la cultura degli strati che leggono il Guerino e quanto poco interesse abbiano per la «geografia», per esempio, per accontentarsi e prendere sul serio il Guerino. Si potrebbe analizzare il Guerino come «enciclopedia» per averne indicazioni sulla rozzezza mentale e sulla indifferenza culturale del vasto strato di popolo che ancora se ne pasce.
Q6 §208 Letteratura popolare. Lo «Spartaco» di R. Giovagnoli. Nel «Corriere della Sera» dell’8 gennaio 1932 è pubblicata la lettera inviata da Garibaldi a Raffaele Giovagnoli il 25 giugno 1874 da Caprera, subito dopo la lettura del romanzo Spartaco. La lettera è molto interessante per questa rubrica sulla «letteratura popolare» poiché il Garibaldi ha scritto anche egli dei «romanzi popolari» e nella lettera sono gli spunti principali della sua «poetica» in questo genere. Spartaco del Giovagnoli, d’altronde, è uno dei pochissimi romanzi popolari italiani che ha avuto diffusione anche all’estero, in un periodo in cui il «romanzo» popolare da noi era «anticlericale» e «nazionale», aveva cioè caratteri e limiti strettamente paesani. Per ciò che ricordo, mi pare che Spartaco si presterebbe specialmente a un tentativo che, entro certi limiti, potrebbe diventare un metodo: si potrebbe cioè «tradurlo» in lingua moderna: purgarlo delle forme retoriche e barocche come lingua narrativa, ripulirlo di qualche idiosincrasia tecnica e stilistica, rendendolo «attuale». Si tratterebbe di fare, consapevolmente, quel lavorio di adattamento ai tempi e ai nuovi sentimenti e nuovi stili che la letteratura popolare subiva tradizionalmente quando si trasmetteva per via orale e non era stata fissata e fossilizzata dalla scrittura e dalla stampa. Se questo si fa da una lingua in un’altra, per i capolavori del mondo classico che ogni età ha tradotto e imitato secondo le nuove culture, perché non si potrebbe e dovrebbe fare per lavori come Spartaco e altri, che hanno un valore «culturale‑popolare» più che artistico? (Motivo da svolgere). Questo lavorio di adattamento si verifica ancora nella musica popolare, per i motivi musicali popolarmente diffusi: quante canzoni d’amore non sono diventate politiche, passando per due tre elaborazioni? Ciò avviene in tutti i paesi e si potrebbero citare dei casi abbastanza curiosi (per es. l’inno tirolese di Andreas Hofer che ha dato la forma musicale alla Molodaia Gvardia).
Per i romanzi ci sarebbe l’impedimento dei diritti d’autore che oggi mi pare durino fino a ottanta anni dalla prima pubblicazione (non si potrebbe però eseguire il rimodernamento per certe opere: per esempio I Miserabili, l’Ebreo Errante, Il conte di Montecristo, ecc. che sono troppo fissati nella forma originale).
Q6 §209 Intellettuali. Intellettuali tradizionali. Per una categoria di questi intellettuali, la più importante forse, dopo quella «ecclesiastica», per il prestigio e la funzione sociale che ha svolto nelle società primitive – la categoria dei medici in senso largo, cioè di tutti quelli che «lottano» o appaiono lottare contro la morte e le malattie – occorrerà confrontare la Storia della medicina di Arturo Castiglioni. Ricordare che c’è stata connessione tra la religione e la medicina e ancora in certe zone, continua ad esserci: ospedali in mano a religiosi per certe funzioni organizzative, oltre al fatto che dove appare il medico appare il prete (esorcismi, assistenze varie, ecc.). Molte grandi figure religiose erano anche o furono concepite come grandi «terapeuti»: l’idea del miracolo fino alla resurrezione dei morti. Anche per i re continuò a lungo ad esservi la credenza che guarissero con l’imposizione delle mani ecc.
Q6 §210 Intellettuali. Cfr Louis Halphen, Les Universités au 13 e siècle, Ed. Alcan, 1931, Fr. 10.
Q6 §211 Intellettuali. Le Accademie. Funzione che esse hanno avuto nello sviluppo della cultura in Italia, nel cristallizzarla e nel farne una cosa da museo, lontana dalla vita nazionale‑popolare (ma le accademie sono state causa o effetto? Non si sono moltiplicate forse per dare una soddisfazione parziale all’attività che non trovava sfogo nella vita pubblica ecc.?) L’Enciclopedia (edizione del 1778) assicura che l’Italia contava allora 550 Accademie.
QUADERNO 7
APPUNTI DI FILOSOFIA. MATERIALISMO E IDEALISMO
Seconda serie
Q7 §1 Benedetto Croce e il materialismo storico cfr a p. 55 bis. A proposito del discorso del Croce nella sezione di Estetica del Congresso filosofico di Oxford (cfr «La Nuova Italia» del 20 ottobre 1930). La traduzione dei termini di un sistema filosofico nei termini di un altro, così come del linguaggio di un economista nel linguaggio di un altro economista ha dei limiti e questi limiti sono dati dalla natura fondamentale dei sistemi filosofici o dei sistemi economici; cioè nella filosofia tradizionale ciò è possibile, mentre non è possibile tra la filosofia tradizionale e il materialismo storico. Lo stesso principio della traducibilità reciproca è un elemento «critico» inerente al materialismo storico, in quanto si presuppone e si postula che una data fase della civiltà ha una «fondamentalmente identica» espressione culturale e filosofica, anche se l’espressione ha un linguaggio diverso dalla tradizione particolare di ciascuna «nazione» o di ogni sistema filosofico. Il Croce avrebbe quindi commesso un arbitrio, curioso: avrebbe ricorso a una «gherminella» polemica, si sarebbe servito di un elemento critico del materialismo storico per assalire in blocco tutto il materialismo storico presentandolo come una concezione del mondo in arretrato persino su Kant. (In ciò il Croce innova «integralmente» tutta la sua critica del materialismo storico: questo punto di vista può essere avvicinato agli elogi che egli ha fatto del libro del De Man). Ma ha il Croce completamente torto? Ho detto che egli ha ricorso a una «gherminella» polemica, cioè non ha compiuto un atto da filosofo, da storico, ma un’«azione politica», «pratica».
È certo che nel materialismo storico si è formata una corrente deteriore che può essere indicata come corrispondente al cattolicismo popolare in confronto a quello teologico o degli intellettuali; così come il cattolicismo popolare può essere tradotto nei termini del «paganesimo» o di altre religioni corrispondenti, così il materialismo storico deteriore può essere tradotto nei termini «teologici», cioè della filosofia prekantiana e precartesiana. La gherminella del Croce corrisponde a quella degli anticlericali massonici e razionalisti volgari che appunto combattevano il cattolicismo con questi confronti e con queste «traduzioni» nel linguaggio «feticista». (Il Croce sarebbe caduto a stessa posizione che il Sorel rimproverava a Clemenceau, di giudicare una filosofia dalla sua letteratura di volgarizzazione intellettuale).
È la posizione dell’uomo del Rinascimento verso l’uomo della Riforma protestante: non capire che la rozzezza intellettuale dell’uomo della Riforma tuttavia prelude alla filosofia classica tedesca e al vasto movimento culturale tedesco moderno). Erasmo e Lutero: «dove entra Lutero, cessa la cultura» disse Erasmo (o qualcosa di simile). Croce rimprovera al materialismo storico il suo «scientismo», la sua «superstizione» materialistica, il suo ritorno al «medio evo» intellettuale. Sono i rimproveri che Erasmo, nel linguaggio del tempo, muoveva a Lutero. L’uomo del Rinascimento e l’uomo della Riforma si sono fusi nell’intellettuale moderno del tipo Croce, ma se questo tipo contiene in sé l’uomo della Riforma, esso non intende più il processo storico per cui dal «medioevale» Lutero si è potuti giungere a Hegel e perciò di fronte alla nuova Riforma intellettuale e morale rappresentata dal materialismo storico, si ritrova nella stessa posizione di Erasmo di fronte a Lutero.
Questa posizione di Croce si può studiare nel suo atteggiamento pratico verso la religione. Croce è antireligioso e per gli intellettuali italiani la sua filosofia, specialmente nelle sue manifestazioni meno sistematiche (come le recensioni, le postille, ecc. raccolte nei volumi come Cultura e vita morale, Conversazioni critiche, Frammenti di etica ecc.), è stata una vera riforma intellettuale e morale, del tipo «Rinascimento»; ma Croce non è andato «al popolo», non è diventato un elemento «nazionale» (come non lo sono stati gli uomini del Rinascimento a differenza dei Luterani e Calvinisti) perché non è riuscito a creare una schiera di discepoli che abbiano potuto rendere questa filosofia «popolare» capace di diventare un elemento educativo fin dalle scuole elementari (e quindi educativo per il semplice operaio e per il semplice contadino, cioè per il semplice uomo del popolo): ciò era impossibile, come hanno dimostrato gli avvenimenti.
Croce in qualche punto ha scritto qualcosa di questo genere: «Non si può togliere la religione all’uomo del popolo, senza subito sostituirla con qualcosa che soddisfi le stesse esigenze per cui la religione si è formata e ancora permane». C’è qualcosa di vero in questa affermazione, ma non è essa anche una confessione dell’impotenza della filosofia idealista a diventare una integrale concezione del mondo? Così è avvenuto che Gentile, praticamente più conseguente del Croce, ha rimesso la religione nelle scuole e ha giustificato questo atto con la concezione hegeliana della religione come fase primitiva della filosofia (Croce del resto avrebbe fatto altrettanto se il suo progetto scolastico avesse superato gli scogli della politica parlamentare): ma non è questa una pura gherminella? Perché si dovrebbe dare al popolo un cibo diverso da quello degli intellettuali? Si ricordi il «frammento» di Etica del Croce sulla religione: esso è bellissimo; perché non è stato svolto? In realtà era impossibile. La concezione dell’«obbiettività del reale» quale è stata radicata nel popolo dalle religioni non può essere sradicata che da un principio che si presenti come «dogmatico», ma abbia in sé la possibilità di storicizzarsi: questo principio non può essere dato che dalla scienza. Essa magari diventerà una superstizione simile o anche peggiore della superstizione religiosa, ma può trovare in se stessa gli elementi per superare questa prima fase primitiva. Essa pone l’uomo in contatto con la natura, mantenendo la superiorità dell’uomo, quindi della storia o dello spirito, come il Croce dice. (Vedere il capitolo del Missiroli sulla «scienza» pubblicato nell’«Ordine Nuovo»).
A questo proposito è interessante questo brano di M. Missiroli («L’Italia letteraria», 23 marzo 1930, Calendario: Religione e filosofia): «È probabile che qualche volta, di fronte alla logica del professore di filosofia, specie se questi sarà un seguace dell’idealismo assoluto, il senso comune degli scolari e il buon senso degli insegnanti delle altre materie, siano tratti a dar ragione al teologo piuttosto che al filosofo. Non vorrei in un eventuale contradditorio, davanti ad un pubblico non iniziato, trovarmi a dover perorare le ragioni della filosofia moderna L’umanità è ancora tutta quanta aristotelica e la comune opinione segue ancora quel dualismo, che è proprio del realismo greco‑cristìano. Che il conoscere sia un “vedere” anziché un “fare”, che la verità sia fuori di noi, esistente in sé e per sé e non una nostra creazione; che la “natura” e il “mondo” siano delle intangibili realtà, nessuno dubita e si rischia di passare per pazzi quando si afferma il contrario. I difensori dell’oggettività del sapere, i difensori più rigidi della scienza positiva, della scienza e del metodo di Galileo contro la gnoseologia dell’idealismo assoluto, oggi si trovano fra i cattolici. Quelli che Croce chiama pseudoconcetti e quello che Gentile definisce come pensiero astratto, sono le ultime rocche dell’oggettivismo. Donde la tendenza, sempre più visibile, della coltura cattolica a valorizzare la scienza positiva e l’esperienza contro la nuova metafisica dell’assoluto. Non è da escludere che il pensiero cattolico possa ringiovanirsi rifugiandosi nella cittadella della scienza sperimentale. Da trent’anni i gesuiti lavorano per eliminare i contrasti – in realtà basati su equivoci – fra la religione e la scienza e non a caso Giorgio Soler uno scritto oggi rarissimo osservava che, fra tutti gli scienziati, i matematici sono i soli per i quali il miracolo non ha nulla di miracoloso».
Questi punti di vista sono stati dal Missiroli più diffusamente esposti e presentati in parte diversamente nel volume Date a Cesare. I cattolici fanno dei grandi sforzi per non perdere il contatto con società moderna, cioè con l’alta cultura: con la diffusione dell’istruzione pubblica, che modifica incessantemente la composizione e il livello culturale delle masse popolari, l’influenza della religione andava esaurendosi, per confinarsi nella generazione più anziana e nelle donne. La religione si trasforma molecolarmente. I cattolici hanno cercato di assorbire il positivismo, ma hanno anche civettato con l’idealismo attuale e specialmente col crocismo. D’altronde il Croce civetta continuamente col «senso comune» e col «buon senso» popolare (bisognerà raccogliere tutti i brani di Croce sui rapporti tra filosofia e «senso comune»).
L’attacco di Croce al materialismo deve essere studiato sotto diversi aspetti: 1°) Atteggiamento di Croce verso il materialismo storico, organicamente espresso nel volume speciale e in articoli sparsi collegati al volume. 2°) Quanto del materialismo storico è penetrato nella stessa filosofia crociana, cioè la funzione che ha avuto il materialismo storico nello sviluppo filosofico del Croce: cioè, in che misura il Croce è un materialista storico «inconsapevole» o consapevole nel modo che egli chiama di «superamento»? 3°) Recente atteggiamento del Croce, nel secondo dopoguerra (il primo accenno di questo ultimo atteggiamento, a mia nozione, è nel volumetto sulla politica già prima nella Storia della storiografia italiana nel sec. XIX), che rappresenta un rinnegamento non solo della prima critica del Croce, ma anche di una parte cospicua della sua stessa filosofia: cioè questo nuovo atteggiamento del Croce non è solo un nuovo atteggiamento del Croce verso il materialismo storico, ma anche verso se stesso, verso tutta la sua filosofia precedente.
Il Croce fa quistioni di parole: quando dice che per il materialismo storico le superstrutture sono apparenze (ciò che è vero nella polemica politica ma non è vero «gnoseologicamente»), non pensa che ciò può significare qualcosa di simile alla sua affermazione della non «definitività» di ogni filosofia? Quando dice che il materialismo storico stacca la struttura dalle superstrutture, rimettendo così in vigore il dualismo teologico, non pensa che questo distacco è posto in senso dialettico, come tra tesi ed antitesi e che pertanto ogni accusa di dualismo teologico è vacua e superficiale? Forse che la struttura è concepita come qualcosa di immobile, o non è essa stessa la realtà in movimento: cosa vuol dire M. nelle Tesi su Feuerbach quando parla di «educazione dell’educatore» se non che la superstruttura reagisce dialetticamente sulla struttura e la modifica, cioè non afferma in termini «realistici» una negazione della negazione? non afferma l’unità del processo del reale?
Il Croce ritorce contro il materialismo storico l’accusa di disgregazione del processo del reale che i Gentiliani hanno rivolto allo stesso Croce, in quanto pone una «distinzione» tra le attività dello spirito e introduce una «dialettica dei distinti» (espressione infelice e incongrua, se anche è esatta la proposizione del Croce); ecco perché si può dire che il Croce, con questo suo atteggiamento verso il materialismo storico, in realtà rivela un processo di revisione dei capisaldi della sua stessa filosofia. (Concetto di blocco storico; nel materialismo storico è l’equivalente filosofico dello «spirito» nella filosofia crociana: introdurre nel «blocco storico» una attività dialettica e un processo di distinzione non significa negarne l’unità reale).
Q7 §2 Traducibilità dei linguaggi scientifici e filosofici. Nel 1921: quistioni di organizzazione. Vilici [Lenin ndc] disse e scrisse: «non abbiamo saputo “tradurre” nelle lingue “europee” la nostra lingua».
Q7 §3 «Esperanto» filosofico e scientifico. Dal non comprendere la storicità dei linguaggi e quindi delle ideologie e delle opinioni è conseguita la tendenza a costruire un esperanto o un volapük della filosofia e della scienza. È strano e curioso come nei rappresentanti di questa tendenza esista lo stesso stato d’animo dei popoli primitivi verso tutti gli altri popoli da loro conosciuti: ogni popolo primitivo chiamava se stesso «uomo» o «uomini», cioè la parola per indicare se stesso è la stessa che serve ad indicare l’«uomo», e gli altri popoli sono chiamati «muti» o «balbettanti» (barbari), in quanto non conoscono la «lingua degli uomini». Così avviene che per gli inventori di volapük della filosofia e della scienza, tutto ciò che non è espresso in questo volapük è delirio, è pregiudizio, è superstizione ecc.: essi (con processo analogo a quello che si verifica nelle mentalità settarie) trasformano in giudizio morale o in diagnosi di ordine psichiatrico ciò che dovrebbe essere un giudizio storico. Pare che in Italia il rappresentante più compiuto di questa tendenza sia oggi il signor Mario Govi, col suo volume Fondazione della Metodologia ‑ Logica ed Epistemologia, Torino, Bocca, 1929, pp. 579 ma molte tracce di questa tendenza si trovano nel Saggio popolare. Per il Govi pare che la logica e l’epistemologia (ossia metodologia speciale, mentre la logica sarebbe la metodologia generale) esistano in se e per sé astratte dal pensiero concreto e dalle concrete scienze particolari (così come la lingua esiste nel vocabolario e nelle grammatiche, la tecnica esiste fuori del lavoro, ecc. ecc.): con questa concezione è naturale che si ritenga legittimo un «volapük» della filosofia.
Q7 §4 Scienza morale e materialismo storico. La base scientifica di una morale del materialismo storico è da cercare, mi pare, nell’affermazione che «la società non si pone compiti per la soluzione dei quali non esistano già le condizioni di risoluzione». Esistendo le condizioni, la soluzione dei compiti diviene «dovere», la «volontà» diviene libera. La morale diventerebbe una ricerca delle condizioni necessarie per la libertà del volere in un certo senso, verso un certo fine e la dimostrazione che queste condizioni esistono. Si dovrebbe trattare anche non di una gerarchia dei fini, ma di graduazione dei fini da raggiungere, dato che si vuole «gradualizzare» non solo ogni individuo singolarmente preso, ma anche tutta una società di individui.
Q7 §5 Il «Saggio popolare», la scienza e gli strumenti della scienza. La Geologia non ha strumenti, oltre il martello. Il suo progresso e la sua storia non possono perciò essere indicati dal progresso e dalla storia dei suoi strumenti. In generale il progredire delle scienze non può essere documentato materialmente; può esserne solo ravvivato il ricordo, e non per tutte, col successivo progresso degli strumenti che sono stati i suoi mezzi e delle macchine che sono state sue applicazioni. I principali «strumenti» del progredire delle scienze sono di ordine intellettuale, metodologìco e giustamente Engels ha detto che gli «strumenti intellettuali» non sono nati dal nulla, non sono innati, ma sono acquisiti e si sono sviluppati e si sviluppano storicamente. Del resto con gli strumenti «materiali» della scienza, si è sviluppata una «scienza degli strumenti», strettamente legata allo sviluppo generale della produzione. (Su questo argomento è da vedere: G. Boffito, Gli strumenti della scienza e la scienza degli strumenti, Libreria Internazionale Sceber, 1929).
Q7 §6 Il «Saggio popolare» e la sociologia. La riduzione del materialismo storico a «sociologia» marxista è un incentivo alle facili improvvisazioni giornalistiche dei «genialoidi». L’«esperienza» del materialismo storico è la storia stessa, lo studio dei fatti particolari, la «filologia». Questo dovrebbero forse voler dire quegli scrittori, che, come accenna molto affrettatamente il Saggio popolare, negano che si possa fare una sociologia marxista e affermano che il materialismo storico vive nei saggi storici particolari.
La «filologia» è l’espressione metodologica dell’importanza dei fatti particolari intesi come «individualità» definite e precisate. A questo metodo si contrappone quello dei «grandi numeri» o della «statistica», preso in prestito dalle scienze naturali o almeno da alcune di esse. Ma non si è osservato abbastanza che la legge dei «grandi numeri» può essere applicata alla storia e alla politica solo fino a quando le grandi masse della popolazione rimangono passive – per rispetto alle quistioni che interessano lo storico o il politico – o si suppone che rimangano passive. Questa estensione della legge dei grandi numeri dalle scienze naturali alle scienze storiche e politiche ha diverse conseguenze per la storia e per la politica: nella scienza storica può avere per risultato spropositi scientifici, che potranno essere corretti agevolmente dalla scoperta di nuovi documenti che precisino meglio ciò che prima era solo «ipotesi»; ma nella scienza e nell’arte politica può avere per risultato delle catastrofi, i cui danni «secchi» non potranno mai più essere risarciti. Nella scienza e nell’arte politica l’elevazione della legge dei grandi numeri a legge essenziale non è solo errore scientifico, ma errore politico in atto: è incitamento alla pigrizia mentale e alla superficialità programmatica, è affermazione aprioristica di «inconoscibilità» del reale, molto più grave che non sia nelle scienze naturali, in cui l’affermazione di «non conoscere» è un criterio di prudenza metodica e non affermazione di carattere filosofico. L’azione politica tende appunto a far uscire le grandi moltitudini passività, cioè a distruggere la «legge» dei grandi numeri; come allora questa può essere ritenuta una «legge»? Anche in questo campo si può vedere lo sconvolgimento che nell’arte politica porta la sostituzione nella funzione direttiva dell’organismo collettivo all’individuo singolo, al capo individuale: i sentimenti standardizzati delle masse che il «singolo» conosce come espressione della legge dei grandi numeri, cioè razionalmente, intellettualmente, e che egli – se è un grande capo – traduce in idee‑forza, in parole‑forza, dall’organismo collettivo sono conosciuti per «compartecipazione», per con-passionalità» e se l’organismo collettivo è innestato vitalmente nelle masse, conosce per esperienza dei particolari immediati, con un sistema di «filologia» vivente, per così dire.
Mi pare che il libro del De Man, se ha un suo valore, lo ha appunto in questo senso: che incita a «informarsi» particolarmente dei «sentimenti» dei gruppi e degli individui e a non accontentarsi delle leggi dei grandi numeri. Il De Man non ha fatto nessuna scoperta nuova, né ha trovato un principio originale che possa superare il materialismo storico o dimostrarlo scientificamente errato o infecondo: ha elevato a «principio» scientifico ciò che è solo un criterio già noto ma insufficientemente definito e sviluppato, o almeno non ancora sistematicamente definito e sviluppato nella sua teoria e nella sua portata scientifica. Il De Man non ha neanche compreso l’importanza del suo criterio, poiché ha creato una nuova legge dei «grandi numeri» inconsapevolmente, un nuovo metodo statistico e classificatorio, una nuova sociologia astratta.
Q7 §7 La metafora dell’ostetrica e quella dì Michelangelo. La metafora dell’ostetrica che aiuta, coi ferri, il neonato a nascere dall’alvo materno e il principio espresso da Michelangelo nei versi: «Non ha l’ottimo artista alcun concetto – che un marmo solo in sé non circoscriva – col suo soverchio e solo a quello arriva – la mano che obbedisce all’intelletto». Togliere il soverchio di marmo che nasconde la figura concepita dall’artista a gran colpi di martello sul blocco corrisponde all’operazione dell’ostetrica che trae alla luce il neonato squarciando il seno materno.
Q7 §8 Benedetto Croce e il materialismo storico. Cfr il giudizio del Croce su Giovanni Botero nel volume Storia dell’età barocca in Italia. Il Croce riconosce che i moralisti del seicento, per quanto piccoli di statura a paragone del Machiavelli, «rappresentavano, nella filosofia politica, uno stadio ulteriore e superiore». Questo giudizio deve essere messo insieme a quello del Sorel a proposito di Clémenceau che non riusciva a vedere, anche attraverso la «letteratura» mediocre, le esigenze che tale letteratura rappresentava e che non erano, esse, «mediocri». Un pregiudizio da «intellettuale» è quello di misurare i movimenti storici e politici col metro dell’«intellettualismo», cioè della compiuta espressione letteraria e non col metro della «scienza politica», cioè della capacità concreta e attuale di conformare il mezzo al fine: questo pregiudizio è anche «popolare», in certi stadi della organizzazione politica e si confonde spesso col pregiudizio dell’«oratore»: l’uomo politico deve essere grande oratore o grande intellettuale, deve avere il crisma del «genio» ecc. ecc.
Q7 §9 B. Croce e la storia etico‑politica. L’avvicinamento delle due espressioni etica e politica è appunto l’espressione esatta delle esigenze in cui si muove la storiografia del Croce: storia etica è l’aspetto della storia correlativo alla «società civile», all’egemonia; storia politica è l’aspetto della storia corrispondente all’iniziativa statale-governativa. Quando c’è contrasto tra egemonia e governo‑statale c’è crisi della società e il Croce giunge ad affermare che il vero «Stato», cioè la forza direttiva dell’impulso storico occorre talvolta cercarlo non là dove si crederebbe, nello Stato giuridicamente inteso, ma spesso nelle forze «private» e talvolta nei così detti «rivoluzionari» (questa proposizione del Croce è molto importante teoricamente per intendere appieno la sua concezione della politica e della storiografia). Sarebbe utile analizzare in concreto la teoria crociana, prendendo come modelli specialmente La storia del regno di Napoli e La Storia d’Italia dal 1870 al 1915.
Q7 §10 Struttura e superstruttura (vedi scritte nella «prima serie»). Mi pare che si potrebbe richiamare a questo proposito il confronto con la tecnica guerresca così come si è trasformata nell’ultima guerra col passaggio dalla guerra manovrata alla guerra di posizione. Ricordare il libretto della Rosa [Luxemburg ndc] tradotto da Alessandri nel 1919‑20 e la cui teoria era basata sulle esperienze storiche del 1905 (d’altronde, a quanto pare, non studiate con esattezza, perché vi erano trascurati gli elementi volontari e organizzativi, molto più diffusi di quanto era portata a credere la Rosa che, per pregiudizio «economistico», li trascurava inconsciamente); questo libretto mi pare il più significativo della teoria della guerra manovrata applicata alla scienza storica e all’arte politica. L’elemento economico immediato (crisi ecc.) è considerato come l’artiglieria campale nella guerra il cui ufficio era quello di aprire un varco nella difesa nemica, sufficiente perché le proprie truppe vi facessero irruzione e ottenessero un successo strategico definitivo o almeno nella linea necessaria del successo definitivo. Naturalmente nella scienza storica l’efficacia dell’elemento economico immediato era ben più complessa di quella che non fosse quella dell’artiglieria campale nella guerra di manovra, poiché esso era concepito come avente un doppio effetto: 1°) di aprire il varco nella difesa nemica dopo aver scompaginato e fatto perdere la fiducia in sé e nelle sue forze e nel suo avvenire al nemico stesso; 2°) di organizzare fulmineamente le proprie truppe, di creare i quadri, o almeno di porre i quadri esistenti (elaborati fino allora dal processo storico generale) fulmineamente al loro posto di inquadramento delle truppe disseminate; di creare fulmineamente la concentrazione dell’ideologia e dei fini da raggiungere. Era una forma di ferreo determinismo economistico, con l’aggravante che gli effetti ne erano concepiti come rapidissimi nel tempo e nello spazio: perciò era un vero e proprio misticismo storico, l’aspettazione di una specie di fulgurazione miracolosa.
L’osservazione del generale Krasnov (nel suo romanzo) che durante la guerra l’Intesa (cioè l’Inghilterra che non voleva la vittoria della Russia imperiale, perché non fosse definitivamente risolta a favore dello zarismo la quistione orientale) impose allo Stato maggiore la guerra di trincea (assurda dato l’enorme sviluppo del fronte dal Baltico al Mar Nero, con grandi zone paludose e boscose), mentre unica possibile era la guerra di manovra, ha solo un’apparenza di verità. In realtà l’esercito russo tentò la guerra di manovra e di sfondamento, specialmente nel settore austriaco (ma anche in Prussia, ai laghi Masuri) ed ebbe successi parziali brillantissimi ma effimeri. La guerra di posizione non è infatti solo costituita dalle trincee vere e proprie, ma da tutto il sistema organizzativo e industriale del territorio che è alle spalle dell’esercito schierato ed è dato specialmente dal tiro rapido dei cannoni, delle mitragliatrici, dei fucili e dalla loro concentrazione (oltre che dalla loro abbondanza, che permette di sostituire il materiale perduto dopo uno sfondamento). Nel fronte orientale si vede subito la differenza che la tattica russa di sfondamento otteneva nei suoi risultati nel settore tedesco e in quello austriaco: anche nel settore austriaco dopo il passaggio del comando ai tedeschi questa tattica cadde nel disastro. Lo stesso si vide nella guerra polacca del 1920, in cui l’invasione irresistibile fu fermata a Varsavia da Weygand e dalla linea tenuta dagli ufficiali francesi.
Con ciò non si vuol dire che la tattica d’assalto e di sfondamento e la guerra manovrata debbano essere considerate come ormai sparite studio dell’arte militare: sarebbe un grosso errore. Ma esse, nelle guerre tra gli Stati più avanzati industrialmente e civilmente, devono considerarsi ridotte più a funzione tattica che a funzione strategica, così come era la guerra d’assedio nel periodo precedente della storia militare.
La stessa riduzione deve avvenire nell’arte e nella scienza della politica, almeno per ciò che riguarda gli Stati più avanzati, dove la «società civile» è diventata una struttura molto complessa e resistente alle «irruzioni» catastrofiche dell’elemento economico immediato (crisi, depressioni ecc.): le superstrutture della società civile sono come il sistema delle trincee nella guerra moderna. Come avveniva che un furibondo attacco di artiglieria contro le trincee avversarie, che sembrava aver distrutto tutto, in realtà aveva distrutto solo la superficie della difesa e al momento dell’avanzata gli assalitori si trovavano di fronte una difesa ancora efficace, così avviene nella politica durante le grandi crisi economiche, né le truppe assalitrici, per effetto della crisi, si organizzano fulmineamente nel tempo e nello spazio, né, tanto meno, acquistano lo spirito aggressivo; per reciproca, gli assaliti non si demoralizzano né abbandonano le difese, pur tra le macerie, né perdono la fiducia nella propria forza e nel proprio avvenire. Non che le cose rimangano tali e quali; ma le cose non si svolgono fulmineamente e con marcia progressiva definitiva come si aspetterebbero gli strateghi del cadornismo politico. L’ultimo fatto di tal genere sono stati avvenimenti del 1917. Essi hanno segnato una svolta decisiva nella storia dell’arte e della scienza della politica.
Si tratta dunque di studiare, con profondità, quali sono gli elementi della società civile che corrispondono ai sistemi di difesa nella guerra di posizione. Dico «con profondità» a disegno, perché essi sono stati studiati, ma da un punto di vista superficiale e banale, come certi storici del costume studiano le stranezze della moda femminile o che so io: o da un punto di vista «razionalistico» cioè con la persuasione che certi fenomeni sono distrutti appena se ne è data una giustificazione o una spiegazione «realistica», come superstizioni, insomma.
Q7 §11 Un giudizio sull’«idealismo attuale» di Gentile. Dall’«Italia Letteraria» del 23 novembre 1930: articolo di Bruno Revel Il VII Congresso di Filosofia: «… l’idealismo attuale ci ripresenta ancora la storia come la suprema istanza di giustificazione. Badando: questa storia è pregna di tutti i valori universali e positivi in se stessi che si solevano un tempo isolare in un regno trascendente di essenze e di norme. Perciò questo idealismo immanentistico, valendosi di tali valori nel corso del tempo sapientemente isolati e assolutizzati – e validi assolutamente sol perché affermati come trascendenti, puri – può permettersi di predicare e d’insegnar morale quasi ignorando il proprio inguaribile relativismo e scetticismo. E giacché l’evoluzione sociale, contrassegnata da una crescente organizzazione attorno alla fabbrica, tende a centralizzazioni razionali ferree e bene agencées, così l’idealismo attuale non fa che prestar lustro d’assoluto, dignità metafisica a tale evoluzione, secondo la sua teoria dello Stato. E crede di conferire così un carattere etico assoluto alle contingenti necessità industriali dello Stato moderno». Contorto e abborracciato, ma vi si vede l’influsso del materialismo storico.
Q7 §12 L’uomo-individuo e l’uomo-massa. Il proverbio latino: «Senatores boni viri, senatus mala bestia» è diventato un luogo comune. Cosa significa questo proverbio e quale significato ha assunto? Che una folla di persone dominate dagli interessi immediati o in preda alla passione suscitata dalle impressioni del momento trasmesse acriticamente di bocca in bocca, si unifica nella decisione collettiva peggiore, che corrisponde ai più bassi istinti bestiali. L’osservazione è giusta e realistica in quanto si riferisce alle folle casuali, raccoltesi come «una moltitudine durante un acquazzone sotto una tettoia”, composte di uomini che non sono legati da vincoli di responsabilità verso altri uomini o gruppi di uomini o verso una realtà economica concreta, il cui sfacelo si ripercuota nel disastro degli individui. Si può dire perciò che in tali folle l’individualismo non solo non è superato ma è esasperato per la certezza dell’impunità e dell’irresponsabilità.
È però anche osservazione comune che un’assemblea «bene ordinata» di elementi riottosi e indisciplinati si unifica in decisioni collettive superiori alla media individuale: la quantità diventa qualità. Se così non fosse, non sarebbe possibile l’esercito, per esempio non sarebbero possibili sacrifizi inauditi che gruppi umani ben disciplinati sanno compiere in determinate occasioni, quando il loro senso di responsabilità sociale è svegliato fortemente dal senso immediato del pericolo comune e l’avvenire appare più importante del presente. Si può far l’esempio di un comizio in piazza che è diverso da un comizio in sala chiusa ed è diverso da un comizio sindacale di categoria professionale e così via. Una seduta di ufficiali di Stato Maggiore sarà ben diversa da un’assemblea di soldati di un plotone ecc.
Tendenza al conformismo nel mondo contemporaneo più estesa e più profonda che nel passato: la standardizzazione del modo di pensare e di operare assume estensioni nazionali o addirittura continentali. La base economica dell’uomo‑collettivo: grandi fabbriche, taylorizzazione, razionalizzazione ecc. Ma nel passato esisteva o no l’uomo‑collettivo? Esisteva sotto forma della direzione carismatica, per dirla con Michels: cioè si otteneva una volontà collettiva sotto l’impulso e la suggestione immediata di un «eroe», di un uomo rappresentativo; ma questa volontà collettiva era dovuta a fattori estrinseci e si componeva e scomponeva continuamente. L’uomo‑collettivo odierno si forma invece essenzialmente dal basso in alto, sulla base della posizione occupata dalla collettività nel mondo della produzione: l’uomo rappresentativo ha anche oggi una funzione nella formazione dell’uomo‑collettivo, ma inferiore di molto a quella del passato, tanto che esso può sparire senza che il cemento collettivo si disfaccia e la costruzione crolli.
Si dice che «gli scienziati occidentali ritengono che la psiche delle masse non sia altro che il risorgere degli antichi istinti dell’orda primordiale e pertanto un regresso a stadi culturali da tempo superati»; ciò è da riferirsi alla così detta «psicologia delle folle» cioè delle moltitudini casuali e l’affermazione è pseudo‑scientifica, è legata alla sociologia positivistica.
Sul «conformismo» sociale occorre notare che la quistione non è nuova e che l’allarme lanciato da certi intellettuali è solamente comico. Il conformismo è sempre esistito: si tratta oggi di lotta tra «due conformismi» cioè di una lotta di egemonia, di una crisi della società civile. I vecchi dirigenti intellettuali e morali della società sentono mancarsi il terreno sotto i piedi, si accorgono che le loro «prediche» sono diventate appunto «prediche», cioè cose estranee alla realtà, pura forma senza contenuto, larva senza spirito; quindi la loro disperazione e le loro tendenze reazionarie e conservative: poiché la particolare forma di civiltà, di cultura, di moralità che essi hanno rappresentato si decompone, essi gridano alla morte di ogni civiltà, di ogni cultura, di ogni moralità e domandano misure repressive allo Stato o si costituiscono in gruppo di resistenza appartato dal processo storico reale, aumentando in tal modo la durata della crisi, poiché il tramonto di un modo di vivere e di pensare non può verificarsi senza crisi. I rappresentanti del nuovo ordine in gestazione, d’altronde, per odio «razionalistico» al vecchio, diffondono utopie e piani cervellotici. Quale il punto di riferimento per il nuovo mondo in gestazione? Il mondo della produzione, il lavoro. Il massimo utilitarismo deve essere alla base di ogni analisi degli istituti morali e intellettuali da creare e dei principii da diffondere: la vita collettiva e individuale deve essere organizzata per il massimo rendimento dell’apparato produttivo. Lo sviluppo delle forze economiche sulle nuove basi e l’instaurazione progressiva della nuova struttura saneranno le contraddizioni che non possono mancare e avendo creato un nuovo «conformismo» dal basso permetteranno nuove possibilità di autodisciplina, cioè di libertà anche individuale.
Q7 §13 Einaudi e il materialismo storico. Non pare che Einaudi abbia studiato molto le teorie del materialismo storico; si può anzi dire che egli parla del materialismo storico da orecchiante, per sentito dire, spesso di terza o quarta mano. Le sue nozioni principali le ha prese dal Croce (Materialismo storico ed economia marxistica) ma in modo superficiale e anche sgangherato (in una nota ho messo a confronto un brano del Croce sulla originalità della scienza e la ripetizione sguaiata che ne fa l’Einaudi). Ciò che più interessa è il fatto che della «Riforma Sociale» è sempre stato scrittore apprezzato (e in qualche tempo anche membro della redazione) Achille Loria, cioè il divulgatore, nel senso deteriore, del materialismo storico. Si può dire anzi che in Italia gran parte di ciò che si chiama materialismo storico non sia altro che lorianismo: recentemente, proprio nella «Riforma Sociale» il Loria ha pubblicato un suo zibaldone di schede caoticamente disposte, intitolandolo
Nuove conferme dell’economismo storico. Nella «Riforma Sociale» di novembre‑dicembre 1930 l’Einaudi pubblica una nota Il mito dello strumento tecnico ecc. a proposito dell’autobiografia di Rìnaldo Rigola che rinforza l’opinione precedentemente accennata. Il Croce precisamente ha mostrato nel suo volume sul materialismo storico che il mito dello strumento è stata una invenzione del Loria, ciò di cui l’Einaudi non fa cenno. L’Einaudi inoltre commette tutta una serie di errori per «ignorantia elenchi»: 1°) confonde lo strumento tecnico con lo «sviluppo delle forze economiche» in generale; per lui parlare dello sviluppo delle forze economiche significa parlare dello strumento tecnico; 2°) crede che per il marxismo «strumento tecnico» o «forze economiche» significhi parlare delle cose materiali e non dei rapporti sociali, cioè umani, che sono incorporati nelle cose materiali e la cui espressione giuridica è il principio di proprietà; 3°) appare anche in questo scritto il solito «cretinismo economico» che è proprio dell’Einaudi e di molti suoi soci, i quali come propagandisti sono dei puri «illuministi»: sarebbe interessante vedere la raccolta degli scritti di propaganda economica dell’Einaudi; da essa apparirebbe che i capitalisti non hanno mai compreso i loro veri interessi e si sono sempre comportati antieconomicamente ecc.
Data la innegabile influenza dell’Einaudi su un largo strato di intellettuali varrà la pena di fare una ricerca di tutte le in cui egli accenna al materialismo storico: ricordare l’articolo sul Gobetti scritto nel numero unico del «Baretti» e il brano sul Gobetti nel Piemonte di Giuseppe Prato.
Q7 §14 Testimonianze. Di Luigi Volpicelli, Per la nuova storiografia italiana («La Fiera Letteraria», 29 gennaio 1928): «Il primo quarto di secolo non è stato infecondo d’opere e di ricerche per gli studi storici; in complesso anzi, molti passi in avanti sono stati fatti sulla storiografia del secolo scorso. Rinnovata totalmente dal materialismo storico, l’indagine contemporanea è riuscita a battere nuove e più congrue vie e a rendersi sempre più esigente e complessa». Ma il Volpicelli non ha coscienza esatta di ciò che scrive; infatti, dopo aver parlato di questa funzione del materialismo storico nel primo quarto di secolo, critica la storiografia dell’800 (in modo molto vago e superficiale) e continua: «Mi sono soffermato a lungo su tale argomento (la storiografia dell’800) per dare un’idea precisa (!) al lettore del passo gigantesco compiuto dalla storiografia contemporanea. Le conseguenze, infatti, sono state enormi (– conseguenze di che?); il rinnovamento, addirittura totale. Sono stati distrutti gli esteriori limiti fissati dalle varie metodologie che esaurivano l’indagine storica in una formale ricerca filologica o diplomatica; sono state di lungo tratto oltrepassate le tendenze economico‑giuridiche del principio di secolo, le lusinghe del materialismo storico, le astrazioni e gli apriorismi di certi ideologi, più romanzieri che storici». Così, il materialismo storico, che inizialmente è il rinnovatore della storiografia, diventa ad un tratto, sotto forma di «lusinga», una vittima del rinnovamento, da becchino della storiografia ottocentesca, diventa parte dell’ottocento seppellita col suo tutto. Il Volpicelli dovrebbe studiare un po’ di logica formale.
Q7 §15 La quistione del capitalismo antico e Barbagallo. Quella del Barbagallo sul capitalismo antico è una storia ipotetica, congetturale, possibile, un abbozzo storico, uno schema sociologico, non una storia certa e determinata. Gli storici come il Barbagallo cadono, mi pare, in un errore filologico‑critico molto curioso: che la storia antica debba essere fatta sui documenti del tempo, su cui si fanno ipotesi ecc., senza tener conto che tutto lo sviluppo storico susseguente è un «documento» per la storia precedente ecc. Gli emigrati inglesi nell’America del Nord hanno portato con loro l’esperienza tecnico‑economica dell’Inghilterra; come mai si sarebbe perduta l’esperienza del capitalismo antico se questo fosse veramente esistito nella misura in cui il Barbagallo lascia supporre o vuole che si supponga?
Q7 §16 Guerra di posizione e guerra manovrata o frontale. È da vedere se la famosa teoria di Bronstein [Trotzky ndc] sulla permanenza del movimento non sia il riflesso politico della teoria della guerra manovrata (ricordare osservazione del generale dei cosacchi Krasnov), in ultima analisi il riflesso delle condizioni generali‑economiche‑culturali‑sociali di un paese in cui quadri della vita nazionale sono embrionali e rilasciati e non possono diventare «trincea o fortezza». In questo caso si potrebbe dire che Bronstein, che appare come un «occidentalista» era invece un cosmopolita, cioè superficialmente nazionale e superficialmente occidentalista o europeo. Invece Ilici [Lenin ndc] era profondamente nazionale e profondamente europeo. Bronstein nelle sue memorie ricorda che gli fu detto che la sua teoria si era dimostrata buona dopo... quindici anni e risponde all’epigramma con un altro epigramma. In realtà la sua teoria, come tale, non era buona né quindici anni prima né quindici anni dopo: come avviene agli ostinati, di cui parla il Guicciardini, egli indovinò all’ingrosso, cioè ebbe ragione nella previsione pratica più generale; come a dire che si predice che una bambina di quattro anni diventerà madre e quando lo diventa a venti anni si dice «l’avevo indovinato», non ricordando però che quando aveva quattro anni si voleva stuprare la bambina sicuri che sarebbe diventata madre. Mi pare che Ilici aveva compreso che occorreva un mutamento dalla guerra manovrata, applicata vittoriosamente in Oriente nel 17, alla guerra di posizione che era la sola possibile in Occidente, dove, come osserva Krasnov, in breve spazio gli eserciti potevano accumulare sterminate quantità di munizioni, dove i quadri sociali erano di per sé ancora capaci di diventare trincee munitissime. Questo mi pare significare la formula del «fronte unico» che corrisponde alla concezione di un solo fronte dell’Intesa sotto il comando unico di Foch. Solo che Ilici non ebbe il tempo di approfondire la sua formula, pur tenendo conto che egli poteva approfondirla solo teoricamente, mentre il compito fondamentale era nazionale, cioè domandava una ricognizione del terreno e una fissazione degli elementi di trincea e di fortezza rappresentati dagli elementi di società civile ecc. In Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale e gelatinosa; nell’Occidente tra Stato e società civile c’era un giusto rapporto e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società civile. Lo Stato era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e di casematte; più o meno, da Stato a Stato, si capisce, ma questo appunto domandava un’accurata ricognizione di carattere nazionale.
La teoria del Bronstein può essere paragonata a quella di certi sindacalisti francesi sullo sciopero generale e alla teoria di Rosa nell’opuscolo tradotto da Alessandri: l’opuscolo di Rosa e la teoria di Rosa hanno del resto influenzato i sindacalisti francesi come appare da certi articoli di Rosmer sulla Germania nella «Vie Ouvrière» (prima serie in fascicoletti): dipende in parte anche dalla teoria della spontaneità.
Q7 §17 Croce. Si potrebbe dire che Croce è l’ultimo uomo del Rinascimento e che esprime rapporti internazionali o cosmopoliti più che rapporti puramente nazionali (ciò non vuol dire che il Croce non sia un elemento nazionale, anche nell’accezione moderna della parola, vuol dire che nel Croce si verifica anche nel tempo moderno, e nelle condizioni della vita moderna, quella funzione di elemento intellettuale cosmopolita che si è verificata negli intellettuali italiani dal Medio Evo fino alla fine del 700). La funzione del Croce, insomma, è simile a quella del papa, e bisogna dire che il Croce, nell’ambito della sua influenza, sa meglio o può meglio condursi dello stesso papa: esempio tipico la guerra. Non bisogna tanto considerare il Croce come filosofo, quanto il Croce come moralista e maestro di vita, costruttore di principi di condotta. I due Croce sono inscindibili teoricamente, ma praticamente l’influsso crociano si diffonde più attraverso la sua attività polemica minuta, che attraverso le sue opere teoretiche.
Si pone il problema di chi rappresenti meglio e più radicalmente l’attuale società contemporanea italiana dal punto di vista teoretico e morale: il papa, Croce, Gentile, cioè chi abbia più importanza dal punto di vista egemonico nella struttura della società civile, contenuto della società politica. Secondo me la importanza maggiore l’ha il papa, poi Croce, terzo Gentile. Mi pare che la filosofia del Gentile, l’attualismo, sia strettamente legata al momento economico‑corporativo, sia ancora alla fase dell’espressione tecnica diretta di questo momento. Per questa stessa ragione molti possono credere il contrario, e con apparenza di ragione, così come credono che sia più rappresentativo degli interessi industriali in Parlamento un industriale stesso piuttosto che un avvocato, un professore o magari un organizzatore di sindacati operai, senza pensare che se l’intera maggioranza del Parlamento fosse composta di industriali, il Parlamento perderebbe immediatamente la sua funzione politica e il suo prestigio. (Ricordare il discorso del Gentile tenuto a Roma e pubblicato in «Cultura e fascismo»). Il papa e il Croce sono sullo stesso piano teorico (cioè il Croce è una specie di papa laico) ma la maggiore importanza del papa è data dall’essere egli a capo di un apparato direttivo fortemente centralizzato e disciplinato, ciò che non si può dire del Croce; inoltre il papa influisce su masse sterminate di popolo nella fissazione di norme di vita che si riferiscono alle cose anche più elementari, mentre la «moralità» del Croce è del tipo Rinascimento, non può diventate popolare.
Q7 §18 Unità negli elementi costitutivi del marxismo. L’unità è data dallo sviluppo dialettico delle contraddizioni tra l’uomo e la materia (natura ‑ forze materiali di produzione). Nell’economia il centro unitario è il valore, ossia il rapporto tra il lavoratore e le forze industriali di produzione (i negatori della teoria del valore cadono nel crasso materialismo volgare ponendo le macchine in sé – come capitale costante o tecnico – come produttrici di valore all’infuori dell’uomo che le conduce). Nella filosofia – la prassi – cioè rapporto tra la volontà umana (superstruttura) e la struttura economica. Nella politica – rapporto tra lo Stato e la società civile – cioè intervento dello Stato (volontà centralizzata) per educare l’educatore, l’ambiente sociale in genere. (Da approfondire e porre in termini più esatti).
Q7 §19 Ideologie. Un elemento di errore nella considerazione del valore delle ideologie mi pare sia dovuto al fatto (fatto che d’altronde non è casuale) che si dà il nome di ideologia sia alla soprastruttura necessaria di una determinata struttura, sia alle elucubrazioni arbitrarie di determinati individui. Il senso deteriore della parola è diventato estensivo e ciò ha modificato e snaturato l’analisi teorica del concetto di ideologia. Il processo di questo errore può essere facilmente ricostruito: 1°) si identifica l’ideologia come distinta dalla struttura e si afferma che non le ideologie mutano le strutture ma viceversa; 2°) si afferma che una certa soluzione politica è «ideologica» cioè è insufficiente a mutare la struttura, mentre crede di poterla mutare si afferma che è inutile, stupida ecc.; 3°) si passa ad affermare che ogni ideologia è «pura» apparenza, inutile, stupida ecc.
Bisogna dunque distinguere tra ideologie storicamente organiche, che sono cioè necessarie a una certa struttura, e ideologie arbitrarie, razionalistiche, «volute». In quanto storicamente necessarie esse hanno una validità che è validità «psicologica», esse «organizzano» le masse umane, formano il terreno in cui gli uomini si muovono, acquistano coscienza della loro posizione, lottano ecc. In quanto «arbitrarie» non creano altro che «movimenti» individuali, polemiche ecc.; (non sono completamente inutili neanche esse, perché sono come l’errore che si contrappone alla verità e l’afferma).
Q7 §20 Il «Saggio popolare». Non è trattato il punto fondamentale: come dalle strutture nasce il movimento storico? Eppure questo è il punto cruciale di tutta la quistione del materialismo storico, è il problema dell’unità tra la società e la «natura». Le due proposizioni: – 1) la «società» non si pone problemi per la cui soluzione non si siano già realizzate le condizioni (premesse) necessarie e sufficienti; 2) nessuna forma di società sparisce prima di aver esaurito tutte le sue possibilità di sviluppo – avrebbero dovuto essere analizzate in tutta la loro portata e conseguenza. Solo su questo terreno può essere eliminato ogni meccanicismo e ogni traccia di «miracolo» superstizioso. Anche in questo terreno deve essere posto il problema del formarsi degli aggruppamenti sociali e dei partiti politici e, in ultima analisi, quello della funzione delle grandi personalità nella storia.
Q7 §21 Validità delle ideologie. Ricordare la frequente affermazione che fa il Marx della «solidità delle credenze popolari» come elemento necessario di una determinata situazione: egli dice presso a poco «quando questo modo di concepire avrà la forza delle credenze popolari» ecc. (Ricercare queste affermazioni e analizzarle nel contesto in cui sono espresse). Altra affermazione del Marx è che una persuasione popolare ha spesso la stessa energia di una forza materiale o qualcosa di simile e che è molto significativa. L’analisi di queste affermazioni credo porti a rafforzare la concezione di «blocco storico», in cui appunto le forze materiali sono il contenuto e le ideologie la forma, distinzione di forma e contenuto meramente didascalica, perché le forze materiali non sarebbero concepibili storicamente senza forma e le ideologie sarebbero ghiribizzi individuali senza le forze materiali.
Q7 §22 Teoria dei costi comparati e decrescenti. Da vedere se questa teoria, che occupa tanto posto nell’economia moderna ufficiale con l’altra dell’equilibrio statico e dinamico, non sia perfettamente aderente o corrispondente in altro linguaggio alla teoria marxista del valore e della caduta del saggio del profitto, non ne sia cioè l’equivalente scientifico in linguaggio ufficiale e «puro» (spogliato di ogni energetica politica per le classi produttrici subalterne).
Q7 §23 Il paese di Cuccagna di Graziadei. Nel suo volumetto Sindacati e salari il Graziadei si ricorda finalmente, dopo 35 anni, di riferirsi alla nota sul paese di Cuccagna a lui dedicata dal Croce nel saggio «Recenti interpretazioni della teoria marxistica del valore» (p. 147 del volume Materialismo storico ecc. IVa ediz.) e chiama «alquanto grossolano» il suo esempio analizzato dal Croce. Realmente il caso del Graziadei di «una società in cui non già col sopralavoro, ma col non lavoro esista il profitto» è tipico anche per tutta la recente produzione del Graziadei e bene ha fatto il Rudas a riportarlo nell’inizio del suo saggio sul Prezzo e sovraprezzo pubblicato nell’«Unter dem Banner» del 1926 (non ricordo più se il Rudas gli ha dato questo valore essenziale). Tutta la concezione del Graziadei è basata su questo sgangherato principio che le macchine e l’organizzazione materiale (di per sé) producano profitto, cioè valore: nel 1894 (articolo della «Critica Sociale» analizzato dal Croce) la sua ipotesi era totale (tutto il profitto esiste senza nessun lavoro); ora la sua ipotesi è parziale (non tutto il profitto esiste per il lavoro) ma la «grossolanità» (grazioso eufemismo chiamare solo «grossolana» l’ipotesi primitiva) rimane parzialmente. Tutto il modo di pensare è «grossolano», da volgare leguleio e non da economista. Col Graziadei bisogna proprio rifarsi ai principi fondamentali dell’economia, alla logica di questa scienza: il Graziadei è maestro nella piccola logica, nell’arte del cavillo e della casistica ma non della grande logica, sia dell’economia, sia di ogni altra scienza del pensiero.
Lo stesso principio del Graziadei del paese di Cuccagna appare dall’introduzione della protezione doganale come elemento «creatore» di margini di profitto e di margini di salario: è dimostrato infatti (confronta letteratura antiprotezionista) che senza produrre nessun «valore» e senza far lavorare un solo operaio (lavorano solo le dattilografe che scrivono i certificati di azioni inesistenti) si possono avere lauti «profitti» e distribuire alti «dividendi» (cfr per es. L. Einaudi e E. Giretti, Le società anonime a catena, «Riforma Sociale» del gennaio‑febbraio 1931 è da vedere se di questa attività «economica» debba occuparsi la scienza economica (sebbene essa sia «economica» nel senso crociano, come il brigantaggio, la camorra ecc.) o la magistratura penale.
Ricordare una polemica nella «Critica Sociale» tra il Graziadei e Luigi Negro (prima del 900, mi pare) in cui il Negro osservava che il Graziadei è portato ad accogliere come «esatte» e base di speculazione scientifica le affermazioni pubbliche degli industriali sulla loro attività.
Q7 §24 Struttura e superstruttura. Economia e ideologia. La pretesa (presentata come postulato essenziale del materialismo storico) di presentare ed esporre ogni fluttuazione della politica e dell’ideologia come una espressione immediata della struttura, deve essere combattuta teoricamente come un infantilismo primitivo, o praticamente deve essere combattuta con la testimonianza autentica del Marx, scrittore di opere politiche e storiche concrete. Per questo aspetto sono importanti specialmente il 18 Brumaio e gli scritti sulla Quistione Orientale, ma anche altri (Rivoluzione e Controrivoluzione in Germania, La guerra civile in Francia e minori). Un’analisi di queste opere permette di fissar meglio la metodologia storica marxista, integrando, illuminando e interpretando le affermazioni teoriche sparse in tutte le opere. Si potrà vedere quante cautele reali Marx introduca nelle sue ricerche concrete, cautele che non potevano trovar posto nelle opere generali (esse potrebbero trovar posto solo in una esposizione metodica sistematica tipo Bernheim, e il libro del Bernheim potrà essere tenuto presente come «tipo» di manuale scolastico o «saggio popolare» del materialismo storico, in cui oltre al metodo filologico ed erudito – cui per programma si attiene il Bernheim, sebbene sia implicita nella sua trattazione una concezione del mondo – dovrebbe essere esplicitamente trattata la concezione marxista della storia). Tra queste cautele si potrebbero elencare come esempio queste:
1°) La difficoltà di identificare volta per volta, staticamente (come immagine fotografica istantanea), la struttura; la politica, di fatto, è volta per volta il riflesso delle tendenze di sviluppo della struttura, tendenze che non è detto necessariamente debbano inverarsi. Una fase strutturale può essere concretamente studiata e analizzata solo dopo che essa ha superato tutto il suo processo di sviluppo, non durante il processo stesso, altro che per ipotesi e esplicitamente dichiarando che si tratta di ipotesi.
2°) Dal 1° si deduce che un determinato atto politico può essere stato un errore di calcolo da parte dei dirigenti delle classi dominanti, errore che lo sviluppo storico, attraverso le «crisi» parlamentari governative delle classi dirigenti, corregge e supera: il materialismo storico meccanico non considera la possibilità di errore, ma assume ogni atto politico come determinato dalla struttura, immediatamente, cioè come riflesso di una reale e permanente (nel senso di acquisita) modificazione della struttura. Il principio dell’«errore» è complesso: può trattarsi di un impulso individuale per errato calcolo, o anche di manifestazione dei tentativi di determinati gruppi o gruppetti di assumere l’egemonia nell’interno del raggruppamento dirigente, tentativi che possono fallire.
3°) Non si considera abbastanza che molti atti politici sono dovuti a necessità interne di carattere organizzativo, cioè legati al bisogno di dare una coerenza a un partito, a un gruppo, a una società. Questo appare chiaro nella storia per esempio della Chiesa cattolica. Se di ogni lotta ideologica nell’interno della Chiesa si volesse trovare la spiegazione immediata, primaria, nella struttura, si starebbe freschi: molti romanzi politico‑economici sono stati scritti per questa ragione. È evidente invece che la maggior parte di queste discussioni sono legate a necessità settarie, di organizzazione. Nella discussione tra Roma e Bisanzio sulla processione dello Spirito Santo, sarebbe ridicolo cercare nella struttura dell’Oriente Europeo l’affermazione che lo Spirito Santo procede solo dal Padre, e in quella dell’Occidente l’affermazione che esso procede dal Padre e dal Figlio. Le Chiese, la cui esistenza e il cui conflitto è in dipendenza dalla struttura e da tutta la storia, hanno posto delle quistioni che sono principio di distinzione e di coesione interna per ognuna, ma poteva avvenire che ognuna delle due Chiese avesse affermato ciò che invece ha affermato l’altra: il principio di distinzione e di conflitto si sarebbe mantenuto lo stesso ed è questo problema della distinzione e del conflitto che costituisce il problema storico, non la casuale bandiera di ognuna delle parti.
La «stelletta» che scrive dei romanzi di appendice ideologici nei «Problemi del Lavoro» (e che dev’essere il famigerato Franz Weiss) nella sua divertente filastroccola Il dumping russo e il suo significato storico, parlando appunto di queste controversie dei primi tempi cristiani, afferma che esse sono legate alle condizioni materiali immediate del tempo, e che se non riusciamo a identificare questo collegamento immediato è perché i fatti sono lontani o per altra debolezza intellettuale. La posizione è comoda, ma irrilevante scientificamente. Infatti ogni fase storica reale lascia traccia di sé nelle fasi successive che ne diventano in un certo senso il migliore documento. Il processo di sviluppo storico è una unità nel tempo, per cui il presente contiene tutto il passato e del passato si realizza nel presente ciò che è «essenziale» senza residuo di un «inconoscibile» che sarebbe la vera «essenza». Ciò che si è «perduto», cioè non è stato trasmesso dialetticamente nel processo storico, era di per se stesso irrilevante, era «scoria» casuale e contingente, cronaca e non storia, episodio superficiale, trascurabile, in ultima analisi.
Q7 §25 Oggettività del reale. Per intendere esattamente i significati che può avere questo concetto, mi pare opportuno svolgere l’esempio dei concetti «Oriente» e «Occidente» che non cessano di essere «oggettivamente reali» seppure all’analisi si dimostrano nient’altro che una «costruzione convenzionale» ossia «storica» (spesso i termini «artificiale» e «convenzionale» indicano fatti «storici», prodotti dello sviluppo della civiltà e non costruzioni razionalisticamente arbitrarie o individualmente arbitrarie). Ricordare il libretto di Bertrand Russell (ediz. Sonzogno, in una nuova collezione scientifica, numero 5 o 6) sulla filosofia neorealistica, e il suo esempio. Il Russell dice presso a poco: «Noi non possiamo pensare, senza l’esistenza dell’uomo sulla terra, all’esistenza di Londra e di Edimburgo, ma possiamo pensare all’esistenza di due posti, dove sono oggi Londra e Edimburgo, uno a Nord e l’altro a Sud». Si potrebbe obbiettare che senza pensare all’esistenza dell’uomo, non si può pensare di «pensare», non si può pensare in genere a nessun fatto o rapporto che esiste solo in quanto esiste l’uomo.
Ma il fatto più tipico, da questo punto di vista, è il rapporto Nord-Sud e specialmente Est‑Ovest. Essi sono rapporti reali e tuttavia non esisterebbero senza l’uomo e senza lo sviluppo della civiltà. È evidente che Est e Ovest sono costruzioni arbitrarie, e convenzionali (storiche), poiché fuori della storia reale ogni punto della terra è Est ed Ovest nello stesso tempo: costruzioni convenzionali e storiche non dell’uomo in generale, ma delle classi colte europee, che attraverso la loro egemonia mondiale le hanno fatte accettare a tutto il mondo. Il Giappone probabilmente è Estremo Oriente non solo per l’Europeo, ma anche per l’americano della California e per lo stesso Giapponese, il quale attraverso la cultura inglese chiamerà prossimo Oriente l’Egitto, che dal suo punto di vista dovrebbe essere Occidente lontano ecc. D’altronde il valore puramente storico di tali riferimenti appare dal fatto che oggi le parole Oriente e Occidente hanno acquistato un significato extracardinale e indicano anche rapporti fra complessi di civiltà.
Perciò il Marocco sarà indicato come paese orientale dalle nazioni dell’Europa mediterranea che sono invece ad Oriente del Marocco e in questo caso «orientale» significherà «musulmano», «arabo», persino «asiatico» ecc. Tuttavia questi riferimenti sono reali, corrispondono a fatti reali, permettono di viaggiare per terra e per mare e di giungere proprio dove si era stabilito di giungere, di prevedere il futuro, di «oggettivare la realtà», di comprendere la «Oggettività reale del mondo esterno». Razionale e reale si identificano. Mi pare che senza aver capito questo rapporto non si può capire il materialismo storico, la sua posizione filosofica in confronto dell’idealismo e del materialismo tradizionali e l’importanza e il significato delle soprastrutture: Marx non ha sostituito l’«idea» hegeliana con il «concetto» di struttura, come dice il Croce. L’idea hegeliana è risolta tanto nella struttura che nelle soprastrutture e tutta la concezione filosofica tradizionale (e non solo hegeliana) è «storicizzata», fatta diventare realtà, con un’altra espressione linguistica e quindi un’altra filosofia, se intesa come sistema di «concetti» sulla realtà.
Q7 §26 Sul «Saggio popolare». Registro degli intellettuali la cui filosofia viene combattuta con qualche diffusione, e annotazione del loro significato e importanza scientifica. Accenni a grandi intellettuali fugacissimi. Si pone la questione: non occorreva invece riferirsi solo ai grandi intellettuali avversari e magari ad uno solo di essi e trascurare i secondari? Si ha l’impressione appunto che si cerchi di combattere contro i più deboli e magari contro le posizioni più deboli (o più inadeguatamente espresse dai più deboli) per ottenere una facile vittoria (dato che vittoria reale ci sia). Illusione che ci sia somiglianza (altro che formale) tra un fronte ideologico e un fronte politico-militare. Nella lotta politica e militare può convenire la tattica di sfondare nei punti di minor resistenza per essere in grado di investire il punto più importante col massimo di forze reso appunto disponibile dall’aver eliminato gli «ausiliari» più deboli ecc. La vittoria politica e militare, entro certi limiti, è permanente, il fine strategico può essere raggiunto in modo, entro certi limiti, decisivo. Sul fronte ideologico invece la sconfitta degli ausiliari e dei minori seguaci ha importanza infinitamente minore: in esso bisogna lottare contro i più eminenti e non contro i minori. Altrimenti si confonde il giornale col libro, la polemica quotidiana con il lavoro scientifico. I minori, appunto, devono essere abbandonati alla polemica di tipo giornalistico. Ma una scienza nuova raggiunge la prova della sua efficienza e vitalità quando dimostra di saper affrontare i grandi campioni della tendenza opposta, quando spiega coi propri mezzi le quistioni vitali che essi hanno posto, o dimostra perentoriamente che questi problemi sono falsi problemi.
È vero che una determinata epoca e una determinata civiltà sono meglio rappresentate dalla media degli intellettuali, e quindi dagli intellettuali mediocri, ma l’ideologia diffusa, di massa, deve essere distinta dalle opere scientifiche, dalle grandi sintesi filosofiche, che poi ne sono le reali chiavi di volta e queste devono essere nettamente superate, negativamente, dimostrandone l’infondatezza, e positivamente, contrapponendo sintesi filosofiche equivalenti per significato e importanza. La parte negativa e positiva non possono essere scisse altro che per motivi didascalici. Leggendo il Saggio popolare si ha l’impressione di uno che sia annoiato e non possa dormire per il chiarore lunare e si diverta a trucidare le lucciole, persuaso che il chiarore diminuirà o sparirà.
Q7 §27 Graziadei e il paese di Cuccagna. Vedere nel Gog di Papini (intervista con Ford, p. 24) le parole attribuite a Ford: «Fabbricare senza nessun operaio un numero sempre più grande di oggetti che non costino quasi nulla».
Q7 §28 Società civile e società politica. Distacco della società civile da quella politica: si è posto un nuovo problema di egemonia, cioè la base storica dello Stato si è spostata. Si ha una forma estrema di società politica: o per lottare contro il nuovo e conservare il traballante rinsaldandolo coercitivamente, o come espressione del nuovo per spezzare le resistenze che incontra nello svilupparsi ecc.
Q7 §29 Sul «Saggio popolare». È possibile scrivere un libro elementare, un manuale, un saggio popolare, quando una dottrina è ancora nello stato di discussione, di polemica, di elaborazione? Il manuale popolare non può essere concepito se non come l’esposizione formalmente dogmatica, stilisticamente calma, scientificamente serena, di un determinato argomento: esso è un’introduzione allo studio scientifico, non l’esposizione stessa delle ricerche scientifiche originali, dedicato o all’età giovanile, o a un pubblico che dal punto di vista della disciplina scientifica, si trova nelle condizioni preliminari dell’età giovanile e che perciò ha immediatamente bisogno di «certezze», di opinioni che si presentano come veridiche e fuori discussione, per il momento. Se una determinata dottrina non ha ancora raggiunto questa fase «classica» del suo sviluppo, ogni tentativo di manualizzarla fallisce, la sua sistemazione logica è solo apparente: si tratterà, invece, come appunto nel Saggio, di una meccanica giustapposizione di elementi disparati o che rimangono inesorabilmente indipendenti e sconnessi tra loro. Perché allora non porre la quistione nei suoi giusti termini storici e teorici e accontentarsi di pubblicare un libro in cui la serie dei problemi essenziali della dottrina sia esposta monograficamente? Sarebbe più serio e più «scientifico». Ma si crede che scienza voglia assolutamente dire «sistema» e perciò si costruiscono sistemi purchessia, che del sistema hanno solo l’esteriorità meccanica.
È notevole che nel Saggio manca una trattazione adeguata della dialettica: la dialettica viene presupposta, non esposta, cosa assurda in un manuale che deve contenere in sé gli elementi essenziali della dottrina trattata e i cui rimandi bibliografici devono avere il fine di spingere ad allargare e approfondire la materia, non di sostituire il manuale stesso. La quistione dell’assenza di una trattazione della «dialettica» può avere due origini:
1°) La prima è costituita dal fatto che il materialismo storico non viene concepito come una filosofia, di cui la dialettica è la dottrina della conoscenza, ma come una «sociologia» la cui filosofia è il materialismo filosofico o metafisico o meccanico (volgare, come diceva Marx). Posta così la quistione, non si capisce più l’importanza e il significato della dialettica, che viene degradata a una sottospecie di logica formale, a una scolastica elementare. La funzione e il significato della dialettica possono solo essere concepiti in tutta la loro fondamentalità, quando il materialismo storico è concepito come una filosofia integrale originale, che inizia una nuova fase nella storia e nello sviluppo mondiale del pensiero, in quanto supera (e superando, ne include in sé gli elementi vitali) e l’idealismo e il materialismo tradizionali, espressioni delle vecchie società succedutesi nella storia mondiale. Se il materialismo storico non può essere pensato che subordinatamente a una altra filosofia, quella del materialismo filosofico, non si può concepire la dialettica marxista, nella quale appunto quel superamento si effettua e si esprime.
2°) La seconda origine mi pare d’ordine psicologico. Si sente che la dialettica è cosa molto ardua e difficile in quanto il pensare dialetticamente va contro il volgare senso comune che ha la logica formale come espressione ed è dogmatico e avido di certezze perentorie. Per aver un modello pratico si pensi ciò che avverrebbe se nelle scuole primarie e secondarie le scienze naturali e cosmografiche fossero insegnate sulla base del relativismo di Einstein e accompagnando alla nozione tradizionale di «legge della natura» quella di «legge statistica o dei grandi numeri». I ragazzi e gli adolescenti non capirebbero nulla di nulla e l’urto tra l’insegnamento scolastico e la logica dei rapporti familiari e popolari sarebbe tale che la scuola diverrebbe oggetto familiare di ludibrio e di scetticismo caricaturale. Questo motivo mi pare sia un freno psicologico per l’autore del Saggio popolare: egli realmente capitola dinanzi al senso comune e al pensiero volgare, perché non si è posto il problema nei termini teorici esatti e quindi è praticamente disarmato e impotente. L’ambiente ineducato e rozzo ha dominato l’educatore, il senso comune volgare si è imposto alla scienza e non viceversa: se l’ambiente è l’educatore, esso deve essere educato a sua volta, ha scritto Marx, ma il Saggio popolare non capisce questa dialettica rivoluzionaria.
Q7 §30 Su Graziadei. Per aver ragione di Graziadei occorre risalire ai concetti fondamentali della scienza economica. 1°) Occorre fissare che la scienza economica parte dall’ipotesi di un mercato determinato, o di pura concorrenza o di puro monopolio, salvo a stabilire poi quali variazioni può apportare a questa costante l’uno o l’altro elemento della realtà, che non è mai «pura». 2°) Che si studia la produzione di nuova ricchezza reale e non le ridistribuzioni di ricchezza esistente (a meno che non si voglia proprio studiare questa ridistribuzione), cioè la produzione di valore e non la ridistribuzione del valore già distribuito sulla base della produzione determinata.
Su Graziadei bisognerà poi fare una accurata ricerca sulla biografia politica e scientifica. Il suo libro sul nitrato del Cile: egli non poteva pensare alla possibilità della produzione sintetica dell’azoto che ha battuto in breccia il monopolio cileno: sarà interessante rivedere le affermazioni perentorie che egli ha fatto su questo monopolio. Per la sua posizione politica la risposta di Graziadei all’inchiesta del «Viandante» nel 1908-909: Graziadei era dei più destri e opportunisti. Opuscolo sul sindacalismo: il modello di Graziadei era il laburismo inglese, egli liquidatore del partito. La sua posizione nel dopoguerra curioso fenomeno di psicologia di intellettuale, che è persuaso «intellettualmente» dell’asinità del riformismo politico e perciò se ne distacca e lo avversa. Ma altro è la sfera dell’intelligenza astratta e altro quella della pratica e dell’azione. Nel campo scientifico trova, dopo il 22, il terreno di ritirata e il ritorno alla posizione di avanguerra. Si pone il problema: è leale ricercare nel passato di un uomo tutti gli errori che egli ha commesso per rimproverarglieli ai fini della polemica attuale? Non è umano che si sbagli? Non è anzi attraverso gli sbagli che si sono formate le attuali personalità scientifiche? E la biografia di ognuno non è in gran parte la lotta contro il passato e il superamento del passato? Se uno oggi è areligioso, è lecito ricordargli che egli è stato battezzato ed ha, fino ad una certa età, osservato le regole del culto? Ma a caso del Graziadei è ben diverso. Egli si è ben guardato dal criticare e superare il proprio passato. Nel campo economico egli si è limitato, per un certo tempo, a tacere: oppure ha sostenuto, a proposito del ritmo di accentramento del capitale nella campagna, che la «pratica attuale» dava ragione alle sue teorie (– sulla superiorità della mezzadria sull’impresa capitalistica accentrata, ciò che era lo stesso che dire sulla superiorità dell’artigianato sul sistema di fabbrica – egli si basava sulla Romagna e anzi addirittura su Imola per questa sua conclusione. Non teneva conto della quasi sparizione dell’obbligato nel periodo 1901-1910, come risulta dal censimento del 1911 e specialmente non teneva conto dei fattori politico‑protezionistici che determinavano la situazione nella valle padana: l’Italia aveva tale scarsezza di capitali che sarebbe stato davvero miracoloso un largo impiego nell’agricoltura).
In politica egli se la cavò affermando sofisticamente di essere stato «storicista» o «tempista» se domina il boia, bisogna fargli da tirapiedi – ecco lo storicismo di Graziadei, cioè di non aver mai avuto principii: nel periodo 95‑1914 «bisognava» essere laburisti, nel dopoguerra antilaburisti ecc. Ricordare l’insistenza noiosa di Graziadei a proposito dell’affermazione «le spese militari improduttive» che egli si vantava d’aver sempre avversato come sciocca e demagogica: sta a vedere come l’avversava allora, quando era favorevole all’andata al governo. Così è da notare la sua concezione pessimistico‑pettegola sugli «Italiani» in blocco, tutti senza carattere, vigliacchi, esseri civilmente inferiori ecc. ecc., concezione stolta e banalmente disfattista, forma di antiretorica, che era poi una vera e propria retorica deprimente e da falso furbo, tipo Stenterello‑Machiavelli. Che in Italia ci sia uno strato piccolo‑borghese particolarmente repugnante è certamente vero, ma è questo strato tutta l’Italia? Sciocca generalizzazione. D’altronde anche questo fenomeno ha un’origine storica e non è affatto una fatale qualità dell’uomo‑italiano: il materialismo storico del Graziadei rassomiglia a quello di Ferri, di Niceforo, di Lombroso, di Sergi e si sa quale funzione storica questa concezione biologica della «barbarie» attribuita ai Meridionali (anzi ai Sudici) ha avuto nella politica della classe dirigente italiana.
Q7 §31 Sulla critica letteraria. Il modello di critica del De Sanctis. Nel trattare questo argomento ricordare il saggio del De Sanctis Scienza e Vita che poi è un modo di porre la quistione dell’unità di teoria e pratica e le discussioni cui ha dato luogo: p. es. l’articolo di L. Russo nel «Leonardo» del 1928 (o 29). Del Russo sarà da vedere lo studio su Francesco De Sanctis e l’Università di Napoli, Casa ed. «La Nuova Italia».
Q7 §32 Henri De Man. Da un articolo di Arturo Masoero, Un americano non edonista (in «Economia» del febbraio 1931) risulta che molte opinioni esposte dal H. De Man nella Gioia del lavoro e quindi anche in altri suoi libri, sono prese dalle teorie dell’economista americano Thorstein Veblen, che ha portato nella scienza economica alcuni principii sociologici del positivismo, specialmente di A. Comte e dello Spencer: il Veblen vuole specialmente introdurre l’evoluzionismo nella scienza economica. Così troviamo nel Veblen l’«instinct of workmanship», che il De Man chiama «istinto creatore». W. James nel 1890 aveva esposto la nozione di un istinto costruttivo («instinct of constructiveness») e già Voltaire parlava di un istinto meccanico. (Cfr questa grossolana concezione dell’«istinto» del De Man con ciò che scrive Marx sull’istinto delle api e su ciò che distingue l’uomo da questo istinto). Ma pare che il De Man abbia preso dal Veblen anche quella sua mirabolante e grossolana concezione di un «animismo» negli operai su cui tanto insiste nella Gioia del lavoro.
Così il Masoero espone la concezione del Veblen: «Presso i primitivi l’interpretazione mitica cessa di essere un ostacolo e spesso diventa un aiuto per ciò che riguarda lo sviluppo della tecnica agricola e dell’allevamento. Non può che giovare infatti, a questo sviluppo il considerare come dotati di anima o addirittura di caratteri divini le piante e gli animali, poiché da una simile considerazione derivano quelle cure, quelle attenzioni che possono portare ai miglioramenti tecnici e alle innovazioni. Una mentalità animista è invece decisamente contraria al progresso tecnico della manifattura, all’esplicarsi dell’istinto operaio sulla materia inerte. Così il Veblen spiega come, all’inizio dell’era neolitica, in Danimarca la tecnica agricola fosse già tanto avanzata mentre rimase nullo per lungo tempo lo sviluppo della tecnica manifatturiera. Attualmente l’istinto operaio, non più ostacolato dalla credenza nell’intervento di elementi provvidenziali e misteriosi, va unito a uno spirito positivo e consegue quei progressi nelle arti industriali, che sono propri dell’epoca moderna».
Il De Man avrebbe preso così dal Veblen l’idea di un animismo operaio» che il Veblen crede esistito nell’età neolitica, ma non più oggi e l’avrebbe riscoperto nell’operaio moderno, con molta originalità.
È da notare, date queste origini spenceriane del De Man, la conseguenzialità del Croce che ha visto nel De Man un superatore del marxismo ecc. Tra Spencer e Freud, che ritorna a forma di sensismo più misterioso ancora di quello settecentesco, il De Man meritava proprio di essere esaltato dal Croce e di vedersi proposto allo studio degli italiani intelligenti. Del Veblen è annunziata la traduzione in italiano per iniziativa dell’on. Bottai. In ogni modo in questo articolo del Masoero si trova in nota la bibliografia essenziale.
Nel Veblen si può osservare, come appare dall’articolo, un certo influsso del marxismo. Il Veblen mi pare che abbia avuto anche influsso nelle teorizzazioni del Ford.
Q7 §33 Posizione del problema. Produzione di nuove Weltanschauungen, che feconda e alimenta la cultura di un’età storica e produzione indirizzata filosoficamente secondo le Weltanschauungen originali. Marx è un creatore di Weltanschauung, ma quale è la posizione di Ilici [Lenin ndc]? È puramente subordinata e subalterna? La spiegazione è nello stesso marxismo – scienza e azione –. Il passaggio dall’utopia alla scienza e dalla scienza all’azione (ricordare opuscolo o di Carlo Radek). La fondazione di una classe dirigente (cioè di uno Stato) equivale alla creazione di una Weltanschauung. L’espressione che il proletariato tedesco è l’erede della filosofia classica tedesca: come deve essere intesa – non voleva indicare Marx l’ufficio storico della sua filosofia divenuta teoria di una classe che sarebbe diventata Stato? Per Ilici questo è realmente avvenuto in un territorio determinato. Ho accennato altrove all’importanza filosofica del concetto e del fatto di egemonia, dovuto a Ilici. L’egemonia realizzata significa la critica reale di una filosofia, la sua reale dialettica. Cfr ciò che scrive Graziadei (Nel ms è aggiunta a questo punto la seguente nota a piè di pagina: «Graziadei è arretrato in confronto di Mons. Olgiati, che nel suo volumetto sul Marx non trova altro paragone possibile che con Gesù, paragone che per un prelato è realmente il colmo della concessione poiché egli crede alla natura divina di Cristo») nell’introduzione a Prezzo e sovraprezzo: egli pone Marx come unità di una serie di grandi scienziati. Errore fondamentale: nessuno degli altri ha prodotto una originale e integrale concezione del mondo. Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, superata da concezione della libertà).
Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che sono omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo‑Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo‑paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, e non teorico).
Q7 §34 Caduta tendenziale del saggio del profitto. Si potrebbe chiamare (forse) un teorema di prima approssimazione: ma (forse) perciò è meno importante? Questo teorema dovrebbe essere studiato in base al taylorismo e al fordismo. Non sono queste due attività il tentativo di superare questa prima approssimazione? Si aumenta il capitale costante, ma in questo incremento esiste una variabile che toglie immediatamente effetto alla legge: una o più variabili, come produzione di macchine più perfette, di metalli più resistenti, di un diverso tipo di operaio, diminuzione dello scarto, utilizzazione dei sottoprodotti (in generale, cioè risparmio di scarti, necessari, reso possibile dalla loro grande quantità). L’industriale con ognuna di queste innovazioni passa da un periodo di costi crescenti a un periodo di costi decrescenti, in quanto viene a godere di un monopolio d’iniziativa che può durare abbastanza a lungo (relativamente): il monopolio dura a lungo anche a causa degli «alti salari» che tali industrie progressive possono e «devono» dare, per avere la possibilità di selezionare, nella massa degli operai esistenti, quelli «psicofisicamente» adatti per i nuovi metodi di lavoro e di produzione. L’estensione del nuovo tipo di produzione porta a una serie di crisi, che ripropone gli stessi problemi della «caduta tendenziale del saggio di profitto», problemi che si può immaginare ritornanti a ciclo finché: 1°) non si sia raggiunto il limite matematico della resistenza del materiale, 2°) non si sia raggiunto il limite nell’uso delle macchine automatiche, 3°) non si sia raggiunto il limite di saturazione nell’industria mondiale, tenendo conto del saggio di aumento della popolazione e della produzione per rinnovare la merce d’uso e i beni strumentali.
La legge tendenziale scoperta da Marx sarebbe quindi alla base dell’americanismo, cioè del ritmo accelerato nel progresso dei metodi di lavoro e di produzione e di modificazione del tipo di operaio.
Q7 §35 Materialismo e materialismo storico. L’affermazione di Feuerbach: «L’uomo è quello che mangia», può essere, presa in sé, interpretata variamente. Interpretazione gretta e stolta: cioè l’uomo è volta per volta quello che mangia materialmente, cioè i cibi hanno una immediata influenza determinatrice sul modo di pensare. Ricordare l’affermazione di Amadeo [Bordiga ndc] che se si sapesse ciò che un uomo ha mangiato prima di un discorso, per esempio, si sarebbe in grado di interpretare meglio il discorso stesso. Affermazione infantile, e, di fatto, estranea anche alla scienza positiva, poiché il cervello non viene nutrito di fave o di tartufi, ma i cibi giungono a ricostituire le molecole del cervello trasformati in sostanze omogenee e assimilabili, che hanno cioè la «stessa natura» potenziale delle molecole cerebrali. Se questa affermazione fosse vera, la storia avrebbe la sua matrice determinante nella cucina e le rivoluzioni coinciderebbero coi mutamenti radicali dell’alimentazione di massa. Il contrario è storicamente vero: cioè sono le rivoluzioni e il complesso sviluppo storico che hanno modificato l’alimentazione e creato i «gusti» successivi nella scelta dei cibi. Non è la semina regolare del frumento che ha fatto cessare il nomadismo, ma viceversa, le condizioni emergenti contro il nomadismo hanno spinto alle semine regolari ecc. (Cfr questa affermazione del Feuerbach con la campagna di S. E. Marinetti contro la pastasciutta e la polemica di S. E. Bontempelli in difesa, e ciò nel 1930, in pieno sviluppo della crisi mondiale).
D’altronde è anche vero che «l’uomo è quello che mangia», in quanto l’alimentazione è una delle espressioni dei rapporti sociali nel loro complesso, e ogni raggruppamento sociale ha una sua fondamentale alimentazione, ma allo stesso modo si può dire che l’«uomo è il suo appartamento», l’«uomo è il suo particolare modo di riprodursi cioè la sua famiglia», poiché l’alimentazione, l’abbigliamento, la casa, la riproduzione sono elementi della vita sociale in cui appunto in modo più evidente e più diffuso (cioè con estensione di massa) si manifesta il complesso dei rapporti sociali.
Il problema di cos’è l’uomo è dunque sempre il così detto problema della «natura umana», o anche quello del così detto «uomo in generale», cioè la ricerca di creare una scienza dell’uomo (una filosofia) che parte da un concetto inizialmente «unitario», da un’astrazione in cui si possa contenere tutto l’«umano». Ma l’«umano» è un punto di partenza o un punto di arrivo, come concetto e fatto unitario? o non è piuttosto, questa ricerca, un residuo «teologico» e «metafisico» in quanto posto come punto di partenza? La filosofia non può essere ridotta ad una naturalistica «antropologia», cioè l’unità del genere umano non è data dalla natura «biologica» dell’uomo; le differenze dell’uomo che contano nella storia non sono quelle biologiche (razze, conformazione del cranio, colore della pelle ecc.; e a ciò si riduce poi l’affermazione «l’uomo è ciò che mangia» – mangia grano in Europa, riso in Asia ecc. – che si ridurrebbe poi all’altra affermazione: «l’uomo è il paese dove abita», poiché la gran parte degli alimenti, in generale, è legata alla terra abitata) e neppure l’«unità biologica» ha mai contato gran che nella storia (l’uomo è quell’animale che ha mangiato se stesso, proprio quando era pìù vicino allo «stato naturale», cioè quando non poteva moltiplicare «artificiosamente» la produzione dei beni naturali). Neanche la facoltà di «ragionare» o lo «spirito» ha creato unità o può essere riconosciuto come fatto unitario, perché concetto solo formale, categorico. Non il «pensiero», ma ciò che realmente si pensa unisce o differenzia gli uomini.
Che la «natura umana» sia il «complesso dei rapporti sociali» è la risposta più soddisfacente, perché include l’idea del divenire: l’uomo diviene, si muta continuamente col mutarsi dei rapporti sociali, e perché nega l’«uomo in generale»: infatti i rapporti sociali sono espressi da diversi gruppi di uomini che si presuppongono, la cui unità è dialettica, non formale. L’uomo è aristocratico in quanto è servo della gleba ecc. (cfr Plekhanov in opuscolo su libertari se fissa questo carattere dialettico). Si può anche dire che la natura dell’uomo è la «storia» (e in questo senso, posta storia = spirito, che la natura dell’uomo è lo spirito) se appunto si dà a storia il significato di «divenire», in una «concordia discors» che non parte dall’unità, ma ha in sé le ragioni di una unità possibile: perciò la «natura umana» non può ritrovarsi in nessun uomo particolare ma in tutta la storia del genere umano (e il fatto che si adoperi la parola «genere», di carattere naturalistico, ha il suo significato) mentre in ogni singolo si trovano caratteri messi in rilievo dalla contraddizione con quelli di altri. Le concezioni di «spirito» delle filosofie tradizionali, come quella di «natura umana» trovata nella biologia, dovrebbero spiegarsi come «utopie scientifiche» che sostituirono la maggior utopia della «natura umana» cercata in Dio (e gli uomini – figli di Dio) e servono a indicare il travaglio continuo della storia, un’aspirazione razionale o sentimentale ecc. È vero che tanto le religioni che affermano l’eguaglianza degli uomini come figli di Dio o le filosofie che affermano la loro uguaglianza come partecipanti della facoltà di ragionare sono state espressioni di complessi movimenti rivoluzionari (la trasformazione del mondo classico – la trasformazione del mondo medioevale) che hanno posto gli anelli più potenti dello sviluppo storico.
Che la dialettica hegeliana sia stata un riflesso di questi grandi nodi storici e che la dialettica, da espressione delle contraddizioni sociali debba diventare, con la sparizione di queste contraddizioni, una pura dialettica concettuale, sarebbe alla base delle ultime filosofie a base utopistica come quella del Croce. Nella storia l’«uguaglianza» reale, cioè il grado di «spiritualità» raggiunto dal processo storico della «natura umana», si identifica nel sistema di associazioni «private e pubbliche», esplicite ed implicite, che si annodano nello «Stato» e nel sistema mondiale politico: si tratta di «uguaglianze» sentite come tali fra i membri di una associazione e di «diseguaglianze» sentite tra le diverse associazioni, uguaglianze e disuguaglianze che valgono in quanto se ne abbia coscienza individualmente e come gruppo. Si giunge così anche all’eguaglianza o equazione tra «filosofia e politica», tra pensiero e azione, cioè ad una filosofia della praxis. Tutto è politica, anche la filosofia o le filosofie (confronta sul carattere delle ideologie) e la sola «filosofia» è la storia in atto, cioè è la vita stessa. In questo senso si può interpretare la tesi del proletariato tedesco erede della filosofia classica tedesca – e si può affermare che la teorizzazione e la realizzazione dell’egemonia fatta da Ilici [Lenin ndc] è stata anche un grande avvenimento «metafisico».
Q7 §36 «Saggio popolare». La metafora e il linguaggio. (Cfr altra nota a proposito dell’affermazione nuda e cruda, fatta nel Saggio popolare come spiegazione in sé esauriente, che Marx adopera i termini «immanenza e immanente» solo come metafora). Tutto il linguaggio è metafora ed è metafora in due sensi: è metafora della «cosa» od «oggetto materiale e sensibile» indicati ed è metafora dei significati ideologici dati alle parole durante i precedenti periodi di civiltà. (Un trattato di semantica – per es. quello di Michel Bréal – può dare un catalogo delle mutazioni semantiche delle singole parole). Dal non tener conto di tale fatto derivano due tendenze erronee principali (per non parlare di altre di carattere più ristretto come quella di ritenere «belle» in sé certe parole a differenza di altre in quanto le si analizza storicamente ed etimologicamente: si confonde la «gioia» libresca del filologo che spasima per le sue parolette con la «gioia» data dall’arte: questo è il caso di rinnovata retorica nel libretto Linguaggio e poesia di Giulio Bertoni): 1°) quella delle lingue fisse o universali; 2°) le quistioni poste dal Pareto e dai pragmatisti sul «linguaggio come causa di errore». Il Pareto, come i pragmatisti e molti altri di minore conto, in quanto credono di aver originato una nuova concezione del mondo (di aver quindi dato alle parole un significato o almeno una sfumatura nuova), si trovano di fronte al fatto che le parole, nell’uso comune e anche nell’uso della classe colta e anche nell’uso di quella sezione di dotti che trattano le stesse scienze, continuano a mantenere il vecchio significato. Si reagisce: il Pareto crea un suo «dizionario» che contiene in nuce la tendenza a creare una lingua matematica, cioè completamente astratta; i pragmatisti ne fanno una quistione filosofica e teorizzano sul linguaggio come causa di errore.
Ma è possibile togliere al linguaggio questo significato metaforico? È impossibile. Il linguaggio si trasforma col trasformarsi di tutta la civiltà e precisamente assume metaforicamente le parole delle civiltà e culture precedenti: nessuno oggi pensa che «dis‑astro» è legato all’astrologia e si ritiene indotto in errore sulle opinioni di chi la adopera. Il nuovo significato metaforico si estende con l’estendersi della nuova cultura, che d’altronde crea anche parole nuove di zecca o le assume da altre lingue con un significato preciso. È probabile che per molti uomini la parola «immanenza» sia conosciuta e capita e usata per la prima volta solo nel nuovo significato datole dal materialismo storico.
Q7 §37 Goethe. Cercare dove e in quali sensi Goethe ha affermato: «Come può un uomo raggiungere l’autocoscienza? Con la contemplazione? Certamente no, ma con l’azione».
Q7 §38 Esame del concetto di natura umana. Origini del sentimento di «uguaglianza»: la religione con la sua idea di dio‑padre e uomini‑figli, quindi uguali; la filosofia secondo l’aforisma: «Omnis enim philosophia, cum ad communem hominum cogitandi facultatem revocet, per se democratica est; ideoque ab optimatibus non iniuria sibi existimatur perniciosa». La scienza biologica, che afferma l’uguaglianza «naturale» cioè psico‑fisica di tutti gli elementi individuali del «genere» umano: tutti nascono allo stesso modo ecc. «L’uomo è mortale; Tizio è uomo, Tizio è mortale». Tizio = tutti gli uomini. Così ha origine empirico-scientifica (empirico = scienza folcloristica) la formula: «Siamo nati tutti nudi».
Ricordare la novella di Chesterton nella Ingenuità di Padre Brown sull’uomo‑portalettere e l’uomo ‑ piccolo costruttore di macchine portentose; c’è un’osservazione di questo genere: «Una vecchia dama abita in un castello con venti servi: è visitata da un’altra dama e dice a questa: “Sono sempre così sola ecc.”; il medico le annunzia che c’è la peste in giro, infezioni ecc. e allora dice “Siamo in tanti”». (Il Chesterton trae da questo spunto effetti puramente novellistici di intrigo).
Q7 §39 Croce. L’elemento «passionale» come origine dell’atto politico, così come è teorizzato dal Croce, non può essere accettato tal quale. Dice il Croce a proposito del Sorel: «il “sentimento di scissione” non l’aveva garantito (il sindacalismo) abbastanza, forse anche perché una scissione teorizzata è una scissione sorpassata; né il “mito” lo scaldava abbastanza, forse perché il Sorel, nell’atto stesso di crearlo, lo aveva dissipato, dandone la spiegazione dottrinale» (cfr Cultura e Vita morale, 2a ed., p. 158). Le osservazioni sul Sorel sono giuste anche per il Croce: la «passione» teorizzata non è anch’essa sorpassata? la «passione» di cui si dà una spiegazione dottrinale, non è anch’essa «dissipata»? Né si dica che la «passione» di Croce sia cosa diversa dal «mito» di Sorel, che la «passione» significhi la «categoria o il momento spirituale pratico» mentre il «mito» sia una «determinata» passione, che come «determinata» può essere dissipata e sorpassata senza che perciò la «categoria» sia dissipata e «sorpassata»; l’obbiezione è vera solo in parte, e cioè in quanto significa che Croce non è Sorel, cosa ovvia e banale. Sorel non ha teorizzato un determinato mito, ma «il mito» come sostanza dell’azione pratica e ha poi fissato quale determinato mito era storicamente e psicologicamente il più aderente a una certa realtà. La sua trattazione ha perciò due aspetti: uno propriamente teorico, di scienza politica, e uno pratico-politico. È possibile, sebbene sia discutibile, che l’aspetto pratico‑politico sia stato dissipato e sorpassato; oggi si può dire che è stato sorpassato solo nel senso che è stato integrato, ma il determinato mito aveva una base reale. In ogni modo rimane la «teoria dei miti» che non è altro che la «teoria delle passioni» con un linguaggio meno preciso e formalmente coerente. Se teorizzare il mito significa dissolvere tutti i miti, teorizzare le passioni significa dissipare tutte le passioni, costruire una nuova medicina delle passioni.
Che il Croce non sia uscito fuori da queste contraddizioni e che le senta, si capisce dal suo atteggiamento verso i «partiti politici», come si può vedere dal capitolo «Il partito come giudizio e come pregiudizio» di Cultura e Vita morale e da ciò che si dice dei partiti negli Elementi di politica, quest’ultimo più significativo. Il Croce riduce i partiti ai «singoli» capi-partito che per la loro «passione» si costruiscono lo strumento adatto di trionfo. Ma anche ciò non spiega nulla. Si tratta di questo: i partiti sono sempre esistiti, anche se con altre forme e altri nomi, e ancor di più è sempre esistita una organizzazione permanente militare, che è l’«attore politico» per eccellenza. Come mettere insieme la «passione» e la «permanenza, l’ordine, la disciplina ecc.»? La volontà politica deve avere anche altra molla oltre alla passione.
Q7 §40 Nazionalizzazioni e statizzazioni. Cfr M. Saitzew, Die öffentliche Unternehmung der Gegenwart, Tübingen, Mohor, 1930, RM. 3,40. Il Saitzew è professore dell’Università di Zurigo. Secondo il Saitzew l’area d’azione delle imprese pubbliche, specialmente in certi rami, è molto maggiore di ciò che si crede; in Germania il capitale delle imprese pubbliche sarebbe un quinto dell’intera ricchezza nazionale (durante la guerra e l’immediato dopoguerra l’impresa pubblica si è dilatata). Il Saitzew non crede che le imprese pubbliche siano una forma di socialismo, ma crede siano parte integrante del capitalismo. Le obbiezioni contro l’impresa pubblica potrebbero farsi anche per le società anonime; si ripetono argomenti che erano buoni quando le imprese private erano individuali, eppure le anonime sono oggi prevalenti ecc.
Sarà utile il volumetto per vedere l’estensione che ha avuto l’impresa pubblica in alcuni paesi: il carattere dell’impresa pubblica non sarebbe, secondo il Saitzew, quello di avere come scopo principale il reddito fiscale, ma quello di impedire che in certi rami, in cui la concorrenza è tecnicamente impossibile, si stabilisca un monopolio privato pericoloso per la collettività.
Q7 §41 Economia. Deve essere molto interessante il volume di Henryk Grossmann, Das Akkumulations‑ und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (Zugleich eine Krisentheorie) in «Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M.», Verlag C. L. Hirschfeld, Lipsia, 1929, pp. XVI‑628, RM. 20, di cui è pubblicata una recensione di Stefano Samogyi nell’«Economia» del marzo 1931 (pp. 327‑332). La recensione non è molto brillante e forse non bisogna sempre fidarsi dei suoi riassunti (il Samogyi usa «tendenzioso» e «tendenziale» indifferentemente, «tracollo» per «catastrofe» e introduce affermazioni pseudoteoriche gradite solo a Gino Arias, ecc.), tuttavia ne trarrò alcune indicazioni (sotto cautela di revisione futura sul testo del Grossmann). Vedi oltre.
Q7 §42 Paragone ellittico? Che la teoria del valore del Marx non sia un paragone ellittico, come vorrebbe spiegarla il Croce, risulta dal fatto che essa teoria è uno sviluppo della teoria di Ricardo (osservazione fatta da Graziadei in Sindacati e Salari, il quale non faceva certamente un «paragone ellittìco». Tuttavia anche questa correzione al Croce mi pare non sia soddisfacente in tutto e per tutto. È arbitraria la teoria di Marx? E in che allora consisterebbe l’arbitrio? Nello svolgimento dato dal Croce alla sua dimostrazione del paragone ellittico non potrebbe esserci tuttavia un grano di verità inconsapevole? Bisognerebbe studiare bene la teoria di Ricardo e specialmente la teoria di Ricardo sullo Stato come elemento che assicura la proprietà, cioè il monopolio dei mezzi di produzione. Se si studia infatti l’ipotesi «economica» pura, come Ricardo probabilmente intendeva fare, non occorre prescindere dagli «Stati» (dico apposta «Stati») e dal monopolio «legale» della proprietà? Non si tratterebbe quindi per nulla di un «paragone ellittico» fatto da Marx come «propugnatore» di una futura forma sociale diversa da quella studiata, ma di una teoria risultante dalla riduzione alla pura «economicità» dei fatti economici, cioè del massimo di determinazione del «libero gioco delle forze economiche». È certo che Ricardo come gli altri economisti classici erano estremamente spregiudicati e la teoria del valore‑lavoro di Ricardo non sollevò nessuno scandalo al suo tempo (cfr la Storia del Gide e Rist; non rappresentava nessun pericolo perché era ed appariva come una constatazione puramente obbiettiva; il valore polemico, pur senza perdere la sua obbiettività, lo acquista col Marx ecc.). Questo problema è legato allo stesso problema fondamentale della scienza economica «pura» cioè alla ricerca e alla identificazione di ciò che è il concetto e il fatto economico, indipendente dagli altri concetti e fatti di spettanza delle altre scienze; e per fatto economico occorre ancora intendere il fatto «produzione e distribuzione dei beni economici materiali» e non tutti i fatti che possono essere compresi nel concetto di «economia» quale appare nel Croce (per il quale anche l’amore, per es., è un fatto economico ecc.).
A proposito di «paragoni ellittici» sarebbe ancora da notate che tutto il linguaggio è una serie di «paragoni ellittici» e che la storia è un paragone implicito tra il passato e il presente (l’attualità storica). E perché l’ellissi sarebbe illecita se il paragone avviene con un’ipotesi avvenire, mentre sarebbe lecita se il paragone avviene con un fatto passato? (il quale in tal caso è preso proprio come «ipotesi», cioè punto di riferimento che fa meglio comprendere il presente?) Questo spunto è da approfondire.
Q7 §43 Riforma e Rinascimento. Questi modelli di sviluppo culturale forniscono un punto di riferimento critico che mi pare sempre più comprensivo e importante (per il suo valore di suggestione pedagogica) quanto più ci rifletto. È evidente che non si capisce il processo molecolare di affermazione di una nuova civiltà che si svolge nel mondo contemporaneo senza aver capito il nesso storico Riforma-Rinascimento. Superficialità del Liefscitz nell’articolo introduttivo alla pubblicazione periodica di bibliografia del Rivière («La Critique Sociale»). Il Liefscitz mi pare non abbia capito gran che del marxismo e la sua concezione si potrebbe chiamare veramente da «burocratico». Luoghi comuni a tutto andare, detti con la mutria di chi è ben soddisfatto di se stesso e creda di essere tanto superiore alla critica che non immagina neanche di non dire continuamente verità strabilianti e originali. Critica (superficiale) fatta dal punto di vista dell’intellettuale (dell’intellettuale mezza calzetta). Il Liefscitz vede nell’uomo politico più il grande intellettuale nel senso letterario che il grande politico. Ma chi è stato più grande intellettuale, Bismarck o Barrès? Chi ha «realizzato» maggiori mutamenti nel mondo della cultura?
Il Liefscitz non capisce nulla di tali quistioni, ma non capisce nulla neanche della quistione che egli malamente imposta: si tratta, è vero, di lavorare alla elaborazione di una élite, ma questo lavoro non può essere staccato dal lavoro di educare le grandi masse, anzi le due attività sono in realtà una sola attività ed è appunto ciò che rende difficile il problema (ricordare l’articolo della Rosa [Luxemburg ndc] sullo sviluppo scientifico del marxismo e sulle ragioni del suo arresto); si tratta insomma di avere una Riforma e un Rinascimento contemporaneamente. Per il Liefscitz il problema è semplicemente un motivo di disfattismo; e non è infatti puro disfattismo trovare che tutto va male e non indicare criticamente una via d’uscita da questo male? Un «intellettuale», come crede di essere il Liefscitz, ha un modo di impostare e risolvere il problema: lavorando concretamente a creare quelle opere scientifiche di cui piange amaramente l’assenza, e non limitarsi a esigere che altri (chi?) lavori. Né il Liefscitz pretenderà che la sua rivista sia già questo lavoro: essa potrebbe essere un’attività utile se fosse scritta con modestia e con migliore autocritica e senso critico in generale. Una rivista è «un terreno» per iniziare a lavorare per la soluzione di un problema di cultura, non è essa stessa una soluzione: e, ancora, deve avere un indirizzo preciso e quindi offrire modo a un lavoro collettivo di un gruppo intellettuale, tutte cose che non si vedono nella rivista del Liefscitz. Recensire i libri è molto più facile che scrivere dei libri, tuttavia è cosa utile: ma un «recensore» per programma può, senza essere un puro disfattista, piangere sconsolatamente sul fatto che gli «altri» non scrivono libri? E se anche gli altri preferiscono scrivere «recensioni»?
Q7 §44 Riforma e Rinascimento. Che il processo attuale di formazione molecolare di una nuova civiltà possa essere paragonato al movimento della Riforma può essere mostrato anche con lo studio di aspetti parziali dei due fenomeni. Il nodo storico‑culturale da risolvere nello studio della Riforma è quello della trasformazione della concezione della grazia, che «logicamente» dovrebbe portare al massimo di fatalismo e di passività, in una pratica reale di intraprendenza e di iniziativa su scala mondiale che ne fu invece conseguenza dialettica e che formò l’ideologia del capitalismo nascente. Ma noi vediamo oggi avvenire lo stesso per la concezione del materialismo storico; mentre da essa, per molti critici, non può derivare «logicamente» che fatalismo e passività, nella realtà invece essa dà luogo a una fioritura di iniziative e di intraprese che stupiscono molti osservatori (cfr estratto dell’«Economist» di Michele Farbman). Se si dovesse fare uno studio su l’Unione, il primo capitolo, o addirittura la prima sezione del libro, dovrebbe proprio sviluppare il materiale raccolto sotto questa rubrica «Riforma e Rinascimento».
Ricordare il libro del Masaryk su Dostoievskij e la sua tesi della necessità di una Riforma protestante in Russia, e le critiche di Leo Davidovich [Trotzky ndc] nel «Kampf» dell’agosto 1914; è notevole che il Masaryk nel suo libro di memorie (La Résurrection d’un Etat. Souvenirs et réflexions, 1914‑1918, Parigi, Plon) proprio nel campo in cui la Riforma avrebbe dovuto operare, cioè come determinatrice di un nuovo atteggiamento verso la vita, atteggiamento attivo, di intraprendenza e iniziativa, riconosce l’apporto positivo del materialismo storico attraverso l’opera del gruppo che lo incarna. (A proposito di cattolicismo e protestantesimo e del loro atteggiamento reciproco verso la dottrina della grazia e quella delle «opere», ricordare che le «opere» nel linguaggio cattolico hanno ben poco da vedere con l’attività e l’iniziativa operosa e laboriosa, ma hanno un significato ristretto e «corporativo»).
Q7 §45 Quando si può dire che una filosofia ha un’importanza storica? Molte ricerche e studi intorno al sìgnificato storico delle diverse filosofie sono assolutamente sterili e cervellotici perché non si tiene conto del fatto che molti sistemi filosofici sono espressioni puramente (o quasi) individuali e che la parte che di essi può chiamarsi storica è spesso minima e annegata in un complesso di astrazioni di origine puramente razionale e astratto. Si può dire che il valore storico di una filosofia può essere «calcolato» dall’efficacia «pratica» che essa ha conquistato (e «pratica» deve essere intesa in senso largo). Se è vero che ogni filosofia è l’espressione di una società, dovrebbe reagire sulla società, determinare certi effetti, positivi e negativi: la misura in cui appunto reagisce è la misura della sua portata storica, del suo non essere «elucubrazione» individuale, ma «fatto storico».
Q7 §46 Sul «Saggio Popolare». La teleologia. Nella frase e nella concezione di «missione storica» non c’è una radice teleologica? E infatti in molti casi essa assume un valore equivoco e mistico. Ma in altri ha un significato che, dopo le limitazioni di Kant, può essere difeso dal materialismo storico.
Q7 §47 Sul «Saggio popolare». Il modo con cui è posto il problema della «realtà oggettiva del mondo esterno» è superficiale ed estraneo al materialismo storico. L’autore non conosce la tradizione cattolica e non sa che proprio la religione sostiene strenuamente questa tesi contro l’idealismo, cioè la religione cattolica sarebbe in questo caso «materialista». L’autore commette questo errore anche nella relazione al Congresso di storia della scienza e della tecnologia tenuta a Londra nel 31 (cfr pubblicazione degli Atti) affermando che la concezione soggettivistica e idealistica è legata alla concezione di un… Adamo che apre gli occhi per la prima volta nel mondo e crede di crearlo lui in quel momento (o qualcosa di simile) dimenticando che Adamo, secondo la Bibbia, e quindi la concezione religiosa, è creato dopo il mondo, e anzi il mondo è creato da Dio per lui. La religione perciò non può allontanarsi dal concetto della «realtà» indipendente dall’uomo pensante. La Chiesa (attraverso i gesuiti e specialmente i neoscolastici – Università di Lovanio e del Sacro Cuore a Milano –) ha cercato di assorbire il positivismo e anzi si serve di questo ragionamento per mettere in ridicolo gli idealisti presso le folle: «Gli idealisti sono quelli che pensano che il tal campanile esiste solo perché tu lo pensi; se tu non lo pensassi, il campanile non esisterebbe più». Cfr Mario Casotti, Maestro e scolaro, p. 49: «le ricerche dei naturalisti e dei biologi presuppongono già esistenti la vita e l’organismo reale», che suona come una frase di Engels nell’Antidühring.
Q7 §48 Giorgio Sorel. Vedere nel libro di Gaétan Pirou su Sorel, la bibliografia completa degli scritti del Sorel stesso (Seguono nel ms cinque righe bianche).
Finisce qui la «Seconda serie» degli Appunti di filosofia. Materialismo e idealismo.
Q7 §49 Letteratura Popolare. Romanzi d’appendice. Nelle «Nouvelles Littéraires» del mese di luglio 1931 e seguenti, cfr la rassegna degli odierni scrittori francesi di romanzi d’appendice Les illustres inconnus di G. Charensol. Finora sono apparsi brevi schizzi su M. Leblanc (autore di Arsenio Lupin), di Allain (autore di Fantomas) e di altri quattro o cinque (autore di Zigomar, ecc.).
Q7 §50 Letteratura popolare. Del carattere non popolare-nazionale della letteratura italiana. Atteggiamento verso il popolo nei Promessi Sposi. Il carattere «aristocratico» del cattolicismo manzoniano appare dal «compatimento» scherzoso verso le figure di uomini del popolo (ciò che non appare in Tolstoi) come fra Galdino (in confronto di frate Cristoforo), il sarto, Renzo, Agnese, Perpetua, la stessa Lucia, ecc. (Su questo argomento ho scritto altra nota). Vedere se spunti interessanti nel libro di A. A. Zottoli, Umili e potenti nella poetica di A. Manzoni, Ed. «La Cultura», Roma‑Milano 1931.
Sul libro dello Zottoli cfr Filippo Crispolti, Nuove indagini sul Manzoni, nel «Pègaso», di agosto 1931. Questo articolo del Crispolti è interessante di per se stesso, per comprendere l’atteggiamento del cristianesimo gesuitico verso gli «umili». Ma in realtà mi pare che il Crispolti abbia ragione contro lo Zottoli, sebbene il Crispolti ragioni «gesuiticamente». Dice il Crispolti del Manzoni: «Il popolo ha per sé tutto il cuore di lui, ma egli non si piega ad adularlo mai; lo vede anzi collo stesso occhio severo con cui vede i più di coloro che non sono popolo». Ma non si tratta di volere che il Manzoni «aduli il popolo», si tratta del suo atteggiamento psicologico verso i singoli personaggi che sono «popolari»; questo atteggiamento è nettamente di casta pur nella sua forma religiosa cattolica; i popolani, per il Manzoni, non hanno «vita interiore», non hanno personalità morale profonda; essi sono «animali» e il Manzoni è «benevolo» verso di loro proprio della benevolenza di una cattolica società di protezione degli animali. In un certo senso il Manzoni ricorda l’epigramma su Paolo Bourget: che per il Bourget occorre che una donna abbia 100 000 franchi di rendita per avere una psicologia. Da questo punto di vista il Manzoni (e il Bourget) sono schiettamente cattolici; niente in loro dello spirito «popolare» di Tolstoi, cioè dello spirito evangelico del cristianesimo primitivo. L’atteggiamento del Manzoni verso i suoi popolani è l’atteggiamento della Chiesa Cattolica verso il popolo: di condiscendente benevolenza, non di medesimezza umana. Lo stesso Crispolti, nella frase citata, inconsapevolmente confessa questa «parzialità» (o «partigianeria») del Manzoni: il Manzoni vede con «occhio severo» tutto il popolo, mentre vede con occhio severo «i più di coloro che non sono popolo»: egli trova «magnanimità», «alti pensierì», «grandi sentimenti» solo in alcuni della classe alta, in nessuno del popolo, che nella sua totalità è bassamente animalesco.
Che non abbia un gran significato il fatto che gli «umili» abbiano una parte di prim’ordine nel romanzo manzoniano, è giusto, come dice il Crispolti. Il Manzoni pone il «popolo» nel suo romanzo, oltre che per i personaggi principali (Renzo, Lucia, Perpetua, fra Galdino, ecc.) anche per la massa (tumulti di Milano, popolani di campagna, il sarto, ecc.), ma appunto il suo atteggiamento verso il popolo non è «popolare‑nazionale», ma aristocratico.
Studiando il libro dello Zottoli, occorre ricordare questo articolo del Crispolti. Si può mostrare che il «cattolicismo» anche in uomini superiori e non «gesuitici» come il Manzoni (il Manzoni aveva certamente una vena giansenistica e antigesuitica) non contribuì a creare in Italia il «popolo‑nazione» neanche nel Romanticismo, anzi fu un elemento anti‑nazionale‑popolare e solamente aulico. Il Crispolti accenna solo al fatto che il Manzoni per un certo tempo accolse la concezione del Thierry (per la Francia) della lotta di razza nel seno del popolo (Longobardi e Romani, come in Francia Franchi e Galli) come lotta tra umili e potenti (Nel ms seguono, tra parentesi, alcune righe cancellate a leggeri tratti di penna): «A questo proposito è ancora più strana l’affermazione del Croce nella Storia della storiografia in Italia nel secolo XIX, che solo in Italia e non in Francia ci sia stata questa ricerca della lotta di razza nel Medio Evo come origine della divisione della società in ordini privilegiati e terzo stato, mentre è proprio l’opposto, ecc.».. Lo Zottoli cerca di rispondere al Crispolti nel «Pègaso» del settembre 1931.
Q7 §51 Storia delle classi subalterne. L’elemento di lotta di razza innestato nella lotta di classe in Francia dal Thierry ha avuto importanza e quale, in Francia, nel determinare la sfumatura nazionalistica dei movimenti delle classi subalterne? Il «gallicismo» operaio di Proudhon sarebbe da studiare, come espressione più compiuta della tendenza democratico‑gallicistica rappresentata dai romanzi popolari di Eugenio Sue.
Q7 §52 Letteratura popolare. ‑ Sezione cattolica. Il gesuita Ugo Mioni. Ho letto in questi giorni (agosto 1931) un romanzo di Ugo Mioni La ridda dei milioni stampato dall’Opera di S. Paolo di Alba. A parte il carattere prettamente gesuitico (e antisemita) che è particolarissimo di questo romanzaccio, mi ha colpito la trascuratezza stilistica e anche grammaticale della scrittura del Mioni. La stampa è pessima, i refusi e gli errori formicolano e questo è già grave in libretti dedicati ai giovani del popolo che spesso in essi imparano la lingua letteraria; ma se lo stile e la grammatica del Mioni possono aver sofferto per la cattiva stampa, è certo che lo scrittore è pessimo oggettivamente, è sgrammaticato e spropositante obbiettivamente. In ciò il Mioni si stacca dalla tradizione di compostezza e anzi di falsa eleganza e lindura degli scrittori gesuitici come il padre Bresciani.
Pare che Ugo Mioni (attualmente Mons. U. M.) non sia più gesuita della Compagnia di Gesù.
Q7 §53 Passato e presente. Debiti della Germania e pagamenti all’America. Pare che aver fissato prima di ogni altro che debba esistere interferenza tra i pagamenti all’America e i debiti di guerra della Germania sia stato Lord Balfour nella sua famosa nota del 1922. Il sen. D’Amelio non avrebbe che aderito alla nota Balfour nella conferenza di Londra del 1923.
Q7 §54 Passato e presente. La quistione della terra. Apparente frazionamento della terra in Italia: ma la terra non è dei contadini coltivatori, ma della borghesia rurale che spesso è più feroce e usuraia del grande proprietario. Accanto a questo fenomeno c’è l’altro del polverizzarsi della poca terra posseduta dai contadini lavoratori (che intanto sono per lo più in alta collina e in montagna). Questo polverizzarsi ha diverse cause: 1) la povertà del contadino che è costretto a vendere una parte della sua poca terra; 2) la tendenza ad avere molte piccolissime parcelle nelle diverse zone agricole del comune o di una serie di comuni, come assicurazioni contro la monocultura esposta a totale distruzione in caso di cattiva annata; 3) il principio di eredità della terra fra i figli, ognuno dei quali vuole una parcella di ogni campo ereditato (questo parcellamento non appare dal catasto perché la divisione non viene fatta legalmente ma bona fide). Pare che il nuovo Codice civile introduca anche in Italia il principio dell’Homestead, o bene di famiglia, che tende appunto in molti paesi a evitare lo sminuzzamento eccessivo della terra, a causa di eredità.
Q7 §55 Passato e presente. Vedere nella collezione della «Gerarchia» le fasi salienti del periodo 1920 e sg. e specialmente la serie di studi sulle nuove istituzioni create dal regime fascista.
Q7 §56 L’on. De Vecchi. Cfr nella «Gerarchia» dell’ottobre 1928 l’articolo di Umberto Zamboni, La marcia su Roma. Appunti inediti. L’azione della colonna Zamboni, dove si dice che il De Vecchi, solo tra i quadrumviri, era rimasto a Roma «per tentare ancora l’estremo tentativo di una soluzione pacifica». L’affermazione è da confrontare con l’articolo di M. Bianchi nel numero unico di «Gerarchia» dedicato alla marcia su Roma e in cui si parla del De Vecchi in forma abbastanza strana. Lo Zamboni andò a Perugia col Bianchi e avrà sentito da lui questa versione dei contatti avuti tra il De Vecchi e il Bianchi il 27 ottobre.
Q7 §57 Passato e presente. L’alimentazione del popolo italiano. In «Gerarchia» del febbraio 1929, p. 158, il prof. Carlo Foà riporta le cifre fondamentali dell’alimentazione italiana in confronto agli altri paesi: l’Italia ha 909 750 calorie disponibili per abitante, la Francia un milione 358 300, l’Inghilterra 1 380 000, il Belgio 1 432 500, gli Stati Uniti 1 866 250. La Commissione scientifica interalleata per i vettovagliamenti ha stabilito che il minimo di consumo alimentare per l’uomo medio è di 1 milione di calorie per anno. L’Italia come media nazionale di disponibilità è al di sotto di questa media. Ma se si considera che la disponibilità non si distribuisce tra gli uomini medii, ma prima di tutto per gruppi sociali, si può vedere come certi gruppi sociali, come i braccianti meridionali (contadini senza terra) a stento devono giungere alle 400 mila calorie annue, ossia 2/5 della media stabilita dagli scienziati.
Q7 §58 Romanzo popolare. Diffusione dell’Ebreo Errante in Italia nel periodo del Risorgimento. Vedere l’articolo di Baccio M. Bacci Diego Martelli, l’amico dei «Macchiaioli» nel «Pègaso» del marzo 1931. Il Bacci riporta integralmente in parte e in parte riassume (pp. 298‑99) alcune pagine inedite dei Ricordi della mia prima età, in cui il Martelli racconta che spesso (tra il 49 e il 59) si riunivano in casa sua gli amici del padre, tutti patriotti e uomini di studio come il padre stesso: Atto Vannucci, Giuseppe Arcangeli, insegnante di greco e di latino, Vincenzo Monteri, chimico, fondatore dell’illuminazione a gas a Firenze, Pietro Thouar, Antonio Mordini, Giuseppe Mazzoni, triumviro con Guerrazzi e Montanelli, il Salvagnoli, il Giusti, ecc.: discutevano di arte e di politica e talvolta leggevano i libri che circolavano clandestini. Vieusseux aveva introdotto l’Ebreo Errante: ne fu fatta lettura in casa Martelli, davanti agli amici intervenuti da Firenze e da fuori. Racconta Diego Martelli: «Chi si strappava i capelli, chi pestava i piedi, chi mostrava le pugna al cielo...».
Q7 §59 Il Sansimonismo in Italia. Studiare la diffusione del Sansimonismo: esistono alcune pubblicazioni in Italia. Potrebbe pensarsi che le idee del basso sansimonismo abbiano avuto una diffusione attraverso Sue.
Q7 §60 Storia degli intellettuali italiani. Cfr l’accenno nei Ricordi di un vecchio normalista di Girolamo Vitelli nella Nuova Antologia del 1° aprile 1930: la filologia classica in Italia per tre secoli (fino alla seconda metà del secolo XIX) fu completamente trascurata: «Quando si conosca un po’ la storia di questi nostri studi, si sa anche che dal Rinascimento in poi, dopo gli italiani del ’400 (e anche sino alla fine del ’500, con l’ultima grande scuola di Pier Vettori), ne tennero successivamente l’egemonia, con tendenze più o meno diverse, i francesi, gli olandesi, gl’inglesi, i tedeschi». Perché questa assenza degli italiani? Il Vitelli non la spiega altro che col «mercantilismo», ma chi più mercantilista degli olandesi e degli inglesi? È curioso che sono proprio le nazioni protestanti (e in Francia mi pare che gli Étiennes fossero ugonotti) che mantengono lo studio del mondo antico in onore. Bisognerebbe vedere l’organizzazione di questi studi in queste nazioni e paragonare coi centri di studi in Italia. La Controriforma ha influito? ecc.
Q7 §61 Quistioni di cultura. Le biblioteche. Cfr l’interessante articolo di Ettore Fabietti, Per la sistemazione delle Biblioteche pubbliche «nazionali» e «popolari», nella «Nuova Antologia» del 1° aprile 30.
Q7 §62 La quistione degli intellettuali. Quando incomincia la vita culturale nei vari paesi del mondo e dell’Europa? Ciò che noi dividiamo in «Storia antica», «medioevale», «moderna», come si può applicare ai diversi paesi? Pure queste diverse fasi della storia mondiale sono state assorbite dagli intellettuali moderni anche dei paesi solo di recente entrati nella vita culturale. Tuttavia il fatto dà luogo ad attriti. Le civiltà dell’India e della Cina resistono all’introduzione della civiltà occidentale, che pure in una forma o nell’altra finirà col vincere: possono esse d’un colpo decadere alle condizioni di folklore? di superstizione? Questo fatto però non può accelerare la rottura tra popolo e intellettuali e la espressione da parte del popolo di nuovi intellettuali formatisi nella sfera del materialismo storico?
Q7 §63 Storia degli intellettuali italiani. Cfr l’articolo di Giuseppe Tucci, Del supposto architetto del Taj e di altri italiani alla corte del Mogul, nella «Nuova Antologia» del 1° maggio 1930. Il supposto architetto del Taj sarebbe stato Jeromino Veroneo, morto nel 1640, cioè prima che il Taj fosse ultimato (1648), ma che si suppone abbia fatto il piano, ultimato poi da un mussulmano (vedi l’articolo per i dettagli).
Q7 §64 Roberto Michels. Nell’articolo Il pangermanismo coloniale tra le cause del conflitto mondiale di Alberto Giaccardi (Nuova Antologia, 16 maggio 1930), a p. 238 è scritto: «Il “posto al sole” reclamato dalla Germania cominciò troppo presto a diventare di una tale ampiezza, che avrebbe ridotto tutti gli altri all’ombra o quasi: perfino al popolo italiano, la cui situazione era analoga a quella del popolo tedesco, un dotto germanico, Roberto Michels, negava il diritto di esigere colonie, perché “l’Italia, pur essendo demograficamente forte, è povera di capitali”». Il Giaccardi non dà il riferimento bibliografico dell’espressione del Michels.
Nel fascicolo del 1° luglio successivo il Giaccardi pubblica una «rettifica» della sua affermazione, evidentemente per impulso del Michels; ricorda: L’Imperialismo italiano del Michels (Milano, 1914, Società editrice libraria) e del 1912 gli Elemente zur Entstehungsgeschichte des Imperialismus in Italien, nell’«Archiv für Sozialwissenschaft», gennaio‑febbraio 1912, pp. 91‑92, e conclude: «Il che corrisponde perfettamente ai sentimenti di italianità costantemente (!) dimostrati dall’ìllustre professore dell’Ateneo perugino, che, sebbene renano d’origine, ha scelto l’Italia come sua Patria di adozione, svolgendo in ogni occasione una intensa ed efficace attività in nostro favore» .
Q7 §65 Femminismo. Cfr l’articolo di Vittorio Cian, Femminismo patriottico del Risorgimento, nella «Nuova Antologia» del 1° giugno 1930. Tipo retorico, ma interessante per le indicazioni obbiettive sulla partecipazione delle donne alla vita politica nel Risorgimento.
In una nota è citato questo brano del Gioberti preso dall’Apologia del libro intitolato «Il Gesuita Moderno ecc.», cap. III della parte I: «la partecipazione della donna alla causa nazionale è un fatto quasi nuovo in Italia e che verificandosi in tutte le sue provincie, vuol essere specialmente avvertito, perché esso è, al parer mio, uno dei sintomi più atti a dimostrare che siamo giunti a maturità civile e a pieno essere di coscienza come nazione». L’osservazione del Gioberti non è valida solo per la vita nazionale: ogni movimento storico innovatore è maturo solo in quanto vi partecipano non solo i vecchi ma i giovani e i maturi e le donne, cosicché esso ha persino un riflesso nella fanciullezza.
Q7 §66 Storia degli intellettuali italiani. Gioacchino Volpe nell’articolo (discorso) Il primo anno dell’Accademia d’Italia («Nuova Antologia», 16 giugno 1930) a p. 494, tra i libri di storia che l’Accademia (Sezione di scienze morali‑storiche) desidererebbe fossero scritti accenna: «O dedicati a quella mirabile irradiazione della nostra coltura che si ebbe fra il XV e XVII secolo, dall’Italia verso l’Europa, pur mentre dall’Europa muovevano verso l’Italia le nuove invasioni e dominazioni».
Q7 §67 Storia degli intellettuali italiani. Cfr Renaud Przezdziecki, Ambasciatori veneti in Polonia, Nuova Antologia, 1° luglio 1930:
«La mancanza di una unità patria, di una dinastia unica, creava tra gli italiani uno stato di spirito indipendente, per cui ciascuno che fosse fornito di capacità politiche e diplomatiche, le considerava come un talento personale che poteva mettere, secondo il suo interesse, al servizio di qualunque causa, allo stesso modo che i capitani di ventura disponevano della loro spada. La diplomazia considerata come un libero mestiere, creava così, nei secoli XVII e XVIII, il tipo del diplomatico senza patria, di cui l’esempio più classico è probabilmente il cardinale di Mazzarino».
La diplomazia, secondo il Przezdziecki, avrebbe trovato in Italia un terreno naturale per nascere e svilupparsi: 1) vecchia cultura; 2) frazionamento «statale» che dava luogo a contrasti e lotte politiche e commerciali e quindi favoriva lo sviluppo delle capacità diplomatiche.
In Polonia si ritrovano di questi diplomatici italiani al servizio di altri Stati: un prelato fiorentino, monsignor Bonzi, fu ambasciatore di Francia a Varsavia, dal 1664 al 1669; un marchese de Monti, bolognese, fu ambasciatore di Luigi XV presso Stanislao Lesczynski; un marchese Lucchesini, fu ministro plenipotenziario del re di Prussia a Varsavia alla fine del ’700. I re di Polonia si servirono spesso delle abilità diplomatiche di italiani, quantunque la nobiltà polacca avesse fatto approvare delle leggi, che vietavano ai sovrani di affidare a forestieri funzioni pubbliche. Ladislao Jagellone, al principio del ’400, aveva incaricato tal Giacomo de Paravesino di missioni diplomatiche, come suo ambasciatore a Venezia, a Milano, a Mantova. L’umanista fiorentino Filippo Buonaccorsi da Fiesole, detto il Callimaco, dopo essere stato pedagogo dei figli di Casimiro III, andò ambasciatore di questo re presso Sisto IV. Innocenzo VIII, la Repubblica di Venezia e il Sultano. Nel secolo XVI, furono ambasciatori polacchi in vari Stati Luigi del Monte, Pietro degli Angeli, i fratelli Magni di Como. Nel secolo XVI, Domenico Roncalli è ministro di Ladislao IV a Parigi e negozia il matrimonio di quel sovrano con Luisa Maria Gonzaga; Francesco Bibboni è ambasciatore polacco a Madrid, Andrea Bollo è ministro di Polonia presso la Repubblica di Genova e un dall’Oglio incaricato d’affari a Venezia alla fine del secolo XVIII. Tra i rappresentanti polacchi presso la santa sede troviamo, anche nella seconda metà del secolo XVIII, un cardinale Antici e un conte di Lagnasco.
Gli Italiani hanno creato la diplomazia moderna. La Santa Sede, durante lunghi secoli arbitra in buona parte della politica mondiale, fu la prima a istituire Nunziature stabili e la Repubblica di Venezia fu il primo Stato che organizzò un servizio diplomatico regolare.
Q7 §68 Storia degli intellettuali italiani. Umanesimo e Rinascimento. Cfr Luigi Arezio, Rinascimento, Umanesimo e spirito moderno, «Nuova Antologia» del 1° luglio 1930.
L’Arezio si occupa del libro di G. Toffanin, Che cosa fu l’Umanesimo (Firenze, Sansoni, 1929) che appare, dai cenni fattine, molto interessante per il mio argomento. Accennerò qualche spunto, perché dovrò leggere il volume. (Il Voigt e il Burckhardt credettero che l’Umanesimo fosse diretto contro la Chiesa; il Pastor – sarà da leggere il suo volume sulla Storia dei Papi, che concerne l’Umanesimo – non crede che l’Umanesimo fosse inizialmente diretto contro la Chiesa). Per il Toffanin, il principio della irreligiosità o della nuova religione non è la via maestra per entrare nel segreto degli umanisti; né vale parlare del loro individualismo, perché «i presunti effetti della rivalutazione della personalità umana» a opera di una cultura, sarebbero tanto più sorprendenti in un tempo rimasto a sua volta famoso per aver «allungata la distanza fra il resto degli uomini e quelli di studio». Il fatto veramente caratteristico dell’Umanesimo «resta quella passione per il mondo antico per cui, quasi d’improvviso, con una lingua morta si tenta di soppiantarne una popolare e consacrata dal genio, s’inventa, possiam dire, la scienza filologica, si rinnova gusto e cultura. Il mondo pagano rinasce».
Il Toffanin sostiene che non bisogna confondere l’umanesimo col progressivo risveglio posteriore all’anno mille; l’umanesimo è un fatto essenzialmente italiano «indipendente da codesti fallaci presagi» e ad esso attingeranno per farsi classici e colti la Francia e il mondo intero. In un certo senso può chiamarsi eretica quella civiltà comunale del duecento, che apparve in una irruzione di sentimenti e pensieri raffinatissimi in forme plebee, e «inizialmente eretico fu quell’impulso all’individualismo anche se tra il popolo esso prese coscienza d’eresia meno di quanto a un primo sguardo si sospetti». La letteratura volgare prorompente dal seno della civiltà comunale e indipendente dal classicismo è indice d’una società «in cui il lievito eretico fermentò»; lievito, che, se indeboliva nelle masse l’ossequio all’autorità ecclesiastica, diventava nei pochi un aperto distacco dalla «romanitas», caratteristico fra il Medio Evo propriamente detto e l’Umanesimo. Alcuni intellettuali sembrano consapevoli di questa discontinuità storica: essi pretendono di essere colti senza leggere Virgilio, cioè senza i liberali studi, il cui generale abbandono giustificherebbe, secondo il Boccaccio, l’uso del volgare, anziché del latino, nella Divina Commedia. Massimo fra questi intellettuali Guido Cavalcanti. In Dante «l’amore della lingua plebea, germogliato da uno stato d’animo comunale e virtualmente eretico» dovette contrastare con un concetto della sapienza quasi umanistico. «Caratterizza gli umanisti la coscienza d’uno stacco senza rimedio tra uomo di cultura e folla: ideali astratti sono per loro quelli della potestà imperiale e papale; reale invece è la loro fede nella universalità culturale e nelle ragioni di essa». La Chiesa favorì il distacco della cultura dal popolo cominciato col ritorno al latino, perché lo considerò come sana reazione contro ogni mistica indisciplinatezza. L’Umanesimo, da Dante a prima del Machiavelli, è una età che sta nettamente a sé, e, contrariamente a quel che ne pensano alcuni per il comune impulso antidemocratico e antieretico ha una non superficiale affinità con la Scolastica. Così il Toffanin nega che l’Umanesimo si trasfonda vitale nella Riforma, perché questa, col suo distacco dalla romanità, con la rivincita ribelle dei volgari, e con tante altre cose rinnova i palpiti della cultura comunale, fremente eresia, contro la quale l’umanesimo era sorto. Col finire dell’umanesimo nasce l’eresia e sono fuori dell’umanesimo Machiavelli, Erasmo (?), Lutero, Giordano Bruno, Cartesio, Giansenio.
Queste tesi del Toffanin spesso coincidono con le già da me fatte in altri quaderni. Solo che il Toffanin si mantiene sempre nel campo culturale‑letterario e non pone l’umanesimo in connessione con i fatti economici e politici che si svolgevano in Italia contemporaneamente: passaggio ai principati e alle signorie, perdita dell’iniziativa borghese e trasformazione dei borghesi in proprietari terrieri. L’Umanesimo fu un fatto reazionario nella cultura perché tutta la società italiana stava diventando reazionaria.
L’Arezio cerca di fare obbiezioni al Toffanin, ma si tratta di inezie e di superficialità. Che l’età comunale sia tutto un fermento di eresie non pare accettabile all’Arezio, che per eresia intende solo l’averroismo e l’epicureismo. Ma il comune era una eresia esso stesso perché tendenzialmente doveva entrare in lotta col papato e rendersene indipendente.
Così non gli piace che il Toffanin ponga tutto l’Umanesimo come fedele al cristianesimo, sebbene riconosca che anche gli scettici facevano ostentazione di religiosità. La verità è che si trattò del primo fenomeno «clericale» nel senso moderno, una Controriforma in anticipo (d’altronde era Controriforma in rapporto all’età comunale). Essi si opponevano alla rottura dell’universalismo medioevale e feudale che era implicito nel Comune e che fu soffocata in fasce, ecc. L’Arezio segue le vecchie concezioni sull’Umanesimo e ripete le affermazioni diventate classiche del Voigt, Burckhardt, del Rossi, De Nolhac, Symonds, Jebb, ecc.
Q7 §69 Azione Cattolica. Per il significato reale e di politica immediata e mediata dell’enciclica Quadragesimo anno di Pio XI per il 40° anniversario dell’enciclica Rerum Novarum per quanto riguarda i rapporti tra cattolicismo e socialdemocrazia, occorre tener conto dell’atteggiamento del cardinale inglese Bourne e del suo discorso a Edimburgo (nella prima quindicina del giugno 1931) sul partito laburista. Cfr i giornali cattolici inglesi del tempo.
Q7 §70 Storia delle classi subalterne. Intellettuali italiani. Da un articolo di Alfredo Panzini (Biancofiore, nel «Corriere della Sera» del 2 dicembre 1931) su Severino Ferrari e il suo poemetto Il Mago: «Al pari di molti figli della piccola borghesia, specie quelli che frequentavano l’Università, si era sentimentalmente accostato al fonte battesimale di Bakunin più forse che di Carlo Marx. I giovani, nell’entrare della vita, domandano un battesimo; e di Giuseppe Mazzini rimaneva la tomba e il gran fulgore della tomba; ma la parola del grande apostolo non bastava più alle nuove generazioni». Da che il Panzini trae che i giovani, ecc., si accostassero più al Bakunin, ecc.? Forse semplicemente dai ricordi personali di Università (Severino Ferrari era nato nel 1856; il Mago fu pubblicato nel 1884) sebbene il Panzini abbia frequentato l’Università di Bologna molti anni dopo il Ferrari.
Q7 §71 Intellettuali. Sulla cultura dell’India. Cfr la serie di articoli pubblicati nella «Civiltà Cattolica» del luglio 1930 e mesi seguenti: Sistemi filosofici e sette dell’Induismo. I gesuiti si pongono questo problema: Il cattolicismo in India riesce a far proseliti solo, e anche in questo caso in misura limitata, fra le caste inferiori. Gli intellettuali indiani sono refrattari alla propaganda, e il papa ha detto che occorre operare anche fra loro tanto più in quanto le masse popolari si convertirebbero se si convertissero dei nuclei intellettuali importanti (il papa conosce il meccanismo di riforma culturale delle masse popolari‑contadine più di molti elementi del laicismo di sinistra: egli sa che una grande massa non si può convertire molecolarmente; occorre, per affrettare il processo, conquistare i dirigenti naturali delle grandi masse, cioè gli intellettuali o formare gruppi di intellettuali di nuovo tipo, onde la creazione di vescovi indigeni); quindi la necessità di conoscere esattamente i modi di pensare e le ideologie di questi intellettuali, per meglio intenderne l’organizzazione di egemonia culturale e morale per distruggerla o assimilarla. Questi studi di parte gesuitica hanno perciò una particolare importanza oggettiva, in quanto non sono «astratti» e accademici, ma sono rivolti a scopi pratici concreti. Essi sono molto utili per conoscere le organizzazioni di egemonia culturale e morale nei grandi paesi asiatici come la Cina e l’India.
Q7 §72 Passato e presente. La borghesia rurale. Articolo di Alfredo Rocco, La Francia risparmiatrice e banchiera, in «Gerarchia» dell’ottobre 1931. Articolo da rettificare in molti particolari; ma il punto principale da notarsi è questo: perché in Francia si accumula tanto risparmio? Sarà solamente perché i francesi sono tirchi e avari, come pare sostenere il Rocco? Sarebbe difficile dimostrarlo, almeno in senso assoluto. Gli italiani sono «sobri, lavoratori, economi»: perché non si accumula risparmio in Italia? Il tenore di vita medio francese è superiore in modo vole a quello italiano (Cfr studio del Camis sull’alimentazione in Italia) perciò gli italiani dovrebbero risparmiare di più dei francesi. In Italia non avviene ciò che avviene in Francia perché esistono classi assolutamente parassitarie che non esistono in Francia, e più importante di tutte la borghesia rurale (Cfr il libro del Serpieri sulle classi rurali in Italia durante la guerra e precisare quanto «costa» una tale classe ai contadini italiani).
Q7 §73 Azione Cattolica. Oltre all’Annuario Pontificio che ha carattere ufficiale e alle altre pubblicazioni di Almanacchi, ecc., vedere la pubblicazione «Annali dell’Italia Cattolica» che nel 1930 sono stati pubblicati dalle edizioni «Pro Familia», Milano (in 16°, pp. 416, L. 8).
Q7 §74 Passato e presente. Gli industriali e le missioni cattoliche. È noto che gli industriali italiani hanno formato un organismo per aiutare direttamente e organicamente le missioni cattoliche nella loro opera di penetrazione culturale ed economica nei paesi arretrati. Si pubblica un bollettino speciale per tale attività: «Bollettino ufficiale del Comitato nazionale industriali e commercianti per le Missioni Cattoliche», Roma, in 8°. Contribuiranno industriali e commercianti anche ebrei e miscredenti, naturalmente, e anche la Fiat che negli anni del dopoguerra aiutava l’Y.M.C.A. e i metodisti a Torino.
Q7 §75 Letteratura popolare. In un articolo di Antonio Baldini («Corriere della Sera», 6 dicembre 1931) su Paolina Leopardi (Tutta‑di‑tutti) e i suoi rapporti con Prospero Viani, si ricorda, sulle tracce di un gruppo di lettere pubblicate da C. Antona‑Traversi («Civiltà moderna», anno III, n. 5, Firenze, Vallecchi) che il Viani soleva inviare alla Leopardi i romanzi di Eugenio Sue (I misteri di Parigi anche L’ebreo errante) che Paolina trovava «deliziosi». Ricordare il carattere di P. Viani, erudito, corrispondente della Crusca e l’ambiente in cui viveva Paolina, accanto all’ultrareazionario Monaldo, che scriveva la rivista «Voce della Ragione» (di cui Paolina era la redattrice capo) ed era avverso alle ferrovie, ecc.
Q7 §76 Nozioni enciclopediche. Bibliografia. Raccogliere i dati bibliografici delle pubblicazioni enciclopediche specializzate per la politica, la sociologia, la filosofia, l’economia. Si potrebbe cominciare dal Dizionario filosofico di Voltaire, in cui «filosofico» significa precisamente «enciclopedico» dell’ideologia dell’enciclopedismo o illuminismo. Ricordare il Dizionario politico di Maurizio Block, che è il «dizionario filosofico» del liberalismo francese. Il Dictionnaire politique et critique di Carlo Maurras (dalle «Nouvelles Littéraires» del 14 novembre 1931 appare che di questo lavoro di Maurras sono già usciti 20 fascicoli di 96 pp. l’uno; ogni fascicolo costa 10 franchi; presso le edizioni «La Cité des Livres»).
Q7 §77 Gli intellettuali. I partiti politici. Una delle quistioni più importanti riguardo ai partiti politici è quella della loro «tempestività», o «tempismo», ossia del come essi reagiscono contro lo spirito di «consuetudine» e le tendenze a diventare anacronistici e mummificati. Praticamente i partiti nascono come organizzazione dopo avvenimenti storici importanti per i gruppi sociali rappresentati: ma essi non sanno sempre adattarsi alle nuove epoche o fasi storiche, non sanno svilupparsi secondo che si sviluppano i rapporti complessivi di forza e quindi i rapporti relativi nel paese determinato o nel campo internazionale. In questa ricerca occorre distinguere: il gruppo sociale; la massa del partito; la burocrazia o stato maggiore del partito. Quest’ultima è la forza consuetudinaria più pericolosa: se essa si organizza come corpo a sé, solidale e indipendente, il partito finisce con l’anacronizzarsi. Avvengono così le crisi dei partiti, che, qualche volta d’un tratto, perdono la loro base sociale storica e si trovano campati in aria: ciò è avvenuto in Germania specialmente con la espansione dell’hitlerismo. I partiti francesi sono i più utili per studiare l’anacronizzarsi delle organizzazioni politiche: nati in conseguenza della Rivoluzione dell’89 e dei movimenti successivi essi ripetono una terminologia vieta, che permette ai dirigenti di mantenere la vecchia base pur facendo compromessi con forze affatto diverse e spesso contrarie e asservendosi alla plutocrazia.
Q7 §78 Azione Cattolica. A proposito dei provvedimenti presi nel 1931 contro l’Azione Cattolica italiana è interessante l’articolo Una grave questione di educazione cristiana: A proposito del Primo Congresso Internazionale dell’Insegnamento medio libero di Bruxelles (28‑31 luglio 1930), pubblicato nella «Civiltà Cattolica» del 20 settembre 1930.
Il Codice Sociale di Malines1, come è noto, non esclude la possibilità dell’insurrezione armata da parte dei cattolici: naturalmente restringe i casi di questa possibilità, ma lascia nel vago e nell’incerto le condizioni positive per la possibilità stessa, che però si capisce riguardare certi casi estremi di soppressione e limitazione dei privilegi ecclesiastici e vaticani. In questo articolo della «Civiltà Cattolica», proprio nella prima pagina e senza altra osservazione, si riproduce un brano del libro: Ch. Terlinden, Guillaume I, roi des Pays bas, et l’Eglise Catholique en Belgique (1814‑1830), Bruxelles, Dewit, 1906, Tom. 2, p. 545: «Se Guglielmo I non avesse violate le libertà e i diritti dei cattolici, questi, fedeli ad una religione che comanda il rispetto all’autorità, non avrebbero mai pensato a sollevarsi, né ad unirsi coi liberali loro irreconciliabili nemici. Né i liberali, pochi allora e con debole influenza sul popolo, avrebbero potuto da soli scuotere il giogo straniero. Senza il concorso dei cattolici, la rivoluzione belga sarebbe stata una sterile sommossa senza esito». Tutta la citazione è impressionante, in tutti e tre i suoi periodetti, come interessante è l’intero articolo in cui il Belgio rappresenta un riferimento polemico d’attualità.
Q7 §79 Passato e presente. Sulla quistione dell’importanza data dal Gentile al Gioberti per individuare un filone filosofico nazionale permanente e conseguente sono da vedere due studi sul Gioberti: quello dello scrittore cattolico Palhoriès, Gioberti, Parigi, Alcan, 1929, in 8°, pp. 408, e quello dell’idealista Ruggero Rinaldi, Gioberti e il Problema religioso del Risorgimento, prefazione di Balbino Giuliano, Vallecchi, Firenze, in 8°, pp. XXVIII‑180. Ambedue sebbene partendo da punti di vista diversi, giungono a dimostrazioni simili: che il Gioberti, cioè, non è per nulla lo Hegel italiano, ma si mantiene nel campo dell’ortodossia cattolica e dell’ontologismo. E da tener conto dell’importanza che ha nel «gentilismo» l’interpretazione idealistica del Gioberti, che in fondo è un episodio di Kulturkampf o un tentativo di riforma cattolica. È da notare l’introduzione del Giuliano al libro del Rinaldi, perché pare che il Giuliano presenti alcuni dei problemi di cultura posti dal Concordato in Italia e cioè come, avvenuto l’accordo politico tra Stato e Chiesa, possa aversi un «accordo» tra trascendenza e immanenza nel campo del pensiero filosofico e della cultura.
Q7 §80 Passato e presente. La discussione su la forza e il consenso ha dimostrato come sia relativamente progredita in Italia la scienza politica e come nella sua trattazione, anche da parte di statisti responsabili, esista una certa franchezza di espressione. Questa discussione è la discussione della «filosofia dell’epoca», del motivo centrale della vita degli Stati nel periodo del dopoguerra. Come ricostruire l’apparato egemonico del gruppo dominante, apparato disgregatosi per le conseguenze della guerra in tutti gli Stati del mondo? Intanto perché si è disgregato? Forse perché si è sviluppata una forte volontà politica collettiva antagonistica? Se così fosse stato, la quistione sarebbe stata risolta a favore di tale antagonista. Si è disgregata invece per cause puramente meccaniche, di diverso genere: 1) perché grandi masse, precedentemente passive, sono entrate in movimento, ma in un movimento caotico e disordinato, senza direzione, cioè senza precisa volontà politica collettiva; 2) perché classi medie che nella guerra avevano avuto funzioni di comando e di responsabilità, ne sono state private con la pace, restando disoccupate, proprio dopo aver fatto un apprendissaggio di comando, ecc.; 3) perché le forze antagonistiche sono risultate incapaci a organizzare a loro profitto questo disordine di fatto. Il problema era di ricostruire l’apparato egemonico di questi elementi prima passivi e apolitici, e questo non poteva avvenire senza la forza: ma questa forza non poteva essere quella «legale», ecc. Poiché in ogni Stato il complesso dei rapporti sociali era diverso, diversi dovevano essere i metodi politici di impiego della forza e la combinazione delle forze legali e illegali. Quanto più grande è la massa di apolitici, tanto più grande deve essere l’apporto delle forze illegali. Quanto più grandi sono le forze politicamente organizzate e educate, tanto più occorre «coprire» lo Stato legale, ecc.
Q7 §81 Riviste‑tipo. Collaborazione straniera. Non si può fare a meno di collaboratori stranieri, ma anche la collaborazione straniera deve essere organica e non antologica e sporadica o casuale. Perché sia organica è necessario che i collaboratori stranieri, oltre a conoscere le correnti culturali del loro paese siano capaci di «confrontarle» con quelle del paese in cui la rivista è pubblicata, cioè conoscano le correnti culturali anche di questo e ne comprendano il «linguaggio» nazionale. La rivista pertanto (ossia il direttore della rivista) deve formare anche i suoi collaboratori stranieri per raggiungere l’organicità.
Nel Risorgimento ciò avvenne molto di rado e perciò la cultura italiana continuò a rimanere alquanto provinciale. Del resto una organicità di collaborazione internazionale si ebbe forse solo in Francia, perché la cultura francese, già prima dell’epoca liberale, aveva esercitato un’egemonia europea; erano quindi relativamente numerosi gli intellettuali tedeschi, inglesi, ecc. che sapevano informare sulla cultura dei loro paesi impiegando un «linguaggio» francese. Infatti non bastava che l’«Antologia» del Vieusseux pubblicasse articoli di «liberali» francesi o tedeschi o inglesi perché tali articoli potessero informare utilmente i liberali italiani, perché tali informazioni cioè potessero suscitare o rafforzare correnti ideologiche italiane: il pensiero rimaneva generico, astratto, cosmopolita. Sarebbe stato necessario suscitare collaboratori specializzati nella conoscenza dell’Italia, delle sue correnti intellettuali, dei suoi problemi, cioè collaboratori capaci di informare nello stesso tempo la Francia sull’Italia.
Tale tipo di collaboratore non esiste «spontaneamente», deve essere suscitato e coltivato. A questo modo razionale di intendere la collaborazione si oppone la superstizione di avere tra i propri collaboratori esteri i capiscuola, i grandi teorici, ecc. Non si nega l’utilità (specialmente commerciale) di avere grandi firme. Ma dal punto di vista pratico di promuovere la cultura, è più importante il tipo di collaboratore affiatato con la rivista, che sa tradurre un mondo culturale nel linguaggio di un altro mondo culturale, perché sa trovare le somiglianze anche dove esse pare non esistano e sa trovare le differenze anche dove pare ci siano solo somiglianze ecc.
Q7 §82 I nipotini di padre Bresciani. Enrico Corradini. Saranno da vedere i giornali contenenti la sua commemorazione (il Corradini è morto il 10 dicembre 1931). Del Corradini è da vedere la sua teoria della «nazione proletaria» in lotta con le nazioni plutocratiche e capitaliste, teoria che servì di ponte ai sindacalisti per passare al nazionalismo prima della guerra libica e dopo. La teoria connessa col fatto dell’emigrazione di grandi masse di contadini in America e quindi con la quistione meridionale. I romanzi e i drammi del Corradini sotto rubrica del Brescianesimo.
Q7 §83 Nozioni enciclopediche. L’opinione pubblica. Ciò che si chiama «opinione pubblica» è strettamente connesso con l’egemonia politica, è cioè il punto di contatto tra la «società civile» e la «società politica», tra il consenso e la forza. Lo Stato quando vuole iniziare un’azione poco popolare crea preventivamente l’opinione pubblica adeguata, cioè organizza e centralizza certi elementi della società civile. Storia dell’«opinione pubblica»: naturalmente elementi di opinione pubblica sono sempre esistiti, anche nelle satrapie asiatiche; ma l’opinione pubblica come oggi si intende è nata alla vigilia della caduta degli Stati assoluti, cioè nel periodo di lotta della nuova classe borghese per l’egemonia politica e per la conquista del potere.
L’opinione pubblica è il contenuto politico della volontà politica pubblica che potrebbe essere discorde: perciò esiste la lotta per il monopolio degli organi dell’opinione pubblica: giornali, partiti, parlamento, in modo che una sola forza modelli l’opinione e quindi la volontà politica nazionale, disponendo i discordi in un pulviscolo individuale e disorganico.
Q7 §84 Nozioni enciclopediche. Mistica. Il termine «mistica» italiano non coincide col francese «mystique», pure anche in italiano si è incominciato a diffondere col significato francese, ma in modo strano, cioè il significato francese che è evidentemente critico e peggiorativo, si sta accettando con significato «positivo» senza senso deteriore. La «mistica» non può essere staccata dal fenomeno dell’«estasi», cioè di uno stato nervoso particolare nel quale il soggetto «sente» di entrare direttamente in contatto con dio, con l’universale, senza bisogno di mediatori (perciò i cattolici sono diffidenti verso il misticismo, che deprezza la chiesa‑intermediaria). Si intende perché i francesi abbiano introdotto il termine «mistica», nel linguaggio politico: vogliono significare uno stato d’animo di esaltazione politica non razionale o non ragionata, un fanatismo permanente incoercibile alle dimostrazioni corrosive, che poi non è altro che la «passione» di cui parla Croce o il «mito» di Sorel giudicato da cervelli cartesianamente logicistici: si parla pertanto di una mistica democratica, parlamentare, repubblicana, ecc. Positivamente si parla di mistica (come nella «Scuola di mistica fascista» di Milano) per non usare i termini di religiosità o addirittura di «religione». Nella prolusione di Arnaldo Mussolini per il terzo anno della Scuola di mistica fascista (Coscienza e dovere, pubblicata nel settimanale «Gente Nostra» del 13 dicembre 1931) si dice, fra l’altro. «Si è detto che la vostra scuola di mistica fascista non ha il titolo appropriato. Mistica è una parola che si addice a qualche cosa di divino, e quando viene portata fuori dal campo rigidamente religioso si adatta a troppe ideologie inquiete, vaghe, indeterminate. Diffidate delle parole e sopra tutto delle parole che possono avere parecchi significati. Certo che qualcuno può rispondermi che con la parola “mistica” si è voluto porre in evidenza i rapporti necessari fra il divino e lo spirito umano che ne è la sua derivazione. Accetto questa tesi senza indugiarmi in una questione di parole. In fondo non sono queste che contano: è lo spirito che vale. E lo spirito che vi anima è in giusta relazione al correre del tempo che non conosce dighe, né ha dei limiti critici; mistica è un richiamo a una tradizione ideale che rivive trasformata e ricreata nel vostro programma di giovani fascisti rinnovatori». Al significato di mistica francese si avvicina quello di «religione» come è impiegata dal Croce nella Storia d’Europa.
Q7 §85 Nozioni enciclopediche. Dottrinarismo e dottrinario. Significherebbe poi «nemico dei compromessi», «fedele ai principii». Parola presa dal linguaggio politico francese. Partito di dottrinari sotto Carlo X e Luigi Filippo: Royer‑Collard, Guizot, ecc.
Q7 §86 Nozioni enciclopediche. Bibliografie. Nella bibliografia di un Dizionario politico e critico occorre tener conto: 1) dei dizionari e delle enciclopedie generali, in quanto esse danno le spiegazioni più comuni e volgari della terminologia delle scienze morali e politiche; 2) delle enciclopedie speciali, cioè delle enciclopedie pubblicate dalle varie correnti intellettuali e politiche, come i cattolici, ecc.; 3) dei dizionari politici, filosofici, economici, ecc., esistenti nei diversi paesi; 4) dei dizionari etimologici generali e speciali, per esempio quello per i termini derivati dal greco del Guarnerio, pubblicato dal Vallardi (mi pare).
Siccome la terminologia acquista diversi contenuti secondo i tempi e secondo le diverse correnti culturali, intellettuali e politiche, la bibliografia generale teoricamente è indefinibile, perché abbraccia tutta la letteratura generale. Si tratta di limiti da porre: un dizionario politico e critico limitato per un certo livello culturale e di carattere elementare, che dovrebbe presentarsi come un saggio parziale.
Tra i libri generali ricordare di Mario Govi, Fondazione della Metodologia. Logica ed Epistemologia, Bocca, Torino 1929, pp. 579, per le nozioni storiche sulla classificazione delle scienze e altri problemi di metodo ecc.
Q7 §87 Nozioni enciclopediche. Agnosticismo. Questo termine è spesso usato nel linguaggio politico con significati spesso curiosi e sorprendenti: ciò avviene specialmente nelle polemiche «provinciali» in cui lo scrittore fa sfoggio di parole difficili. Si dice per esempio che Tizio è agnostico in proposito, quando Tizio non vuole discutere perché non prende sul serio un determinato argomento, ecc.
Il termine è d’origine religiosa e si riferisce al teòs agnostos (deus ignotus; ignoramus, ignorabimus, su dio, ecc.). Setta degli agnostici, ecc. Agnosticismo uguale pertanto a empirismo e materialismo (nominalismo, ecc.) ecc.; impossibilità di conoscere l’assoluto, gli universali, ecc., in quanto legati alla metafisica religiosa, ecc.
Q7 §88 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. Roberto Bellarmino. Pio XI il 13 maggio 1923 dette al Bellarmino il titolo di beato, più tardi (nel 50° anniversario del suo sacerdozio, quindi in una data specialmente segnalata) lo inscrisse nell’albo dei Santi, insieme coi gesuiti missionari morti nell’America settentrionale; nel settembre 1931 infine lo dichiarò Dottore della Chiesa Universale. Queste particolari attenzioni alla massima autorità gesuitica dopo Ignazio di Loyola, permettono di dire che Pio XI, il quale è stato chiamato il papa delle Missioni e il papa dell’Azione Cattolica, deve specialmente essere chiamato il papa dei gesuiti (le Missioni e l’Azione Cattolica, del resto, sono le due pupille degli occhi della Compagnia di Gesù). È da osservare che nella lettera apostolica tradotta con cui il Bellarmino è dichiarato Dottore (vedi «Civiltà Cattolica» del 7 novembre 1931) parlandosi della Compagnia in generale, il Bellarmino è chiamato «vero compagno di Gesù»: perché «compagno» e non «soldato», come dovrebbe esattamente dirsi? Il nome «Compagnia» è solo la traduzione di «Societas» o non ha il significato militare? La parola latina «Societas» non può avere significato militare (almeno mi pare) ma quale fu l’intenzione di Ignazio di Loyola? (Ricordare la connessione del Bellarmino con il processo di Galileo).
Nell’articolo di commento della «Civiltà Cattolica» alla Lettera apostolica si accenna al fatto che la «causa» (di beatificazione e di santificazione) del Bellarmino era stata arrestata dalle «mene e (dalle) minacce (!) di quegli sconsigliati politici e avversari del Pontificato, amici altri dell’assolutismo regio (“gli integrali”), altri del sovversivismo demagogico (“i modernisti”)»; accenna la «Civiltà Cattolica» a fatti del 700, ma parla poi dei «loro infelici successori e imitatori odierni». (Pare che la beatificazione del Bellarmino nel 700 sia stato uno degli elementi della lotta che portò alla soppressione della Compagnia per imposizione dei Borboni).
I gesuiti oggi vedono nella santificazione e nel «dottorato» una rivincita (sebbene l’ultimo atto papale coincida con la soppressione dei gesuiti in Ispagna), ma sono cauti: «Nessuno certo vuole esagerare oltre misura questo avvenimento, o troppo allargarne l’importanza, il significato, l’opportunità o “attualità” rispetto all’ora presente, e tanto più rispetto all’insolita bufera che doveva essere non solo impreveduta ma imprevedibile, quando fu deliberato prima e discusso poi, ecc., il decreto per la dichiarazione di Dottore».
Q7 §89 Passato e presente. La religione nella scuola. «Ecco perché nei nuovi programmi per le scuole, secondo la riforma gentiliana, l’arte e la religione sono assegnate alla sola scuola elementare, e la filosofia è largamente attribuita alle scuole secondarie. Nell’intenzione filosofica dei programmi elementari, le parole “l’insegnamento della religione è considerato come fondamento e coronamento di tutta l’istruzione primaria” significano appunto che la religione è una categoria necessaria, ma inferiore, attraverso la quale deve passare l’educazione, giacché, secondo la concezione dell’Hegel, la religione è una filosofia mitologica e inferiore, corrispondente alla mentalità infantile ancora incapace di levarsi alla filosofia pura, nella quale poi la religione deve essere risoluta e assorbita. Notiamo subito che, nel fatto, questa teoria idealistica non è riuscita ad inquinare l’insegnamento religioso nella scuola elementare facendovelo trattare come mitologico, sia perché i maestri o non si intendono o non si curano di tali teorie, sia perché l’insegnamento religioso cattolico è intrinsecamente storico e dogmatico, ed è esternamente vigilato e diretto dalla Chiesa nei programmi, testi, insegnamenti. Inoltre, le parole “fondamento e coronamento” sono state accettate dalla Chiesa nel loro significato ovvio e ripetute nel concordato tra la Santa Sede e l’Italia, secondo il quale (art. 36) l’insegnamento religioso è esteso alle scuole medie. Questo estendimento è venuto a contrariare le mire dell’idealismo, il quale pretendeva di escludere la religione dalle scuole medie e lasciarvi dominare solo la filosofia, destinata a superare e assorbire in sé la religione appresa nelle scuole elementari». «Civiltà Cattolica», 7 novembre 1931 (Il buono ed il cattivo nella pedagogia nuova, anonimo, ma del padre Mario Barbera).
Q7 §90 Passato e presente. Stato e partiti. La funzione egemonica o di direzione politica dei partiti può essere valutata dallo svolgersi della vita interna dei partiti stessi. Se lo Stato rappresenta la forza coercitiva e punitiva di regolamentazione giuridica di un paese, i partiti, rappresentando lo spontaneo aderire di una élite a tale regolamentazione, considerata come tipo di convivenza collettiva a cui tutta la massa deve essere educata, devono mostrare nella loro vita particolare interna di aver assimilato come principii di condotta morale quelle regole che nello Stato sono obbligazioni legali. Nei partiti la necessità è già diventata libertà, e da ciò nasce il grandissimo valore politico (cioè di direzione politica) della disciplina interna di un partito, e quindi il valore di criterio di tal disciplina per valutare la forza di espansività dei diversi partiti. Da questo punto di vista i partiti possono essere considerati come scuole della vita statale. Elementi di vita dei partiti: carattere (resistenza agli impulsi delle culture oltrepassate), onore (volontà intrepida nel sostenere il nuovo tipo di cultura e di vita), dignità (coscienza di operare per un fine superiore), ecc.
Q7 §91 Passato e presente. Tendenze nell’organizzazione esterna dei fattori umani produttivi nel dopoguerra. Mi pare che tutto l’insieme di queste tendenze debba far pensare al movimento cattolico economico della Controriforma, che ebbe la sua espressione pratica nello Stato gesuitico del Paraguay. Tutte le tendenze organiche del moderno capitalismo di Stato dovrebbero essere ricondotte a quella esperienza gesuitica. Nel dopoguerra c’è stato un movimento intellettualistico e razionalistico che corrisponde al fiorire delle utopie nella Controriforma: quel movimento è legato al vecchio protezionismo, ma se ne differenzia e lo supera, sboccando in tanti tentativi di economie «organiche» e di Stati organici. Si potrebbe applicare ad essi il giudizio del Croce sullo Stato del Paraguay: che si tratti, cioè, di un modo per un savio sfruttamento capitalistico nelle nuove condizioni che rendono impossibile (almeno in tutta la sua esplicazione ed estensione) la politica economica liberale.
Q7 §92 Risorgimento. L’Italia meridionale. Studiare le origini e le cause della convinzione che esiste nel Mazzini che l’insurrezione nazionale dovesse cominciare o fosse più facile da fare incominciare nell’Italia meridionale (fratelli Bandiera, Pisacane). Pare che tale convincimento fosse pure nel Pisacane che pure, come scrive Mazzini (Opere, vol. LVIII, Epist., XXXIV, 1931) aveva un «concetto strategico della Guerra d’Insurrezione». Si trattò di un desiderio (contrapporre l’iniziativa popolare meridionale a quella monarchica piemontese?) diventato convinzione o aveva delle origini razionali e positive? E quali potevano essere?
Riallacciare questa convinzione a quella di Bakònin e dei primi internazionalisti, già prima del 70: ma in Bakònin rispondeva a una concezione politica dell’efficienza sovvertitrice di certe classi sociali. Questo concetto strategico della guerra d’insurrezione nazionale del Pisacane dove occorre ricercarlo? Nei suoi saggi politico‑militari, in tutti gli scritti che ci rimangono di lui e in più: negli scritti di Mazzini (in tutti gli scritti, ma specialmente nell’Epistolario; si potrebbe scrivere un saggio su Pisacane e Mazzini) e nei vari atteggiamenti pratici del Pisacane. Uno dei momenti più importanti mi pare debba essere l’avversione di Pisacane a Garibaldi durante la Repubblica Romana. Perché tale avversione? Era Pisacane avverso in linea di principio alla dittatura militare? Oppure l’avversione era di carattere politico‑ideologico, cioè era contro il fatto che tale dittatura sarebbe stata meramente militare, con un vago contenuto nazionale, mentre Pisacane voleva alla guerra d’insurrezione dare oltre al contenuto nazionale anzi e specialmente un contenuto sociale? In ogni caso l’opposizione di Pisacane fu un errore nel caso specifico, perché non si trattava di una dittatura vaga e indeterminata ma di una dittatura in regime di Repubblica già instaurata, con un governo mazziniano in funzione (sarebbe stato un governo di salute pubblica, di carattere più strettamente militare, ma forse appunto i pregiudizi ideologici di avversione alle esperienze della Rivoluzione francese ebbero gran parte nel determinare tale avversione).
Q7 §93 Nomenclatura politica. Privilegi e prerogative. Fissare i significati storici dei due termini. Mi pare che se in uno Stato moderno sarebbe assurdo parlare di privilegi a determinati gruppi sociali, non altrettanto assurdo è invece parlare di prerogative. D’altronde di prerogative non si può parlare che con riferimento ai corpi costituiti e con riferimento alle funzioni politiche, non come benefici nella vita economica: la prerogativa non può non essere «strettamente» legata alla funzione sociale e all’esplicazione di determinati doveri. Perciò è da vedere se i «privilegi» non sono che «prerogative» degenerate, cioè involucri senza contenuto sociale e funzionale, benefici mantenuti parassitariamente anche quando la funzione da cui erano giustificati era morta o si era spostata a un nuovo gruppo sociale che quindi aveva il gravame funzionale senza aver tutti i mezzi giuridico‑politici per esplicarlo regolarmente. È da mettere in rilievo che i concetti di privilegio e di prerogativa erano concetti giuridici originariamente, anzi sono stati il contenuto di tutta una epoca della storia degli Stati: essi sono diventati concetti morali reprobativi solo quando appunto non hanno corrisposto più a servizi sociali e statali necessari. «Prerogative della Corona» è la frase più comune in cui ricorre oggi il termine di «prerogativa». Se la teoria costituzionale che la funzione della Corona di impersonare la sovranità sia nel senso statale che in quello della direzione politico‑culturale (cioè di essere arbitra nelle lotte interne dei ceti dominanti, la classe egemone e i suoi alleati) sta passando ai grandi partiti di tipo «totalitario» è esatta, è evidente che a tali partiti passano le prerogative corrispondenti. Perciò è da studiare la funzione del Gran Consiglio, che tende a diventare un «Consiglio di Stato» nel vecchio senso (cioè con le vecchie attribuzioni), ma con funzioni ben più radicali e decisive.
Q7 §94 Laburismo inglese. L’arcivescovo di Canterbury, primate della Chiesa anglicana e il laburismo. Durante le elezioni inglesi del 1931 il candidato laburista W. T. Collyer affermò in una riunione che l’arcivescovo di Canterbury era uno dei sottoscrittori per il fondo del Labour Party. Fu domandato all’arcivescovo se l’affermazione era esatta e il suo segretario rispose: «L’Arcivescovo mi incarica di dire che egli è stato membro sottoscrittore del Labour Party dal 1919 al 1925 o 26, quando egli trovò che un crescente disagio col movimento e con lo spirito e l’umore del partito rendeva impossibile la continuazione di una tale affiliazione (membership)». (Cfr il «Manchester Guardian Weekly» del 30 ottobre 1931, p. 357).
Q7 §95 Nomenclatura politica. Reich, ecc. Cercare l’origine storica e ideologica esatta di questo termine che viene malamente tradotto con «impero». Così il «Commonwealth» delle nazioni britanniche non può essere tradotto con «repubblica» sebbene significhi anche «repubblica».
Q7 §96 Nomenclatura politica. Artigianato, piccola, media, grande industria. Concetti quantitativi e concetti qualitativi. Dal punto di vista quantitativo si parte dal numero dei lavoratori impiegati nelle singole aziende, stabilendo delle cifre medie per ogni tipo: da 1 a 5 artigianato, da 5 a 50 piccola industria, da 50 a 100 media industria, da 100 in su grande industria; si tratta di tipi o generalizzazioni molto relative e che possono mutare da paese a paese. Il concetto qualitativo sarebbe più scientifico ed esatto, ma è molto più complesso e presenta molte difficoltà. Qualitativamente i tipi dovrebbero essere fissati dalla combinazione di elementi svariati: oltre che dal numero degli operai, dal tipo delle macchine e dall’ingranamento tra macchina e macchina, dal grado di divisione del lavoro, dal rapporto tra diversi tipi di lavoratori (manovali, manovali specializzati o addetti macchina, operai qualificati, specializzati) e del grado di razionalizzazione (oltre che di industrializzazione) dell’insieme dell’apparato produttivo e amministrativo. Un’azienda razionalizzata ha meno lavoratori di un’azienda non razionalizzata, e quindi con 50 lavoratori può essere più «grande industria» di una con 200 lavoratori (ciò avviene quando certe aziende per certe parti della loro produzione si servono di un’azienda esterna che è come il reparto specializzato di tutto un gruppo di aziende non collegate organicamente, ecc.). Questi elementi singoli hanno diverso peso relativo a seconda della branca industriale: nell’industria edile il macchinismo non si svilupperà mai come nell’industria meccanica. Il tipo di macchina tessile si sviluppa in modo diverso da quello dell’industria meccanica, ecc.
A questo concetto di grandezza dell’industria è legato il concetto di «macchina». È anche legata la nozione di «fabbrica disseminata», che è un aspetto dell’artigianato, del lavoro a domicilio e della piccola industria. Ma anche una grande impresa edilizia non può, in un certo senso, considerarsi come una fabbrica disseminata? E quella tranviaria e ferroviaria? (Dal punto di vista dell’organizzazione territoriale ossia della concentrazione tecnica, queste imprese sono disseminate e ciò ha un’importanza per la psicologia dei lavoratori. Un casellante ferroviario non avrà mai la stessa psicologia del manovale di una grande fabbrica, ecc.).
Altro elemento importante è la forza motrice adoperata: un artigiano che si serve dell’energia elettrica è più un artigiano nel senso tradizionale? Il fatto moderno della facilità di distribuzione della forza motrice elettrica anche per piccole unità trasforma e rinnova tutti i tipi d’industria e di azienda.
Q7 §97 Nomenclatura politica. Ierocrazia‑teocrazia. «Un governo nel quale hanno partecipazione e ingerenza legale il clero, il papa o altre autorità ecclesiastiche» sarebbe più propriamente ierocratico; ma può anche esserci un governo «che opera per impulsi religiosi e subordina leggi, rapporti di vita civile, costumi e dettami religiosi» senza essere composto di ecclesiastici, ed è teocratico. In realtà elementi di teocrazia sussistono in tutti gli stati dove non esista netta e radicale separazione tra chiesa e Stato, ma il clero eserciti funzioni pubbliche di qualsiasi genere e l’insegnamento della religione sia obbligatorio o esistano concordati. (Rovesciamento della massima di Machiavelli: «regnum instrumentum religionis»).
Q7 §98 Azione cattolica. Cfr in altro quaderno l’annotazione di due studi pubblicati nella «Civiltà Cattolica» dell’agosto 1930 su Cesare D’Azeglio e gli albori della stampa cattolica in Italia e La fortuna del La Mennais e le prime manifestazioni di Azione Cattolica in Italia. Questi studi si riferiscono specialmente alla fioritura di periodici cattolici in varie città italiane durante la Restaurazione, che tendevano a combattere le idee dell’Enciclopedia e della Rivoluzione Francese che tuttavia perduravano, ecc. In questo movimento intellettuale‑politico si riassume l’inizio del neoguelfismo italiano, che non può quindi staccarsi dalla Società dei Sanfedisti (pars magna di queste riviste fu il principe di Canosa, che abitava a Modena, dove era pubblicata una delle più importanti riviste del gruppo). Nel cattolicismo italiano erano due tendenze principali: 1) quella nettamente austriacante, che vedeva la salvezza del Papato e della religione nel gendarme imperiale a guardia dello statu quo politico italiano; 2) quella Sanfedista in senso stretto che sosteneva la supremazia politico‑religiosa del Papa prima di tutto in Italia e quindi era avversaria subdola dell’egemonia austriaca in Italia e favorevole a un certo movimento di indipendenza nazionale (se in questo caso si può parlare di nazionale). È a questo movimento che si riferisce la «Civiltà Cattolica» quando polemizza coi liberali del Risorgimento e sostiene il «patriottismo e unitarismo» dei cattolici d’allora: ma quale fu l’atteggiamento dei gesuiti? Pare che essi fossero piuttosto austriacanti che sanfedisti «indipendentisti».
Si può dire perciò che questo periodo preparatorio dell’Azione Cattolica abbia avuto la sua massima espressione nel neoguelfismo, cioè in un movimento di totalitario ritorno alla posizione politica della Chiesa nel Medio Evo, alla supremazia papale, ecc. La catastrofe del neoguelfismo nel 48 riduce l’Azione Cattolica a quella che sarà ormai la sua funzione nel mondo moderno: funzione difensiva essenzialmente, nonostante le profezie apocalittiche dei cattolici sulla catastrofe del liberalismo e sul ritorno trionfale del dominio della Chiesa sulle macerie dello Stato liberale e del suo antagonista storico, il socialismo (quindi astensionismo clericale e creazione dell’esercito di riserva cattolico). In questo periodo della restaurazione il cattolicismo militante si atteggia diversamente secondo gli Stati: la posizione più interessante è quella dei sanfedisti piemontesi (De Maistre, ecc.) che sostengono l’egemonia piemontese e la funzione italiana della monarchia e della dinastia dei Savoia.
Q7 §99 Nomenclatura politica. Fazione. Il termine serve oggi a indicare generalmente una certa degenerazione dello spirito di partito, una certa unilateralità estremista fanatica, esclusiva, aliena da compromessi anche, anzi specialmente, su quistioni secondarie e subordinate; il punto di vista di tale giudizio è lo spirito nazionale, cioè un certo modo di concepire la direzione politica di un paese. «Fazione» e «fazioso» sono adoperati dai partiti di destra contro i loro avversari, i quali hanno risposto col termine di «consorteria», di «spirito di consorteria», ecc., per indicare la tendenza di certi aggruppamenti politici governativi a identificare i loro interessi particolari con quelli dello Stato e della Nazione, e a difenderli con altrettanto fanatismo ed esclusivismo.
La parola «fazione» che è d’origine militare (probabilmente) è diventata comune in Italia per indicare i partiti che si combattevano nei Comuni medioevali, ecc., ed è implicito nell’uso il concetto che tali lotte impedirono l’unificazione nazionale prima del Risorgimento, cioè tutta una concezione antistorica dello sviluppo nazionale italiano. «Fazione» indica il carattere delle lotte politiche medioevali, esclusiviste, tendenti a distruggere fisicamente l’avversario, non a creare un equilibrio di partiti in un tutto organico con l’egemonia del partito più forte, ecc. «Partito» è parte di un tutto; «fazione», forza armata che segue le leggi militari esclusiviste, ecc.
Q7 §100 Passato e presente. Ricordare la pubblicazione di B. Croce sui rapporti tra Maria Sofia e Malatesta (e la precedente pubblicazione nell’«Unità» di Firenze del 14 o del 15). In un articolo di Alberto Consiglio: Giro per l’Aspromonte, nel «Corriere della Sera» del 24 dicembre 1931, è detto: «L’impresa di Fabrizio Ruffo, che aveva radunato questi montanari e li aveva condotti a “mangiare il cuore” dei giacobini napoletani, aveva creato nel Reame una fama di lealismo borbonico che i calabresi dividevano equamente coi pescatori di Santa Lucia e coi lazzaroni dei borghi napoletani. Questo mito (!) produsse e alimentò molta parte del banditismo politico del primo decennio unitario, ed era ancor vivo, al principio del secolo, tra gli ultimi e sparuti borbonici. Infatti dicono che da Parigi, ove era in esilio, la Regina Maria Sofia inviò a Musolino un po’ di danaro perché il bandito tenesse desta nella Calabria la ribellione». (Un giornaletto borbonizzante uscì a Napoli fino al 1907 o 1908: Eugenio Guarino pubblicò nel «Viandante» di Monicelli un articolo per la sua scomparsa).
Q7 §101 Giornalismo. Corrispondenti dall’estero. Cfr altra nota in proposito nella rubrica Riviste‑tipo. In essa si accennava ai collaboratori stranieri di riviste italiane. Il tipo del «corrispondente dall’estero» di un quotidiano è qualcosa di diverso, tuttavia alcune osservazioni dell’altra nota sono valide anche per questa attività. Intanto non bisogna concepire il corrispondente dall’estero come un puro reporter o trasmettitore di notizie del giorno per telegramma o per telefono, cioè una integrazione delle agenzie telegrafiche. Il tipo moderno più compiuto di corrispondente dall’estero è il pubblicista di partito, il critico politico che osserva e commenta le correnti politiche più vitali di un paese straniero e tende a diventare uno «specialista» sulle quistioni di quel dato paese (i grandi giornali perciò hanno «uffici di corrispondenza» nei diversi paesi, e il capo ufficio è lo «scrittore politico», il direttore dell’ufficio). Il corrispondente dovrebbe mettersi in grado di scrivere, entro un tempo determinato, un libro sul paese dove è mandato per risiedervi permanentemente, un’opera completa su tutti gli aspetti vitali della sua vita nazionale ed internazionale. (Altro è il corrispondente viaggiante che va in un paese per informare su grandi avvenimenti immediati che vi si svolgono).
Criteri per la preparazione e la formazione di un corrispondente: 1) Giudicare gli avvenimenti nel quadro storico del paese stesso e non solo con riferimento al suo paese d’origine. Ciò significa che la posizione di un paese deve essere misurata dai progressi o regressi verificatisi in quel paese stesso e non può essere meccanicamente paragonata alla posizione di altri paesi nello stesso momento. Il paragone tra Stato e Stato ha importanza, perché misura la posizione relativa di ognuno di essi: infatti un paese può progredire, ma se in altri il progresso è stato maggiore o minore, la posizione relativa muta, e muta la influenza internazionale del paese dato. Se giudichiamo l’Inghilterra da ciò che essa era prima della guerra, e non da ciò che essa è oggi in confronto della Germania, il giudizio muta, sebbene anche il giudizio di paragone abbia grande importanza. 2) I partiti in ogni paese hanno un carattere nazionale, oltre che internazionale: il liberalismo inglese non è uguale a quello francese o a quello tedesco, sebbene ci sia molto di comune ecc. 3) Le giovani generazioni sono in lotta con le vecchie nella misura normale in cui i giovani sono in lotta coi vecchi, oppure i vecchi hanno un monopolio culturale divenuto artificiale o dannoso? I partiti rispondono ai problemi nuovi o sono superati e c’è crisi? ecc.
Ma l’errore più grande e più comune è quello di non saper uscire dal proprio guscio culturale e misurare l’estero con un metro che non gli è proprio: non vedere la differenza sotto le apparenze uguali e non vedere l’identità sotto le diverse apparenze.
Q7 §102 Passato e presente. Chiarezza del mandato e mandato imperativo. Nelle elezioni italiane nessuna chiarezza nel mandato, perché non esistevano partiti definiti intorno a programmi definiti. Il governo era sempre di coalizione, e di coalizione sul terreno strettamente parlamentare, quindi spesso tra partiti lontani uno dall’altro: conservatori con radicali, mentre i liberali democratici erano fuori del governo, ecc. Le elezioni erano fatte su quistioni molto generiche, perché i deputati rappresentavano posizioni personali e locali, non posizioni di partiti nazionali. Ogni elezione sembrava essere quella per una costituente, e nello stesso tempo sembrava essere quella per un club di cacciatori. Lo strano è che tutto ciò pareva essere il massimo della democrazia.
Q7 §103 Nozioni enciclopediche. Opinione pubblica. Tra gli elementi che recentemente hanno turbato il normale governo dell’opinione pubblica da parte dei partiti organizzati e definiti intorno a programmi definiti sono da porre in prima linea la stampa gialla e la radio (dove è molto diffusa). Essi danno la possibilità di suscitare estemporaneamente scoppi di panico o di entusiasmo fittizio che permettono il raggiungimento di scopi determinati nelle elezioni, per esempio. Tutto ciò è legato al carattere della sovranità popolare, che viene esercitata una volta ogni 3‑4‑5 anni: basta avere il predominio ideologico (o meglio emotivo) in quel giorno determinato per avere una maggioranza che dominerà per 3‑4‑5 anni, anche se, passata l’emozione, la massa elettorale si stacca dalla sua espressione legale (paese legale non eguale a paese reale). Organismi che possono impedire o limitare questo boom dell’opinione pubblica più che i partiti sono i sindacati professionali liberi e da ciò nasce la lotta contro i sindacati liberi e la tendenza a sottoporli a controllo statale: tuttavia la parte inorganizzabile dell’opinione pubblica (specialmente le donne, dove esiste il voto alle donne) è talmente grande da rendere sempre possibili i booms e i colpi di mano elettorali dove la stampa gialla è molto diffusa e molto diffusa la radio (in monopolio controllato dal governo). Uno dei problemi di tecnica politica che si presentano oggi, ma che le democrazie non riescono a trovare il modo di risolvere è appunto questo: di creare organismi intermedi tra le grandi masse, inorganizzabili professionalmente (o difficilmente organizzabili), i sindacati professionali, i partiti e le assemblee legislative. I consigli comunali e provinciali hanno avuto nel passato una funzione approssimativamente vicina a questa, ma attualmente essi hanno perduto di importanza. Gli Stati moderni tendono al massimo di accentramento, mentre si sviluppano, per reazione, le tendenze federative e localistiche, sì che lo Stato oscilla tra il dispotismo centrale e la completa disgregazione (fino alla Confederazione dei tre oppressi).
Q7 §104 Storia degli intellettuali. Lotta tra Stato e Chiesa. Diverso carattere che ha avuto questa lotta nei diversi periodi storici. Nella fase moderna, essa è lotta per l’egemonia nell’educazione popolare; almeno questo è il tratto più caratteristico, cui tutti gli altri sono subordinati. Quindi è lotta tra due categorie di intellettuali, lotta per subordinare il clero, come tipica categoria di intellettuali, alle direttive dello Stato, cioè della classe dominante (libertà dell’insegnamento ‑ organizzazioni giovanili ‑ organizzazioni femminili ‑ organizzazioni professionali).
Q7 §105 I nipotini di padre Bresciani. Ardengo Soffici. Filiazione del Lemmonio Boreo dal Jean‑Christophe di Romain Rolland. Perché il Lemmonio Boreo fu interrotto? Il piglio donchisciottesco del Lemmonio Boreo è esteriore e fattizio: in realtà esso manca di sostanza epico‑lirica: è una coroncina di fatterelli, non un organismo.
Potrebbe aversi in Italia un libro come il Jean‑Christophe? Jean‑Christophe, a pensarci bene, conclude tutto un periodo della letteratura popolare francese (dai Miserabili a Jean‑Christophe); il suo contenuto supera quello del periodo precedente: dalla democrazia al sindacalismo. Jean‑Christophe è il tentativo di un romanzo «sindacalista» ma fallito: il Rolland era tutt’altro che un antidemocratico, quantunque risentisse fortemente gli influssi morali e intellettuali della temperie sindacalista.
Dal punto di vista nazionale‑popolare quale era l’atteggiamento del Soffici? Una esteriorità donchisciottesca senza elementi ricostruttivi, una critica superficiale ed estetistica.
Q7 §106 Nozioni enciclopediche. Bibliografia. A London Bibliography of the Social Science. Comp. under the direction of B. M. Headicar and C. Fuller, with an introd. by S. Webb. È uscito il III volume, dalla P alla Z, in 8° gr., pp. XI‑1232. Sarà in 4 voll., Londra, School of Economics and Political Science.
Q7 §107 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. In altra nota è citato il periodico «Fede e Ragione», come di carattere «integralista» (la «Civiltà Cattolica» lo cita appunto in una sua polemica cogli integralisti). «Fede e Ragione» è un settimanale cattolico che esce a Fiesole da circa 14 anni. È diretto dal sacerdote Paolo De Toth (almeno era diretto dal De Toth nel 1925) e l’abbonamento costava nel 1925 15 lire, ciò che significa che deve trattarsi di una semi-rivista.
Q7 §108 Risorgimento. Iniziative popolari. Cfr nella rivista «Irpinia» (di Avellino) del luglio 1931 (è riassunta nel «Marzocco» del 26 luglio 1931) la lettura di Nicola Valdimiro Testa sugli avvenimenti svoltisi nella provincia di Avellino negli anni 1848‑49. La narrazione pare molto interessante per intendere quali fossero i sentimenti popolari e quali correnti di passioni attraversassero le grandi masse, che però non avevano un indirizzo e un programma e si esaurivano in tumulti e atti brutali di violenza disordinata. Partecipazione di alcuni elementi del clero a queste passioni di massa, che spiegano l’atteggiamento di alcuni preti verso le così dette «bande di Benevento». Si verifica la solita confusione tra «comunismo» e «riforma agraria» che il Testa (da ciò che appare nel riassunto del «Marzocco») non sa criticamente presentare (come del resto non sanno fare la maggior parte dei ricercatori di archivio e degli storici). Sarebbe interessante raccogliere la bibliografia di tutte le pubblicazioni come queste per gli anni del Risorgimento.
QUADERNO 8
APPUNTI PER UNA STORIA DEGLI INTELLETTUALI ITALIANI
1° Carattere provvisorio – di pro‑memoria – di tali e appunti; 2° Da essi potranno risultare dei saggi indipendenti, non un lavoro organico d’insieme; 3° Non può esserci ancora una distinzione tra la parte principale e quelle secondarie dell’esposizione, tra ciò che sarebbe il «testo» e ciò che dovrebbero essere le «»; 4° Si tratta spesso di affermazioni non controllate, che potrebbero dirsi di «prima approssimazione»: qualcuna di esse nelle ulteriori ricerche potrebbe essere abbandonata e magari l’affermazione opposta potrebbe dimostrarsi quella esatta; 5° Non deve fare una cattiva impressione la vastità e l’incertezza di limiti del tema, per le cose sopra dette: non ha affatto l’intenzione di compilare uno zibaldone farraginoso sugli intellettuali, una compilazione enciclopedica che voglia colmar tutte le «lacune» possibili e immaginabili.
Saggi principali: Introduzione generale. Sviluppo degli intellettuali italiani fino al 1870: diversi periodi. – La letteratura popolare dei romanzi d’appendice. – Folclore e senso comune. – La quistione della lingua letteraria e dei dialetti. – I nipotini di padre Bresciani. – Riforma e Rinascimento. – Machiavelli. – La scuola e l’educazione nazionale. – La posizione di B. Croce nella cultura italiana fino alla guerra mondiale. – Il Risorgimento e il partito d’azione. – Ugo Foscolo nella formazione della retorica nazionale. – Il teatro italiano. – Storia dell’Azione Cattolica: Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. – Il Comune medioevale, fase economico‑corporativa dello Stato. – Funzione cosmopolitica degli intellettuali italiani fino al secolo XVIII. – Reazioni all’assenza di un carattere popolare‑nazionale della cultura in Italia: i futuristi. – La scuola unica e cosa essa significa per tutta l’organizzazione della cultura nazionale. – Il «lorianismo» come uno dei caratteri degli intellettuali italiani. – L’assenza di «giacobinismo» nel Risorgimento italiano. – Machiavelli come tecnico della politica e come politico integrale o in atto.
Appendici: Americanismo e fordismo.
Raggruppamenti di materia:
1° Intellettuali. Quistioni scolastiche.
2° Machiavelli.
3° Nozioni enciclopediche e argomenti di cultura.
4° Introduzione allo studio della filosofia e critiche ad un Saggio popolare di sociologia.
5° Storia dell’Azione Cattolica. Cattolici integrali – gesuiti – modernisti.
6° Miscellanea di varie di erudizione (Passato e presente).
7° Risorgimento italiano (nel senso dell’Età del Risorgimento italiano dell’Omodeo, ma insistendo sui motivi più strettamente italiani).
8° I nipotini di padre Bresciani. La letteratura popolare ( di letteratura).
9° Lorianesimo.
10° Appunti sul giornalismo (Nel ms il resto della pagina 2 e la successiva pagina 2 bis non sono state utilizzate.) .
Q8 §1 Risorgimento. Da un articolo di Gioacchino Volpe Una scuola per la storia dell’Italia moderna (nel «Corriere della Sera» del 9 gennaio 1932, articolo importante): «Tutti lo sanno: per capire il “Risorgimento” non basta spingersi al 1815 e neppure al 1796, l’anno in cui Napoleone irruppe nella Penisola e vi suscitò la tempesta. Il “Risorgimento”, come ripresa di vita italiana, come formazione di una nuova borghesia, come consapevolezza crescente di problemi non solo municipali e regionali ma nazionali, come sensibilità a certe esigenze ideali, bisogna cercarlo parecchio prima della Rivoluzione: è anche esso sintomo, uno dei sintomi, di una rivoluzione in marcia, non solo francese, ma, in certo senso, mondiale. Tutti egualmente sanno che la storia del Risorgimento non si studia solo coi documenti italiani e come fatto solamente italiano, ma nel quadro della vita europea; trattisi di correnti di coltura, di trasformazioni economiche, di situazioni internazionali nuove, che sollecitano gli italiani a nuovi pensieri, a nuove attività, a nuovo assetto politico».
Q8 §2 Lo Stato e la concezione del diritto. La rivoluzione portata dalla classe borghese nella concezione del diritto e quindi nella funzione dello Stato consiste specialmente nella volontà di conformismo (quindi eticità del diritto e dello Stato). Le classi dominanti precedenti erano essenzialmente conservatrici nel senso che non tendevano ad elaborare un passaggio organico dalle altre classi alla loro, ad allargare cioè la loro sfera di classe «tecnicamente» e ideologicamente: la concezione di casta chiusa. La classe borghese pone se stessa come un organismo in continuo movimento, capace di assorbire tutta la società, assimilandola al suo livello culturale ed economico: tutta la funzione dello Stato è trasformata: lo Stato diventa «educatore», ecc. Come avvenga un arresto e si ritorni alla concezione dello Stato come pura forza ecc. La classe borghese è «saturata»: non solo non si diffonde, ma si disgrega; non solo non assimila nuovi elementi, ma disassimila una parte di se stessa (o almeno le disassimilazioni sono enormemente più numerose delle assimilazioni). Una classe che ponga se stessa come passibile di assimilare tutta la società, e sia nello stesso tempo realmente capace di esprimere questo processo, porta alla perfezione questa concezione dello Stato e del diritto, tanto da concepire la fine dello Stato e del diritto come diventati inutili per aver esaurito il loro compito ed essere stati assorbiti dalla società civile.
Q8 §3 Formazione e diffusione della nuova borghesia in Italia. In altra nota ho segnato che si potrebbe fare una ricerca «molecolare» negli scritti italiani del Medio Evo per cogliere il processo di formazione intellettuale della borghesia, il cui sviluppo storico culminerà nei Comuni per subire poi una disgregazione e un dissolvimento. La stessa ricerca si potrebbe fare nel periodo 1750‑1850, quando si ha la nuova formazione borghese che culmina nel Risorgimento. Anche qui il modello del Groethuysen (Origines de l’esprit bourgeois en France: 1° L’Eglise et la Bourgeoisie) potrebbe servire, integrato, naturalmente, di quei motivi che sono peculiari della storia sociale italiana. Le concezioni del mondo, dello Stato, della vita contro cui deve combattere lo spirito borghese in Italia non sono simili a quelle che esistevano in Francia.
Foscolo e Manzoni in un certo senso possono dare i tipi italiani. Il Foscolo è l’esaltatore delle glorie letterarie e artistiche del passato (cfr i Sepolcri, i Discorsi civili, ecc.), la sua concezione è essenzialmente «retorica» (sebbene occorra osservare che nel tempo suo questa retorica avesse un’efficienza pratica attuale e quindi fosse «realistica»).
Nel Manzoni troviamo spunti nuovi, più strettamente borghesi (tecnicamente borghesi). Il Manzoni esalta il commercio e deprime la poesia (la retorica). Lettere al Fauriel. Nelle Opere inedite ci sono dei brani in cui il Manzoni biasima l’unilateralità dei poeti che disprezzano la «sete dell’oro» dei commercianti, disconoscono l’audacia dei navigatori mentre parlano di sé come di esseri sovrumani. In una lettera al Fauriel scrive: «pensi di che sarebbe più impacciato il mondo, del trovarsi senza banchieri o senza poeti, quale di queste due professioni serva più, non dico al comodo, ma alla coltura dell’umanità». (Cfr Carlo Franelli, Il Manzoni e l’idea dello scrittore, nella «Critica Fascista» del 15 dicembre 1931). Il Franelli osserva: «I lavori di storia e di economia politica li mette più in alto che una letteratura piuttosto (?!) leggera. Sulla qualità della coltura italiana d’allora ha dichiarazioni molto esplicite nelle lettere all’amico Fauriel. Quanto ai poeti, la loro tradizionale megalomania lo offende, Osserva che oggidì perdono tutto quel gran credito che godettero in passato. Ripetutamente ricorda che alla poesia ha voluto bene in “gioventù”».
Q8 §4 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. In Ungheria. Il «Marzocco» del 4 ottobre 1931 riassume dall’«Illustrazione Toscana» un articolo del dott. Ladislao Holik‑Barabàs su Filippo Scolari detto Pippo Spano che fu «una delle figure più caratteristiche fra gli italiani che hanno portato lungi dalla patria straordinarie energie conquistando gradi eminenti nei paesi d’elezione». Lo Scolari fu successivamente intendente delle miniere, poi liberatore del sovrano, re Sigismondo d’Ungheria, conte di Temesvar, governatore generale dell’Ungheria e condottiero degli Ungheresi contro i Turchi. Pippo Spano morì il 27 dicembre 1426.
Q8 §5 Risorgimento. Il Partito d'Azione. Per la storia del Partito d’Azione e del «trasformismo» italiano in generale è molto interessante una lettera di Francesco De Sanctis a Giuseppe Civinini pubblicata nel «Bullettino Storico Pistoiese» da Filippo Civinini e riassunta nel «Marzocco» del 4 ottobre 1931. La lettera è senza data ma pare debba essere stata scritta tra il secondo semestre del 1866 e i primi del 1868. Scrive il De Sanctis, tra l’altro: «La trasformazione dei partiti, la costituzione di un partito progressista di contro a un partito conservatore, è una mia vecchia idea per la quale combatto da tre anni e che è la bandiera del mio giornale». «Per me partito moderato e partito d’azione avevano cessato di esistere fin dalla catastrofe di Aspromonte. L’antica Sinistra morì il giorno che Mordini e Crispi non vollero dimettersi, come molti dei loro compagni, per le cose di Sicilia. Da quel tempo la Sinistra entrava in una via di trasformazione e diventò un’opposizione costituzionale progressista. Il programma del Mordini e l’altro di Crispi, al tempo delle elezioni generali, confermarono questo indirizzo. E fu questo il partito che uscì molto rinforzato dalle urne e a cui si accostarono in grandissimo numero degli uomini nuovi venuti in Parlamento a costituire la consorteria. Ne’ programmi di quel tempo non più traccia di odio napoleonico, di agitazioni di piazza, di insurrezioni, senza e contro il governo, di velleità repubblicane» ecc. La datazione mi pare errata, perché il De Sanctis scrive di sedere nella Sinistra, «nella nuova Sinistra», e mi pare che il passaggio del De Sanctis alla Sinistra sia avvenuto più tardi.
Q8 §6 Giacobinismo. Per avere una indicazione del modo di considerare i francesi nel periodo giacobino e napoleonico si può citare dal libro di Alessandro Andryane (Memorie di un prigioniero di Stato, passi scelti da Rosolino Guastalla, Barbèra, Firenze, p. 214): il cancelliere Schiller, quando l’Andryane riesce a farsi togliere i ferri dai piedi per una storta, dice: «diavoli di francesi! C’era ben ragione di chiamarli signori tutto‑si‑può‑quando‑si‑vuole». Questa fama di «volitivi» ossia di volontaristi dei francesi nel periodo della grande rivoluzione, presso gli altri popoli ha un certo significato storico.
Q8 §7 Giornalismo. Ecco come negli «Annali dell’Italia Cattolica» per il 1926 si descrivono i diversi tipi di giornale, con riferimento alla stampa cattolica: «In senso largo il giornale “cattolico” (o piuttosto “scritto da cattolici”) è quello che non contiene nulla contro la dottrina e morale cattolica, e ne segue e difende le norme. Dentro tali linee il giornale può perseguire intenti politici, economico‑sociali, o scientifici. – Invece il giornale “cattolico” in senso stretto è quello che, d’intesa con l’Autorità Ecclesiastica, ha come scopo diretto un efficace apostolato sociale cristiano, a servizio della Chiesa e in aiuto dell’Azione cattolica. Esso importa, almeno implicitamente, la responsabilità dell’Autorità Ecclesiastica, e però ne deve seguire le norme e direttive». Si distingue, insomma, il giornale così detto d’informazione o «senza partito» dal giornale d’opinione, dall’organo ufficiale di un determinato partito, il giornale per le masse popolari o giornale «popolare», dal giornale per un pubblico necessariamente ristretto.
Nella storia della tecnica giornalistica può essere ritenuto «esemplare» il «Piccolo» di Trieste, come appare dal libro dedicato al «Piccolo» da Silvio Benco. Un tipo molto interessante è stato anche il «Corriere della Sera» nel periodo giolittiano, molto interessante se si tiene conto della situazione giornalistica e politica italiana, totalmente diversa da quella francese e in generale da quella degli altri paesi europei. La divisione netta, esistente in Francia, tra giornali popolari e giornali di opinione, non può esistere in Italia, dove manca un centro così popolato e così predominante come Parigi (e dove esiste minore «indispensabilità» del giornale politico anche nelle classi superiori). Sarebbe interessante vedere nella storia del giornalismo italiano, le ragioni tecnico‑politico‑culturali della fortuna avuta dal vecchio «Secolo» di Milano.
Mi pare che nella storia del giornalismo italiano si possano distinguere due periodi: 1°) quello «primitivo» dell’indistinto generico politico culturale che rese possibile la grande diffusione del «Secolo» intorno al programma generico‑indistinto di un vago «laicismo» (contro l’influenza cattolica) e di un vago «democraticismo» (contro l’influsso preponderante nella vita statale delle forze di destra); 2°) quello successivo in cui le forze di destra si «nazionalizzano», si «popolarizzano» e il «Corriere della Sera» sostituisce il «Secolo» nella grande diffusione: il vago laicismo‑democraticismo del «Secolo» diventa nel «Corriere» un vago unitarismo nazionale che comprende una forma di laicismo meno plebeo e sbracato e così un nazionalismo meno popolaresco e democratizzante. È interessante notare che nessuno dei partiti distintisi dall’informe popolarismo «secolino» abbia tentato di ricreare l’unità democratica su un piano politico‑culturale più elevato di quello del periodo primitivo, ma questo compito sia stato abbandonato quasi senza lotta ai conservatori espressi dal «Corriere». Eppure questo dovrebbe essere il compito dopo ogni progresso di chiarificazione e distinzione: ricreare l’unità, rottasi nel processo di avanzata, su un piano superiore, rappresentato dalla élite che dall’indistinto generico è riuscita a conquistare la sua personalità, che esercita una funzione direttiva sul vecchio complesso da cui si è distinta e staccata.
Lo stesso processo si ripete nel mondo cattolico con la formazione del Partito popolare, «distinzione» democratica che i destri riescono a subordinare ai propri programmi. Nell’un caso e nell’altro i piccoli borghesi pure essendo il maggior numero tra gli intellettuali dirigenti, sono sopraffatti dagli elementi della classe fondamentale: nel campo laico gli industriali del «Corriere», nel campo cattolico la borghesia agraria unita ai grandi proprietari sopraffanno i professionisti della politica del «Secolo» e del Partito Popolare che pure rappresentano le grandi masse dei due campi: semiproletari e piccoli borghesi della campagna e della città.
Q8 §8 Azione Cattolica. Pubblicazioni periodiche cattoliche. (Cifre ricavate dagli «Annali dell’Italia Cattolica» per il 1926 e che si riferiscono alla situazione esistente fino al settembre 1925). I cattolici pubblicavano 627 periodici, così classificati dagli «Annali»: 1°) Quotidiani 18, di cui 13 nell’Italia Settentrionale, 3 nella Centrale, 1 a Napoli, 1 in Sardegna; 2°) Periodici di formazione e propaganda cattolica 121, di cui 83 nel Settentrione, 22 nel Centro, 12 nel Mezzogiorno, 1 in Sardegna, 4 in Sicilia; 3°) Bollettini ufficiali di Azione Cattolica (Giunta Centrale e Organizzazioni Nazionali) 17, di cui 1 a Bologna, 5 a Milano, 11 a Roma; 4°) Pubblicazioni di Azione Cattolica nelle Diocesi 71, di cui 46 nel Settentrione, 15 nel Centro, 5 nel Mezzogiorno, 1 in Sardegna, 3 in Sicilia; 5°) Periodici ufficiali di opere e organizzazioni diverse 42, di cui 26 nel Settentrione, 15 nel Centro (tutti a Roma), 1 nel Mezzogiorno; 6°) Bollettini diocesani 134 di cui 44 nel Settentrione, 33 nel Centro, 43 nel Mezzogiorno, 2 in Sardegna, 9 in Sicilia; 7°) Periodici religiosi 177, di cui 89 nel Settentrione, 53 nel Centro, 25 nel Mezzogiorno, 3 in Sardegna, 6 in Sicilia; 8°) Periodici di cultura (arte, scienze e lettere) 41, di cui 17 nel Settentrione, 16 nel Centro, 5 nel Mezzogiorno, 3 in Sicilia; 9°) Periodici giovanili 16 di cui 10 nel Settentrione, 2 nel Centro, 2 nel Mezzogiorno, 2 in Sicilia.
Delle 627 pubblicazioni, 328 escono nel Settentrione, 161 nel Centro, 94 nel Mezzogiorno, 8 in Sardegna, 27 in Sicilia. Sono queste le cifre statistiche, ma se si tiene conto dell’importanza delle singole pubblicazioni il peso del Settentrione aumenta e di molto. Sono da calcolare nel 25 circa 280 diocesi e circa 220 Giunte diocesane di Azione Cattolica. Bisognerebbe fare dei confronti col 19‑20 e col periodo posteriore al Concordato. La composizione dei periodici deve essere molto mutata: quotidiani e periodici di formazione e propaganda molto diminuiti, perché più strettamente legati alla fortuna del Partito Popolare e all’attività politica. Ricordare episodi per cui ai settimanali fu proibito in alcune province di pubblicare réclame e orari tranviari e ferroviari ecc.
Q8 §9 Assenza di un carattere nazionale‑popolare nella letteratura italiana. Da un articolo di Paolo Milano nell’«Italia letteraria» del 27 dicembre 1931: «Il valore che si dà al contenuto di un’opera d’arte non è mai troppo – ha scritto Goethe. Un simile aforisma può tornare in mente a chi rifletta sullo sforzo, da tante generazioni (?) avviato (sic) e che si sta tuttora compiendo, di creare una tradizione del moderno romanzo italiano. Quale società, anzi quale ceto dipingere? I tentativi più recenti non consistono forse nel desiderio di uscire dai personaggi popolareschi che tengono la scena nell’opera manzoniana e verghiana? E le mezze riuscite non si possono forse ricondurre alle difficoltà e all’incertezza nel fissare un ambiente (fra alta borghesia oziosa e gente minuta e bohème marginale)?».
Il brano è sorprendente per il modo meccanico ed esteriore di porre le quistioni. Infatti avviene che «generazioni» di scrittori tentino a freddo di fissare l’ambiente da descrivere senza con ciò stesso manifestare il loro carattere «astorico» e la loro povertà morale e sentimentale? Del resto per «contenuto» non basta intendere la scelta di un dato ambiente: ciò che è essenziale per il contenuto è l’atteggiamento dello scrittore e di una generazione verso questo ambiente. L’atteggiamento solo determina il mondo culturale di una generazione e di un’epoca e quindi il suo stile. Anche nel Manzoni e nel Verga, non i «personaggi popolareschi» sono determinanti, ma l’atteggiamento dei due scrittori verso di essi, e questo atteggiamento è antitetico nei due: nel Manzoni è un paternalismo cattolico, una ironia sottintesa, indizio di assenza di profondo istintivo amore verso quei personaggi, è un atteggiamento dettato da un esteriore sentimento di astratto dovere dettato dalla morale cattolica, corretto appunto e vivificato dall’ironia diffusa. Nel Verga è un atteggiamento di fredda impassibilità scientifica e fotografica, dettata dai canoni del verismo applicato più razionalmente che dallo Zola. L’atteggiamento del Manzoni è il più diffuso nella letteratura che rappresenta «personaggi popolareschi» e basta ricordare Renato Fucini; esso è ancora di carattere superiore, ma si muove su un filo di rasoio e infatti degenera, negli scrittori subalterni, nell’atteggiamento «brescianesco» stupidamente e gesuiticamente sarcastico.
Q8 §10 Risorgimento. Il realismo di Cavour. Il peso relativamente preponderante che i fattori internazionali ebbero nello sviluppo del Risorgimento risulta dal particolare realistico del Cavour, che consisteva nel valutare in una misura che sembrava mostruosa al Partito d’Azione l’attività diplomatica. Quando Crispi, credendo di diminuire l’importanza di Cavour, disse a Ferdinando Martini, che Cavour non aveva fatto altro che «diplomatizzare la rivoluzione» in realtà egli, senza volerlo, riconosceva l’indispensabilità del Cavour. Ma per Crispi ammettere che organizzare i rapporti internazionali fosse stato più importante ed essenziale che organizzare i rapporti interni sarebbe stato impossibile: avrebbe significato ammettere che le forze interne nazionali erano troppo deboli in confronto dei compiti da risolvere e che, specialmente, esse si erano mostrate impari alla loro missione e politicamente impreparate e abuliche (abuliche nel terreno della volontà politica concreta e non del giacobinismo formale). Perciò il «realismo di Cavour» è un argomento ancora da trattare, senza pregiudizi e senza retorica.
Q8 §11 Risorgimento. 48‑49. Mi pare che gli avvenimenti degli anni 1848‑49, data la loro spontaneità, possano essere considerati come tipici per lo studio delle forze sociali e politiche della nazione italiana. Troviamo in quegli anni alcune formazioni fondamentali: i reazionari moderati, municipalisti –, i neoguelfi ‑ democrazia cattolica –, e il partito d’azione ‑ democrazia liberale di sinistra borghese nazionale –. Le tre forze sono in lotta fra loro e tutte e tre sono successivamente sconfitte nel corso dei due anni. Dopo la sconfitta avviene una riorganizzazione delle forze verso destra dopo un processo interno in ognuno dei gruppi di chiarificazione e scissione. La sconfitta più grave è quella dei neoguelfi, che muoiono come democrazia cattolica e si riorganizzano come elementi sociali borghesi della campagna e della città insieme ai reazionari costituendo la nuova forza di destra liberale conservatrice. Si può istituire un parallelo tra i neoguelfi e il Partito Popolare, nuovo tentativo di creare una democrazia cattolica, fallito allo stesso modo e per ragioni simili. Così come il fallimento del Partito d'Azione rassomiglia a quello del «sovversivismo» del 19‑20.
Q8 §12 Letteratura popolare. Bibliografia. Réginald W. Hartland, Walter Scott et le roman «frénétique», ed. Honoré Champion. Romanzo «frenetico» o romanzo «nero»: le origini sarebbero da ricercare in Orazio Walpole e nel suo Castello d’Otranto. Dal Castello d’Otranto sarebbero derivati i romanzi di Anna Radcliffe (1798‑1831) e di Clara Reeve, di Lewis (Il frate) ecc. Il Castello d’Otranto determinò una corrente d’immaginazione che era nell’aria e di cui esso fu la manifestazione iniziale. Le Moine par M. C. Lewis, raconté par Antonin Artaud, ed. Denoël et Steele. Cfr Alice Killen, Le Roman Terrifiant, Champion, 1924.
Q8 §13 Passato e presente. Manzoni dialettico. Cap. VIII dei Promessi Sposi, episodio della tentata sorpresa di Renzo e Lucia a Don Abbondio per farsi sposare in casa: «Renzo che strepitava di notte in casa altrui, dove s’era introdotto di soppiatto, e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l’apparenza di un oppressore; eppure alla fin dei fatti, era l’oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a’ fatti suoi, parrebbe la vittima; eppure in realtà era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo... voglio dire, così andava nel secolo decimosettimo».
Q8 §14 Argomenti di cultura. I) Sul predicatore cattolico. La Controriforma elaborò un tipo di predicatore che si trova descritto nel De Predicatore Verbi Dei, Parigi, 1585. Alcuni canoni: 1°) sia la predicazione intonata all’uditorio: diversa quindi per un pubblico di campagnoli ed uno di cittadini, per nobili e plebei ecc.; 2°) il predicatore non deve indulgere alla eloquenza esteriore, non alla soverchia raffinatezza della forma; 3°) non si addentri in questioni troppo sottili e non faccia sfoggio di dottrina; 4°) non riferisca gli argomenti degli eretici dinanzi alla moltitudine inesperta, ecc. Il tipo del predicatore elaborato dalla Controriforma lo si può trovare modernamente nel giornalista cattolico, poiché in realtà i giornalisti sono una varietà culturale del predicatore e dell’oratore. Il punto 4° è specialmente interessante e serve a capire perché il più delle volte le polemiche coi giornali cattolici siano sterili di risultati: essi non solo non riportano gli «argomenti degli eretici», ma anche nel combatterli indirettamente, li storcono e li sfigurano, perché non vogliono che i lettori inesperti riescano a ricostruirli dalla polemica stessa. Spesso addirittura l’«eresia» è lasciata senza obbiezione, perché si ritiene minor male lasciarla circolare in un dato ambiente piuttosto che, combattendola, farla conoscere agli ambienti non ancora infetti.
II) Apostati e loro sistemi sleali di polemica. I cattolici si lamentano spesso, e con ragione, che gli apostati dal cattolicismo si servono degli argomenti degli eretici tacendone le confutazioni, ma presentandoli, agli inesperti, come novità originali non confutate. Nei seminari questi argomenti sono appunto esposti, analizzati, confutati nei corsi di apologetica: il prete spretato, con insigne slealtà intellettuale, ripresenta al pubblico quegli argomenti come suoi originali, come inconfutati e inconfutabili ecc.
Q8 §15 Testimonianze cattoliche. «Si insidia e si sovverte lentamente l’unità religiosa della patria; s’insegna la ribellione alla Chiesa, rappresentandola quale semplice società umana, che si arrogherebbe diritti che non ha, e di rimbalzo si colpisce anche la società civile, e si preparano gli uomini all’insofferenza di ogni giogo. Poiché, scosso il giogo di Dio e della Chiesa, quale altro se ne troverà che possa frenare l’uomo, e costringerlo al dovere duro della vita quotidiana?»: «Civiltà Cattolica», 2 gennaio 1932, ultimo periodo dell’articolo Il regno di Dio secondo alcuni filosofi moderni. Espressioni di questo genere sono diventate sempre più frequenti nella «Civiltà Cattolica» (accanto alle espressioni che propongono la filosofia di S. Tomaso come «filosofia nazionale» italiana, come «prodotto nazionale» che deve preferirsi ai prodotti stranieri) e ciò è per lo meno strano, perché è la teorizzazione esplicita della religione come strumento di azione politica.
Q8 §16 Passato e presente. La filosofia di Gentile. Selvaggio attacco contro Gentile e i suoi discepoli sferrato nella «Roma fascista» dell’ottobre 1931. Gentile è accusato di «alto tradimento», di procedimenti sleali e truffaldini. L’attacco fu fatto cessare d’autorità, ma non pare che l’attaccante (G. A. Fanelli) sia stato colpito da sanzioni, nonostante la estrema gravità delle accuse, evidentemente non provate perché il Gentile è rimasto nei posti occupati. Ricordare il precedente attacco di Paolo Orano ecc. Appare che la posizione occupata ufficialmente dal Gentile nel campo della cultura nazionale non si vuole rimanga indiscussa e si rafforzi troppo fino a diventare un’istituzione: la filosofia del Gentile non è riconosciuta come ufficiale e nazionale, ciò che significherebbe subordinazione esplicita del cattolicismo e sua riduzione a un compito subalterno ecc.
Q8 §17 Passato e presente. Una generazione può essere giudicata dallo stesso giudizio che essa dà della generazione precedente, un periodo storico dal suo stesso modo di considerare il periodo da cui è stato preceduto. Una generazione che deprime la generazione precedente, che non riesce a vederne le grandezze e il significato necessario, non può che essere meschina e senza fiducia in se stessa, anche se assume pose gladiatorie e smania per la grandezza. È il solito rapporto tra il grande uomo e il cameriere. Fare il deserto per emergere e distinguersi. Una generazione vitale e forte, che si propone di lavorare e di affermarsi, tende invece a sopravalutare la generazione precedente perché la propria energia le dà la sicurezza che andrà anche più oltre; semplicemente vegetare è già superamento di ciò che è dipinto come morto.
Si rimprovera al passato di non aver compiuto il compito del presente: come sarebbe più comodo se i genitori avessero già fatto il lavoro dei figli. Nella svalutazione del passato è implicita una giustificazione della nullità del presente: chissà cosa avremmo fatto noi se i nostri genitori avessero fatto questo e quest’altro..., ma essi non l’hanno fatto e quindi noi non abbiamo fatto nulla di più. Una soffitta su un pianterreno è meno soffitta di quella sul decimo o trentesimo piano? Una generazione che sa far solo soffitte si lamenta che i predecessori non abbiano già costruito palazzi di dieci o trenta piani. Dite di esser capaci di costruire cattedrali ma non siete capaci che di costruire soffitte.
Differenza col Manifesto che esalta la grandezza della classe moritura.
Q8 §18 Passato e presente. Gli avvocati in Italia. Cfr l’articolo di Mariano D’Amelio, La classe forense in cifre, nel «Corriere della Sera» del 26 gennaio 1932. Cita uno studio di Rodolfo Benini, pubblicato negli Atti dell’Accademia dei Lincei, «ricco di savie e sottili osservazioni circa la classe degli avvocati, dei procuratori e dei causidici, relativo agli anni 1880 e 1913». Libro di Piero Calamandrei (edito dalla «Voce», mi pare, e intitolato Troppi avvocati). Studio recente dello Spallanzani (di circa 20 pp.) L’efficienza della classe forense sulla vita italiana (senza indicazioni bibliografiche). Nel 1880 nei tre albi di avvocati e procuratori, di soli avvocati e soli procuratori, erano inscritti 12 885 professionisti, cioè 45,17 per 100 000 abitanti; nel 1913 il numero era di 21 488, 61,97 per 100 000 abitanti. Nel 1923, 23 925, 54,41 per 100 000. Nel 1927, dopo la revisione straordinaria degli albi disposta dalla nuova legge, il numero ascende a 26 679, 68,85 per 100 000; furono cancellati più di 2000. L’azione di revisione e le nuove norme restrittive per le inscrizioni riducono, nel 29, il numero a 25 353, 64,21 per 100 000. Ora in media si inscrivono 10 avvocati all’anno, meno delle vacanze che si verificano.
Negli altri paesi: Francia: nel 1911 gli avocats e avoués 10 236, 29 per 100 000 abitanti; nel 1921, 15 236, 39 per 100 000. Germania del dopo‑guerra: nel 1925, 13 676 Rechtsanwälte (avvocati e procuratori), 22 per 100 000 nel 1913, 18 per 100 000. Austria: prima della guerra 15 per 100 000; dopo la guerra 18. Inghilterra: nel 1920 17 946, 47 per 100 000, prima della guerra 45 per 100 000.
Nelle facoltà di giurisprudenza italiane ogni anno 9000 studenti: le lauree in legge che nel periodo 1911‑14 furono 1900, nel 1928‑29 furono 2240. Nel 1911‑14 i licenziati dal liceo 4943 in media all’anno, nel 1926‑29, 5640. Nella magistratura superiore (Corti d’Appello, d’Assise, Cassazione) i magistrati nel 1880, 2666; nel 1913, 2553; nel 1922, 2546; nel 1929, 2557.
Q8 §19 Senso comune. Il Manzoni fa distinzione tra senso comune e buon senso (Cfr Promessi Sposi, Cap. XXXII sulla peste e sugli untori). Parlando del fatto che c’era pur qualcuno che non credeva agli untori ma non poteva sostenere la sua opinione contro l’opinione volgare diffusa, aggiunge: «Si vede ch’era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica: il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune».
Q8 §20 Risorgimento. I moderati toscani. Cfr la conferenza di Mario Puccioni, Uomini del Risorgimento in Toscana, pubblicata nella «Miscellanea storica della Valdelsa» e riassunta nel «Marzocco» del 15 novembre 1931. L’attività apologetica del Puccioni a favore dei moderati toscani è un tratto interessante della cultura toscana moderna: dimostra come ancora sia instabile la coscienza nazionale del ceto dirigente toscano e la sua «dignità e prestigio» discussi. I moderati toscani trovarono aiuto e adesione soltanto nella borghesia colta, nella piccola possidenza e nel popolo della città: l’aristocrazia con la classe agricola rappresentò l’assenteismo e il quietismo. «Scoppiata (!) la rivoluzione, fu provvidenziale che la sera del 27 aprile Ubaldino Peruzzi accettasse di far parte del triumvirato, rassicurando i timidi del Granducato e le diplomazie, tutte avverse al movimento, che sotto di lui non si sarebbero ripetuti gli eccessi del 1849». Cosa c’è di «nazionale» in tutto ciò? I moderati erano espressione, dunque, dei «timori» dell’aristocrazia e della gente per bene che aveva paura degli «eccessi» e delle diplomazie; cosa c’è di «nazionale» in questa espressione? E perché le classi agricole erano assenti? Non erano esse la maggioranza del popolo toscano, cioè la «forza nazionale»? La paura degli «eccessi» non era la paura che tali classi entrassero in movimento per le loro rivendicazioni progressive, e i «paurosi» non erano i retrivi conservatori di uno statu quo antinazionale, tanto vero che era quello dell’antico regime? Si tratta dunque di una ripetizione del vecchio principio: Franza o Spagna, purché se magna. Granducato o Italia unita, purché le cose rimangano come sono: il fatto politico e nazionale è indifferente, ciò che conta è l’ordinamento economico‑sociale che deve essere conservato contro le forze nazionali progressive. Così è della paura delle diplomazie. Come può una rivoluzione aver paura delle diplomazie? Questa paura non significa coscienza di essere subordinati all’estero e di dover trascurare le esigenze nazionali alle pretese straniere?
L’apologetica del Puccioni parte da concezioni ben meschine e basse: ma perché chiamare «nazionale» ciò che è solo servile e subalterno? «Quanto più avevan tardato i moderati ad afferrare l’idea che inspirò i rivoluzionari ed a sentire la necessità dell’adesione al Piemonte, tanto più decisi (?), dopo un lavoro di ricostruzione, furono nel sostenerla, predicarla, effettuarla, a dispetto (!) delle contrarie diplomazie, a contrasto con le indebite (!) ingerenze dei seguaci del sovrano fuggito. Non è il caso di preoccuparci (!) se i moderati accederono a cose fatte (– o non furono precursori? –) alla rivoluzione: constatiamo invece quanto fosse utile e indispensabile il loro appoggio, se non altro (!) a mostrare (!) all’estero che i terribili rivoluzionari erano rappresentati da uomini della migliore società, i quali avrebbero avuto tutto da perdere e nulla da guadagnare da una rivoluzione, quando essa non fosse riuscita seria e promettitrice di migliore avvenire». Migliore per chi? e come? Il Puccioni diventa spassoso, ma è spassoso che egli sia invitato a dire tali cose e che le sue proposizioni e il suo modo di pensare siano applauditi.
Q8 §21 Il moderno Principe. Sotto questo titolo potranno raccogliersi tutti gli spunti di scienza politica che possono concorrere alla formazione di un lavoro di scienza politica che sia concepito e organizzato sul tipo del Principe del Machiavelli. Il carattere fondamentale del Principe è appunto quello di non essere una trattazione sistematica, ma un libro «vivente», in cui l’ideologia diventa «mito» cioè «immagine» fantastica e artistica tra l’utopia e il trattato scolastico, in cui l’elemento dottrinale e razionale si impersona in un «condottiero» che presenta plasticamente e «antropomorficamente» il simbolo della «volontà collettiva». Il processo per la formazione della «volontà collettiva» viene presentato non attraverso una pedantesca disquisizione di principii e di criterii di un metodo d’azione, ma come «doti e doveri» di una personalità concreta, che fa operare la fantasia artistica e suscita la passione.
Il Principe del Machiavelli potrebbe essere studiato come una esemplificazione storica del «mito» sorelliano, cioè dell’ideologia politica che si presenta non come fredda utopia né come dottrinario raziocinio, ma come «fantasia» concreta operante su un popolo disperso e polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collettiva. Il carattere utopistico del Principe è dato dal fatto che il «principe» non esisteva realmente, storicamente, non si presentava al popolo italiano con caratteri di immediatezza storica, ma era esso stesso un’astrazione dottrinaria, il simbolo del capo in generale, del «condottiero ideale». Si può studiare come mai il Sorel, dalla concezione del «mito» non sia giunto alla concezione del partito politico, attraverso la concezione del sindacato economico; ma per il Sorel il mito non si impersonava nel sindacato, come espressione di una volontà collettiva, ma nell’azione pratica del sindacato e della volontà collettiva già organizzata e operante, azione pratica, la cui realizzazione massima avrebbe dovuto essere lo sciopero generale, cioè una «attività passiva» per così dire, non ancora passata alla fase «attiva o costruttiva». Ma può essere un mito «non‑costruttivo», può immaginarsi, nell’ordine di intuizioni del Sorel, che sia produttivo ciò che lascia la «volontà collettiva» alla sua fase primitiva di formarsi, distinguendosi (scindendosi), per distruggere?
Il moderno Principe, il mito‑Principe non può essere una persona reale, un individuo concreto; può essere solo un organismo, un elemento sociale nel quale già abbia inizio il concretarsi di una volontà collettiva riconosciuta e affermatasi parzialmente nell’azione. Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico ed è il partito politico, la forma moderna in cui si riassumono le volontà collettive parziali che tendono a diventare universali e totali. Solo un’azione politico‑storica immediata, caratterizzata dalla necessità di un procedimento rapido e fulmineo, può incarnarsi in un individuo concreto: la rapidità non può essere data che da un grande pericolo imminente, grande pericolo che appunto crea fulmineamente l’arroventarsi delle passioni e del fanatismo e annulla il senso critico e l’ironia che possono distruggere il carattere «carismatico» del condottiero (esempio del Boulanger). Ma questa azione immediata, per ciò stesso non può essere di vasto respiro e di carattere organico: sarà quasi sempre del tipo restaurazione e riorganizzazione e non del tipo proprio alla fondazione di nuovi Stati e nuove strutture nazionali e sociali (come era il caso nel Principe di Machiavelli, in cui l’aspetto restaurazione se mai era di tinta retorica, cioè legato al concetto dell’Italia discendente di Roma e che doveva restaurare l’ordine romano); di tipo «difensivo» e non creativo, in cui si suppone che una «volontà collettiva» già esistente si sia snervata e dispersa e occorra riconcentrarla e irrobustirla, e non già che una «volontà collettiva» sia da creare ex‑novo e da indirizzare verso mete concrete sì, ma di una concretezza non ancora verificata dall’esperienza passata. Il carattere «astratto» (spontaneista) del Sorel appare dalla sua avversione (che assume la forma passionale di una repugnanza etica) per i giacobini che furono una «incarnazione» «categorica» del Principe di Machiavelli.
Il moderno Principe deve avere una parte dedicata al giacobinismo (nel senso completo della nozione già fissata in altre ) come esempio di come si forma una concreta e operante volontà collettiva. E occorre che si definisca la «volontà collettiva» e la volontà politica in generale nel senso moderno, la volontà come coscienza operosa della necessità storica, come protagonista di un reale e immediato dramma storico. Il primo capitolo (parte) appunto dovrebbe essere dedicato alla «volontà collettiva» impostando la quistione così: esistono le condizioni fondamentali perché possa suscitarsi una volontà collettiva nazionale‑popolare? Quindi un’analisi storica (economica) della struttura sociale del paese dato e una rappresentazione «drammatica» dei tentativi fatti attraverso i secoli per suscitare questa volontà e le ragioni dei successivi fallimenti.
Perché in Italia non si ebbe la monarchia assoluta al tempo di Machiavelli? Bisogna salire fino all’impero romano (quistione degli intellettuali e della lingua) per comprendere i Comuni medioevali e la funzione della Chiesa. La ragione dei successivi fallimenti nel tentativo di creare una volontà collettiva nazionale popolare è da porsi nell’esistenza di certe classi e nel particolare carattere di altre dipendente dalla situazione internazionale dell’Italia (sede della Chiesa universale). Questa posizione determina all’interno una situazione che si può chiamare «economico‑corporativa», cioè politicamente, una forma particolare di feudalismo anarchico: mancò sempre una forza «giacobina» efficiente, la forza appunto che crea la volontà collettiva nazionale popolare, fondamento di tutti gli Stati moderni. Esistono finalmente le condizioni per questa volontà, ossia quale è il rapporto attuale tra queste condizioni e le forze opposte? Tradizionalmente le forze opposte sono l’aristocrazia terriera e più generalmente la proprietà terriera nel suo complesso, cioè quella speciale «borghesia terriera» che è l’eredità di parassitismo lasciata ai tempi moderni dallo sfacelo della borghesia comunale (le cento città, le città del silenzio). Ogni formazione di volontà collettiva nazionale popolare è impossibile senza che le masse dei contadini coltivatori entrino simultaneamente nella vita politica. Ciò voleva il Machiavelli attraverso la riforma della milizia, ciò fecero i giacobini nella Rivoluzione francese, in ciò consiste il giacobinismo precoce di Machiavelli, il germe fecondo della sua concezione (della) rivoluzione nazionale. Tutta la storia dal 1815 in poi è lo sforzo delle classi tradizionali per non lasciar formare una volontà nazionale, ma per mantenere il potere «economico‑corporativo» in un sistema internazionale di equilibrio rimorchiato ecc.
Una parte importante del moderno Principe è la quistione di una riforma intellettuale e morale, cioè la quistione religiosa o di una concezione del mondo. Anche in questo campo troviamo assenza di «giacobinismo» e paura del «giacobinismo» espresse in forme filosofiche (ultimo esempio: Benedetto Croce). Il moderno Principe deve essere il banditore di una riforma intellettuale e morale, che è il terreno per un ulteriore sviluppo della volontà collettiva nazionale popolare nel terreno di una forma compiuta e totale di civiltà moderna.
Realmente il moderno Principe dovrebbe limitarsi a questi due punti fondamentali: formazione di una volontà collettiva nazionale popolare di cui il moderno Principe è appunto espressione attiva e operante, e riforma intellettuale e morale. I punti concreti di programma d’azione devono essere incorporati nel primo punto, cioè devono risultare «drammaticamente» dal discorso, non essere una fredda esposizione di raziocini. (Può esserci riforma culturale, e cioè elevamento culturale degli elementi depressi della società, senza una precedente riforma economica e un mutamento nel tenore economico di vita? Perciò la riforma intellettuale e morale è sempre legata ad un programma di riforma economica, anzi il programma di riforma economica è il modo concreto con cui si presenta ogni riforma intellettuale e morale. Il moderno Principe, sviluppandosi, sconvolge tutto il sistema di rapporti intellettuali e morali in quanto il suo svilupparsi significa appunto che ogni azione è utile o dannosa, virtuosa o scellerata, in quanto ha come punto concreto di riferimento il moderno Principe e incrementa il suo potere o lo combatte. Egli prende il posto, nelle coscienze, della divinità e dell’imperativo categorico, egli è la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume).
Q8 §22 Storia degli intellettuali. Spunti di ricerca. La repubblica di Platone. Quando si dice che Platone vagheggiava una «repubblica di filosofi» bisogna intendere «storicamente» il termine di filosofi che oggi dovrebbe tradursi con «intellettuali» (naturalmente Platone intendeva i «grandi intellettuali» che erano d’altronde il tipo di intellettuale del tempo suo, oltre a dare importanza al contenuto specifico dell’intellettualità che in concreto potrebbe dirsi di «religiosità»: gli intellettuali di governo cioè erano quei determinati intellettuali più vicini alla religione, la cui attività cioè aveva un carattere di religiosità intesa nel significato generale del tempo e speciale di Platone, e perciò attività in certo senso «sociale», di elevazione ed educazione e direzione intellettuale, quindi con funzione di egemonia della polis). Si potrebbe perciò forse sostenere che l’«utopia» di Platone precorre il feudalismo medioevale, con la funzione che in esso è propria della Chiesa e degli ecclesiastici, categoria intellettuale di quella fase dello sviluppo storico‑sociale. L’avversione di Platone per gli «artisti» è da intendersi pertanto come avversione alle attività spirituali «individualistiche» che tendono al «particolare», quindi «areligiose», «asociali».
Gli intellettuali nell’Impero Romano. Il mutamento della condizione della posizione sociale degli intellettuali a Roma dal tempo della Repubblica all’Impero (da un regime aristocratico‑corporativo a un regime democratico‑burocratico) è legato a Cesare che conferì la cittadinanza ai medici e ai maestri delle arti liberali affinché abitassero più volentieri a Roma e altri vi fossero richiamati: «Omnesque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et coeteri appeterent civitate donavit»: Svetonio, Vita di Cesare, XLII, Cesare si propose quindi: 1°) di far stabilire a Roma gli intellettuali che già vi si trovavano, creando così una permanente categoria di essi, perché senza la permanenza non poteva crearsi un’organizzazione culturale. Ci sarà stata precedentemente una fluttuazione che era necessario arrestare ecc.; 2°) di attirare a Roma i migliori intellettuali di tutto l’Impero romano, promovendo una centralizzazione di grande portata. Così ha inizio quella categoria di intellettuali «imperiali» a Roma, che continuerà nel clero cattolico e lascerà tante tracce in tutta la storia degli intellettuali italiani con la loro caratteristica di «cosmopolitismo» fino al ’700.
Q8 §23 Federico Confalonieri. Dal libretto: A. F. Andryane, Memorie di un prigioniero di Stato allo Spielberg, Capitoli scelti e annotati da Rosolino Guastalla, Firenze, Barbèra, 1916, tolgo alcune indicazioni bibliografiche su Federico Confalonieri: Rosolino Guastalla, Letteratura spielberghese in Le mie prigioni commentate, Livorno, Giusti, 1912; Giorgio Pallavicino, Spilbergo e Gradisca (1856), ristampato nelle Memorie (Loescher, 1882); Federico Confalonieri, Memorie e Lettere (Milano, Hoepli, 1890); Alessandro Luzio, Antonio Salvotti e i processi del Ventuno, Roma, 1901; Domenico Chiattone, commento alle Mie Prigioni del Pellico. I Mémoires dell’Andryane sono stati tradotti in italiano da F. Regonati (quattro volumi, 1861, Milano) corredati da documenti.
Posizione del Luzio contro Andryane, mentre giustifica il Salvotti (!); cfr altre osservazioni del Luzio e il carattere tendenzioso e acrimonioso dei suoi scritti sul Risorgimento. Cfr G. Trombadori, Il giudizio del De Sanctis sul Guicciardini nella «Nuova Italia» del 20 novembre 1931; scrive il Trombadori: «La legittima ammirazione che tutti tributiamo al Luzio soprattutto per l’opera da lui svolta nel campo degli studi sul nostro Risorgimento, non deve essere scompagnata dalla conoscenza dei limiti entro cui è chiusa la sua visione della storia, che sono un moralismo piuttosto esclusivistico e quella mentalità così schiettamente giuridica (ma è esatto dire giuridica? o non è piuttosto “giudiziaria”?) che lo ha fatto impareggiabile indagatore di carte processuali ecc. ecc.» (vedi il testo in caso di bisogno). Ma non si tratta solo di temperamento, si tratta specialmente di tendenziosità politica. Il Luzio potrebbe chiamarsi il Cesare Cantù del moderatismo conservatore (cfr Croce su Cantù nella Storia della storiografia italiana nel secolo XIX). Continuo la citazione sul Luzio del Trombadori: «Sono due atteggiamenti che si integrano e si completano a vicenda, per cui qualche volta ti sembra che la sua portentosa perizia nel sottoporre all’analisi deposizioni e testimonianze e “costituti” abbia l’unico fine di liberare qualcuno dalla taccia di vigliacco o di traditore, o di ribadirgliela, di condannare, o di assolvere. Così avviene che raramente egli si sottragga al gusto di accompagnare ai nomi di uomini che nella storia ebbero la loro parte grande o piccola, aggettivi come: vile, generoso, nobile, indegno e via dicendo». Perciò il Luzio partecipò alla polemica che si svolse negli anni scorsi sul Guicciardini, contro il giudizio del De Sanctis, naturalmente per difendere il Guicciardini, credendo che ci fosse bisogno di difenderlo, come se il De Sanctis avesse fatto una requisitoria da procuratore contro di lui e non avesse invece rappresentato un periodo della cultura italiana, quello dell’«Uomo del Guicciardini»; l’intervento del Luzio anche in questo caso non è un fatto di «temperamento» di studioso, ma un fatto politico tendenziale: in realtà l’«uomo del Guicciardini» è il rappresentante ideale del «moderato italiano» sia esso lombardo, toscano o piemontese tra il 1848 e il 1870 e del moderno clerico‑moderato, di cui il Luzio è l’aspetto «istoriografico».
È da notare che il Croce non cita, neppure per incidenza, il nome del Luzio nella sua Storia della storiografia italiana nel secolo XIX, edizione del 1921, sebbene una parte dell’opera del Luzio risalga agli anni precedenti il 1900: mi pare ne parli però nell’appendice pubblicata recentemente nella «Critica» e incorporata poi nella nuova edizione del libro.
Q8 §24 Storia degli intellettuali. Gli Elementi di scienza politica del Mosca (nuova edizione aumentata del 1923) sono da esaminare per questa rubrica. La cosiddetta «classe politica» del Mosca non è altro che la categoria intellettuale del gruppo sociale dominante: il concetto di «classe politica» del Mosca è da avvicinare al concetto di élite del Pareto, che è un altro tentativo di interpretare il fenomeno storico degli intellettuali e la loro funzione nella vita statale e sociale. Il libro del Mosca è un enorme zibaldone di carattere sociologico e positivistico, con in più la tendenziosità della politica immediata che lo rende meno indigesto e letterariamente più vivace.
Q8 §25 Risorgimento. Cercare cosa significa e come è giustificata nel Quinet la formula dell’equivalenza di rivoluzione‑restaurazione nella storia italiana. Secondo Daniele Mattalia (Gioberti in Carducci nella «Nuova Italia» del 20 novembre 1931) la formula del Quinet sarebbe stata adottata dal Carducci attraverso il concetto giobertiano della classicità nazionale (Rinnovamento, III, 88; Primato, III, 1, 5, 6, 7…; il Rinnovamento nell’edizione Laterza, il Primato nell’edizione Utet). Questo concetto del Quinet può essere avvicinato a quello di «rivoluzione passiva» del Cuoco? Sia la «rivoluzione‑restaurazione» del Quinet che la «rivoluzione passiva» del Cuoco esprimerebbero il fatto storico dell’assenza di iniziativa popolare nello svolgimento della storia italiana, e il fatto che il «progresso» si verificherebbe come reazione delle classi dominanti al sovversivismo sporadico e disorganico delle masse popolari con «restaurazioni» che accolgono una qualche parte delle esigenze popolari, quindi «restaurazioni progressive» o «rivoluzioni‑restaurazioni» o anche «rivoluzioni passive». Trasportando questo spunto nella rubrica «Passato e presente» si potrebbe dire che si tratta di «rivoluzioni dell’uomo del Guicciardini» e che il Cavour «diplomatizzò» appunto la rivoluzione dell’uomo del Guicciardini.
Q8 §26 Passato e presente. La politica di Luigi Cadorna. Nell’articolo del Fermi: La Spagna cattolica in «Gerarchia» del dicembre 1931 si accenna alla Costituzione spagnola del 1812 e si dice: «La resistenza indomita opposta ai francesi dal 1808 al 1813 da tutte, o quasi, le classi della nazione, guidate dal clero, anch’esso ridestato, segnò una pagina gloriosa. Ferdinando VII e le Cortes del 1812 si incaricarono di annullarne i risultati. Queste, con la costituzione modellata sul figurino francese del 1791, inflissero al paese un travestimento: cattiva copia di una cattiva copia, come diceva L. Cadorna di un travestimento analogo». Dove e quando il Cadorna si espresse in tali termini? Il giudizio del Fermi sulla costituzione spagnola del 12 è il solito giudizio superficiale della demagogia reazionaria.
Q8 §27 Conservazione e innovazione. Una determinata corrente storicistica pone a suo fondamento e dichiara solo storicistico un metodo d’azione in cui il progresso storico (lo svolgimento) risulta dalla dialettica di conservazione e innovazione: il contemperamento di conservazione e innovazione costituisce il «classicismo nazionale» del Gioberti così come costituisce il classicismo letterario e artistico dell’ultima estetica crociana. È questo lo storicismo dei moderati, non tanto teoria scientifica quanto tendenza pratico‑politica o ideologia. Ma perché conservazione deve essere proprio quella data «conservazione», quel dato elemento dialettico del passato? E perché si deve essere «irrazionalisti» e «antistoricisti» se non si conserva questo determinato elemento? In realtà, se è vero che il progresso è dialettica di conservazione e innovazione e l’innovazione conserva superando il passato, è anche vero che il passato è cosa complessa e che è dato scegliere in questa complessità: né la scelta può essere arbitrariamente fatta a priori da un individuo o da una corrente; se questa scelta è fissata in tal modo si tratta di «ideologia», di tendenza pratico‑politica unilaterale, che non può dare fondamento a una scienza. Presentare questa scelta come «scienza» è appunto elemento ideologico, poiché ogni ideologia cerca di presentarsi come scienza, e come filosofia. Ciò che sarà conservato nel processo dialettico sarà determinato dal processo stesso, sarà un fatto necessario, non un arbitrio di così detti scienziati e filosofi. E intanto si osserva che la forza innovatrice in quanto si è costituita nel passato, è essa stessa un fatto del passato, è appunto essa stessa conservazione‑innovazione, contiene in sé l’intero passato, quello degno di svolgersi e perpetuarsi. Per questa specie di storicisti moderati (e si intende moderati in senso politico, di classe cioè di quelle classi che operarono la restaurazione dopo il 1815 e il 1848) l’irrazionale è il giacobinismo, antistoria uguale giacobinismo. Ma chi potrà storicamente provare che solo l’arbitrio abbia guidato i giacobini? E non è proposizione storica banale che né Napoleone né la Restaurazione hanno distrutto i «fatti compiuti» dai giacobini? O forse l’antistoricismo dei giacobini sarà consistito in ciò che delle loro iniziative non si è «conservato» il 100%, ma solo una percentuale relativa? Non pare che ciò sia plausibile da sostenersi perché la storia non si fa con calcoli matematici e d’altronde nessuna forza storica innovatrice si realizza immediatamente al 100%, ma appunto è sempre razionale e irrazionale, storicistica e antistoricistica, è «vita» cioè con tutte le debolezze e le forze della vita, con le sue contraddizioni e le sue antitesi.
Q8 §28 Nomenclatura Politica. Teorici, dottrinari, astrattisti ecc. Nel linguaggio comune «teorico» è adoperato in senso deteriore, come «dottrinario» e meglio ancora come «astrattista». Ha avuto la stessa sorte del termine «idealista» che dal significato tecnico filosofico ha preso a significare «vagheggiatore di nebulosità» ecc. Che certi termini abbiano assunto questo significato deteriore non è avvenuto a caso. Si tratta di una reazione del senso comune contro certe degenerazioni culturali, ecc., ma il «senso comune» è stato a sua volta il filisteizzatore, il mummificatore di una reazione giustificata in uno stato d’animo permanente, in una pigrizia intellettuale altrettanto degenerativa e repulsiva del fenomeno che voleva combattere. Il «buon senso» ha reagito, il «senso comune» ha imbalsamato la reazione e ne ha fatto un canone «teorico», «dottrinario», «idealistico».
Q8 §29 Buon senso e senso comune. I rappresentanti del «buon senso» sono l’«uomo della strada», il «francese medio» diventato «l’uomo medio», «monsieur Tout‑le-monde». Nella commedia borghese sono specialmente da ricercare i rappresentanti del buon senso.
Q8 §30 Storia degli intellettuali italiani. Gioberti. Importanza del Gioberti per la formazione del carattere nazionale moderno degli intellettuali italiani. Sua funzione accanto al Foscolo. In una nota precedente osservazioni sulla soluzione formale data dal Gioberti al problema nazionale‑popolare come contemperamento di conservazione e innovazione, come «classicità nazionale». Soluzione formale non solo del maggior problema politico‑sociale, ma anche di quelli derivati, come quello di una letteratura nazionale‑popolare. Occorrerà rivedere ai fini di questo studio le maggiori pubblicazioni polemiche del Gioberti: il Primato e il Rinnovamento, gli scritti contro i gesuiti (Prolegomeni e il Gesuita moderno). Libro dell’Anzilotti sul Gioberti.
Q8 §31 Risorgimento. La Carboneria e la Massoneria. Articolo di A. Luzio, Le origini della Carboneria, nel «Corriere della Sera» del 7 febbraio 1932. Il Luzio parla di due libri di Eugenio Lennhoff, fr ... gerarca della Massoneria austriaca (del Lennhoff ha parlato spesso lo scrittore di Massoneria della «Civiltà cattolica»): Die Freimaurer e Politische Geheimbünde (Casa ed. Amalthea, Vienna). Il Luzio incomincia col notare gli errori di lingua italiana contenuti nelle citazioni politiche del Lennhoff e altri errori più gravi (Mazzini confuso col gran maestro Mazzoni, p. 204 dei Freimaurer, e quindi fatto diventare gran maestro; ma si tratta di errore storico o di errore di stampa?). Come recensione del Lennhoff, l’articolo del Luzio non vale nulla. Per le origini della Carboneria: opere dell’Alberti sulle assemblee costituzionali italiane e sulla rivoluzione napoletana del 1820, edite dai Lincei; studi del Sòriga, «Risorgimento italiano» gennaio‑marzo 1928, e articolo del Sòriga sulla Carboneria nell’Enciclopedia Treccani (v. VIII), libro dei Luzio sulla Massoneria. In questo articolo il Luzio riporta dalle memorie inedite del generale Rossetti (di cui parla Guido Bustico nella «Nuova Antologia» del 1927) un rapporto del Rossetti stesso a Gioacchino Murat (del giugno 1814) in cui si parla dei primi tempi della Carboneria, che sarebbe stata conosciutissima in Francia, soprattutto nella Franca Contea, e a cui il Rossetti si sarebbe affiliato nel 1802, essendo di stanza a Gray. (Ma sono cose vaghe e che si perdono nella notte dei tempi, fra i fondatori della Carboneria sarebbe stato Francesco I ecc.). Secondo il Rossetti la Carboneria nel Reame di Napoli avrebbe cominciato a propagarsi nella provincia di Avellino nel 1811, estendendosi solo verso la metà del 1812.
Q8 §32 Risorgimento. Origini. Le quistioni «tendenziali» poste a proposito delle origini del moto nazionale del Risorgimento: 1) tesi francofila‑democratica: il moto è dovuto alla rivoluzione francese, ciò che ha determinato l’altra tesi: 2) la rivoluzione francese coi suo intervento nella penisola ha interrotto il movimento «veramente» nazionale, tesi che ha un doppio aspetto: quello gesuitico e quello moderato che si riferisce ai principi riformatori. Mai il movimento riformatore era stato interrotto per la paura della rivoluzione francese, quindi: 3) la rivoluzione francese, col suo intervento, non interruppe il movimento indigeno, ma anzi ne rese possibile la ripresa e il compimento.
Q8 §33 Nesso storico 1848‑49. Il federalismo di Ferrari‑Cattaneo. Fu l’impostazione politico‑storica delle contraddizioni esistenti tra il Piemonte e la Lombardia. La Lombardia non voleva essere annessa, come una provincia, al Piemonte: era più progredita, intellettualmente, politicamente, economicamente, del Piemonte. Aveva fatto, con forze e mezzi propri, la sua rivoluzione democratica con le cinque giornate: era, forse, più italiana del Piemonte, nel senso che rappresentava l’Italia meglio del Piemonte. Che il Cattaneo presentasse il federalismo come immanente in tutta la storia italiana non è altro che elemento ideologico, mitico, per rafforzare il programma politico attuale. Perché accusare il federalismo di aver ritardato il moto nazionale e unitario? Bisogna ancora insistere sul criterio metodologico che altro è la storia del Risorgimento e altro l’agiografia delle forze patriottiche e anzi di una frazione di esse, quelle unitarie. E Risorgimento è uno svolgimento storico complesso e contraddittorio che risulta integrale da tutti i suoi elementi antitetici, dai suoi protagonisti e dai suoi antagonisti, dalle loro lotte, dalle modificazioni reciproche che le lotte stesse determinano e anche dalla funzione delle forze passive e latenti come le grandi masse agricole, oltre, naturalmente, la funzione eminente dei rapporti internazionali.Cattaneo
Q8 §34 Passato e presente. Bibliografia. Provveditorato Generale dello Stato: Pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso: Spoglio dei periodici e delle opere collettive 1926‑1930 (Parte 1a: Scritti biografici e critici; parte 2a: Ripartizione per materia), Ed. Libreria dello Stato, Roma.
Q8 §35 Risorgimento. Giuseppe Ferrari. Come il giacobinismo storico (unione della città e della campagna) si è diluito e astrattizzato in Giuseppe Ferrari. La «legge agraria» da punto programmatico concreto e attuale, ben circoscritto nello spazio e nel tempo, è divenuta una vaga ideologia, un principio di filosofia della storia. Da notare che nei giacobini francesi la politica contadina non fu che un’intuizione politica immediata (arma di lotta contro l’aristocrazia terriera e contro il federalismo girondino) e opposero a ogni «esagerazione» utopistica degli astratti. L’impostazione della «riforma agraria» spiega il fatto della relativa popolarità che il Ferrari continua ad avere fra i libertari: molti punti di contatto tra il Ferrari e il Bakunin e in generale i narodniki russi i nullatenenti della campagna sono mitizzati per la «pandistruzione». Nel Ferrari, a differenza del Bakunin, è però ancor viva la coscienza che si tratta di una riforma liberalesca. Bisognerebbe confrontare le idee del Ferrari sulla riforma agraria come punto d’innesto delle masse agricole nella rivoluzione nazionale, con le idee di Carlo Pisacane. Il Pisacane si avvicina più al Machiavelli; concetto più limitato e concretamente politico. (Il Ferrari contro il principio d’eredità nel possesso terriero, contro residui di feudalismo, ma non contro l’eredità nella forma capitalistica; cfr. con le idee di Eugenio Rignano).
Q8 §36 Risorgimento. Il trasformismo. Il trasformismo come una delle forme storiche di ciò che è stato già notato sulla «rivoluzione‑restaurazione» o «rivoluzione passiva» a proposito del processo di formazione dello Stato moderno in Italia. Il trasformismo come «documento storico reale» della reale natura dei partiti che si presentavano come estremisti nel periodo dell’azione militante (Partito d'Azione). Due periodi di trasformismo: 1) dal 60 al 900 trasformismo «molecolare», cioè le singole personalità politiche elaborate dai partiti democratici d’opposizione si incorporano singolarmente nella «classe politica» conservatrice‑moderata (caratterizzata dall’avversione a ogni intervento delle masse popolari nella vita statale, a ogni riforma organica che sostituisse un’«egemonia» al crudo «dominio» dittatoriale); 2) dal 900 in poi trasformismo di interi gruppi di estrema che passano al campo moderato (il primo avvenimento è la formazione del Partito nazionalista coi gruppi ex‑sindacalisti e anarchici, che culmina nella guerra libica in un primo tempo e nell’interventismo in un secondo tempo). Tra i due periodi è da porre il periodo intermedio – 90-900 – in cui una massa di intellettuali passa nei partiti di sinistra, così detti socialistici, ma in realtà puramente democratici.
Guglielmo Ferrero nel suo opuscolo Reazione (Torino, Roux edit., 1895) così rappresenta il movimento degli intellettuali italiani degli anni novanta (il brano lo riporto dagli Elementi di scienza politica di G. Mosca, IIa ed., 1923): «C’è sempre un certo numero di individui che hanno bisogno di appassionarsi per qualche cosa di non immediato, di non personale e di lontano; a cui la cerchia dei propri affari, della scienza, dell’arte, non basta per esaurire tutta l’attività dello spirito. Che rimaneva a costoro in Italia se non l’idea socialista? Veniva da lontano, ciò che seduce sempre; era abbastanza complessa ed abbastanza vaga, almeno in certe sue parti, per soddisfare ai bisogni morali così differenti dei molti proseliti; da un lato portava uno spirito vasto di fratellanza e di internazionalismo, che corrisponde ad un reale bisogno moderno; dall’altro era improntata a un metodo scientifico che rassicurava gli spiriti educati alle scuole sperimentali. Dato ciò, nessuna meraviglia che un gran numero di giovani si sia inscritto in un partito dove almeno, se c’era pericolo di incontrare qualche umile uscito dal carcere o qualche modesto repris de justice, non si poteva incontrare nessun panamista, nessun speculatore della politica, nessun appaltatore di patriottismo, nessun membro di quella banda di avventurieri senza coscienza e senza pudore, che, dopo aver fatto l’Italia, l’hanno divorata. La più superficiale osservazione vi mostra subito che in Italia non esistono quasi in nessun posto le condizioni economiche e sociali per la formazione di un vero e grande partito socialista; inoltre un partito socialista dovrebbe trovare logicamente il nerbo delle sue reclute nelle classi operaie, non nella borghesia, come era accaduto in Italia. Ora se un partito socialista si sviluppava in Italia in condizioni si sfavorevoli e in un modo così illogico, si è perché rispondeva più che altro a un bisogno morale di un certo numero di giovani, nauseati di tanta corruzione, bassezza e viltà; e che si sarebbero dati al diavolo pur di sfuggire ai vecchi partiti imputriditi sino nelle midolla delle ossa».
Un Punto da vedere è la funzione che ha svolto il Senato in Italia come terreno per il trasformismo «molecolare». Il Ferrari, nonostante il suo repubblicanesimo federalista ecc., entra nel Senato e così tanti altri fino al 1914: ricordare le affermazioni comiche del senatore Pullè entrato nel Senato con Gerolamo Gatti e altri bissolatiani.
Q8 §37 Il moderno Principe. In questa serie di osservazioni potrebbero trovare posto le scritte a proposito dello studio delle situazioni e di ciò che occorre intendere per «rapporti di forza». Lo studio di come occorre analizzare le «situazioni», cioè di come occorre stabilire i diversi gradi di rapporti di forza, potrebbe prestarsi a una esposizione elementare di scienza politica, intesa come un insieme di canoni pratici di ricerca. Insieme un’esposizione di ciò che in politica occorre intendere per strategia e tattica per «piano», per propaganda e agitazione, elementi di organizzazione ecc.
Gli elementi pratici che sono esposti di solito alla rinfusa nei trattati di politica (si può prendere come esemplare gli Elementi di scienza politica del Mosca) dovrebbero, in quanto non sono quistioni astratte o campate in aria, trovar posto nei vari settori dei rapporti di forza, iniziando con i rapporti di forza internazionale (in cui entrerebbero le scritte su ciò che è una grande potenza) per passare ai rapporti obbiettivi sociali, cioè al grado di sviluppo delle forze produttive, ai rapporti di forza politica (o di egemonia) o di partito, e ai rapporti militari o meglio politici immediati.
I rapporti internazionali precedono o seguono i rapporti sociali fondamentali? Seguono indubbiamente. Ogni innovazione organica nella struttura modifica organicamente i rapporti assoluti e relativi nel campo internazionale attraverso le sue espressioni tecnico‑militari. Anche la posizione geografica di uno Stato nazionale non precede ma segue le innovazioni strutturali, pur reagendo su di esse in una certa misura (nella misura appunto in cui le superstrutture reagiscono sulla struttura, la politica sull’economia). D’altronde i rapporti internazionali reagiscono passivamente e attivamente specialmente sui rapporti politici (di egemonia dei partiti). Quanto più la vita economica immediata di una nazione è subordinata ai rapporti internazionali, tanto più un determinato partito rappresenta questa situazione e la sfrutta per impedire il sopravvento dei partiti avversari. Da questa serie di fatti si può giungere alla conclusione che spesso il così detto «partito dello straniero» non è proprio quello che come tale viene volgarmente indicato, ma proprio il partito più nazionalistico (un accenno a questo elemento internazionale «repressivo» delle energie interne, si trova negli articoli di G. Volpe pubblicati dal «Corriere» del 22 e 23 marzo) che in realtà, più che rappresentare le forze vitali del proprio paese, ne rappresenta la subordinazione e l’asservimento economico verso le nazioni o un gruppo di nazioni egemoniche.
Q8 §38 Passato e presente. La paura del kerenskismo. È uno dei tratti più rilevanti degli anni del dopoguerra. Corrisponde forse, in una certa misura, alla paura del lafayettismo nel periodo successivo alla Rivoluzione francese. Intorno al kerenskismo si è formato tutto un «mito negativo». Sono state attribuite al Kerensky tutte le qualità negative, le debolezze, le irrisolutezze, le deficienze di un’intera epoca storica. Non essere il Kerensky del proprio paese, è diventata l’ossessione di tutta una serie di capi di governo. Da questa paura sono derivate alcune delle massime politiche del machiavellismo attuale e dei principi critici su cui si svolge la propaganda politica di massa. Ma cosa c’è di reale in questa paura? Non si osserva che uno degli elementi del kerenskismo è appunto questa paura stessa di essere Kerensky, cioè il fatto che a un indirizzo positivo si sostituisce un indirizzo negativo nella vita politica, si pensa più al «non fare» che al «fare concreto», si è ossessionati dall’avversario che si sente dominare nell’interno stesso della propria personalità. Del resto si è «Kerensky» non per volontà, così come la volontà non può fare evitare dall’essere Kerensky.
Kerensky è stato l’espressione di un determinato rapporto di forze politiche, organizzative, militari immediate che non era stato creato da lui e che egli non riuscì a correggere nonostante i suoi sforzi disperati, tanto disperati e incomposti da dargli l’aspetto di un Arlecchino. Si è preso sul serio il quadro morale e intellettuale di Kerensky dipinto dai suoi nemici come arma di lotta contro di lui, come mezzo immediato per liquidarlo e isolarlo e se ne è fatto un uomo di paglia assoluto, fuori del tempo e dello spazio, un tipico «ilota» da mostrare agli «spartiati» per educarli. Si potrebbe dimostrare che non è vero che Kerensky non abbia ricorso alle misure di forza, tutt’altro; ma forse appunto questo suo ricorso alla forza accelerò il processo politico da cui egli fu travolto. In realtà il Kerensky ebbe molti successi relativi, e la sua linea politica non era sbagliata in sé; ma ciò contò poco nell’insieme delle forze scatenate intorno a lui, che erano incontrollabili da politici di tipo Kerensky, cioè dall’insieme delle forze sociali di cui Kerensky era l’espressione più adeguata.
Q8 §39 Lo «storicismo» di Croce. Lo storicismo di Croce è da mettere in rapporto con ciò che è stato osservato in precedenti sui concetti di «rivoluzione passiva», di «rivoluzione-restaurazione», di «conservazione-innovazione» e sul concetto giobertiano di «classicismo nazionale». È questo dello «storicismo» uno dei punti e dei motivi permanenti di tutta l’attività intellettuale e filosofica del Croce e una delle ragioni della fortuna e dell’influsso esercitato dalla sua attività da trent’anni in qua. Il Croce si inserisce nella tradizione culturale del nuovo Stato italiano e riporta la cultura nazionale alle origini, ma vivificandola e arricchendola con tutta la cultura europea e depurandola da tutte le scorie magniloquenti e bizzarre del Risorgimento. Stabilire con esattezza il significato storico e politico dello storicismo crociano significa appunto ridurlo alla sua reale portata, spogliandolo della grandezza brillante che gli viene attribuita come di manifestazione di una scienza obbiettiva, di un pensiero sereno e imparziale che si colloca al di sopra di tutte le miserie e le contingenze della lotta quotidiana, di una contemplazione disinteressata dell’eterno divenire della storia umana.
Q8 §40 Rinascimento. Le statue viventi di Cuneo. Uno degli aneddoti cuneesi più graziosi: per la visita di Vittorio Emanuele II, l’amministrazione della città raccolse dai dintorni i giovani fisicamente più prestanti, che ingessati a dovere, furono collocati, prima della sfilata reale, su piedistalli in pose da statue antiche. Nello stesso tempo tutti i gozzuti furono rinchiusi nelle cantine. Al passaggio del re, le «statue» si disposero in ordine, dando l’impressione di un grande spettacolo di bellezza e di arte, ma dalle cantine le voci squarciate dei gozzuti fecero sentire una nota stonata: «Siamo noi i cuneesi, Cuneo siamo noi» ecc. I villaggi di Potiomkin non sono dunque solo una privativa della vecchia Russia feudale e burocratica e interi periodi storici possono essere chiamati dei villaggi di Potiomkin.
Q8 §41 Intellettuali. Cfr Valeria Benetti Brunelli, Il rinnovamento della politica nel pensiero del secolo XV in Italia (Paravia, Torino, 20 lire). Esame del pensiero politico di Leon Battista Alberti. Tentativo di una revisione di alcuni giudizi sull’Umanesimo e il Rinascimento.
Q8 §42 Francia‑Italia. 1°) È realmente mai esistita una francofilia in Italia? Ed erano realmente francofili i radicali‑massoni del «Secolo», che appunto sono giudicati solitamente come spudoratamente francofili? Penso che, analizzando più profondamente, si può trovare che neanche quella corrente fu francofila in senso proprio. La Francia rappresentò un mito per la democrazia italiana, la trasfigurazione in un modello straniero di ciò che la democrazia italiana non era mai riuscita a fare e non si proponeva di fare concretamente, il senso della propria impotenza e inettitudine nell’ambito proprio nazionale. La Francia era la Rivoluzione francese, e non il regime attuale, era la partecipazione delle masse popolari alla vita politica e statale, era l’esistenza di forti correnti d’opinione, la sprovincializzazione dei partiti, il decoro dell’attività parlamentare ecc., cose che non esistevano in Italia, che si agognavano, ma per il cui raggiungimento non si sapeva e non si voleva far nulla di preciso, di coordinato, di continuativo: si mostrava al popolo italiano l’esemplare francese, quasi si aspettasse che il popolo italiano facesse da sé, cioè per iniziativa spontanea di massa, ciò che i francesi avevano raggiunto attraverso una serie di rivoluzioni e di guerre, a costo di torrenti di sangue. Ma non era francofilia nel senso tecnico e politico: anzi c’era, proprio in questi democratici, molta invidia per la Francia e un odio sordo. Francofili sono stati i moderati, che ritenevano un dovere della Francia di aiutare sempre l’Italia come una pupilla e che si sarebbero subordinati alla politica francese: per disillusione si gettarono nelle braccia della Germania.
Q8 §43 Machiavelli. Oltre che dall’esempio delle grandi monarchie assolute di Francia e Spagna, il Machiavelli fu spinto alla sua concezione politica del principato unitario dal ricordo del passato romano, ma non astrattamente, bensì attraverso gli avvenimenti dell’Umanesimo e del Rinascimento: «questa provincia (l’Italia) pare nata per risuscitare le cose morte, come si è visto della poesia, della pittura e della scultura» scrive nell’Arte della guerra, libro VII, perché dunque non ritroverebbe la virtù militare? ecc. Cercare se nel Machiavelli altri accenni del genere.
Q8 §44 Massimario machiavellico. Prendendo come spunto l’affermazione del Foscolo nei Sepolcri che il Machiavelli «temprando lo scettro ai regnatori, gli allor ne sfronda ed alle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue» si potrebbe fare una raccolta di tutte le massime «universali» del Machiavelli e ordinarle commentandole e volgarizzandole opportunamente.
Q8 §45 Nozioni enciclopediche. comandare e obbedire. In che misura sia vero che l’obbedire sia più facile del comandare. Il comandare proprio del caporalismo. L’attendere passivamente gli ordini. Nell’obbedienza c’è un elemento di comando e nel comando un elemento di obbedienza (autocomando e autoobbedienza). Il «perinde ac cadaver» dei gesuiti. Il carattere del comando e dell’obbedienza nell’ordine militare. Bisogna obbedire senza comprendere dove l’obbedienza conduce e a che fine tende? Si obbedisce in questo senso, volentieri, cioè liberamente, quando si comprende che si tratta di forza maggiore: ma perché si sia convinti della forza maggiore occorre che esista collaborazione effettiva quando la forza maggiore non esiste.
Comandare per comandare è il caporalismo; ma si comanda perché un fine sia raggiunto, non solo per coprire le proprie responsabilità giuridiche: «io ho dato l’ordine: non sono responsabile se non è stato eseguito o se è stato eseguito male ecc.; responsabile è l’esecutore che ha mancato».
Il comando del direttore d’orchestra: accordo preventivo raggiunto, collaborazione, il comando è una funzione distinta, non gerarchicamente imposta.
Q8 §46 Nozioni enciclopediche. La concezione melodrammatica della vita. Non è vero che solo in alcuni strati deteriori dell’intelligenza si possa trovare un senso libresco e non nativo della vita. Nelle classi popolari esiste ugualmente la degenerazione «libresca» della vita, che non è solo data dai libri, ma anche da altri strumenti di diffusione della cultura e delle idee. La musica verdiana, o meglio il libretto e l’intreccio dei drammi musicati dal Verdi sono responsabili di tutta una serie di atteggiamenti «artificiosi» di vita popolare, di modi di pensare, di uno «stile». «Artificioso» non è forse la parola propria, perché negli elementi popolari questa artificiosità assume forme ingenue e commoventi. Il barocco, il melodrammatico sembrano a molti popolani un modo di sentire e di operare straordinariamente affascinante, un modo di evadere da ciò che essi ritengono basso, meschino, spregevole nella loro vita e nella loro educazione per entrare in una sfera più eletta, di alti sentimenti e di nobili passioni.
I romanzi d’appendice e da sottoscala (tutta la letteratura sdolcinata, melliflua, piagnolosa) prestano eroi ed eroine; ma il melodramma è il più pestifero, perché le parole musicate si ricordano di più e formano come delle matrici in cui il pensiero prende una forma nel suo fluire. Osservare il modo di scrivere di molti popolani: è ricalcato su un certo numero di frasi fatte.
D’altronde il sarcasmo è troppo corrosivo. Bisogna ricordare che si tratta non di uno snob dilettantesco, ma di qualcosa profondamente sentita e vissuta.
Q8 §47 I negri d’America. Corrispondenza da New York di Beniamino De Ritis nel «Corriere della Sera» del 18 febbraio 1932 (Colonie a contanti?). Tendenze americane di abbinare il problema dei debiti europei con le necessità politico‑strategiche degli Stati Uniti nel mar dei Caraibi: domanda di cessione dei possedimenti europei nelle Antille e anche di colonie africane. L’economista Stephen Leacok ha pubblicato nell’«Herald Tribune» un articolo dove scrive che la cessione del Congo sarebbe sufficiente a pagare l’intero debito di guerra: «un gran sogno diverrebbe realtà. Sei generazioni fa, gli indigeni del Congo vennero in America trasportati come schiavi. Sono passate sei generazioni di storia, di lavoro, di lacrime ed ora milioni di lavoratori educati alle arti e alle scienze dell’uomo bianco potrebbero tornare alla terra da cui partirono schiavi i loro antentati e potrebbero tornarvi liberi, civilizzati. Tutto questo non richiede altro che una nuova sistemazione delle riparazioni e dei debiti sulla base di compensi territoriali».
Q8 §48 Machiavelli. Il moderno Principe. Grande politica e piccola politica. La grande politica abbraccia le quistioni connesse alla fondazione di nuovi Stati e colla lotta per la difesa e la conservazione di una determinata struttura sociale politica. La piccola politica le quistioni parziali e quotidiane che si pongono nell’interno di una struttura già stabilita per le lotte di preminenza tra le diverse frazioni di una stessa classe politica. È invece da dilettanti porre le quistioni in modo tale che ogni elemento di piccola politica non può non diventare quistione di grande politica, di riorganizzazione statale. La politica internazionale ripresenta due forme: 1) la grande politica per le quistioni che riguardano la statura relativa dei singoli Stati nei confronti reciproci; 2) la piccola politica le quistioni diplomatiche minute nell’interno di una organizzazione già consolidata. Il Machiavelli studia solo le quistioni di grande politica: creazione di nuovi Stati, conservazione e difesa delle nuove strutture: quistioni di dittatura e di egemonia su vasta scala, cioè su tutta l’area statale. Il Russo nei Prolegomeni fa del Principe il trattato della dittatura (momento dell’autorità e dell’individuo) e dei Discorsi quello dell’egemonia o del consenso accanto a quello dell’autorità e della forza: certo però l’osservazione è giusta. Così è giusta l’osservazione che non c’è opposizione di principio tra principato e repubblica, ma si tratta piuttosto della ipostasi dei due momenti di autorità e universalità.
Q8 §49 Passato e presente. La frase che «non si rimane a Roma senza idee» che trovasi citata in altra nota, ed è attribuita al Mommsen, è stata pronunciata il 26 marzo 1861 (in Parlamento) da Giuseppe Ferrari, che sosteneva doversi andare a Roma «colle idee proclamate dalla Rivoluzione Francese», che «ci possono redimere dal pontefice perché riscattano la ragione». Nel 1872 (16 dicembre, in Parlamento) il Ferrari osservava che come tante altre cose d’Italia si erano fatte «a poco a poco, lentamente, per una serie di quasi» si era «persino trovato il mezzo di venire a Roma a poco a poco» e aggiungeva: non vorrei «che a poco a poco fossero snaturate le nostre istituzioni e che noi ci trovassimo in un altro mondo: per esempio, nel Medio Evo». Ricordare che dei moderati, Quintino Sella trovava che «bisognava andare a Roma» con un’idea universale, e quest’idea trovava nella «scienza».
Cfr B. Croce, Storia d’Italia, p. 4 (3a ediz.) e nota alla pagina 4, a p. 305. In un articolo del 22 dicembre 1864, all’annunzio della votazione che decide il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, Francesco De Sanctis (nell’«Italia» di Napoli o nel «Diritto»? cercare) scrive: «A Roma noi andiamo per edificarvi la terza civiltà, per farla una terza volta regina del mondo civile. La capitale del mondo pagano e del mondo cattolico è ben degna di essere la capitale dello spirito moderno. Roma dunque è per noi non il passato, ma l’avvenire.
Q8 §50 Nozioni enciclopediche. Epigoni e Diadochi. Qualcuno impiega il termine «Epigoni» in modo abbastanza curioso e ci ricama intorno tutta una teoria sociologica abbastanza bizzarra e sconclusionata. Perché gli Epigoni dovrebbero essere inferiori ai progenitori? Perché dovrebbe essere legato al concetto di Epigono quello di degenerato?
Nella tragedia greca, gli «Epigoni» realmente portano a compimento l’impresa che i «Sette a Tebe» non erano riusciti a compiere. Il concetto di degenerazione è invece legato ai Diadochi, i successori di Alessandro.
Q8 §51 Risorgimento. Accanto ai concetti di Rivoluzione Passiva, di Rivoluzione‑Restaurazione ecc. porre questa affermazione di Giuseppe Ferrari (10 novembre 1864 in Parlamento): «Noi siamo il Governo più libero che abbia mai avuto l’Italia da cinquecento anni; se io esco da questo Parlamento, io cesso di appartenere alla rivoluzione ordinata, legale, ufficiale».
Q8 §52 Machiavelli. Il moderno Principe. La quistione della classe politica (cfr i libri di Gaetano Mosca). Ma nel Mosca la quistione è posta in modo insoddisfacente: non si capisce neanche esattamente cosa il Mosca intenda precisamente per classe politica, tanto la nozione è ondeggiante ed elastica. Pare abbracci tutte le classi possidenti, tutta la classe media; ma quale allora la funzione della classe alta? Altre volte pare si riferisca solo a un’aristocrazia politica al «personale politico» di uno Stato e ancora, a quella parte che opera «liberamente» nel sistema rappresentavo, cioè con esclusione della burocrazia anche nel suo strato superiore, che per il Mosca deve essere controllata e guidata dalla classe politica. La deficienza del Mosca appare nel fatto che egli non affronta nel suo complesso il problema del «partito politico» e si capisce, dato il carattere dei suoi libri e specialmente degli Elementi di scienza politica. L’interesse del Mosca ondeggia tra una posizione «obbiettiva» e disinteressata di scienziato e una posizione appassionata di immediato uomo di parte che vede svolgersi avvenimenti che lo angustiano e ai quali vuole reagire. Le due parti del libro scritte in due momenti tipici della storia politico‑sociale italiana, nel 1895 e nel 1923, mentre la classe politica si disintegra e non riesce a trovare un terreno solido di organizzazione.
Nel moderno Principe la quistione dell’uomo collettivo, cioè del «conformismo sociale» ossia del fine di creare un nuovo livello di civiltà, educando una «classe politica» che già in idea incarni questo livello: quindi quistione della funzione e dell’atteggiamento di ogni individuo fisico nell’uomo collettivo; quistione anche di ciò che è la «natura» del diritto secondo una nuova concezione dello Stato, realistica e positiva.
Anche la quistione della cosidetta «rivoluzione permanente», concetto politico sorto verso il 1848, come espressione scientifica del giacobinismo in un periodo in cui non si erano ancora costituiti i grandi partiti politici e i grandi sindacati economici e che ulteriormente sarà composto e superato nel concetto di «egemonia civile».
La quistione della guerra di posizione e della guerra di movimento, con la quistione dell’arditismo, in quanto connesse con la scienza politica: concetto quarantottesco della guerra di movimento in politica è appunto quello della rivoluzione permanente: la guerra di posizione, in politica, è il concetto di egemonia, che può nascere solo dopo l’avvento di certe premesse e cioè: le grandi organizzazioni popolari di tipo moderno, che rappresentano come le «trincee» e le fortificazioni permanenti della guerra di posizione.
Anche la quistione del valore delle ideologie; polemica Malagodi-Croce; osservazione del Croce sul «mito» del Sorel, che si può ritorcere contro la sua «passione»; le «ideologie» come «strumento pratico» di azione politica devono essere studiate in un trattato di politica.
Q8 §53 Passato e presente. Hegel aveva affermato che la servitù è la culla della libertà. Per Hegel, come per Machiavelli, il «principato nuovo» e la connessa servitù sono giustificati solo come educazione e disciplina dell’uomo non ancora libero. Lo Spaventa (Principi di etica, Appendice, Napoli, 1904) lo interpretava: «Ma la culla non è la vita. Alcuni ci vorrebbero sempre in culla». Lo stesso si potrebbe dire per il protezionismo doganale, che era presentato come una culla, ma la vita diventava poi sempre una culla.
Q8 §54 Passato e presente. La Sardegna. Nel «Corriere della Sera» tre articoli di Francesco Coletti, col titolo generale La Sardegna che risorge, enumerano alcuni dei più importanti problemi sardi e danno un prospetto sommario dei provvedimenti governativi. Il terzo articolo è del 20 febbraio 1932; gli altri due di qualche settimana prima. Il Coletti si è sempre occupato della Sardegna, anche negli anni prima della guerra, e i suoi scritti sono sempre utili, perché ordinati e riassuntivi di molti fatti. Non so se abbia fatto delle raccolte in volume di scritti vecchi. Vedere.
Q8 §55 Nozioni enciclopediche. Self‑government e burocrazia. L’autogoverno è una istituzione o un costume politico‑amministrativo, che presuppone condizioni ben determinate: l’esistenza di uno strato sociale che viva di rendita, che abbia una tradizionale pratica degli affari e che goda di un certo prestigio tra le grandi masse popolari per la sua rettitudine e il suo disinteresse (e anche per alcune doti psicologiche, come quella di saper esercitare l’autorità con fermezza dignitosa, ma senza alterigia e distacco superbioso). Si capisce che perciò l’autogoverno sia stato possibile solo in Inghilterra, dove la classe dei proprietari terrieri, oltre alle condizioni di indipendenza economica, non era stata mai in lotta accanita con la popolazione (ciò che successe in Francia) e non aveva avuto grandi tradizioni militari di corpo (come in Germania), con il distacco e l’atteggiamento autoritario derivanti. Cambiamento di significato dell’autogoverno in paesi non anglosassoni: lotta contro il centralismo dell’alta burocrazia governativa, ma istituzioni affidate a una burocrazia controllata immediatamente dal basso. Burocrazia divenuta necessità: la quistione deve essere posta di formare una burocrazia onesta e disinteressata, che non abusi della sua funzione per rendersi indipendente dal controllo del sistema rappresentativo. Si può dire che ogni forma di società ha la sua impostazione o soluzione del problema della burocrazia, e una non può essere uguale all’altra.
Q8 §56 Machiavelli. Il moderno Principe. La concezione del Croce, della politica‑passione, esclude i partiti, perché non si può pensare a una «passione» organizzata e permanente: la passione permanente è uno stato spasmodico, Esclude il partito ed esclude ogni «piano» d’azione concertato preventivamente. Ma la concezione dovrebbe essere applicabile anche alla guerra e quindi dovrebbe spiegare il fatto degli eserciti permanenti. La guerra è un momento della vita politica, è la continuazione, in altre forme, di una determinata politica: bisogna dunque spiegare come la «passione» possa diventare «dovere» morale di morale politica.
Sui «piani politici», che sono connessi ai partiti, cioè a formazioni permanenti, ricordare ciò che Moltke diceva dei piani militari: che essi non possono essere elaborati e fissati in precedenza in tutti i loro dettagli, ma solo nel loro nucleo e disegno centrale, perché le particolarità dell’azione dipendono in una certa misura dalle mosse dell’avversario. Per Croce tutto ciò dovrebbe essere assurdo, perché appunto nei particolari si manifesta la «passione». Nella critica al Croce vale il concetto che la teoria deve essere d’accordo con la storia, coi fatti della storia, né vale o può valere la posizione negativa di mostrare che una determinata opinione o spiegazione proposta non è filosoficamente valida: questa posizione è uno stadio iniziale della critica, che non può accontentare, perché lascia il problema insoluto.
Q8 §57 Riviste‑tipo. Individualmente nessuno può seguire tutta la letteratura pubblicata su un gruppo di argomenti e neanche su un solo argomento. Il servizio di informazione critica, per un pubblico di mediocre cultura o che si inizia alla vita culturale, di tutte le pubblicazioni sul gruppo di argomenti che più lo possono interessare, è un servizio d’obbligo. Come i governanti hanno una segreteria o un ufficio stampa che periodicamente o quotidianamente li tengono informati di tutto ciò che si pubblica per loro indispensabile da sapere, così una rivista fa per il suo pubblico. Fisserà il suo compito, lo limiterà, ma questo sarà il suo compito: ciò domanda però che si dia un corpo organico e completo di informazioni: limitato, ma organico e completo. Le recensioni non devono essere casuali e saltuarie, ma sistematiche, e non possono non essere accompagnate da «rassegne riassuntive» retrospettive sugli argomenti più essenziali.
Una rivista, come un giornale, come un libro, come qualsiasi altro modo di espressione didattica che sia predisposto avendo di mira una determinata media di lettori, ascoltatori ecc., di pubblico, non può accontentare tutti nella stessa misura, essere ugualmente utile a tutti ecc.: l’importante è che sia uno stimolo per tutti, poiché nessuna pubblicazione può sostituire il cervello pensante o determinare ex novo interessi intellettuali e scientifici dove esiste solo interesse per le chiacchiere da caffè o si pensa che si vive per divertirsi e passarsela buona. Perciò non bisogna turbarsi della molteplicità delle critiche: anzi la molteplicità delle critiche è la prova che si è sulla buona strada; quando invece il motivo di critica è unico, occorre riflettere: 1) perché può trattarsi di una deficienza reale, 2) perché ci si Può essere sbagliati sulla «media» dei lettori ai quali ci si riferisce, e quindi si lavora a vuoto, «per l’eternità».
Q8 §58 Machiavelli. Lo Schopenhauer avvicina l’educazione politica del Machiavelli a quella fornita dal maestro di scherma, che insegna l’arte di ammazzare («e di non farsi ammazzare»), ma non insegna a diventare sicari e assassini.
Q8 §59 Letteratura Popolare. Per le quistioni teoriche cfr Croce, Conversazioni critiche, seconda serie, pp. 237 sgg.: «I romanzi italiani del Settecento» dove lo spunto è preso dal libro di Giambattista Marchesi Studi e ricerche intorno ai nostri romanzieri e romanzi del Settecento, coll’aggiunta di una bibliografia dei romanzi editi in Italia in quel secolo (Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1903).
Q8 §60 Riviste‑tipo. Le recensioni. Ho accennato a diversi tipi di recensione, ponendomi dal punto di vista delle esigenze culturali di un pubblico ben determinato e di un movimento culturale, anch’esso ben determinato, che si vorrebbe suscitare: quindi recensioni «riassuntive», per i libri che si pensa non potranno esser letti e recensioni‑critiche per i libri che si ritiene necessario indicare alla lettura, ma non così, senz’altro, ma dopo averne fissato i limiti e indicato le deficienze parziali ecc. Questa seconda forma è la più importante e scientificamente degna e deve essere concepita come una collaborazione del recensente al tema trattato dal libro recensito. Quindi necessità di recensori specializzati e lotta contro l’estemporaneità e la genericità dei giudizi critici.
Queste osservazioni e sulle riviste‑tipo e su altri motivi di tecnica giornalistica potranno essere raccolte e organate insieme col titolo: Manualetto di tecnica giornalistica.
Q8 §61 Machiavelli. La quistione: che cosa è la politica, cioè quale posto l’attività politica deve avere in una concezione del mondo sistematica (coerente e conseguente), in una filosofia della praxis, è la prima quistione da risolvere in una trattazione sul Machiavelli, perché è la quistione della filosofia come scienza. Progresso fatto fare dal Croce, a questo proposito, agli studi sul Machiavelli e sulla scienza politica, progresso che consiste essenzialmente nella caduta di una serie di problemi falsi e inesistenti. Il Croce si è fondato sulla sua distinzione di momenti dello Spirito, e sull’affermazione di un momento della pratica, di uno spirito pratico, autonomo e indipendente, sebbene legato circolarmente all’intera realtà con la mediazione della dialettica dei distinti. Dove tutto è pratica, in una filosofia della praxis, la distinzione non sarà tra momenti dello Spirito assoluto, ma tra struttura e superstrutture, si tratterà di fissare la posizione dialettica dell’attività politica come distinzione nelle superstrutture, e si potrà dire che l’attività politica è appunto il primo momento o primo grado delle superstrutture, è il momento in cui tutte le superstrutture sono ancora nella fase immediata di mera affermazione volontaria, indistinta ed elementare.
In che senso si può parlate di identità di storia e politica e quindi che tutta la vita è politica. Come tutto il sistema delle superstrutture possa concepirsi come sistema di distinzioni della politica, e quindi introduzione del concetto di distinzione nella filosofia della praxis. Ma si può parlare di dialettica dei distinti? Concetto di blocco storico, cioè di unità tra la natura e lo spirito, unità di opposti e di distinti. Se la distinzione introdotta nelle superstrutture, si introdurrà nella struttura. Come sarà da intendere la struttura: come nel fatto economico si potrà distinguere l’«elemento» tecnica, scienza, lavoro, classe ecc., intesi «storicamente» e non «metafisicamente». Critica della posizione del Croce per cui, polemicamente, la struttura diventa un «dio ascoso», un «noumeno», in contrapposizione alle «apparenze» superstrutturali. «Apparenze» in senso metaforico e in senso positivo. Perché furono «storicamente» chiamate «apparenze»: proprio il Croce ha estratto, da questa concezione generale, la sua particolare dottrina dell’errore e della origine pratica dell’errore. Per il Croce l’errore ha origine in una «passione» immediata, cioè di carattere individuale o di gruppo; ma non può esistere una «passione» di portata storica più larga; la passione‑interesse del Croce, che determina l’errore, è il momento che nelle glosse a Feuerbach si chiama «schmutzig‑jüdisch». Come la passione «schmutzig‑jüdisch» determina l’errore immediato, così la passione del più vasto gruppo sociale determina l’«errore» filosofico (intermedio l’«errore» ‑ ideologia, di cui il Croce tratta a parte): l’importante quindi in questa serie non è l’«egoismo», l’ideologia, la filosofia, ma il termine «errore», cui non sarà da dare un significato moralistico o dottrinario‑metafisico, ma puramente «storico» dialettico, di «ciò che è storicamente caduco e degno di cadere», della «non‑definitività» della filosofia della «morte‑vita», dell’«essere ‑ non essere», cioè del termine dialettico da superare individualmente (morale), come gruppo (nell’interno suo), come società‑storia.
In queste ricerche si può partire dalla stessa posizione assunta dal Marx in confronto di Hegel: in Hegel, si dice nella Sacra famiglia, si può finire col vedere la realtà, anche se essa è capovolta, come, per dir così, si vede nella macchina fotografica, in cui le immagini sono rovesciate e il cielo occupa il posto della terra; basta porre l’uomo sui suoi piedi. Si tratta dunque di prendere la «realtà» crociana e metterla in piedi ecc.
Q8 §62 Machiavelli. Una concezione del diritto penale che dev’essere tendenzialmente rinnovatrice. Non può, pertanto, essere trovata, integralmente, in nessuna dottrina preesistente, sebbene sia sottintesa in molte di esse (ma appunto non può essere sottintesa nella così detta scuola positiva, e particolarmente nelle concezioni del Ferri): in che senso? Nel senso che il diritto penale ha una sua funzione nella vita statale, è in un certo rapporto con gli altri momenti di questa vita, e perciò, se muta il contenuto, non muta il rapporto o la forma relativa. Se ogni Stato tende a creare o a mantenere un certo tipo di civiltà e quindi di convivenza, la giustizia (il diritto) sarà uno strumento per questo fine, deve essere elaborato affinché sia più conforme a questo fine, sia la più efficace e produttiva di risultati positivi. Sarà da liberare da ogni forma di trascendenza e di assoluto, praticamente di fanatismo moralistico, ma non potrà partire dal punto di vista che lo Stato non ha il diritto di punire, se questo termine è ridotto al suo significato umano, e tenersi al solo punto di vista di una lotta contro la «pericolosità». In realtà lo Stato deve essere concepito come «educatore», in quanto appunto tende a creare un nuovo tipo o livello di civiltà; come ciò avviene? Per il fatto che si opera essenzialmente sulle forze economiche, che si riorganizza e si sviluppa l’apparato di produzione economica, che si innova la struttura, non deve trarsi la conseguenza che i fatti di soprastruttura siano abbandonati a se stessi, al loro sviluppo spontaneo, a una germinazione casuale e sporadica. Lo Stato è una «razionalizzazione» anche in questo campo, è uno strumento di accelerazione e taylorizzazione, opera secondo un piano, preme, incita, sollecita ecc. L’aspetto negativo o repressivo di questa attività è appunto la giustizia penale, il diritto penale, che non può essere staccato da tutto il complesso dell’attività positiva o incivilizzatrice. D’altronde, se non si parte da punti di vista astratti, si vede che il «diritto penale» si è ampliato, ha assunto forme originali ed è stato integrato da una attività premiatrice (da una specie di «gogna della vertù», che non è la filistea istituzione pensata da E. Sue).
Q8 §63 Azione Cattolica. Sui letterati cattolici cfr «Il Ragguaglio dell’attività culturale e letteraria dei cattolici in Italia. 1932», Firenze, Edizione del «Ragguaglio», 1932, pp. 490, L. 10. Esce dal 1930. (Prefazione di G. Papini).
Q8 §64 Passato e presente. Il patto di Londra. L’articolo 13 del Patto di Londra stabilisce che, nel caso in cui Francia e Inghilterra avessero aumentato i loro dominii coloniali a spese della Germania, questi due paesi avrebbero riconosciuto come principio che l’Italia avrebbe potuto esigere compensi equi, specialmente nel regolamento delle quistioni concernenti le frontiere delle colonie ecc. La imprecisione e l’ambiguità della formulazione sono connesse al carattere del patto, per cui l’Italia s’impegnava a dichiarare guerra all’Austria e non alla Germania. Questo elemento rimane il fattore centrale della politica estera e di alleanze dell’Italia in quel periodo. Perché si prese questa decisione e come si sapeva dell’atteggiamento che avrebbe preso la Germania? cioè che la Germania non avrebbe, essa, dichiarato guerra all’Italia? Problemi che rimangono ancora insoluti. Elementi per risolverli: 1) il documento Cadorna che Salandra scrive di non aver conosciuto; 2) atteggiamento Salandra‑Sonnino per cui essi non si associano Giolitti, ma pretendono di «fare la storia» da soli, cioè a beneficio del loro partito, senza però riuscire a dominare le forze politiche dominanti del paese; 3) atteggiamento Giolitti nel 1918‑19, cioè movimenti di Giolitti per una Costituente o almeno per limitazione del potere esecutivo, da cui parrebbe che non sono stati mantenuti dei patti o delle promesse fatte a Giolitti dietro le spalle di Salandra e Sonnino.
Q8 §65 Nozioni enciclopediche. Bibliografia. Un Dizionario di Sociologia di Fausto Squillace è stato pubblicato dall’ed. Remo Sandron di Palermo, e il libro ha avuto una seconda edizione interamente rifatta (L. 12). Lo Squillace è scrittore di tendenza sindacalistica, molto superficiale, che non è mai riuscito ad emergere accanto ai suoi sodali.
Q8 §66 Storia delle classi subalterne. Bibliografia. Nelle edizioni Remo Sandron molti libri per questa rubrica. Due direzioni. Il Sandron ha avuto un momento di carattere «nazionale»: ha pubblicato molti libri che riguardano la cultura nazionale e internazionale (edizioni originali di opere del Sorel); ed è editore «siciliano», cioè ha pubblicato libri sulle quistioni siciliane, specialmente legate agli avvenimenti del 93‑94. Carattere positivistico da una parte e dall’altra sindacalistico delle pubblicazioni del Sandron. Molte edizioni esauritissime, da ricercare nell’antiquaria. Pare che la collezione degli scritti di Marx‑Engels‑Lassalle diretta da Ettore Ciccotti, prima che da Luigi Mongini, sia stata iniziata dal Sandron (col Capitale) (vedere questo particolare di storia della cultura). Il libro di Bonomi sulle Vie nuove del socialismo, di A. Zerboglio Il socialismo e le obbiezioni più comuni, di Enrico Ferri Discordie positiviste del socialismo, di Gerolamo Gatti Agricoltura e socialismo (ediz. francese con prefazione di Sorel), di G. E. Modigliani La fine della lotta per la vita fra gli uomini, di A. Loria Marx e la sua dottrina, di E. Leone sul Sindacalismo, di Arturo Labriola su La teoria del valore di Carlo Marx (sul III libro del Capitale), di E. Bruni su Socialismo e diritto privato, di Carlo F. Ferraris su Il materialismo storico e lo Stato ecc. Libri sulla quistione meridionale. Del capitano Francesco Piccoli la Difesa del Dr. Nicola Barbato innanzi al Tribunale di Guerra, pronunziata in Palermo, maggio 1894.
Q8 §67 La Scuola. Cfr C. M. Derada, Gli uomini e le riforme pedagogiche della Rivoluzione Francese. Dall’«ancien régime» alla Convenzione, Remo Sandron, Palermo, L. 7,50.
Q8 §68 Riforma e Rinascimento. Sarà da vedere il libro, molto lodato e apprezzato, di Domenico Guerri, La corrente popolare nel rinascimento. Un modo di porre la quistione falsa è quella di Giulio Augusto Levi che, nella recensione del libro di Luigi Ponnelle e Luigi Bordet, San Filippo Neri e la società del suo tempo (1515‑1595), trad. di Tiro Casini, pref. di Giovanni Papini, Ediz. Cardinal Ferrari (nella «Nuova Italia» del gennaio 1932), scrive: «Volgarmente si pensa che l’umanesimo sia nato e cresciuto sempre nelle stanze dei dotti; ma il Guerri ha ricordato la viva parte che vi prese la piazza; io per la mia parte avevo già rilevato lo spirito popolare di quel movimento nella mia Breve storia dell’estetica e del gusto (2a ed., 1925, pp. 17‑18). Anche, e molto più, la controriforma cattolica si pensa che sia stata opera di prelati e di principi, imposta con rigore di leggi e di tribunali; grande, ma uggiosa (così sembra ai più), è rispettata e non amata. Ma se quel rinnovamento religioso fosse stato operato solo per via di costrizione, come sarebbe nata proprio in quel tempo, in terra cattolica, anzi in Italia, la grande musica sacra? Col terrore delle pene si piegano le volontà, ma non si fanno nascere opere d’arte. Chi vuol vedere quanta freschezza, vivacità, purezza, sublimità d’ispirazione, quanto amore di popolo ci fu in quel movimento, legga la storia di questo santo ecc. ecc.». Il bello è che fa il raffronto tra Sant’Ignazio e Filippo così: «l’uno pensava alla conquista cristiana del mondo intero, l’altro non mirava più lontano del cerchio dove poteva stendersi l’azione sua personale e a malincuore permise il sorgere di una filiale a Napoli». E ancora: «L’opera dei gesuiti ebbe effetti più vasti e più duraturi: quella di Filippo, affidata alle ispirazioni del cuore, dipendeva troppo dalla sua persona: ciò che l’ispirazione fa non può essere né continuato né ripetuto; non si può se non rifare con una ispirazione nuova, la quale è sempre diversa». Appare dunque che Filippo non fa parte della Controriforma, ma è fiorito nonostante la Controriforma, se pure non dovrà dirsi contro di essa.
Q8 §69 Machiavelli. (Bacone ha chiamato i «Re Magi» i tre re che iniziano energicamente le monarchie assolute: Luigi XI di Francia, Ferdinando il cattolico di Spagna e Enrico VII d’Inghilterra. Machiavelli è il teorico dei Re Magi).
Q8 §70 Storia delle classi subalterne. Bibliografia. Nel Catalogo Sandron è contenuto anche un libro di Filippo Lo Vetere sull’agricoltura siciliana. Il Lo Vetere (cfr «Problemi del Lavoro» del 1° febbraio 1932) era della generazione dei Fasci siciliani. Dirigeva una rivista «Problemi Siciliani» che sarà interessante ricercare e vedere. È morto nel settembre 1931. Era del gruppo Rigola.
Q8 §71 Passato e Presente. Quistioni e polemiche personali. A chi giovano? A quelli che vogliono ridurre le quistioni di principio e generali a schermaglie e bizze particolari, a casi di ambizione individuale, a trastulli letterari e artistici (quando sono letterari e artistici). L’interesse del pubblico viene sviato: da parte in causa, il pubblico diventa mero «spettatore» di una lotta di gladiatori che si aspetta i «bei colpi», in sé e per sé: la politica, la letteratura, la scienza vengono degradate a gioco «sportivo». In questo senso occorre perciò condurre le polemiche personali, bisogna cioè ottenere che il pubblico senta che «de te fabula narratur».
Q8 §72 Passato e presente. L’errore degli antiprotezionisti di sinistra (scrittori della «Voce», «Unità», sindacalisti ecc.). Essi impostavano le quistioni come quistioni di principio (scientifico), come scelta di un indirizzo generale della politica statale e anzi nazionale dei governi. Dividevano gli industriali liberisti da quelli protezionisti ecc., invitando a scegliere tra queste due categorie. Ma si potevano esse dividere, oppure i loro interessi non erano già strettamente connessi attraverso le banche e tendevano sempre più a connettersi attraverso i gruppi finanziari e i cartelli industriali? Occorreva quindi, se si voleva creare una forza politica «liberista» efficiente, non proporsi fini irraggiungibili, quali questo di dividere il campo industriale e dare a una parte di esso l’egemonia sulle masse popolari (specialmente sui contadini), ma tendere a creare un blocco fra le classi popolari, con l’egemonia di quella più avanzata storicamente. (Libro di Rerum Scriptor, su Tendenze vecchie e bisogni nuovi del movimento operaio italiano potrebbe essere recensito in tal senso). Infatti Rerum Scriptor e soci ottennero lo scopo meschino di deviare il rancore contadino contro gruppi sociali «innocenti» relativamente ecc.
Q8 §73 Nozioni enciclopediche. Dottrinari ecc. Il carattere «dottrinario» strettamente inteso di un gruppo può essere stabilito dalla sua attività reale (politica e organizzativa) e non dal contenuto «astratto» della dottrina stessa. Un gruppo di «intellettuali» per il fatto stesso che si costituisce in una certa misura quantitativa, mostra di rappresentare «problemi sociali», le condizioni per la cui soluzione esistono già o sono in via di apparizione. Si chiama «dottrinario» perché rappresenta non solo interessi immediati ma anche quelli futuri (prevedibili) di un certo gruppo: è «dottrinario» in senso deteriore quando si mantiene in una posizione puramente astratta e accademica, e alla stregua delle «condizioni già esistenti o in via di apparizione» non si sforza di organizzare, educare e dirigere una forza politica corrispondente. In questo senso i «giacobini» non sono stati per nulla «dottrinari».
Q8 §74 Lorianismo. E. Ferri. Il modo di giudicare la musica e il Verdi di Enrico Ferri è raccontato originariamente dal Croce nelle Conversazioni Critiche (Serie II, p. 314), in un capitoletto sui Ricordi ed affetti di Alessandro D’Ancona pubblicati dai Treves nel 1902 e che sarà apparso nella «Critica» dei primi anni (1903 o 1904): «Noto in quello (“ricordo”) sul centenario del Leopardi una felicissima invettiva contro i critici letterari della cosidetta scuola lombrosiana: invettiva che per altro a me pare ormai superflua, avendo io udito, or è qualche settimana, uno di codesti solenni critici, Enrico Ferri, in una sua commemorazione dello Zola tenuta a Napoli, dichiarare circa la quistione se Verdi sia o no un genio: che egli, Ferri, non intendendosi punto di musica, ossia non essendo esposto alle seduzioni della malia di quell’arte, poteva perciò dare in proposito “un giudizio sulla sua obbiettività sincero” e affermare con pacata coscienza, che il Verdi è un “ingegno” e non un “genio”, tanto vero che suol tenere in perfetto ordine i conti dell’azienda domestica!» L’aneddoto è stato raccontato anche in altra forma: che cioè il Ferri si ritenesse il più adatto a giudicare obbiettivamente e spassionatamente chi fosse più grande genio, Wagner o Verdi, appunto perché non si intendeva affatto di musica.
Q8 §75 I nipotini delpadre Bresciani. Giulio Bechi. Cfr l’articoletto di Croce («I seminatori di G. Bechi») riportato nelle Conversazioni critiche, Serie seconda, pp. 348 sgg. Il Croce dà un giudizio favorevole di questo romanzo e in generale dell’opera letteraria del Bechi, specialmente della Caccia grossa, sebbene distingua tra la parte «programmatica e apologetica» del libro e la parte più propriamente artistica e drammatica. Ma anche Caccia grossa non è essenzialmente un libro da politicante e dei peggiori che si possano immaginare?.
Q8 §76 Lorianesimo. In questa rubrica mi pare di non aver registrato pro‑memoria A. O. Olivetti, che di diritto ci appartiene per ogni rispetto: come inventore di pensamenti genialissimi e come sconnesso e pretensioso erudito da bazar.
Q8 §77 Lorianesimo. G. A. Borgese. «Quasi tutte le guerre e le rivolte in ultima analisi si possono ridurre a secchie rapite; l’importante è vedere che cosa nella secchia vedessero rapitori e difensori». «Corriere della Sera» 8 marzo 1932 (Psicologia della proibizione). L’aureo aforisma del Borgese potrebbe essere citato come commento autentico al libriccino in cui G. A. B. parla delle nuove correnti di opinione scientifica (Eddington) e annunzia che esse hanno dato il colpo mortale al materialismo storico. Si può scegliere: tra l’«ultima analisi» economica e l’«ultima analisi» secchia rapita.
Q8 §78 Machiavelli. Che il programma e la tendenza di collegare la città alla campagna potesse avere nel Machiavelli solo una espressione militare si capisce riflettendo che il giacobinismo francese sarebbe inesplicabile senza la scuola fisiocratica, con la sua dimostrazione dell’importanza economica e sociale del coltivatore diretto. Le teorie economiche del Machiavelli sono state studiate da Gino Arias (negli «Annali di Economia» dell’Università Bocconi): esse non potevano uscire dai quadri del mercantilismo. (Ma anche Rousseau sarebbe stato possibile senza i fisiocrati? ecc. Non mi pare giusto affermare che i fisiocrati abbiano rappresentato i meri interessi agricoli: essi rappresentavano la borghesia in una fase già sviluppata e più ancora come organizzatrice di una società avvenire ben più complessa di quella del tempo: certo non rappresentavano il sistema corporativo e mercantilista ecc. Storicamente i fisiocrati rappresentano appunto la rottura del corporativismo e l’allargamento alla campagna dell’attività economica capitalistica: il loro «linguaggio» è legato al tempo, ed esprime il contrasto immediato tra città e campagna).
Q8 §79 Machiavelli. Grande potenza. Nella nozione di grande potenza (ma di potenza in genere, quindi come elemento sussidiario alla nozione di grande potenza) è da porre anche la «tranquillità interna» cioè il grado e l’intensità della funzione egemonica della classe dirigente. Si potrebbe dire che quanto più forte è la polizia politica e in generale la polizia, e tanto più debole è l’esercito, e quanto più debole (cioè relativamente inutile) la polizia, tanto più forte è l’esercito.
Q8 §80 Le colonie. Studiare se e in che misura le colonie hanno servito per il popolamento, nel senso che il colonialismo sia legato all’esuberanza demografica delle nazioni colonizzatrici. Certo sono andati più inglesi negli Stati Uniti dopo il distacco che quando gli Stati Uniti erano colonia inglese ecc.: più inglesi negli Stati Uniti indipendenti che nelle colonie inglesi ecc. Le colonie hanno permesso un’espansione delle forze produttive e quindi hanno assorbito l’esuberanza demografica di una serie di paesi, ma non c’è stato in ciò influsso del fattore «dominio diretto». L’emigrazione segue leggi proprie, di carattere economico, cioè si avviano correnti migratorie nei vari paesi secondo i bisogni di varie specie di mano d’opera o di elementi tecnici dei paesi stessi. Uno Stato è colonizzatore non in quanto prolifico, ma in quanto ricco di capitale da collocare fuori dei propri confini ecc. Così vedere in quali paesi si sono dirette le correnti migratorie degli Stati senza colonie e quali di questi paesi «potevano» diventare loro colonie (astrattamente). La enorme maggioranza delle emigrazioni tedesca, italiana, giapponese verso paesi non «colonizzabili».
Q8 §81 Nozioni enciclopediche. Lo spirito di corpo. Nel senso migliore del termine potrebbe significare la concordia degli intenti e delle volontà, la compatta unità morale per cui importa che le cose buone siano fatte nell’interesse dell’unico tutto, non importa se dall’uno o dall’altro componente del tutto. Di solito però «spirito di corpo» ha assunto un significato deteriore, cioè di «difesa» del tutto contro le sanzioni per il male fatto dai singoli. E si comprende quale sia la radice della degenerazione: è una falsa comprensione di ciò che è il «tutto». Si assume per «tutto» solo una frazione di esso, una frazione, s’intende, subordinata, e attraverso la «forza» data dallo spirito di corpo, si tende e si tenta di far prevalere la parte (subordinata) al tutto, per esercitare un potere indiretto (se non è possibile quello diretto) e ottenere privilegi. Se si analizza ancora si vede che alla radice di tale spirito di corpo è l’ambizione di una persona o di un piccolo gruppo di persone (che si chiama allora «consorteria», «cricca», «combriccola», «camarilla» ecc.). L’elemento burocratico, civile, ma specialmente militare, ha le maggiori tendenze allo spirito di corpo, che conduce alla formazione di «caste». L’elemento psicologico e morale più forte dello spirito di corpo è il punto di onore, dell’onore del corpo, si intende, che crea le passioni più sviate e deteriori. La lotta contro lo spirito di corpo deteriore è la lotta del tutto contro la parte, della collettività contro le ambizioni dei singoli e contro i privilegi, dello Stato contro le caste e le «associazioni a delinquere».
Q8 §82 I nipotini del padre Bresciani. Ghita, la «ilustre fregona» (novella del Cervantes).
Q8 §83 Passato e presente. Avvenimenti del 1917. Il ministero Salandra cade il 10 giugno 1906 contraccolpo della dichiarazione di guerra alla Germania, mentre durava la minaccia dell’esercito austriaco dal Trentino. Boselli forma il ministero nazionale (vedere atteggiamento dei giolittiani a questo proposito). Il 12 giugno 1917 crisi del ministero: i ministri rimettono al Boselli i loro portafogli, per dargli la possibilità di organizzare meglio l’opera del governo. Contrasti in politica estera e in quella interna: Bissolati e altri osteggiavano la politica di Sonnino, cioè volevano che fossero precisati e mutati i fini della guerra, osteggiavano la politica militare del Cadorna (memoriale Douhet a Bissolati), osteggiavano la politica interna troppo liberale e indulgente verso gli avversari del governo (socialisti, giolittiani, cattolici). Cadorna a sua volta osteggiava la politica interna del governo ecc. È da notare che a Torino comincia a mancare il pane proprio nella seconda metà di giugno (cfr gli articoli della «Gazzetta del Popolo» pubblicati, ma occorrerebbe conoscere se già prima la «Gazzetta del Popolo» abbia voluto intervenire e ne sia stata impedita dalla censura senza che nel giornale apparisse traccia di questi tentativi: forse nell’Archivio di Stato tracce più concrete. Cfr anche l’autodifesa del prefetto Verdinois, che però è scolorita e imprecisa). Il gabinetto Boselli cade il 16 ottobre 1917 alla vigilia di Caporetto.
(Poteva chiamarsi nazionale un governo da cui fosse assente Giolitti? Nel 17 appunto si hanno i frutti della politica Salandra‑Sonnino, che vollero monopolizzare a sé e al loro partito la gloria dell’entrata in guerra e, non impedendo la caccia a Giolitti, determinarono il suo ulteriore atteggiamento).
I memoriali dell’allora colonnello Douhet sono pubblicati nel volume: Giulio Douhet, Le profezie di Cassandra, a cura del generale Gherardo Pàntano, Genova, Soc. Ed. Tirrena, 1931, in 8°, pp. 443. Su questo volume cfr la strabiliante recensione di Giacomo Devoto nel «Leonardo» del febbraio 1932. Il Devoto si domanda: «Ma perché poi critiche così fondate, venendo da un uomo di prim’ordine come era senza dubbio il Douhet, non hanno avuto il successo che in se stesse meritavano?» E risponde: «Non per la malvagità degli uomini, non per il carattere inelastico dell’autore, nemmeno per un destino crudelmente avverso. Le perdite morali e materiali che il deficiente comando ha procurato erano necessarie all’Italia. L’Italia che per lunga abitudine, al primo accenno di sconfitta o di incertezza in una battaglia coloniale perdeva la calma, doveva imparare a sopportare pazientemente prove francamente dure. Una buona metà dei nostri soldati sono stati sacrificati, dal punto di vista militare, inutilmente. Ma come per imparare a bene operare è fatale che prima si erri, così per imparare a sacrificarsi utilmente, un paese deve temprarsi a sacrifizi non proporzionati. Nessuna apologia potrà farci credere che il vecchio comando supremo abbia condotto bene l’esercito. Ma per arrivare a comandare bene, bisogna voler comandare». Bisognerebbe sapere chi è questo signor Giacomo Devoto, se è un militare (un G. Devoto è professore di glottologia all’Università di Padova). Il suo ragionamento rassomiglia a quello dell’on. Giuseppe Canepa, commissario per gli approvvigionamenti nel 1917, che dopo gli avvenimenti di Torino, si giustificò della disorganizzazione del suo servizio, ricordando il «provando e riprovando» dell’Accademia del Cimento. Ma questa è la filosofia di Monsignor Perrelli nel governo dei cavalli. E non si tien conto che la massa dell’esercito non è un corpo vile e passivo per fare tali esperienze, ma reagisce, appunto disfacendosi: perciò è utile sapere chi è il Devoto, se appartiene ai circoli militari e se le sue opinioni sono pure idiosincrasie o concezione diffusa.
Paolo Boselli si potrebbe chiamare la «cicala nazionale». La sua scelta a capo del governo nazionale nel giugno 1916 è il segno della debolezza della combinazione, che si costituisce su un terreno di retorica parolaia e non di realismo politico: sotto il velo dell’unità data dai discorsi del Boselli, il governo era dilaniato da dissidi insanabili e che d’altronde non si voleva sanare, ma solo coprire.
Politica dei giolittiani nel dopoguerra: discorso di Giolitti a Dronero, dove si pone la quistione della soppressione dell’art. 5 dello Statuto, cioè dell’allargamento dei poteri parlamentari contro il potere esecutivo. La caratteristica della politica giolittiana è di non aver coraggio di se stessa (ma che cosa poi si proponeva Giolitti? e non si accontentava poi egli di ottenere appunto solo ciò che ottenne effettivamente, cioè di disperdere il partito salandrino?): i giolittiani vogliono una Costituente senza la Costituente, senza cioè l’agitazione politica popolare che è legata alla convocazione di una Costituente: vogliono che il normale Parlamento funzioni come una Costituente ridotta ai minimi termini, edulcorata, addomesticata. Bisogna ricercare la funzione svolta da Nitti per togliere ancora il residuo di veleno alla parola d’ordine lanciata da Giolitti, per annegarla nel marasma parlamentare: certo è che la quistione della soppressione dell’art. 5 fa la sua comparsa ufficiale in Parlamento, per essere dimenticata. I giolittiani, prima del ritorno di Giolitti al governo, lanciano la parola d’ordine di una «inchiesta politica sulla guerra». Cosa poi significhi di preciso questa formula è difficile capire: ma essa è appunto solo uno pseudonimo della Costituente ridotta voluta da Giolitti, come arma per intimorire gli avversari. È da ricordare che i giolittiani ponevano tutta la loro speranza politica nel Partito Popolare, come partito di massa centrista che avrebbe dovuto (e in realtà servì) servire da strumento per la manovra giolittiana. Articoli di Luigi Ambrosini nella «Stampa», entrata di Ambrosini nel Partito Popolare (cfr alcuni di questi articoli raccolti nel volumetto Fra Galdino alla cerca). È tutto un periodo di storia politica e dei partiti italiani da studiare e da approfondire.
Q8 §84 Machiavelli. Essere e dover essere. Il «troppo» realismo politico ha portato spesso all’affermazione che il politico deve operare solo nella «realtà effettuale», non interessarsi del «dover essere», ma solo dell’«essere». L’errore ha portato Paolo Treves a trovare nel Guicciardini e non nel Machiavelli il «vero politico». Bisogna distinguere tra scienziato della politica e politico in atto. Lo scienziato deve muoversi solo nella realtà effettuale, in quanto mero scienziato. Ma il Machiavelli non è un mero scienziato, è un uomo appassionato, un politico in atto e perciò non può non occuparsi del «dover essere» inteso non moralisticamente. La quistione è più complessa: si tratta di vedere se il «dover essere» sia un atto arbitrario o un fatto necessario, sia volontà concreta, o velleità, desiderio, amore con le nuvole. Il politico in atto è un creatore; ma non crea dal nulla, non trae dal suo cervello le sue creazioni. Si fonda sulla realtà effettuale; ma cos’è questa realtà effettuale? È forse qualcosa di statico e immobile, o non piuttosto una realtà in movimento, un rapporto di forze in continuo mutamento di equilibrio? Applicare la volontà a creare un nuovo equilibrio delle forze, realmente esistenti e operanti, fondandosi sulla forza in movimento progressivo per farla trionfare è sempre muoversi nel terreno della realtà effettuale ma per dominarla e superarla. Il «dover essere» entra in campo, non come astratto e formale pensiero, ma come interpretazione realistica e sola storicistica della realtà, come sola storia in atto o politica. L’opposizione Savonarola- Machiavelli non è l’opposizione tra essere e dover essere, ma tra due «dover essere» quello astratto e fumoso del Savonarola e quello realistico del Machiavelli, realistico anche se non diventato realtà immediata, ché non si può attendere che un individuo e un libro mutino la realtà, ma solo la interpretino e indichino la linea dell’azione. Né il Machiavelli pensava o si proponeva di mutare la realtà ma solo e concretamente di mostrare come avrebber dovuto operare le forze storiche concrete per mutare la realtà esistente in modo concreto e di portata storica. (Il Russo ha accumulato molte parole a questo proposito – nei Prolegomeni – ma il limite e l’angustia del Machiavelli consiste poi solo nell’essere il Machiavelli un singolo individuo uno scrittore e non il capo di uno Stato o di un esercito, che è pure un singolo individuo, ma avente a sua disposizione le forze di uno Stato o di un esercito e non solo eserciti di parole).
Q8 §85 Passato e presente. Quistioni agrarie. «L’agricoltore è risparmiatore: egli sa che la sistemazione del terreno, gli impianti, le costruzioni, sono cose periture e sa che cagioni nemiche, che egli non può dominare, possono fargli perdere il raccolto; non calcola quote d’ammortamento, di reintegro e di rischio, ma accumula risparmio e, nei momenti difficili, ha una resistenza economica che meraviglia chi esamina le situazioni contingenti». (Antonio Marozzi, La razionalizzazione della produzione, «Nuova Antologia», 16 febbraio 1932). È vero che il contadino è un risparmiatore generico e che ciò, in circostanze molto determinate, è una forza; ma bisognerebbe notare a che prezzo sono possibili questi risparmi «generici» resi necessari dall’impossibilità di calcoli economici precisi, e come questi risparmi vengano scremati dalle manovre della finanza e della speculazione.
Q8 §86 Machiavelli. Altro punto da fissare e da svolgere è quello della «doppia prospettiva» nell’azione politica e nella vita statale. Vari gradi in cui può presentarsi la doppia prospettiva, dai più elementari ai più complessi. Ma anche questo elemento è legato alla doppia natura del Centauro machiavellico, della forza e del consenso, del dominio e dell’egemonia, della violenza e della civiltà (della «Chiesa e dello Stato» come direbbe il Croce), dell’agitazione e della propaganda, della tattica e della strategia. Alcuni hanno ridotto la teoria della «doppia prospettiva» a qualcosa di angusto, meschino, banale, cioè a nient’altro che a due forme di «immediatezza» successive l’una all’altra. Invece può avvenire proprio il contrario: che quanto più la prima è «immediatissima», elementarissima, tanto più la seconda può essere lontana, complessa, elevata, cioè può avvenire come nella vita umana, che quanto più il singolo è costretto a difendere la propria esistenza fisica immediata, tanto più sostiene e si pone dal punto di vista di tutti i complessi e più elevati valori dell’umanità.
Q8 §87 relle di cultura giapponese. Cfr altra nota sulle religioni nel Giappone di fronte allo Stato, sulla riforma apportata allo Shintoismo, che mentre da una parte è stato ridotto a religione (o superstizione) popolare, dall’altra è stato privato dell’elemento costituito dal «culto dell’Imperatore», divenuto elemento a se stante e costituito in dovere civico, in coefficente morale dell’unità dello Stato. Studiare come è nata questa riforma, che ha una grande portata e che è legata alla nascita e allo sviluppo del parlamentarismo e della democrazia nel Giappone. Dopo il suffragio allargato (quando e in che forma?) ogni elezione, con gli spostamenti nelle forze politiche dei partiti, e con i cambiamenti che i risultati possono portare nel governo, opera attivamente a dissolvere la forma mentale «teocratica» e assolutista delle grandi masse popolari giapponesi. La convinzione che l’autorità e la sovranità non è posta nella persona dell’imperatore, ma nel popolo, conduce a una vera e propria riforma intellettuale e morale, corrispondente a quella avvenuta in Europa per opera dell’illuminismo e della filosofia classica tedesca, portando il popolo giapponese al livello della sua moderna struttura economica e sottraendolo all’influsso politico e ideologico dei baroni e della burocrazia feudale.
Q8 §88 Nozioni enciclopediche. Vette di comando - leve di comando. Espressioni usate in lingue diverse per dire la stessa cosa. L’espressione «vette di comando» ha forse un’origine di carattere militare; quella «leve di comando» un’origine evidentemente industriale. Nella lotta occorre avere le vette o leve di comando, quelle che si chiamano anche le chiavi della situazione ecc., cioè, quando si hanno forze determinate e limitate, occorre distribuirle in modo da avere in mano le posizioni strategiche che dominano l’insieme della situazione e permettono di guidare lo sviluppo degli avvenimenti. (Un capitano che si acquartierasse nel fondo di una valle e non si preoccupasse di occupare e munire le cime circostanti e i passaggi obbligati, facilmente potrebbe essere circondato, fatto prigioniero o distrutto anche se in prevalenza numerica: un grosso cannone in fondo a un burrone o su una cima ha diversa potenzialità ecc.).
Q8 §89 relle di cultura americana. G. A. Borgese in Strano interludio («Corriere della Sera», 15 marzo 1932) divide la popolazione degli Stati Uniti in quattro strati: la classe finanziaria, la classe politica, l’Intelligenza, l’Uomo comune. L’Intelligenza è minuscola all’estremo, in confronto alle prime due: alcune decine di migliaia, accentrate specialmente nell’East, fra cui qualche migliaio di scrittori. «Non si giudichi soltanto dal numero. Essa è spiritualmente fra le meglio attrezzate del mondo. Uno che ne fa parte la compara a ciò che fu l’Enciclopedia nella Francia del Settecento. Per ora, a chi non ami esorbitare dai fatti, essa appare un cervello senza membra, un’anima priva di forza operante; la sua influenza sulla cosa pubblica è presso che nulla». Osserva che dopo la crisi, la classe finanziaria che prima padroneggiava la classe politica, in questi ultimi mesi ne ha «subito» il soccorso, virtualmente un controllo. «Il Congresso sorregge la banca e la borsa; il Campidoglio di Washington puntella Wall Street. Ciò mina l’antico equilibrio dello Stato americano; senza che un nuovo ordine sorga». Poiché in realtà classe finanziaria e classe politica sono in America la stessa cosa, o due aspetti della stessa cosa, il fatto significherebbe solo che è avvenuta una vera e propria differenziazione, cioè che la fase economico‑corporativa della storia americana è in crisi e si sta per entrare in una nuova fase: ciò apparirà chiaramente solo se si verifica una crisi dei partiti storici (repubblicano e democratico) e la creazione di qualche potente nuovo partito che organizzi permanentemente la massa dell’Uomo Comune. I germi di tale sviluppo esistevano già (partito progressista), ma la struttura economico‑corporativa ha finora sempre reagito efficacemente contro di essi.
L’osservazione che l’Intelligenza americana ha una posizione storica come quella dell’Enciclopedia francese nel 700 è molto acuta e può essere sviluppata.
Q8 §90 Nozioni enciclopediche. La macchina. Articolo di Metron, La diffusione della macchina, nel «Corriere della Sera» del 15 marzo 1932. Significato più largo del concetto di macchina: in Oriente è macchina sia il rasoio di sicurezza che l’automobile. In Occidente si chiama macchina sia l’«ordegno» per cucire e per scrivere che il motore elettrico e la macchina a vapore. Per Metron sono cose diverse: per lui la macchina vera e propria è quella «che permette la utilizzazione delle energie naturali» (formula equivoca, perché anche il rasoio di sicurezza e la leva di Archimede permettono di utilizzare energie naturali prima non utilizzate), le altre sono, a voler parlare con esattezza, soltanto «utensili o trasmissioni». «Le macchine utensili migliorano, rendono più perfetto il lavoro umano; le macchine motrici si sostituiscono del tutto ad esso. La vera rivoluzione nel mondo si deve non alle macchine che, come quella per scrivere o per cucire, hanno pur sempre bisogno del motore uomo, ma a quelle macchine che eliminano del tutto lo sforzo muscolare».
Osserva Metron: «Secondo i calcoli contenuti in uno studio pubblicato in occasione della Conferenza mondiale dell’energia tenuta il 1930 a Berlino, l’energia meccanica di ogni provenienza (carbone, oli minerali, cadute d’acqua ecc.) consumata nel corso di un anno dall’umanità intera si può valutare a circa un trilione e 700 miliardi di chilowattora, cioè 900 chilowattora per persona. Orbene 900 chilowattora rappresentano pressoché dieci volte il lavoro che un uomo robusto può fare in un anno. In sostanza per ogni uomo di carne ed ossa e a suo benefizio hanno lavorato dieci altri uomini metallici. Se questo processo dovesse continuare, non potrebbe portare ad altro che a una forma ideale di ozio, non l’ozio che abbrutisce, ma quello che eleva: cioè la forza muscolare lasciata completamente a disposizione dell’uomo che dovrebbe lavorare solamente di cervello, vale a dire nella forma più nobile e più ambita». Ciò è scritto nel 1932, cioè quando, proprio nei paesi dove «gli uomini metallici» lavorano per gli altri uomini in proporzione enormemente superiore alla media mondiale, esiste la più terribile crisi di ozio forzato e di miseria degradante. Anche questo è un oppio della miseria!
In realtà la distinzione fatta da Metron tra macchine motrici e macchine utensili, con la prevalenza rivoluzionaria delle prime, non è esatta: le macchine motrici hanno «allargato» il campo del lavoro e della produzione, hanno reso possibili cose che prima della loro scoperta erano impossibili o quasi. Le macchine utensili però sono quelle che realmente hanno sostituito il lavoro umano, e hanno sconvolto tutta l’organizzazione umana della produzione. Osservazione giusta: che dal 1919 in poi la innovazione di maggior portata è l’introduzione nelle officine del trasporto meccanico del materiale, degli uomini e dei convogliatori.
La quistione d’altronde della prevalenza delle macchine motrici o di quelle utensili è oziosa fuori di certi limiti: importa per stabilire il distacco dall’antichità alla modernità. D’altronde anche nelle macchine utensili differenziazioni ecc.
Q8 §91 Confalonieri. Silvio d’Amico, in un capitolo del suo
libro Certezze
(Treves‑Treccani‑Tuminelli, di prossima pubblicazione; il
capitolo è riportato dai giornali del 16 marzo 1932, «Resto del
Carlino») scrive che in una raccolta del museo dello Spielberg è
conservata la «supplica rivolta a … Francesco I dal conte
Confalonieri di Milano entrato in carcere, come si sa, fiorente
di gagliardissima giovinezza: egli scrive all’Imperatore come un
uomo fiaccato, chiedendo grazia e pietà. Documento spaventevole,
dico, perché anche lasciando la debita parte alle forme servili
del tempo (? da parte del Confalonieri?), di fatto qui le parole
imploranti denunciano una violazione spirituale cento volte più
turpe di una condanna a morte, gemono la disfatta di una tempra
spezzata in due: non è più il baldo patrizio che parla, è il
fanciullo che un gigante ha costretto a scrivere a proprio
talento, schiacciandogli l’esile mano nel pugno d’acciaio, è il
meschinissimo che è stato stordito e ubbriacato per vederlo
delirare». Scrive il D’Amico che questo museo dello Spielberg è
stato messo insieme, col permesso del governo ceco, dal dottor
Aldo Zaniboni, un medico italiano che viveva o vive ancora a
Brno. Avrà fatto qualche pubblicazione in proposito? E questa
supplica del Confalonieri è stata pubblicata?1
Q8 §92 Passato e presente. Nazionalizzazioni. Cfr l’articolo di A. De Stefani nel «Corriere» del 16 marzo 32 (La copertura delle perdite): «Anche in tempi ordinari negli attuali regimi protezionistici, è tutta la Nazione che concorre a pareggiare sistematicamente i bilanci delle aziende e a formare i loro utili… Il problema della copertura delle perdite di un’azienda è appunto quello della loro ripartizione oltre la cerchia che dovrebbe direttamente sopportarle a termine del diritto comune: i proprietari (azionisti), i creditori (prestatori di danaro, prestatori d’opera e fornitori). Tale processo potrebbe chiamarsi, nei casi in cui lo Stato provvede a coprire le perdite di un’azienda, un processo di nazionalizzazione delle perdite, un’estensione del principio del risarcimento dei danni di guerra e degli infortuni naturali». Che si nazionalizzino le perdite e non i profitti, che si risarciscano i danni creati dalla speculazione (voluta) ma non dalla disoccupazione (involontaria) non fa ridere il De Stefani.
Q8 §93 Risorgimento italiano. Nesso 1848‑49. Su Carlo Alberto e i tentativi fatti nel 1931 per modificare il giudizio tradizionale (sfavorevole) cfr lo studio di Pietro Silva nella «Cultura» dell’agosto‑settembre 1931.
Q8 §94 Nozioni enciclopediche. Homo homini lupus. Fortuna avuta da questa espressione nella scienza politica, ma specialmente nella scienza politica dei filistei da farmacia provinciale. Pare che l’origine della formula sia da trovarsi in una più vasta formula dovuta agli ecclesiastici medioevali, il latino grosso: Homo homini lupus, foemina foeminae lupior, sacerdos sacerdoti lupissimus.
Q8 §95 Cattolici integrali – gesuiti – modernisti. Nelle memorie di Alfred Loisy si troveranno elementi per questa rubrica: Alfred Loisy, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique de notre temps, pubblicato nel 1930 o 31 (circa 2000 pp. in 8°).
Q8 §96 Passato e presente. Giolitti. Nella commemorazione di Giolitti (morto il 17 luglio 1928) scritta per il «Journal des Débats», Maurice Pernot dice: «Egli prese come punto di partenza un’idea originale e forse giusta: nel momento in cui in Italia si delineavano due forze nuove, cioè una borghesia intraprendente e una classe operaia organizzata, bisognava sostituire ai vecchi Governi di partito un Governo d’opinione pubblica e far partecipare queste due forze alla vita politica del Paese». L’affermazione non è esatta né in generale né in alcuni particolari. Cosa vuol dire «sostituire ai governi di partito un governo d’opinione pubblica?» Significa sostituire al governo di «certi» partiti, il governo di «altri» partiti. Nel caso concreto, in Italia, significava distruggere le vecchie consorterie e cricche particolaristiche, che vivevano parassitariamente sulla polizia statale che difendeva i loro privilegi e il loro parassitismo e determinare una più larga partecipazione di «certe» masse alla vita statale attraverso il Parlamento. Bisognava, per Giolitti, che rappresentava il Nord e l’industria del Nord, spezzare la forza retriva e asfissiante dei proprietari terrieri, per dare alla nuova borghesia più largo spazio nello Stato, e anzi metterla alla direzione dello Stato. Giolitti ottenne questo con le leggi liberali sulla libertà di associazione e di sciopero ed è da notare come nelle sue Memorie egli insista specialmente sulla miseria dei contadini e sulla grettezza dei proprietari. Ma Giolitti non creò nulla: egli «capì» che occorreva concedere a tempo per evitare guai peggiori e per controllare lo sviluppo politico del paese e ci riuscì. In realtà Giolitti fu un grande conservatore e un abile reazionario, che impedì la formazione di un’Italia democratica, consolidò la monarchia con tutte le sue prerogative e legò la monarchia più strettamente alla borghesia attraverso il rafforzato potere esecutivo che permetteva di mettere al servizio degli industriali tutte le forze economiche del paese. È Giolitti che ha creato così la struttura contemporanea dello Stato Italiano e tutti i suoi successori non hanno fatto altro che continuare l’opera sua, accentuando questo o quell’elemento subordinato.
Che Giolitti abbia screditato il parlamentarismo è vero, ma non proprio nel senso che sostengono molti critici: Giolitti fu antiparlamentarista, e sistematicamente cercò di evitare che il governo diventasse di fatto e di diritto un’espressione dell’assemblea nazionale (che in Italia poi era imbelle per l’esistenza del Senato così come è organizzato); così si spiega che Giolitti fosse l’uomo delle «crisi extraparlamentari». Che il contrasto tra il Parlamento come si pretendeva fosse e come era realmente, cioè poco meno di nulla, abbia screditato il parlamentarismo, era inevitabile avvenisse: ma è la lotta contro il parlamentarismo da parte di Giolitti e non l’essere egli parlamentarista, che ha screditato il parlamentarismo. (Un gesto «parlamentarista» di Giolitti fu quello fatto col discorso di Cuneo sull’art. 5 dello Statuto, ma si trattò di una manovra per sgominare gli avversari politici; infatti Giolitti non ne fece nulla quando andò al potere).
Q8 §97 Passato e presente. Una riflessione che si legge spesso è quella che il cristianesimo si sia diffuso nel mondo senza bisogno dell’aiuto delle armi. Non mi pare giusto. Si potrà dire così fino al momento in cui il cristianesimo non fu religione di Stato (cioè fino a Costantino), ma dal momento in cui divenne il modo esterno di pensare di un gruppo dominante, la sua fortuna e la sua diffusione non può distinguersi dalla storia generale e quindi dalle guerre; ogni guerra è stata anche guerra di religione, sempre.
Q8 §98 I nipotini delpadre Bresciani. G. Papini. Nel marzo 1932 Papini ha scritto un articolo nella «Nuova Antologia» (contro Croce) e uno sul «Corriere della Sera» sull’Edipo di A. Gide. Ho letto finora solo quest’ultimo: è raffazzonato, prolisso, pomposo e vuoto. Nel marzo devono essere nominati i nuovi Accademici che devono completare i seggi dell’Accademia d’Italia: i due articoli sono evidentemente la «tesi» e la «tesina» di laurea di G. Papini.
Q8 §99 Passato e presente. Ho letto riportato un brano del «Tevere» in cui il prof. Orestano, che rappresenta la filosofia italiana nell’Accademia, è chiamato «ridicolo» personaggio o qualcosa di simile. E il «Tevere» ha una certa importanza nel mondo culturale odierno. Ma come tuttavia si aspettano che l’Accademia d’Italia unifichi e centralizzi la vita intellettuale e morale della nazione?
Q8 §100 Passato e presente. Il rutto del pievano e altre strapaesanerie. Cesare De Lollis (Reisebilder, pp. 8 e sgg.) scrive alcune interessanti sui rapporti tra «minoranza» che fece l’Italia e popolo: «… non molti giorni or sono mi capitò di leggere in un giornale quotidiano che da tempo l’Italia si dava troppo pensiero delle scuole elementari e popolari in genere (tra i principali responsabili si designava il Credaro), laddove è l’educazione delle classi superiori che bisogna curare nell’interesse vero della nazione. Or con questo si torna o si vorrebbe tornare al concetto dell’educazione come privilegio di classe; concetto del tutto ancien régime, la controriforma compresa, che si guardò bene anch’essa dall’avvicinare la cultura alla vita, e quindi al popolo. Eppure: perché la nazione sia stilizzata in una vera unità, occorre che quanti la compongono si ritrovin tutti in un certo grado di educazione. Le classi inferiori devono nelle superiori ravvisare i tratti della perfezione conseguita; queste devono in quelle riconoscere la perfettibilità. … Ora, che si sia fatto molto in questo senso non potran dire che i superficiali osservatori o i retori che empiono la bocca propria e la testa degli altri di paroloni come “stirpe” e “gente”, paroloni i quali tendono, conferendo titoli di nobiltà ereditaria, ad abolire il senso dello sforzo e del dovere personale, così come l’ammirazione ora di moda, e tutta romantica, del costume e dei costumi locali tende a immobilizzare e cristallizzare, invece che incitare sulla via del progresso». (È acuto l’accostamento implicito tra lo strapaesanismo e la cultura privilegio di classe).
Fatto affine è quello dei nomi delle strade (cfr Corrado Ricci, I nomi delle strade, Nuova Antologia del 1° marzo 1932): il Ricci, nel giugno 1923, al senato, discutendosi un decreto relativo ai mutamenti di nomi delle strade e delle piazze comunali, propose che si facesse una revisione dei nomi vecchi e nuovi, per vedere se non convenisse, in diversi casi, tornare all’antico. (Ciò che avvenne in molti casi, e il fatto che talvolta fu opportuno, non toglie niente al significato dell’indirizzo).
Così le diverse «Famiglie» meneghina, torinese, bolognese ecc. che prosperano in questo stesso periodo. Tutti tentativi di immobilizzare e cristallizzare ecc.
Q8 §101 Passato e presente. Parlamento italiano. Vedere per quale preciso movimento politico si interpretò lo Statuto in modo da allargare la funzione e le attribuzioni del Parlamento. In realtà la formazione di un governo che emanava dal Parlamento, si costituiva in Gabinetto con un proprio Presidente ecc., è pratica che s’inizia fin dai primi tempi dell’era costituzionale, è il modo «autentico» di interpretare lo Statuto. Solo più tardi, per dare una soddisfazione ai democratici, fu data a questa interpretazione una tendenziosità di sinistra (forse le discussioni politiche al tempo del proclama di Moncalieri possono servire per provare la giustezza di questa analisi). Per iniziativa della destra si giunge a una contrapposizione della lettera dello Statuto a quella che ne era sempre stata la pratica normale e indiscussa (articolo di Sonnino Torniamo allo Statuto nella Nuova Antologia del 1° gennaio 1897, e la data è da ritenere perché prelude al conato reazionario del 98) e questa iniziativa segna una data perché rappresenta il manifesto della formazione consortesca che si va organizzando, che per circa 20 anni non riesce mai a prendere e mantenere il potere stabilmente, ma che ha una parte fondamentale nel governo «reale» del paese. Si può dire che a mano a mano che illanguidisce la tendenza per domandare una Costituente democratica, una revisione dello Statuto in senso radicale, si rafforza la tendenza «costituentesca» alla rovescia, che dando un’interpretazione restrittiva dello Statuto minaccia un colpo di Stato reazionario.
Q8 §102 Passato e presente. Cfr Gioacchino Volpe, 23 marzo 1919: 27 ottobre 1922, nel «Corriere della Sera» del 22 marzo 1932 (in occasione dell’anniversario della fondazione del Fascio di Milano). Articolo interessante e abbastanza comprensivo. Sarà da fare una bibliografia di tutti gli scritti del Volpe sugli avvenimenti del dopoguerra: alcuni sono già raccolti in volume. Nel «Corriere» del 23 marzo è uscito un secondo articolo del Volpe, Fascismo al Governo: 1922‑1932, molto meno interessante del primo, ma con elementi voli: è evidente il tentativo di scrivere non da apologeta puro, ma da critico che si pone da un punto di vista storico, ma non pare molto riuscito.
Q8 §103 Sulla Cina. M. T. Z. Tyan, Two years of nationalist China, Kelly and Walsh, Shangai (del 1930 o 31). Opera documentaria (di circa 500 pp.) che pare sia molto interessante e ben fatta. Storia di due anni. Kuomintang, organizzazione del Governo Nazionalista, statistiche sulla vita cinese, appendice di documenti.
L’autore è direttore del «The Peking Leader» quotidiano e della «The Chinese Social and Political Review», uno dei giornalisti politici cinesi più abili e più preparati.
Q8 §104 I nipotini delpadre Bresciani. A. Luzio. Articolo di A. Luzio nel «Corriere della Sera» del 25 marzo 1932 (La morte di Ugo Bassi e di Anita Garibaldi) in cui si tenta una riabilitazione del padre Bresciani. Le opere del Bresciani «al postutto non possono, quanto al contenuto, venir liquidate con sommarie condanne». Il Luzio pone insieme il saggio del De Sanctis con un epigramma del Manzoni (il quale, interrogato se conoscesse l’Ebreo di Verona, avrebbe risposto, secondo il diario di Margherita di Collegno: «Ho letto i due primi periodi; paiono due sentinelle che dicano non andate avanti») e poi chiama «sommarie» le condanne; non c’è del gesuitico in questo furbo giocherello?
E ancora: «Non simpatico certo è il tono con cui egli, portavoce della reazione susseguita ai moti del ’48‑49, rappresentava e giudicava gli assertori delle aspirazioni nazionali: ma in più d’uno dei suoi racconti, sopratutto nel Don Giovanni ossia il Benefattore occulto (volumi 26‑27 della “Civiltà Cattolica”), non mancano accenti di umana e cristiana pietà per le vittime; parziali episodi vengono equamente messi in bella luce, per esempio la morte di Ugo Bassi e la straziante fine di Anita Garibaldi». Ma forse che il Bresciani poteva far diversamente? Ed è proprio vole, per giudicare il Luzio, che egli dia per buono al Bresciani proprio il suogesuitismo e la sua demagogia di bassa lega.
Q8 §105 I nipotini di padre Bresciani. Papini come apprendista gesuita. L’articolo di Papini nella «Nuova Antologia» del 1° marzo 1932 (Il Croce e la Croce) mi pare dimostri che anche come gesuita il Papini non sarà mai più che un modesto apprendista. Questo è un vecchio somaro che vuole continuare a fare il somarello nonostante il peso degli anni e gli acciacchi e sgambetta e saltella turpemente. Mi pare che la caratteristica di questo articolo sia l’insincerità. Vedere come il Papini inizi l’articolo coi soliti lazzi stereotipati e meccanici contro il Croce e come verso la fine, facendo l’agnello pasquale, annunzi untuosamente che nella raccolta delle sue opere, gli scritti sul Croce saranno espurgati di ogni «piacevolezza» e apparirà solo la discussione «teorica». L’articolo è scritto di getto, si vede, e nel corso della scrittura il Papini ha cambiato atteggiamento, ma non si è curato d’intonare i latrati delle prime pagine ai belati delle ultime: il letterato soddisfatto di sé e dei colpi di fioretto, che egli crede azzeccati, è sempre superiore al pseudocattolico, ma anche al gesuita, ahi lui! e non ha voluto sacrificare il già scritto. Ma tutto lo scritto appare impacciato, tirato, costruito meccanicamente, come una ciliegia tira l’altra, specialmente la seconda parte, in cui l’ipocrisia traspare in modo repugnante. Mi pare però che Papini appaia ossessionato dal Croce: il Croce ha in lui la funzione della coscienza, delle «mani insanguinate» di lady Macbeth, e che egli reagisca a questa ossessione ora facendo lo spavaldo, tentando lo scherzo e lo sfottimento, ora piagnucolando miseramente. Lo spettacolo è sempre pietoso. Lo stesso titolo dell’articolo è sintomatico: che il Papini si serva della «Croce» per fare dei bisticci testimonia della qualità letteraria del suo cattolicesimo.
Q8 §106 Passato e presente. La lingua italiana a Malta. La difesa della lingua e della cultura italiana a Malta, come appare dagli avvenimenti dei primi mesi del 1932 (cfr articolo del «Corriere della Sera» del 25 marzo 1932), è stata resa più difficile dall’esistenza del Concordato. Finché lo Stato italiano era in conflitto con la Chiesa, l’esistenza di una italianità organizzata a Malta (come in molti altri paesi del mondo) non rappresentava un pericolo per gli Stati egemonici: essa difficilmente poteva svilupparsi nella sfera nazionale e politica; rimaneva nella sfera del folclore e delle culture dialettali. Col Concordato, la quistione è cambiata: la Chiesa, amministrata da italiani e rappresentata localmente da italiani, non più in conflitto con lo Stato, in realtà si confonde con lo Stato italiano e non più col ricordo folcloristico della cosmopoli cattolica. Ecco dunque che il Concordato, invece di facilitare un’espansione di cultura italiana, la rende più difficile non solo, ma ha creato la situazione per una lotta contro i nuclei di italianità tradizionali. Così appare che nel mondo moderno un imperialismo culturale e spirituale è utopistico: solo la forza politica, fondata sull’espansione economica, può essere la base per un’espansione culturale.
Q8 §107 Nozioni enciclopediche. Reich. Per il significato del termine Reich, che non significa affatto «impero» (ho visto che in «Gerarchia» è talvolta stato tradotto addirittura con «regno»), osservare che esso esiste in tutte le lingue germaniche e appare nel termine corrispondente a Reichstag nelle lingue scandinave ecc.; appare realmente che Reich è termine germanico per indicare genericamente lo «Stato» territoriale.
Q8 §108 La burocrazia. Mi pare che dal punto di vista economico‑sociale il problema della burocrazia e dei funzionari occorra considerarlo in un quadro molto più vasto: nel quadro della «passività» sociale, passività relativa, e intesa dal punto di vista dell’attività produttiva di beni materiali. Cioè dal punto di vista di quei particolari beni o valori che gli economisti liberali chiamano «servizi». In una determinata società quale è la distribuzione della popolazione per rispetto alle «merci» e per rispetto ai «servizi»? (E s’intende «merci» in senso ristretto, di «merci» materiali, di beni fisicamente consumabili come «spazio e volume»). È certo che quanto più è estesa la parte «servizi» tanto più una società è male organizzata. Uno dei fini della «razionalizzazione» è certo quello di restringere al mero necessario la sfera dei servizi. Il parassitismo si sviluppa specialmente in questa sfera. Il commercio e la distribuzione in generale appartengono a questa sfera. La disoccupazione «produttiva» determina «inflazione» di servizi (moltiplicazione del piccolo commercio).
Q8 §109 Gli intellettuali. Latino ecclesiastico e volgare nel MedioEvo. «La predicazione in lingua volgare risale in Francia alle origini stesse della lingua. Il latino era la lingua della Chiesa: così le prediche erano fatte in latino ... ai chierici (cleres), ai frati, anche alle monache. Ma per i laici le prediche erano fatte in francese. Fin dal IX secolo, i concilii di Tours e di Reims ordinano ai preti d’istruire il popolo nella lingua del popolo. Ciò era necessario per essere compresi. Nel secolo XII vi fu una predicazione in volgare, attiva, vivace, potente, che trascinava grandi e piccoli alla crociata, riempiva i monasteri, gettava in ginocchio e in tutti gli eccessi della penitenza intere città. Dall’alto dei loro pulpiti, sulle piazze, nei campi, i predicatori erano i direttori pubblici della coscienza degli individui e delle folle; tutto e tutti passano sotto la loro aspra censura, e dalle sfrontate acconciature delle donne nessuna parte segreta o visibile della corruzione del secolo sconcertava l’audacia del loro pensiero o della loro lingua» (Lanson, Storia della letteratura francese, Hachette, 19° ed., pp. 160‑61). Il Lanson dà questi dati bibliografici: abbé L. Bourgain, La Chaire française au XII e siècle, Parigi, 1879; Lecoy de la Marche, La Chaire française ou moyen âge, 2e ed., Paris, 1886; Langlois, L’Éloquence sacrée au moyen âge, «Revue des Deux Mondes», 1° gennaio 1893.
Q8 §110 Giornalismo. La rassegna della stampa. Nel giornalismo
tradizionale italiano la rubrica della «rassegna della stampa» è
sempre stata poco sviluppata, nonostante che in esso la parte
polemica abbia sempre avuto una funzione spesso esorbitante: ma
appunto si trattava di polemica spicciola, occasionale, legata
più al temperamento litigioso dell’individualismo italiano che a
un disegno programmatico di rendere un servizio al pubblico dei
lettori.
Occorre distinguere tra la rassegna della stampa dei giornali d’informazione e quella dei giornali d’opinione: la prima è anch’essa un servizio d’informazione, cioè il giornale dato offre quotidianamente ai suoi lettori ordinati e rubricati i giudizi sugli avvenimenti in corso pubblicati dagli altri giornali (così fanno molti giornali francesi: i giornali italiani danno queste informazioni nei servizi da Roma per i giornali della capitale ecc., cioè nel corpo del giornale stesso e come notizie a se stanti); nei giornali d’opinione la rubrica ha un’altra funzione: serve per ribadire i propri punti di vista, per sminuzzarli, per presentarne, in contradditorio, tutte le faccette e tutta la casistica. Appare quanto sia utile «didatticamente» questo modo di «ripetere» non meccanicamente e senza pedanteria le proprie opinioni: la «ripetizione» acquista un carattere quasi «drammatico» e di attualità, come obbligo di replicare a un avversario. A mia conoscenza la migliore «rassegna della stampa» è quella dell’«Action Française» tanto più se si considera come rassegna della stampa (come è in realtà) anche il quotidiano articolo di Maurras. Si vede che tra lo scritto di Maurras e la «rassegna della stampa» propriamente detta dell’«Action Française» c’è una divisione di lavoro: Maurras si attribuisce i «pezzi» polemici di maggiore importanza teorica. È da osservare che la rassegna della stampa non può essere lasciata a uno scagnozzo qualsiasi di redazione, come fanno spesso alcuni giornali: essa domanda il massimo di responsabilità politica e intellettuale e il massimo di capacità letteraria e di inventività negli spunti, nei titoletti ecc. poiché le ripetizioni, necessarie, dovrebbero essere presentate col massimo di varietà formale ed esteriore. (Esempio degli Scampoli di G. M. Serrati che, a loro modo, erano una rassegna della stampa: molto letti, forse la prima cosa che il lettore cercava ogni giorno, sebbene non fossero sistematici e non sempre di un alto livello intellettuale; le Opinioni del Missiroli nel «Resto del Carlino» e nella «Stampa» – in volume – così la rubrica del «fromboliere» del «Popolo d’Italia», la Dogana in «Critica fascista», la Rassegna della Stampa nell’«Italia Letteraria»).
Q8 §111 Religione. La contraddizione creata dagli intellettuali che non credono, che sono giunti all’ateismo e a «vivere senza religione» attraverso la scienza o la filosofia, ma sostengono che la religione è necessaria per la organizzazione sociale: la scienza sarebbe contro la vita, ci sarebbe contraddizione tra scienza e vita. Ma come il popolo può amare questi intellettuali, ritenerli elementi della propria personalità nazionale?
La situazione si riproduce nel Croce, sebbene meno scandalosamente di ciò che sia avvenuto per alcuni intellettuali francesi (il Taine è classico per ciò e ha creato i Maurras del nazionalismo integrale). Mi pare che il Croce accenni in qualche parte sdegnosamente al Disciple di Bourget, ma non è proprio questo l’argomento trattato dal Bourget, sia pure con quel consequenziarismo razionalistico proprio della cultura francese?
Posizione del Kant tra la Critica della ragion pura e la Critica della ragion pratica per ciò che riguarda Dio e la religione.
Q8 §112 La storia come storia della libertà e il liberalismo. L’equivoco in cui si mantiene la più recente storiografia del Croce è appunto basato su questa confusione tra la storia come storia della libertà e la storia come apologia del liberalismo. Se la storia è storia della libertà – secondo la proposizione di Hegel – la formula è valida per tutta la storia del genere umano e ogni corrente, ogni partito sono espressioni della libertà. Qual è quindi la caratteristica particolare della storia del secolo XIX? Che in questo secolo esiste una coscienza critica prima inesistente: si fa la storia, sapendo quello che si fa, si sa che la storia è storia della libertà. Ma si tratta solo di una posizione speculativa o contemplativa? Certo no: esiste una corrente di attività pratica, un partito, che riduce la filosofia hegeliana a «ideologia politica» immediata, a strumento di dominio e d’egemonia sociale e questo è il «liberalismo» o partito liberale in senso largo. È noto che l’accezione del termine «liberale» è stata molto larga ed ha abbracciato campi politici antitetici. Negli Annali d’Italia di Pietro Vigo sono «liberali» tutti i «non clericali» e il liberalismo comprende anche gli Internazionalisti e i marxisti.
[Cfr Eternità e storicità p. 51.]2
Q8 §113 Storia degli intellettuali. L’Umanesimo. Studiare la riforma pedagogica introdotta dall’umanesimo: la sostituzione della «composizione scritta» alla «disputa orale», per esempio, che ne è uno degli elementi «pratici» più significativi. (Ricordare alcune sul modo di diffusione della cultura per via orale, per discussione dialogica, attraverso l’oratoria, che determina un’argomentazione poco rigorosa, e produce la convinzione immediata più che altro per via emotiva).
Q8 §114 Machiavelli. Jean Bodin (1530‑1596) fu deputato agli Stati di Blois del 1576 e fece rifiutare dal Terzo Stato i sussidi domandati per la guerra civile. Opere: Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566), dove indica l’influenza del clima, l’idea del progresso ecc.; La Republique (1576), dove esprime le opinioni del Terzo Stato sulla monarchia assoluta e i suoi rapporti col popolo; Heptaplomeres (inedito fino all’epoca moderna), in cui confronta tutte le religioni e le giustifica come espressioni diverse della religione naturale, sola ragionevole, e tutte egualmente degne di rispetto e di tolleranza. Durante le guerre civili in Francia, il Bodin è l’esponente del terzo partito, detto dei «politici», che si pone dal punto di vista dell’interesse nazionale. Il Bodin è catalogato tra gli «antimachiavellici», ma evidentemente è questo un carattere estrinseco e superficiale del suo significato storico.
Il Bodin fonda in Francia la scienza politica in un terreno molto più avanzato di quello che l’Italia aveva offerto al Machiavelli. Per il Bodin non si tratta di fondare lo Stato territoriale e unitario (nazionale), ma di equilibrare le forze sociali in lotta nell’interno di questo Stato già forte e radicato: non il momento della forza interessa il Bodin, ma quello del consenso. È da osservare che nell’Italia che osservava il Machiavelli non esistevano istituzioni rappresentative voli come quelle degli Stati Generali in Francia. Quando modernamente si osserva che le istituzioni parlamentari sono state importate in Italia dall’estero, non si tiene conto che ciò riflette una condizione di debolezza della storia passata italiana, e cioè l’essere rimasta la struttura statale alla fase comunale e non essere passata alla fase territoriale moderna (nazionale). Del resto istituzioni rappresentative sono esistite, specialmente nel Mezzogiorno e in Sicilia, ma con carattere molto più ristretto che in Francia, per il poco sviluppo in queste regioni del Terzo Stato (i Parlamenti siciliani strumento dei baroni contro la monarchia, essenzialmente).
Ricordare lo studio di Antonio Panella sugli Antimachiavellici pubblicato nel «Marzocco» del 1927 (o anche 26: undici articoli): vedere come giudicato il Bodin in confronto al nostro. (Si può vedere come nel Machiavelli le istituzioni rappresentative sono accennate in nuce).
Q8 §115 I nipotini di padre Bresciani. Secondo Luigi Tonelli («L’Italia che scrive», marzo 1932, Pietro Mignosi), nel volume Epica e santità del Mignosi (Palermo, Priulla, 1925) sarebbe contenuto un «bellissimo “Canto” un po’ alla Rimbaud, in lode degli “animali poveri”», e cita: «vermi e sorci, mosche, pidocchi e poeti, che tutte le armi della terra non riescono a sterminare» .
Q8 §116 Passato e presente. Phlipot. La farsa dei Trois Galants
et Phlipot contenuta nel Recueil de farces ecc. par Le Roux de
Lincy et F. Michel (Parigi, Techener, 1837, in 4 voll.) (nel 4°
vol., n. 12). Phlipot, quando sente il «Qui vive?», risponde
subito: «je me rends!», grida successivamente: «Vive France!
Vive Angleterre! Vive Bourgogne!», finché minacciato da tutte le
parti, e non sapendo dove cacciarsi grida: «Evviva i più forti!»
Farsa francese del secolo XV‑XVI.
Q8 §117 Americanismo. La delinquenza. Di solito si spiega lo sviluppo della delinquenza organizzata in grande stile negli Stati Uniti come una derivazione del proibizionismo e del relativo contrabbando. La vita dei contrabbandieri, le loro lotte ecc. hanno creato un clima di romanticismo che dilaga in tutta la società e determina imitazioni, slanci avventurosi ecc. È vero. Ma un altro fattore occorre cercarlo nei metodi di inaudita brutalità della polizia americana: sempre lo «sbirrismo» crea il «malandrinismo». Questo elemento è molto più efficiente di quanto non paia nello spingere alla delinquenza professionale molti individui che altrimenti continuerebbero nell’attività normale di lavoro. Anche la brutalità delle «terze sezioni» serve a nascondere la corruzione della polizia stessa ecc. L’illegalità elevata a sistema degli organi di esecuzione determina una lotta feroce da parte dei malcapitati ecc.
Q8 §118 Risorgimento italiano. Cfr Antonio Lucarelli, La Puglia nel Risorgimento, storia documentata, vol. I, Bari, Commissione provinciale di archeologia e storia patria, 1931, pp. 455, L. 30. In questo primo volume si giunge fino alla famosa cospirazione giacobina del 1793‑94, dopo aver dato un quadro della vita pugliese nel sec. XVIII. Volume necessario per comprendere la quistione meridionale. Pare che l’autore riesca a dare un quadro impressionante delle condizioni terrificanti del popolo pugliese. I fatti del 93‑94, non gravi in se stessi, acquistarono importanza per la feroce reazione che si scatenò: prima emigrazione politica verso il Nord, preparazione della rivoluzione napoletana del 1799.
Q8 §119 Passato e presente. Avvenimenti del giugno 1914. Ricordare articolo di Rerum Scriptor sulla assenza di programma di tali avvenimenti. E strano che Rerum Scriptor non si sia accorto che quegli avvenimenti avevano un grande valore perché rinnovavano i rapporti tra Nord e Sud, tra le classi urbane settentrionali e le classi rurali meridionali. Se il fatto che dette origine agli avvenimenti si ebbe ad Ancona, bisogna ricordare che l’origine reale fu l’eccidio di Roccagorga, tipicamente «meridionale», e che si trattava di opporsi alla politica tradizionale di Giolitti, ma anche dei governi di tutti gli altri partiti, di passare immediatamente per le armi i contadini meridionali che elevassero anche una protesta pacifica contro il mal governo e le cattive amministrazioni degli amici di tutti i governi. È anche da ricordare l’aggettivo «ignobile» impiegato da Adolfo Omodeo per qualificare quegli avvenimenti (cfr «Critica» del 20 gennaio 1932, Momenti della vita di guerra, pp. 29‑30). L’Omodeo parla di «Ignazio di Trabia (il secondogenito del principe Pietro)» che come ufficiale di cavalleria nel giugno 14 «dovette caricare per le vie di Roma la folla durante l’ignobile settimana rossa. Ne riportò un disgusto profondo. Scriveva: “È stata un’ora proprio brutta per tutta l’Italia e ce ne dobbiamo tutti rammaricare. Il Paese ha dato uno spettacolo addirittura incivile. Non è stato ecc.”». Bisognerebbe mettere a confronto con queste parole del principino di Trabia le deposizioni dei contadini di Roccagorga al processo fatto a Milano contro Mussolini e Scalarini. Ma è da notare che Adolfo Omodeo, liberale classico, commenta gli avvenimenti originati per la difesa dei contadini meridionali con le parole di un latifondista siciliano che delle condizioni di abbrutimento dei contadini meridionali è uno degli organizzatori. E per la superficialità di storico e l’incongruenza politica dell’Omodeo occorre confrontare questo atteggiamento con quello che risulta dal libro L’età del Risorgimento italiano dove l’Omodeo mette in luce le avvilenti condizioni del contadiname meridionale come causa di ritardo del Risorgimento italiano.
Q8 §120 Passato e presente. 1915. Per ciò che riguarda il rapporto delle forze al momento dell’entrata in guerra dell’Italia, e per giudicare la capacità politica di Salandra-Sonnino, non bisogna considerare la situazione quale era al 24 maggio, ma quale era quando fu fissata la data del 24 maggio per l’inizio delle ostilità. È evidente che una volta fissata questa data, per trattato, non era più possibile mutarla perché nel frattempo la situazione sul fronte orientale era mutata. La quistione che si pone è se non convenisse che l’entrata in guerra dell’Italia avesse a coincidere con l’inizio dell’offensiva russa e non calcolare «assolutamente» sulla buona riuscita dell’offensiva stessa. Che Salandra metta in vista e insista sul fatto che l’entrata in guerra coincise col rovescio russo, quasi ad affermare che non si andava in soccorso del vincitore, non testimonia di molta serietà politica e di responsabilità storica.
Quistione della dissoluzione dell’Impero Austro‑Ungarico. Dalle Memorie del conte Czernin apparirebbe che il Czernin riteneva che l’esistenza del Patto di Londra significava la distruzione della monarchia absburgica, poiché senza Trieste la monarchia non sarebbe più esistita. I tentativi di pace separata da parte dell’Austria (iniziativa di Sisto di Borbone – polemica Clemenceau‑Czernin nei primi mesi del 1918 – dimissioni di Czernin) sarebbero falliti per l’opposizione dell’Italia e per il Patto di Londra, nonostante l’austrofilia latente in Francia e Inghilterra (tanto che Czernin scrive che l’Italia aveva «la direzione diplomatica della guerra»). Ma queste affermazioni di Czernin non mutano il giudizio sulla condotta del Sonnino verso il problema dell’Austria, poiché si tratta non di sapere se l’Impero absburgico sarebbe «meccanicamente» morto per l’amputazione di Trieste, ma se Sonnino voleva la fine dell’Impero absburgico. Intanto è da dubitare che l’Impero sarebbe crollato senza Trieste; poteva anche avere un sussulto di energia e dar luogo a una nuova guerra con l’Italia. La posizione di Sonnino è da vedere per riguardo alle quistioni nazionali esistenti in Austria e quindi come problema politico‑militare immediato, come elemento della guerra in atto: una politica di nazionalità (come voleva anche il generale Cadorna) avrebbe accelerato la vittoria italiana determinando il dissolvimento interno dell’esercito austroungarico? Questo è il problema e intorno ad esso sono da discutere le responsabilità di Salandra‑Sonnino e specialmente di Sonnino.
Q8 §121 Bibliografie. La «Rivista Militare Italiana». Fondata nel marzo 1856 a Torino da Carlo e Luigi Mezzacapo, esuli napoletani rifugiatisi a Torino dopo aver preso parte agli assedi di Roma e di Venezia. È da notare anche questo particolare a proposito delle così dette «tradizioni militari» del Piemonte: che la maggiore rivista italiana di carattere militare è stata fondata a Torino da due napoletani. La tradizione scientifico‑tecnica militare di Napoli, formatasi con gli avvenimenti successivi alla Rivoluzione Francese è il maggiore elemento che è entrato a costituire la struttura dell’esercito moderno nazionale). Nel 1859 direttore Mariano D’Ayala ecc. Nel 1918 la pubblicazione della Rivista venne sospesa e ripresa nel 1927 per volontà del generale Badoglio, che ne fissò le direttive. Nel 1906 (cinquantenario della fondazione) pubblicò un numero unico in cui si trovava una rassegna dell’attività precedente.
Q8 §122 Letteratura popolare. Uno degli atteggiamenti più caratteristici del pubblico popolare verso la sua letteratura è questo: non importa il nome e la personalità dell’autore, ma la persona del protagonista. Gli eroi della letteratura popolare, quando sono entrati nella sfera della vita intellettuale popolare, si staccano dalla loro origine «letteraria» e acquistano la validità del personaggio storico. Tutta la loro vita interessa, dalla nascita alla morte, e ciò spiega la fortuna delle «continuazioni», anche se artefatte: cioè può avvenire che il primo creatore del tipo, nel suo lavoro, faccia morire l’eroe e il «continuatore» lo faccia rivivere, con grande soddisfazione del pubblico che si appassiona nuovamente, e rinnova l’immagine prolungandola col nuovo materiale che gli è stato offerto. Non bisogna intendere «personaggio storico» in senso letterale, sebbene anche questo avvenga, che dei lettori popolari non sappiano più distinguere tra mondo effettuale della storia passata e mondo fantastico e discutano sui personaggi romanzeschi come farebbero su quelli che hanno vissuto, ma in un modo traslato, per comprendere che il mondo fantastico acquista nella vita intellettuale popolare una concretezza fiabesca particolare. Così avviene per esempio che avvengano delle contaminazioni tra romanzi diversi, perché i personaggi si rassomigliano: il raccontatore popolare unisce in un solo eroe le avventure dei vari eroi ed è persuaso che così debba essere fatto per essere «intelligenti».
Q8 §123 Passato e presente. Bilancio della guerra. Camillo Pellizzi annunzia nel «Corriere» del 7 aprile 1932 il libro di Luigi Villari The war on the Italian Front (Londra, Cobden‑Sanderson, 1932, con prefazione di sir Rennell Rodd). In un’appendice sono pubblicate le cifre sul bilancio comparativo della guerra, e il Pellizzi riproduce le seguenti: l’Italia ha mobilitato il 14,48 % della sua popolazione, la Francia il 20,08, l’Inghilterra il 12,31; l’Italia ha avuto il 14% di morti sul numero dei mobilitati, la Francia il 16,15, l’Inghilterra l’11,05; l’Italia ha speso nella guerra oltre un quarto della sua ricchezza totale, la Francia meno di un sesto; l’Italia ha perso il 58,93% del suo tonnellaggio mercantile, la Gran Bretagna il 43,63, la Francia il 39,44.
Occorrerebbe vedere come queste cifre sono ottenute e se si tratta di quantità omogenee. Le cifre percentuali della mobilitazione possono essere rese non esatte dal fatto che si calcolano tutti i mobilitati di vari anni e si fa la percentuale sulla popolazione di un anno dato. Così per il tonnellaggio occorrerebbe sapere l’età delle navi perdute, perché è noto che alcuni paesi tengono in servizio le navi più di altri, onde il maggior numero di disastri anche in tempo di pace. Il calcolo della ricchezza di un paese varia sensibilmente a seconda dell’onestà fiscale nel denunziare i redditi, e questa forma di onestà non è mai abbondante.
Q8 §124 Fase economico‑corporativa nella storia italiana. L’impresa di Lepanto. A. Salimei, Gli italiani a Lepanto (Roma, auspice la Lega navale). Il Salimei ha raccolto diligentemente tutti i dati che si riferiscono alla organizzazione delle forze che parteciparono all’impresa di Lepanto e ha dimostrato che esse, dalle navi agli uomini, furono in maggioranza italiane. Negli archivi vaticani esistono i documenti coi conti per la ripartizione delle spese tra il re di Spagna e la repubblica di Venezia per la lega cristiana del 1571, rimessi al successore di Pio V perché decidesse sulle controversie insorte nello stabilire l’ammontare del rispettivo credito e debito. Con tali documenti è possibile precisare il numero e il nome delle galee, delle navi, delle fregate ecc. e il numero dei reggimenti e delle rispettive compagnie con i nomi dei colonnelli e dei capitani tanto per la flotta e le fanterie che si trovarono alla battaglia di Lepanto, quanto per quelle che non vi si trovarono ma furono egualmente mobilitate per la spedizione nello stesso anno 1571.
Delle più che duecento navi partecipanti alla battaglia solo 14 erano spagnole, tutte le altre erano italiane; dei 34 mila armati solo 5000 fanti «vennero dalla Spagna», e 6000 erano tedeschi (ma 1000 di questi no, parteciparono al combattimento), tutti gli altri erano di «nazionalità» italiana. Dall’elenco degli «ufficiali, venturieri e militi» distinti secondo le nazionalità e, «per quanto riguarda l’Italia» anche secondo le regioni e le città di origine il Salimei deduce che non c’è parte della penisola e delle isole, dalle Alpi alla Calabria, compresa la Dalmazia e le isole di dominio veneto, dalla Sicilia alla Sardegna alla Corsica a Malta, che non vi partecipi. Questa ricerca è molto interessante e potrebbe essere analizzata opportunamente. Il Salimei la inquadra in una cornice retorica, perché si serve di concetti moderni per fatti non omogenei. Rivendica il carattere «nazionale» di Lepanto, che è attribuito di solito alla cristianità (cioè al Papa) con prevalenza alla Spagna e afferma che a Lepanto per l’ultima volta gli italiani, anzi tutti gli italiani, «combatterono per una causa che non fosse quella degli stranieri» e che «con Lepanto si chiude l’era della nostra efficienza navale e militare come popolo italiano, fino al 1848». Sarebbe da vedere, a questo proposito, perché nacquero le controversie tra Venezia e Spagna per dividersi le spese, e sotto quali bandiere erano arruolati i soldati che avevano origine da paesi italiani.
Sulla lega di Lepanto cfr: A. Dragonetti De Torres, La lega di Lepanto nel carteggio diplomatico di don Luys de Torres nunzio straordinario di SS. Pio V a Filippo II, Torino, Bocca, 1931. Dalla preparazione diplomatica della Lega dovrebbe apparire più concretamente il carattere dell’impresa.
Q8 §125 Nozioni enciclopediche e argomenti di cultura. Può essere questo il titolo generale della rubrica in cui raccogliere tutti gli spunti e motivi annotati finora, talvolta sotto titoli vari. Spunti per un dizionario di politica e critica, nozioni enciclopediche propriamente dette, motivi di vita morale, argomenti di cultura, apologhi filosofici ecc.
1) Ultra. Nomi diversi dati in Francia e in Germania ai cattolici, favorevoli a una influenza del papato nei loro rispettivi paesi, ciò che significa poi in gran parte: che lottavano per accrescere la loro forza di partito con l’aiuto di una potenza straniera (non solo «spirituale e culturale», ma anche temporale – e come! – perché avrebbe voluto prelevare imposte, decime, ecc. e dirigere la politica internazionale). Era una forma di certi tempi di «partito dello straniero» opposto a «gallicano» in Francia.
2) Artigiano. Artigianato. Da un articolo di Ugo Ojetti (Arti e artigiani d’Italia, nel «Corriere» del 10 aprile 1932) tolgo alcuni spunti: per la legge italiana è artigiano chi non occupa più di cinque lavoranti se esercita un mestiere d’arte, più di tre se esercita un mestiere usuale. Definizione imprecisa. «Il proprio dell’artigiano è di lavorare egli stesso con le sue mani all’arte sua o al suo mestiere. Che da lui dipendano cinque o dieci persone, ciò non muta il suo carattere d’artigiano, quello che subito lo distingue dall’industriale». Ma anche questa definizione è imprecisa, perché l’artigiano può non lavorare, ma dirigere il lavoro di una bottega: la definizione deve essere cercata nel modo di produzione e di lavoro.
In Germania esiste la patente di mestiere, che ha tre gradi come il mestiere: dell’apprendista «che noi diremmo meglio garzone o novizio», del «compagno» che ha finito il tirocinio di garzone, del «maestro».
L’Ojetti impiega la parola «compagno» per indicare il lavorante artigiano già formato professionalmente, ma questa parola come si giustifica? Non storicamente, perché in italiano non è rimasto l’uso come in francese e tedesco di una parola che un tempo aveva un significato giuridico preciso, e oggi non ha significato «professionale» ma solo di posizione «economica». Professionalmente il «compagno» è un «maestro», ma non ha la proprietà di una bottega e deve lavorare per un altro che sia appunto proprietario.
Q8 §126 Nozioni enciclopediche e argomenti di cultura. Il Medio Evo. Cfr Luigi Sorrento, Medio Evo, il termine e il concetto (Milano, Soc. Ed. «Vita e Pensiero», 1931, pp. 54 in 8°). Il Sorrento è professore all’Università del Sacro Cuore (e la pubblicazione è appunto un discorso tenuto in questa università) ed è da immaginare che studi l’argomento oltre che da un punto di vista cattolico ed apologetico, anche entro limiti storico‑letterari, senza cioè occuparsi del contenuto economico‑sociale del concetto di Medio Evo. Occorrerebbe invece studiare in modo completo l’argomento, per giungere alla distinzione del Medio Evo dall’età del mercantilismo e delle monarchie assolute che popolarmente sono incluse nel Medio Evo. (Ancien Régime popolarmente si confonde con Medio Evo, mentre è appunto l’età del mercantilismo e delle monarchie assolute, chiuso dalla Rivoluzione francese). L’opuscolo del Sorrento sarà più utile per l’indicazione delle fonti letterarie.
Un paragrafo si potrebbe dedicare a riassumere ciò che ha significato il termine «Italia» nei vari tempi, prendendo le mosse dallo studio in proposito del prof. Carlo Cipolla pubblicato negli Atti della Accademia delle Scienze di Torino.
Q8 §127 Storia delle classi subalterne. La Bohème. Carlo Baudelaire. Cfr C. Baudelaire, Les Fleurs du Mal et autres poèmes, Texte intégral précédé d’une étude inédite d’Henri de Régnier («La Renaissance du Livre», Paris s. d.). Nello studio del de Régnier (a pp. 14‑15, a contare dalla pagina stampata, perché nel testo della prefazione non c’è numerazione) si ricorda che il Baudelaire partecipò attivamente ai fatti del febbraio e del giugno 1848. «Fait étrange de contagion révolutionnaire, dans cette cervelle si méticuleusement lucide», scrive il de Régnier. Il Baudelaire, con Champfleury, fondò un giornale repubblicano in cui scrisse articoli violenti. Diresse poi un giornale locale a Châteauroux. «Cette double campagne typographique (sic) et la part qu’il prit au mouvement populaire suffirent, il faut le dire, à guérir ce qu’il appela plus tard sa “folie” et que, dans Mon cœur mis à nu, il cherche à s’expliquer à lui‑même quand il écrit: “Mon ivresse de 1848. De quelle nature était cette ivresse? Goût de la vengeance, plaisir naturel de la démolition. Ivresse littéraire. Souvenirs de lectures”. Crise bizarre qui transforma cet aristocrate d’idées et de goûts qu’était foncièrement Baudelaire en un énergumène que nous décrit dans ses s son camarade Le Valvasseur et dont les mains “sentaient la poudre”, proclamant “l’apothéose de la banqueroute sociale”; crise bizarre d’où il rapporta une horreur sincère de la démocratie mais qui était peut‑être aussi un premier avertissement physiologique» ecc. è un primo sintomo della nevrastenia del Baudelaire (ma perché non il contrario? cioè perché la malattia del Baudelaire non avrebbe invece determinato il suo distacco dal movimento popolare? ecc.).
In ogni caso vedere se questi scritti politici del Baudelaire sono stati studiati e raccolti.
Q8 §128 Scienza economica. Concetto e fatto di «mercato determinato», cioè rilevazione che determinate forze sono apparse storicamente, il cui operare si presenta con un certo «automatismo» che consente una certa misura di «previdibilità» e di certezza per le iniziative individuali. «Mercato determinato» pertanto equivale a dire «determinato rapporto di forze sociali in una determinata struttura dell’apparato di produzione» garantito da una determinata superstruttura giuridica. Perché si possa parlare di una nuova «scienza» occorrerebbe aver dimostrato che esistono un nuovo rapporto di forze ecc. che hanno determinato un nuovo tipo di mercato con un suo proprio «automatismo» e fenomenismo che si presenta come qualcosa di «obbiettivo», paragonabile all’automatismo delle leggi naturali.
Scienza economica e «critica di una scienza economica». La «critica» della scienza economica parte dal concetto della «storicità» del «mercato determinato» e del suo «automatismo», mentre gli «economisti» puri pongono questi elementi come «eterni», «naturali»; analizza i rapporti delle forze che «determinano» il mercato, valuta le loro «modificabilità» connesse all’apparire di fattori nuovi e al loro rafforzarsi e presenta la «caducità» e la «sostituibilità» della «scienza» criticata: la studia come «vita» ma anche come «morte», e trova nel suo intimo gli elementi del suo superamento immancabile da parte di un «erede» che sarà «presuntivo» finché non avrà dato prove manifeste di vitalità ecc. Da queste considerazioni si può trarre argomento per stabilire ciò che significa «regolarità», «legge», «automatismo» nei fatti storici. Non si tratta di «scoprire» una legge metafisica di «determinismo», e neppure di stabilire una legge «generale» di causalità. Si tratta di vedere come nello sviluppo generale si costituiscono delle forze relativamente «permanenti» che operano con una certa regolarità e un certo automatismo. Anche la legge dei grandi numeri, sebbene sia molto utile come termine di paragone, non può essere assunta come la «legge» dei fatti sociali.
Occorrerà studiare l’impostazione delle leggi economiche così come fu fatta da Davide Ricardo (il cosidetto metodo del «posto che»): in essa certo è da ritrovare uno dei punti di partenza delle esperienze filosofiche di Marx ed Engels che portarono allo sviluppo del materialismo storico.
Il caso e la legge. Concetti filosofici di «caso» e di «legge»: tra concetto di una «provvidenza» che ha stabilito dei fini al mondo e all’uomo, e del materialismo filosofico che «il mondo a caso pone».
Q8 §129 Azione Cattolica. La debolezza di ogni organizzazione nazionale di Azione Cattolica consiste nel fatto che la sua azione è limitata e continuamente turbata dalle necessità di politica internazionale e interna, in ogni Stato, della Santa Sede. A misura che ogni Azione Cattolica nazionale si estende e diventa organismo di massa, essa tende a diventare un vero e proprio partito, le cui direttive sono imposte dalle necessità interne dell’organizzazione; ma questo processo non può diventare mai organico appunto per l’intervento della Santa Sede. In questo fatto è forse da ricercare la ragione per cui in Germania l’Azione Cattolica non è stata mai molto bene accetta: il Centro si era già tanto sviluppato come forza politico‑parlamentare, impegnata nelle lotte interne tedesche, che ogni formazione vasta di Azione Cattolica controllata strettamente dall’Episcopato, ne avrebbe compromesso la potenza attuale e le possibilità di sviluppo. È da richiamare il conflitto avvenuto tra il Centro e il Vaticano, quando il Vaticano volle che il Centro approvasse le leggi militari di Bismarck, alle quali il Centro si era strenuamente opposto.
Sviluppo simile in Austria, dove il clericalismo è sempre stato forte politicamente come partito e non aveva bisogno di una vasta organizzazione permanente come quella di Azione Cattolica ma solo di greggi elettorali disorganiche sotto il tradizionale controllo dei parroci.
Q8 §130 Nozioni enciclopediche e argomenti di cultura. Statolatria. Atteggiamento di ogni diverso gruppo sociale verso il proprio Stato. L’analisi non sarebbe esatta se non si tenesse conto delle due forme in cui lo Stato si presenta nel linguaggio e nella cultura delle epoche determinate, cioè come società civile e come società politica, come «autogoverno» e come «governo dei funzionari». Si dà il nome di statolatria a un determinato atteggiamento verso il «governo dei funzionari» o società politica, che nel linguaggio comune è la forma di vita statale a cui si dà il nome di Stato e che volgarmente è intesa come tutto lo Stato.
L’affermazione che lo Stato si identifica con gli individui (con gli individui di un gruppo sociale), come elemento di cultura attiva (cioè come movimento per creare una nuova civiltà, un nuovo tipo di uomo e di cittadino) deve servire a determinare la volontà di costruire nell’involucro della Società politica una complessa e bene articolata società civile, in cui il singolo individuo si governi da sé senza che perciò questo suo autogoverno entri in conflitto con la società politica, anzi diventandone la normale continuazione, il complemento organico. Per alcuni gruppi sociali, che prima della ascesa alla vita statale autonoma non hanno avuto un lungo periodo di sviluppo culturale e morale proprio e indipendente (come nella società medioevale e nei governi assoluti era reso possibile dall’esistenza giuridica degli Stati o ordini privilegiati), un periodo di statolatria è necessario e anzi opportuno: questa «statolatria» non è altro che la forma normale di «vita statale», di iniziazione, almeno, alla vita statale autonoma e alla creazione di una «società civile» che non fu possibile storicamente creare prima dell’ascesa alla vita statale indipendente. Tuttavia questa tale «statolatria» non deve essere abbandonata a sé, non deve, specialmente, diventare fanatismo teorico, ed essere concepita come «perpetua»: deve essere criticata, appunto perché si sviluppi, e produca nuove forme di vita statale, in cui l’iniziativa degli individui e dei gruppi sia «statale» anche se non dovuta al «governo dei funzionari» (far diventare «spontanea» la vita statale). Cfr pag. 45, l’argomento «Iniziativa individuale».
Q8 §131 Nozioni enciclopediche e argomenti di cultura. 1) Il motto della «Civiltà Cattolica»: «Beatus populus cuius Dominus Deus eius». (Ps. 143, 15). Gli scrittori della rivista traducono così: «Beato il popolo che ha Dio per suo Signore». Ma è esatto? La traduzione è questa: «Beato il popolo che ha per signore il proprio Dio». Cioè il motto riproduce l’esaltazione della nazione ebrea e del Dio nazionale ebraico che ne era il Signore. Ora la «Civiltà Cattolica» vuole chiese nazionali, come è implicito nel motto? (Cfr la traduzione della Bibbia fatta dal Luzzi per l’accertamento dei testi).
2) Religione e politica. Un argomento da studiare è questo: se esista un rapporto e quale sia tra l’unità religiosa di un paese e la molteplicità dei partiti e viceversa tra la unità relativa dei partiti e la molteplicità delle chiese e sette religiose. Si osserva che negli Stati Uniti, dove i partiti politici efficienti sono due o tre, esistono centinaia di chiese e sette religiose; in Francia dove l’unità religiosa è notevole, esistono decine e decine di partiti. Ciò che fa riflettere è il caso della Russia zarista, dove partiti politici normalmente e legalmente non esistevano o erano repressi ed esisteva la tendenza alla molteplicità delle sette religiose le più imbevute di fanatismo. Si potrebbe spiegare osservando che sia il Partito che la Religione sono forme di concezione del mondo e che l’unità religiosa è apparente come è apparente l’unità politica: l’unità religiosa nasconde una reale molteplicità di concezioni del mondo che trovano espressione nei partiti, perché esiste «indifferentismo» religioso, come l’unità politica nasconde molteplicità di tendenze che trovano espressione nelle sette religiose ecc. Ogni uomo tende ad avere una sola concezione del mondo organica e sistematica, ma poiché le differenziazioni culturali sono molte e profonde, la società assume una bizzarra variegazione di correnti che presentano un colorito religioso o un colorito politico a seconda della tradizione storica.
Q8 §132 Machiavelli. La passione. Se il concetto crociano della passione come momento della politica si urta nella difficoltà di spiegare e giustificare le formazioni politiche permanenti come i partiti e ancor più gli eserciti nazionali e gli Stati maggiori, poiché non si può concepire una passione organizzata permanentemente senza che essa diventi razionalità e riflessione ponderata, cioè non più passione, la soluzione non può trovarsi se non nella identificazione di politica ed economia; la politica è azione permanente e dà nascita a organizzazioni permanenti in quanto appunto si identifica con l’economia. Ma essa anche se ne distingue e perciò può parlarsi separatamente di economia e di politica e può parlarsi di «passione politica» come di impulso immediato all’azione che nasce sul terreno «permanente e organico» della vita economica, ma lo supera, facendo entrare in gioco sentimenti e aspirazioni nella cui atmosfera incandescente lo stesso calcolo della vita umana individuale ubbidisce a leggi diverse da quelle del tornaconto individuale ecc.
Q8 §133 Lorianismo. Giuseppe De Lorenzo. Anche alcuni aspetti dell’attività intellettuale del De Lorenzo rientrano nella categoria del Lorianismo. Tuttavia occorre con lui essere discreti.
Q8 §134 Passato e presente. Un giudizio su Paolo Boselli. Nella commemorazione di Paolo Boselli scritta in «Gerarchia» (marzo 1932) da Filippo Caparelli è contenuto questo spunto: «Sembra forse un po’ strano che in quegli anni (del Risorgimento) così pieni di mirabili vicende, egli non pensasse ad attingere ad altre fonti, che pur si presentavano copiose e degnissime, e cioè al diretto contatto con la vita, questi generosi entusiasmi. Invece non bisogna allarmarsi (sic) perché questo era il suo temperamento e la sua inclinazione (!) lo portava più a coltivare gli entusiastici accenti patriottici nelle tranquille contrade letterarie che sui campi sommamente (!) disagevoli dell’azione».
Q8 §135 Letteratura popolare. Cfr E. Brenna, La letteratura educativa popolare italiana nel secolo XIX (Milano, F.I.L.P., 1931, pp. 246, L. 6). Dalla recensione dovuta alla prof. E. Formiggini‑Santamaria («Italia che scrive», marzo 1932) si traggono questi spunti: il libro della Brenna ebbe un premio d’incoraggiamento nel concorso Ravizza, che pare aveva per tema appunto la «letteratura educativa popolare». La Brenna ha dato un quadro dell’evoluzione del romanzo, della novella, di scritti di divulgazione morale e sociale, del dramma, degli scritti vernacoli più diffusi nel secolo XIX con riferimenti al secolo XVIII e in rapporto coll’indirizzo letterario nel suo globale svolgimento.
La Brenna ha dato al termine «popolare» un senso molto largo, «includendoci cioè anche la borghesia, quella che non fa della coltura il suo scopo di vita, ma che può accostarsi all’arte»; così ha considerato come «letteratura educativa del popolo tutta quella di stile non aulico e ricercato, includendovi per es. I Promessi Sposi, i romanzi del D’Azeglio e gli altri della stessa indole, i versi del Giusti e quelli che prendono ad argomento le lievi vicende e la serena natura, come le rime del Pascoli e di Ada Negri». La Formiggini‑Santamaria fa alcune considerazioni interessanti: «Questa interpretazione del tema si giustifica pensando quanto sia stata scarsa nella prima metà del secolo scorso la diffusione dell’alfabeto tra gli artigiani e i contadini (ma la letteratura popolare non si diffonde solo per lettura individuale, ma anche per letture collettive; altre attività: i Maggi in Toscana, i cantastorie nell’Italia meridionale, sono proprie di ambienti arretrati dove è diffuso l’analfabetismo; anche le gare poetiche in Sardegna e Sicilia), e scarsa anche la stampa di libri adatti (cosa vuol dire «adatti»? e la letteratura non fa nascere nuovi bisogni?) alla povera mentalità di lavoratori del braccio; l’A. avrà pensato che, rievocando soltanto questi, il suo studio sarebbe riuscito molto ristretto. Pure a me pare che l’intenzione implicita nel tema dato, sia stata di far risaltare, insieme con la scarsità di scritti d’indole popolare del sec. XIX, il bisogno di scrivere per il popolo libri adatti, e di far ricercare – attraverso l’analisi del passato – i criteri ai quali una letteratura popolare debba ispirarsi. Non dico che non dovesse esser dato uno sguardo alle pubblicazioni che nelle intenzioni degli scrittori dovevano servire ad educare il popolo senza tuttavia arrivare ad esso; ma da tale cenno avrebbe dovuto più esplicitamente risultare per quale motivo la buona intenzione restò intenzione. Vi furono invece altre opere (specialmente nella seconda metà del sec. XIX) che si proposero in prima linea il successo e secondariamente l’educazione, ed ebbero molta fortuna nelle classi popolari. È vero che, prendendole in esame, la Brenna avrebbe dovuto staccarsi molto spesso dal campo dell’arte, ma nell’analisi di quei libri che si diffusero e si diffondono tuttora tra il popolo (per es. gli illogici, complicati, tenebrosi romanzi della Invernizio), nello studio su quei drammoni d’arena che strapparono lacrime ed applausi al pubblico domenicale dei teatri secondari (e che sono pur sempre ispirati ad amore della giustizia e al coraggio) si sarebbe meglio potuto trovare l’aspetto più emergente dell’animo popolare, il segreto di ciò che può educarlo quando sia portato in un campo d’azione meno unilaterale e più sereno».
La Formiggini nota poi che la Brenna non si è occupata dello studio del folclore, e ricorda che bisogna occuparsi almeno delle favole e novelle tipo fratelli Grimm.
La Formiggini insiste sulla parola «educativa» ma non indica il contenuto che dovrebbe avere tale concetto, eppure la quistione è tutta qui. La «tendenziosità» della letteratura popolare educativa d’intenzione è così insipida e falsa, risponde così poco agli interessi mentali del popolo che l’impopolarità è la sanzione giusta.
Q8 §136 Caratteri della letteratura italiana. Cfr l’articolo di Piero Rébora, Libri italiani ed editori inglesi, nell’«Italia che scrive» del marzo 1932. Perché la letteratura italiana contemporanea non ha quasi corso in Inghilterra: «Scarsa capacità di obiettiva narrazione e d’osservazione, egocentrismo morboso, antiquata ossessione erotica; ed insieme, caos linguistico e stilistico, pel quale molti nostri libri son scritti tuttora con torbido impressionismo lirico che infastidisce il lettore italiano e stordisce uno straniero. Centinaia di vocaboli usati dagli scrittori contemporanei non si trovano nei vocabolari e nessuno sa quello che significhino esattamente». «Sopratutto, forse, rappresentazione dell’amore e della donna più o meno incomprensibile per gli anglo‑sassoni, verismo provinciale semi‑vernacolo, mancanza di unità linguistica e stilistica». «Occorrono libri di tipo europeo, non di trito verismo provinciale». «L’esperienza m’insegna che il lettore straniero (e probabilmente anche l’italiano) trova nei nostri libri spesso qualcosa di caotico, di urtante, di ripugnante quasi, inseritosi chissà come qua e là, in mezzo a pagine invece ammirevoli, rivelanti un ingegno solido e profondo». «Vi sono romanzi, libri di prose, commedie riuscitissime, che sono irremissibilmente guastate da due o tre pagine, da una scena, da qualche battuta magari, di sconcertante volgarità, sciatteria, disgustosità; che rovina tutto». «... Il fatto rimane che un professore italiano all’estero non riesce, anche con la maggior buona volontà, a mettere insieme una dozzina di buoni libri italiani contemporanei, che non contengano qualche pagina disgustosa, discreditante, disastrosa per la nostra elementare dignità, penosamente triviale, che è meglio non metter sotto il naso di intelligenti lettori stranieri. Taluni hanno il malvezzo di chiamare tali pudori e tali disgusti con l’infamante nome di “puritanismo”; mentre invece si tratta solo ed unicamente di “buon gusto”».
L’editore, secondo il Rébora, dovrebbe intervenire di più nel fatto letterario, e non essere solo un commerciante‑industriale, funzionando da prima istanza «critica», specialmente per quanto riguarda la «socialità» del lavoro ecc.
Q8 §137 Letteratura popolare. Cfr Ernesto Brunetto, Romanzi e romanzieri d’appendice nel «Lavoro Fascista» del 19 febbraio 1932.
Q8 §138 Nozioni enciclopediche e argomenti di cultura. Ogni
nazione ha il suo poeta o scrittore in cui riassume la gloria
intellettuale della nazione e della razza. Omero per la Grecia,
Dante per l’Italia, Cervantes per la Spagna, Camoens per il
Portogallo, Shakespeare per l’Inghilterra, Goethe per la
Germania. È da notare che la Francia non ha nessuna di queste
grandi figure che sia rappresentativa senza discussione, così
non l’hanno gli Stati Uniti. Per la Russia si potrebbe parlare
di Tolstoi? Per la Cina di Confucio?
Il fatto francese è notevole perché la Francia tradizionalmente è paese unitario per eccellenza (Victor Hugo?) anche nel campo della cultura, anzi specialmente in questo. La data in cui queste figure sono apparse nella storia di ogni nazione è elemento interessante per fissare il contributo di ogni popolo alla civiltà comune e anche la «sua attualità culturale». Come «elemento ideologico» attualmente operante, riflette gloria sulla Grecia la grandezza di Omero? Gli ammiratori di Omero sono stati abituati a distinguere la Grecia antica dalla Grecia moderna.
Q8 §139 Risorgimento. Garibaldi e la frase del «metro cubo di letame». Nell’articolo Garibaldi e Pio IX («Corriere della Sera» del 15 aprile 1932) A. Luzio scrive che «va escluso assolutamente che fosse sua (di Garibaldi) una lettera in cui il vecchio Pontefice veniva oltraggiato con l’epiteto volgare di “metro cubo di letame”». Il Luzio ricorda di aver già scritto in proposito (Profili, I, 485). G. C. Abba avrebbe detto al Luzio d’aver udito da Garibaldi «le più sdegnose proteste per l’inqualificabile abuso del proprio nome».
La quistione non è chiara, perché si tratterebbe del fatto che qualcuno avrebbe scritto una «intera lettera» col nome di Garibaldi, senza che questi protestasse immediatamente per l’abuso, mentre le «sdegnose proteste» le fece privatamente all’Abba in conversazione privata di cui l’Abba non avrebbe lasciato altra traccia che la conversazione privata col Luzio.
Poiché l’articolo del Luzio è un tentativo di riabilitazione popolare di Pio IX, non molto d’accordo con altre ricostruzioni del carattere di Pio IX, è da pensare che il Luzio, pur non inventando completamente, abbia alquanto «esagerato» qualche espressione di Garibaldi che attenuava la sua drastica frase.
Il Luzio scrive a proposito di Pio IX: «Documenti diplomatici insospettabili confermano, a ogni modo, qualche cosa di più che la “deserta volontà d’amare” cantata dal Carducci, in Pio IX: la realtà era fors’anche più poetica (sic!) e drammatica. Ci mostra infatti il Papa, circuito dal cardinal Antonelli e da altri intransigenti, chieder loro affannosamente (!!), con mal repressa (!!) ribellione (!): – Ma se la Provvidenza ha decretato l’Unità italiana, devo esser io a contrastarla, a frastornare le decisioni divine, col mostrarmi inconciliabile?»
Pare invece, da altri documenti, che l’influsso dell’Antonelli fosse molto piccolo ecc. In ogni modo il carattere «romanzato» e da romanzo d’appendice della ricostruzione del Luzio è troppo in rilievo, fino a mancare di rispetto alla personalità del papa, che non poteva porre in quel modo la quistione di un possibile decreto della Provvidenza e parlare di «frastornamenti» di divine decisioni.
Q8 §140 Passato e presente. Malta. Controllare se l’on. Enrico Mizzi, uno dei leaders del partito nazionalista maltese, sia stato tra i fondatori del Partito Nazionalista Italiano. Probabilmente l’affermazione fatta da qualche giornale inglese, si riferisce al fatto che il Mizzi avrà mandato la sua adesione al Comitato organizzatore o a qualche personalità come Corradini o Federzoni o Coppola.
Q8 §141 Machiavelli. 1) Altro elemento da esaminare e quello dei rapporti organici tra la politica interna e la politica estera di uno Stato. È la politica interna che determina quella estera o viceversa? Anche in questo caso occorrerà distinguere: tra grandi potenze, con relativa autonomia internazionale, e altre potenze, e ancora tra diverse forme di governo (un governo come quello di Napoleone III aveva due politiche, apparentemente, reazionaria all’interno e liberale all’estero).
2) Condizioni di uno Stato prima e dopo una guerra. È evidente che contano, in una alleanza, le condizioni in cui uno Stato si trova al momento della pace. Può avvenire perciò che chi ha avuto l’egemonia durante la guerra, finisca col perderla per l’indebolimento subito nella lotta e debba vedere un «subalterno» che è stato più abile o più «fortunato» diventare egemone. Ciò si verifica nelle «guerre mondiali» quando la situazione geografica costringe uno Stato a gettare tutte le sue risorse nel crogiolo: vince per le alleanze, ma la vittoria lo trova prostrato ecc. Ecco perché nel concetto di «grande potenza» occorre tener conto di molti elementi e specialmente di quelli «permanenti», cioè specialmente «potenzialità economica e finanziaria» e popolazione.
Q8 §142 Nozioni enciclopediche e argomenti di coltura. L’iniziativa individuale. (Argomento connesso con quello della «statolatria», di p. 41). Elementi per impostare la quistione: identità‑distinzione tra società civile e società politica, e quindi identificazione organica tra individui (di un determinato gruppo) e Stato, per cui «ogni individuo è funzionario» non in quanto è impiegato stipendiato dallo Stato e sottoposto al controllo «gerarchico» della burocrazia statale, ma in quanto «operando spontaneamente» la sua operosità si identifica coi fini dello Stato (cioè del gruppo sociale determinato o società civile). L’iniziativa individuale non è perciò una ipotesi di «buona volontà» ma un presupposto necessario. Ma «iniziativa individuale» si intende nel campo economico e precisamente si intende nel senso preciso di iniziativa a carattere «utilitario» immediato e strettamente personale, con l’appropriazione del profitto che l’iniziativa stessa determina in un determinato sistema di rapporti giuridici. Ma non è questa l’unica forma d’iniziativa «economica» storicamente manifestatasi (catalogo delle grandi iniziative individuali che sono finite in disastro negli ultimi decenni: Kreuger, Stinnes; in Italia: fratelli Perrone; forse a questo proposito utili i libri del Lewinsohn): si hanno esempi di tali iniziative non «immediatamente interessate», cioè «interessate» nel senso più elevato, dell’interesse statale o del gruppo che costituisce la società civile. Un esempio mirabile è la stessa «alta burocrazia» italiana, i cui componenti, se volessero impiegare ai fini di una attività economica per l’appropriazione personale, le qualità di organizzatori e di specialisti di cui sono dotati, avrebbero la possibilità di crearsi una posizione finanziaria ben altrimenti elevata di quella che loro fa lo Stato imprenditore: né si può dire che l’idea della pensione li tenga fedeli all’impiego di Stato, come avviene per il più basso strato burocratico.
Q8 §143 Giornalismo. I titoli. Tendenza a titoli magniloquenti e pedanteschi, con opposta reazione di titoli così detti «giornalistici» cioè anodini e insignificanti. Difficoltà dell’arte dei titoli che dovrebbero riassumere alcune esigenze: di indicare sinteticamente l’argomento centrale trattato, di destare interesse e curiosità spingendo a leggere. Anche i titoli sono determinati dal pubblico al quale il giornale si rivolge e dall’atteggiamento del giornale verso il suo pubblico: atteggiamento demagogico‑commerciale quando si vuole sfruttare le tendenze più basse; atteggiamento educativo‑didattico, ma senza pedanteria, quando si vuole sfruttare il sentimento predominante nel pubblico, come base di partenza per un suo elevamento. Il titolo «Brevi cenni sull’universo», come caricatura del titolo pedantesco e pretenzioso.
Q8 §144 Nozioni enciclopediche. Bibliografia. Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo, Firenze, 1881. (Non lo conosco. Vedere come compilato, di che tendenza politica ecc.; lodato dall’Einaudi).
Q8 §145 Carattere non popolare‑nazionale della letteratura italiana. Consenso della nazione o degli «spiriti eletti». Cosa deve interessare di più un artista, il consenso all’opera sua della «nazione» o quello degli «spiriti eletti»? Ma può esserci separazione tra «spiriti eletti» e «nazione»? Il fatto che la quistione sia stata posta e si continui a porre in questi termini, mostra per se stesso una situazione determinata storicamente di distacco tra intellettuali e nazione. Quali sono poi gli «spiriti» riputati «eletti»? Ogni scrittore o artista ha i suoi «spiriti eletti», cioè si ha la realtà di una disgregazione degli intellettuali in combriccole e sette di «spiriti eletti», disgregazione che appunto dipende dalla non aderenza alla nazione‑popolo, dal fatto che il «contenuto» sentimentale dell’arte, il mondo culturale è astratto dalle correnti profonde della vita popolare‑nazionale, che essa stessa rimane disgregata e senza espressione. Ogni movimento intellettuale diventa o ridiventa nazionale se si è verificata una «andata al popolo», se si è avuta una fase «Riforma» e non solo una fase «Rinascimento» e se le fasi «Riforma‑Rinascimento» si susseguono organicamente e non coincidono con fasi storiche distinte (come in Italia, in cui tra il movimento comunale – riforma – e quello del Rinascimento c’è stato un iato storico dal punto di vista della partecipazione popolare alla vita pubblica). Anche se si dovesse cominciare con lo scrivere «romanzi d’appendice» e versi da melodramma, senza un periodo di andata al popolo non c’è «Rinascimento» e non c’è letteratura nazionale.
Q8 §146 Nozioni enciclopediche. Università. Termine rimasto nel senso medievale di corporazione o comunità: per es. «le Università israelitiche», le «Università agrarie» nelle regioni dove esistono usi civici sulle terre e sui boschi riconosciuti e regolati dalle leggi (come nel Lazio). Nel linguaggio comune il termine Università è rimasto per certi istituti di studi superiori (Università degli Studi) e ricorda l’antica organizzazione corporativa degli studi.
Q8 §147 Giornalismo. La cronaca giudiziaria. Si può osservare che la cronaca giudiziaria dei grandi giornali è redatta come un perpetuo «Mille e una notte» concepito secondo gli schemi del romanzo d’appendice. C’è la stessa varietà di schemi sentimentali e di motivi: la tragedia, il dramma frenetico, l’intrigo abile e intelligente, la farsa. Il «Corriere della Sera» non pubblica romanzi d’appendice: ma la sua pagina giudiziaria ne ha tutte le attrattive, con in più la nozione, sempre presente, che si tratta di fatti veri.
Q8 §148 Nozioni enciclopediche. Bibliografia. Roberto Michels, Introduzione alla storia delle dottrine economiche e politiche, in 16°, pp. XIII‑310, Bologna, Zanichelli, 1932, L. 15.
Dizionari: del Guillaumin Dictionnaire de l’Economie Politique, pubblicato dalla «Librairie de Guillaumin & C.», Parigi (4a ed. del 1873), di Palgrave. Cossa, Introduzione allo studio delle dottrine economiche; Ricca‑Salerno, Storia delle dottrine finanziarie.
Q8 §149 Argomenti di coltura. Una serie di «argomenti» può essere offerta dalla descrizione critica di alcune grandi imprese editoriali di cultura, come la collezione degli economisti italiani 50 volumi del Custodi, la Biblioteca degli Economisti 80 volumi del Ferrara‑Boccardo, la Collezione di storia economica 8 volumi del Pareto‑Ciccotti, la nuova collezione progettata dal Bottai la collezione di scrittori politici di Attilio Brunialti.
Q8 §150 Nozioni enciclopediche. Demiurgo. Dal significato originario di «lavorante per il popolo, per la comunità» (artigiano) fino ai significati attuali di «creatore» ecc. (cfr scritti di Filippo Burzio).
Q8 §151 Argomenti di coltura. Contro natura, naturale ecc. Cosa significa dire che una certa azione è «naturale», o che essa è invece «contro natura»? Ognuno, nel suo intimo, crede di sapere esattamente cosa ciò significa, ma se si domanda una risposta esplicita, si vede che la cosa non è poi così facile. Intanto occorre fissare che non si può parlare di «natura» come qualcosa di fisso e oggettivo; in questo caso «naturale» significa giusto e normale secondo la nostra attuale coscienza storica, che è poi la nostra «natura». Molte azioni che alla nostra coscienza appaiono contro natura, per altri sono naturali perché gli animali le compiono e non sono forse gli animali gli «esseri più naturali del mondo»? Queste forme di ragionamento si sentono talvolta fare a proposito di problemi connessi ai rapporti sessuali. Perché l’incesto sarebbe «contro natura» se esso è comune nella «natura»? Intanto anche queste affermazioni sugli animali non sempre sono esatte, perché le osservazioni sono fatte su animali addomesticati dall’uomo per il suo utile e costretti a una forma di vita che per loro non è naturale, ma è secondo la volontà umana. Ma se anche ciò fosse vero, che valore avrebbe ciò per l’uomo? La natura dell’uomo è l’insieme dei rapporti sociali che determina una coscienza storicamente definita, e questa coscienza indica ciò che è «naturale» o no ed esiste così una natura umana contraddittoria perché è l’insieme dei rapporti sociali.
Si parla di «seconda natura»; una certa abitudine è diventata una seconda natura; ma la «prima natura» sarà stata proprio «prima»? Non c’è in questo modo di esprimersi del senso comune l’accenno alla storicità della natura umana? (continua sotto).
Q8 §152 Passato e presente. Si potrebbe dire che la borghesia francese è il «gargagnan della civiltà europea».
Q8 §153 Argomenti di coltura. Contro natura, naturale, ecc. Constatato che essendo contraddittorio l’insieme dei rapporti sociali, è contraddittoria la coscienza storica degli uomini, si pone il problema del come si manifesti tale contraddittorietà: si manifesta nell’intero corpo sociale, per l’esistenza di coscienze storiche di gruppo, e si manifesta negli individui come riflesso di queste antinomie di gruppo. Nei gruppi subalterni, per l’assenza di iniziativa storica, la disgregazione è più grave, è più forte la lotta per liberarsi da principii imposti e non proposti autonomamente, per il raggiungimento di una coscienza storica autonoma. Come si formerà? Come ognuno dovrà scegliere gli elementi che costituiranno la coscienza autonoma? Ogni elemento «imposto» sarà perciò da ripudiare a priori? Sarà da ripudiare come imposto, ma non in se stesso, cioè occorrerà dargli una nuova forma che sia legata al gruppo dato. Che l’istruzione sia «obbligatoria» non significa che sia da ripudiare: occorre fare «libertà» di ciò che è «necessario», ma perciò occorre riconoscere una necessità «obbiettiva», cioè che sia obbiettiva anche per il gruppo in parola. Bisogna riferirsi quindi ai rapporti tecnici di produzione, a un determinato tipo di produzione che per essere continuato e sviluppato domanda un determinato modo di vivere e quindi determinate regole di condotta. Bisogna persuadersi che non solo è «oggettivo» e necessario un certo attrezzo, ma anche un certo modo di comportarsi, una certa educazione, una certa civiltà; in questa oggettività e necessità storica si può porre l’universalità del principio morale, anzi non è mai esistita altra universalità che questa oggettiva necessità, spiegata con ideologie trascendenti e presentata nel modo più efficace volta per volta perché si ottenesse lo scopo. (Continua pagina seguente).
Q8 §154 Passato e presente. Franz Weiss, «stelletta» dei «Problemi del Lavoro» potrebbe chiamarsi il «nuovo Masticabrodo» e la raccolta dei suoi scritti il nuovo libro delle Sette Trombe.
L’altra «stelletta», quella del «Lavoro» (Weiss ha sei punte, Ansaldo ha cinque punte: la stelletta di Ansaldo viene identificata anche come «stelletta nera» del «Lavoro») è più «aristocratica» e nello stile e nel contenuto di argomenti. La «popolarità» dello stile del Weiss consiste specialmente in ciò che i suoi articoli sono formicolanti di proverbi e di modi di dire popolari più proverbioso di Sancio Pancia: si potrebbe fare una raccolta di «sapienze»: «tanto va la gatta al lardo, bandiera vecchia, gallina vecchia, il senno di poi, due pesi e due misure», ecc.; vedere anche la «falsa» familiarità e il brio da cocotte stanca. Si ha l’impressione che Weiss abbia uno stock di proverbi e modi di dire da mettere in circolazione, come il commesso viaggiatore ha il suo stock di freddure: quando vuol scrivere un articolo, non gli importa il contenuto dell’articolo, ma la razione di proverbi da esitare. Lo svolgimento letterario è dettato non dalla necessità intima della dimostrazione, ma dal bisogno di collocare le preziose gemme della sapienza dei popoli. Parallelo con Corso Bovio, che, invece dei proverbi, costella gli articoli di grandi nomi; ogni colonnina di giornale è una passeggiata in un Pincio della Società delle Nazioni: bisogna che appaiano, per colonna, almeno 50 nomi, da Pitagora a Paneroni, dall’Ecclesiaste a Tom Pouce. Si potrebbe, come esempio di ilotismo letterario, analizzare così un articolo di Weiss e uno di Corso Bovio. (C’è però un po’di Bovio in Weiss e un po’di Weiss in Bovio e ambedue fanno rimaner babbeo il lettore operaio al quale si rivolgono).
Q8 §155 Passato e presente. Apologhi. Spunti sulla religione. L’opinione corrente è questa: che non si deve distruggere la religione se non si ha qualcosa da sostituirle nell’animo degli uomini. Ma come si fa a capire quando una sostituzione è avvenuta e il vecchio può essere distrutto?
Altro modo di pensare connesso al primo: la religione è necessaria per il popolo, anzi per il «volgo», come si dice in questi casi. Naturalmente ognuno crede di non essere più «volgo», ma che volgo sia ogni suo prossimo e perciò dice necessario anche per sé fingere di essere religioso, per non turbare lo spirito degli altri e gettarli nel dubbio. Avviene così che siano molti a non credere più, ognuno persuaso di essere superiore agli altri perché non ha bisogno di superstizioni per essere onesto ma ognuno persuaso che occorre mostrare di «credere» per rispetto agli altri.
Q8 §156 Argomenti di coltura. Contro natura, naturale, ecc. Una concezione come quella esposta pare conduca a una forma di relativismo e quindi di scetticismo morale. È da osservare che ciò si può dire di tutte le concezioni precedenti, la cui imperatività categorica e oggettiva è sempre stata riducibile dalla «cattiva volontà» a una forma di relativismo. Perché la concezione religiosa potesse almeno apparire assoluta e oggettivamente universale, sarebbe stato necessario che essa si presentasse monolitica, per lo meno intellettualmente uniforme in tutti i credenti, ciò che è lungi dalla realtà (differenze di scuola, sette, tendenze, e differenze di classe: semplici e colti ecc.). Così si dica della formula categorica del Kant: opera come vorresti operassero tutti gli uomini nelle stesse circostanze.
È evidente che ognuno può pensare che tutti dovrebbero operare come lui: un marito geloso che ammazza la moglie infedele pensa che tutti i mariti dovrebbero ammazzare le mogli infedeli; la formula kantiana, analizzata realisticamente, non supera un ambiente dato, con tutte le sue superstizioni morali e i suoi costumi barbarici, è statica è una vuota formula che può essere riempita di qualsiasi contenuto storico attuale (con le sue contraddizioni, naturalmente, per cui ciò che è verità di là dai Pirenei è bugia di qua dai Pirenei). L’argomento del pericolo del relativismo e scetticismo non è valido pertanto. Il problema da porsi è un altro: cioè questa data concezione ha in sé i caratteri di una certa durata? oppure è mutevole ogni giorno e dà luogo, nello stesso gruppo, alla formulazione della teoria della doppia verità? Risolti questi problemi, la concezione è giustificata. Ma ci sarà un periodo di rilassatezza, anzi di libertinaggio e di dissolvimento morale. Questo è tutt’altro che escluso. Ma è argomento non valido. I periodi di rilassatezza e di dissolvimento si sono spesso verificati nella storia, predominando sempre la stessa concezione morale; essi sono dipendenti da cause storiche reali e non dalle concezioni morali, essi indicano anzi che una vecchia concezione si disgrega e un’altra nasce, ma quella in disgregamento tenta di mantenersi coercitivamente, costringendo la società a forme di ipocrisia alle quali appunto i periodi di rilassamento e libertinaggio reagiscono.
Il pericolo di non vivacità morale è invece rappresentato dalla teoria fatalistica degli stessi gruppi che dividono la concezione della naturalità secondo la natura dei bruti, per cui tutto è giustificato dall’ambiente sociale; ogni responsabilità individuale così viene ad essere annegata nella responsabilità sociale. Se questo fosse vero, il mondo e la storia sarebbero immobili sempre. Infatti se l’individuo per cambiare ha bisogno che tutta la società cambi, meccanicamente, per chissà quale forza extraumana, il cambiamento non avverrebbe mai. La storia è una lotta continua di individui o di gruppi per cambiare la società, ma perché ciò sia questi individui e gruppi dovranno sentirsi superiori alla società, educatori della società ecc. L’ambiente quindi non giustifica ma solo «spiega» il comportamento degli individui e specialmente di quelli più passivi storicamente. La spiegazione servirà a rendere talvolta indulgenti verso i singoli e darà materiale per l’educazione, ma non deve mai diventare «giustificazione» senza condurre necessariamente a una delle forme più ipocrite e rivoltanti di conservatorismo e di «retrivismo». (Continua a p. 49).
Q8 §157 Argomenti di coltura. Una frase del generale Gazzera nel discorso al Parlamento come ministro della guerra (22 aprile 1932; cfr giornali del 23): «L’ardimento nasce dalla passione, la sagacia dall’intelletto, l’equilibrio dal sapere». Si potrebbe commentare, cercando, ciò che è specialmente interessante, di vedere come ardimento, sagacia ed equilibrio da doti personali diventano, attraverso l’organizzazione dell’esercito, qualità collettive di un insieme organico e articolato di ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati, poiché, nell’azione, tutte e quattro le gradazioni hanno vita propria intensa e insieme formano una collettività organica.
Q8 §158 Argomenti di coltura. La tendenza a diminuire l’avversario. Mi pare che tale tendenza di per se stessa sia un documento della inferiorità di chi ne è posseduto. Si cerca infatti di diminuire l’avversario per poter credere di esserne vittoriosi; quindi in tale tendenza è anche istintivamente un giudizio sulla propria incapacità e debolezza, ossia un inizio di autocritica, che si vergogna di se stessa, che ha paura di manifestarsi esplicitamente e con coerenza sistematica, perché si crede nella «volontà di credere» come condizione di vittoria, ciò che non sarebbe inesatto se non fosse concepito meccanicamente e non diventasse un autoinganno (contiene una indebita confusione tra massa e capi e finisce coll’abbassare la funzione del capo al livello della funzione del più arretrato e incondito gregario), Un elemento di tale tendenza è di natura oppiacea: è proprio dei deboli abbandonarsi alla fantasticheria, sognare a occhi aperti che i propri desideri sono realtà, che tutto si svolge secondo essi: da una parte l’incapacità, la stupidaggine, la barbarie, la paurosità, dall’altra le più alte doti di carattere e di intelligenza: la lotta non dovrebbe essere dubbia e già pare di tenere in pugno la vittoria. La lotta rimane lotta sognata e vinta in sogno: nella realtà, da dovunque si cominci ad operare, le difficoltà appaiono gravi, e siccome si deve cominciare sempre necessariamente da piccole cose (poiché, per lo più, le grandi cose sono un insieme di piccole cose), viene a sdegno la «piccola cosa»: è meglio continuare a sognare e rimandare tutto al momento della «grande cosa». La funzione di sentinella è gravosa, noiosa, defatigante; perché «sprecare» così la forza umana e non conservarla invece per la grande battaglia eroica? e così via.
Non si riflette poi che se l’avversario ti domina e tu lo diminuisci, riconosci di essere dominato da uno che consideri inferiore? Ma come è riuscito a dominarti? Come mai ti ha vinto ed è stato superiore a te proprio in quell’attimo decisivo che doveva dare la misura della tua superiorità e della sua inferiorità? Ci sarà stata di mezzo la «coda del diavolo». Ebbene impara ad avere la coda del diavolo dalla tua parte.
Q8 §159 Argomenti di coltura. Naturale, contro natura, ecc. Al concetto di «naturale» si contrappone quello di «artificiale» o «convenzionale». Ma cosa significa «artificiale» e «convenzionale» quando è riferito alle grandi moltitudini? Significa «storico» e inutilmente si cerca un senso deteriore nella cosa, perché essa è penetrata nella coscienza come una «seconda natura». Si potrà quindi parlare di artificio e di convenzione in riferimento a idiosincrasie personali, non a fenomeni di massa già in atto. Viaggiare in ferrovia è artificiale, ma non certo come l’imbellettarsi per una donna.
Per ciò che si è accennato nei paragrafi precedenti, come positività, si pone il problema di chi dovrà decidere che un determinato contegno morale è il più conforme a un determinato stadio di sviluppo delle forze produttive. Certo non si creerà un ufficio apposta. Le forze dirigenti nasceranno per il fatto stesso che il modo di pensare sarà indirizzato in questo senso realistico, e nasceranno dall’urto stesso dei pareri discordi, senza «convenzionalità» e «artifici».
Q8 §160 I nipotini di padre Bresciani. Papini. Il cattolicismo atteggia lo stile del Papini. Non dirà più «sette» ma «quanti sono i peccati capitali»: «Non già che mancassero traduzioni italiane del capo d’opera goethiano: il Manacorda ne ha tenute presenti, fra integre e no, tante quanti sono i peccati capitali» (Il Faust svelato in «Corriere della Sera» del 26 aprile 1932).
Q8 §161 Quistione degli intellettuali. Sicilia e Sardegna. Per il diverso peso che esercita la grande proprietà in Sicilia e in Sardegna, e quindi per la diversa posizione relativa degli intellettuali, ciò che spiega il diverso carattere dei movimenti politico‑culturali, valgono queste cifre: in Sardegna solo il 18% del territorio appartiene a Enti pubblici, il resto proprietà privata: dell’area coltivabile il 50% comprende possessi inferiori a 10 ha, e solo il 4% al di sopra di 200 ha.
Sicilia: nel 1907 il Lorenzoni assegnava 1400 proprietà di oltre 200 ha con una estensione di ha 717 729,16 cioè il 29,79% dell’estensione catastale dell’isola, posseduta da 787 proprietari. Nel 1929 il Molè constatava 1055 latifondi di oltre 200 ha con estensione complessiva di ha 540 700 cioè il 22,2% dell’area agraria e forestale (ma si tratta di vero frazionamento del latifondo?)
Inoltre occorre tener conto della differenza storico‑sociale‑culturale dei grandi proprietari siciliani da quelli sardi: i siciliani hanno una grande tradizione e sono fortemente uniti. In Sardegna niente di ciò.
Q8 §162 Machiavelli. Studi particolari su Machiavelli come «economista»: Gino Arias negli «Annali di Economia della Università Bocconi» pubblica uno studio dove si trova qualche indicazione. (Studio di Vincenzo Tangorra). Pare che lo Chabod, in qualche suo scritto sul Machiavelli, trovi che sia una deficienza del fiorentino, in confronto, per es., al Botero, il fatto della quasi assenza di riferimenti economici nei suoi scritti (sull’importanza del Botero per lo studio della storia del pensiero economico cfr Mario De Bernardi e recensione di L. Einaudi nella Riforma Sociale di marzo‑aprile 1932).
Occorre fare alcune osservazioni generali sul pensiero politico del Machiavelli e sul suo carattere di «attualità» a differenza di quello del Botero, che ha carattere più sistematico e organico sebbene meno vivo e originale. Occorre anche richiamare il carattere del pensiero economico di quel tempo (spunti nel citato articolo dell’Einaudi) e la discussione sulla natura del mercantilismo (scienza economica o politica economica?) Se è vero che il mercantilismo è una mera politica economica, in quanto non può presupporre un «mercato determinato» e l’esistenza di un preformato «automatismo economico», i cui elementi si formano storicamente solo a un certo grado di sviluppo del mercato mondiale, è evidente che il pensiero economico non può fondersi nel pensiero politico generale, cioè nel concetto di Stato e delle forze che si crede debbano entrare a comporlo. Se si prova che il Machiavelli tendeva a suscitare legami tra città e campagna e ad allargare la funzione delle classi urbane fino a domandar loro di spogliarsi di certi privilegi feudali‑corporativi nei rispetti della campagna, per incorporare le classi rurali nello Stato, si dimostrerà anche che il Machiavelli implicitamente ha superato in idea la fase mercantilista e ha già degli accenni di carattere «fisiocratico», cioè egli pensa a un ambiente politico‑sociale che è quello presupposto dall’economia classica.
Il prof. Sraffa attira l’attenzione su un possibile avvicinamento del Machiavelli a un economista inglese del 1600, William Petty, che Marx chiama il «fondatore dell’economia classica» e le cui opere complete sono state tradotte anche in francese. (Marx ne parlerà nei volumi del Mehrwert, Storia delle dottrine economiche).
Q8 §163 Machiavelli. Rapporti di forze, ecc. L’osservazione fondamentale che tali analisi non sono fini a se stesse, ma devono servire a giustificare il lavoro pratico, in quanto sono fatte per sceverare i punti su cui applicare la forza della volontà. Perciò elemento sempre fondamentale rimane la forza permanente organizzata che si può fare avanzare quando la situazione diventa propizia (collasso dell’avversario, crisi, ecc.) e compito essenziale attendere sistematicamente a formare, sviluppare, ampliare, rendere sempre più omogenea, compatta, consapevole di se stessa questa forza.
Q8 §164 Nozioni enciclopediche. Bibliografia. S. E. il generale Carlo Porro, Terminologia geografica, Raccolta di vocaboli di geografia e scienze affini, per uso degli studi di geografia generale e militare, in 8°, pp. x‑794, Utet, Torino, 1902, L. 7,50.
L’avvocato di tutti. Piccola enciclopedia legale, in 8°, pp. VIII‑1250, L. 120, Utet, Torino.
Q8 §165 A. Oriani. Occorre studiarlo come il rappresentante più onesto e appassionato per la grandezza nazionale‑popolare italiana fra gli intellettuali italiani della vecchia generazione. La sua posizione non è però critica‑ricostruttiva, e quindi tutti i motivi della sua sfortuna e dei suoi fallimenti. In realtà a chi si richiamava l’Oriani? Non alle classi dominanti, da cui tuttavia si attendeva riconoscimenti e onori, nonostante le sue diatribe corrosive. Non ai repubblicani, cui tuttavia si apparenta la sua forma mentale recriminatoria. La Lotta politica sembra il manifesto per un grande movimento democratico nazionale popolare, ma l’Oriani è troppo imbevuto di filosofia idealistica, quale si venne foggiando nell’epoca della Restaurazione, per saper parlare al popolo come capo e come eguale nello stesso tempo, per far partecipare il popolo alla critica di se stesso e delle sue debolezze senza tuttavia fargli perdere la fede nella propria forza e nel proprio avvenire. La debolezza dell’Oriani è in questo carattere meramente intellettuale delle sue critiche, che creano una nuova forma di dottrinarismo e di astrattismo. Tuttavia vi è un movimento abbastanza sano di pensiero che si dovrebbe approfondire. La fortuna di Oriani in questi ultimi tempi è più un’imbalsamazione funeraria che un’esaltazione di nuova vita del suo pensiero.
APPUNTI DI FILOSOFIA. MATERIALISMO E IDEALISMO
Terza serie
Q8 §166 Graziadei. Oltre alle teorie del Loria, cercare se le quistioni sollevate dal Graziadei non hanno origine nelle teorie del Rodbertus. Nella «Histoire des doctrines économiques» di Gide e Rist (V ediz., ristampa del 1929) a p. 504 si legge: «Remarquons aussitôt la différence d’attitude entre Rodbertus et Marx. Le second, tout imprégné de l’économie politique et du socialisme anglais, part de la théorie de l’échange et fait du travail la source de toute valeur. Rodbertus, inspiré par les Saint‑Simoniens, part de la production et fait du travail l’unique source de tout produit, proposition plus simple et plus vraie que la précédente, quoique encore incomplète. Non seulement Rodbertus ne dit pas que le travail seul crée la valeur, mais il le nie expressément à diverses reprises, en donnant les raisons de son opinion». In nota il Rist dà riferimenti bibliografici in proposito e cita una lettera di Rodbertus a R. Meyer del 7 gennaio 1872 dove è un accenno al fatto che la «demonstration pourrait, le cas échéant, (s’)utiliser contre Marx».
Q8 §167 Il libro di De Man. Porre in luce i «valori psicologici ed etici» del movimento operaio significa forse confutare le dottrine del materialismo storico? Sarebbe come dire che il porre in luce il fatto che la grande maggioranza degli abitanti del mondo è ancora tolemaica significa confutare le dottrine di Copernico. Marx afferma che gli uomini acquistano coscienza della loro posizione sociale nel terreno delle soprastrutture; ha forse escluso i proletari da questo modo di prendere coscienza di sé? Che il materialismo storico cerchi di modificare questa fase culturale, elevando l’autocoscienza ecc., non significa appunto che gli stessi materialisti storici lavorano in quel terreno che il De Man crede di aver scoperto? La scoperta del De Man è un luogo comune e la sua confutazione una petizione di principio (o ignorantia elenchi).
Q8 §168 Antonio Labriola e lo hegelismo. È da studiare come il Labriola, partendo da posizioni herbartiane e antihegeliane sia passato al materialismo storico. La dialettica in Antonio Labriola, insomma.
Q8 §169 Unità della teoria e della pratica. Il lavoratore medio opera praticamente, ma non ha una chiara coscienza teorica di questo suo operare‑conoscere il mondo; la sua coscienza teorica anzi può essere «storicamente» in contrasto col suo operare. Egli cioè avrà due coscienze teoriche, una implicita nel suo operare e che realmente lo unisce a tutti i suoi collaboratori nella trasformazione pratica del mondo, e una «esplicita», superficiale, che ha ereditato dal passato. La posizione pratico‑teorica, in tale caso, non può non diventare «politica» cioè quistione di «egemonia». La coscienza di essere parte della forza egemonica (cioè la coscienza politica) è la prima fase di una ulteriore e progressiva autocoscienza, cioè di unificazione della pratica e della teoria. Anche l’unità di teoria e pratica non è un dato di fatto meccanico, ma un divenire storico, che ha la sua fase elementare e primitiva nel senso di «distinzione», di «distacco», di «indipendenza». Ecco perché altrove ho osservato che lo sviluppo del concetto‑fatto di egemonia ha rappresentato un grande progresso «filosofico» oltre che politico‑pratico.
Tuttavia, nei nuovi sviluppi del materialismo storico, l’approfondimento del concetto di unità della teoria e della pratica non è ancora che ad una fase iniziale: ancora ci sono dei residui di meccanicismo. Si parla ancora di teoria come «complemento» della pratica, quasi come accessorio ecc. Penso che anche in questo caso la quistione debba essere impostata storicamente, e cioè come un aspetto della quistione degli intellettuali. L’autocoscienza storicamente significa creazione di una avanguardia di intellettuali: una «massa» non si «distingue» e non diventa «indipendente» senza organizzarsi e non c’è organizzazione senza intellettuali, cioè senza organizzatori e dirigenti. Ma questo processo di creazione degli intellettuali è lungo e difficile, come si è già visto altrove. E per molto tempo, cioè finché la «massa» degli intellettuali non ha raggiunto una certa ampiezza, ciò che significa finché la più grande massa non ha raggiunto un certo livello di cultura, appare sempre come un distacco tra intellettuali (o certi di essi, o un gruppo di essi) e le grandi masse: quindi l’impressione di «accessorio e complementare». L’insistere sulla «pratica», cioè, dopo avere nell’«Unità» affermata, non distinto, ma separato la pratica dalla teoria (operazione puramente meccanica) significa storicamente che la fase storica è ancora relativamente elementare, è ancora la fase economico‑corporativa, in cui si trasforma il quadro generale della «struttura».
A proposito degli intellettuali si potrebbe ancora osservare, a questo proposito, la differenza fondamentale tra l’epoca prima e dopo la Rivoluzione francese e l’epoca attuale: l’individualismo economico dell’epoca precedente è anch’esso fenomeno di struttura, poiché la vecchia struttura si sviluppava per apporti individuali. L’intellettuale immediato del capitalismo era l’«industriale», organizzatore della produzione. Nell’economia di massa, la selezione individuale avviene nel campo intellettuale e non in quello economico; l’affare principale è quello dell’unificazione di pratica e teoria, cioè di direzione di «tutta la massa economicamente attiva», e ciò agli inizi non può non avvenire che individualmente (adesione individuale ai partiti politici e non Labour Party o associazioni sindacaliste): i Partiti sono gli elaboratori della nuova intellettualità integrale e totalitaria e l’intellettuale tradizionale della fase precedente (clero, filosofi professionali ecc.) sparisce necessariamente, a meno che non si assimili dopo processo lungo e difficile.
Q8 §170 Ideologie scientifiche. L’affermazione di Eddington: «Se nel corpo di un uomo eliminassimo tutto lo spazio privo di materia e riunissimo i suoi protoni ed elettroni in una sola massa, l’uomo (il corpo dell’uomo) sarebbe ridotto a un corpuscolo appena visibile al microscopio» (cfr La natura del mondo fisico, ed. francese, p. 20) ha molto colpito la fantasia di G. A. Borgese (cfr il suo libretto). Ma cosa significa poi concretamente l’affermazione di Eddington? Mi pare significhi proprio nulla. Se anche si facesse la riduzione su descritta, e la si estendesse a tutto il mondo, i rapporti non muterebbero, le cose rimarrebbero tali come sono. Le cose muterebbero solo se solo l’uomo o determinati uomini subisse questa riduzione, nell’ipotesi: si avrebbe allora una riedizione dei Viaggi di Gulliver, con i Lillipuziani, i giganti ecc.
Si potrebbe anche ricordare, a proposito di questo uomo ridotto a un corpuscolo visibile solo al microscopio, la novellina ebrea della ragazza che ha subito un guasto piccolo piccolo, tic… come un colpettino d’unghia. E poi, cosa significherebbe in questo caso un «microscopio» e chi guarderebbe nel microscopio, se l’uomo è un corpuscolo ecc. ecc.? Si tratta in realtà di giochi di parole, non di pensiero scientifico o filosofico. Questo modo di porre le quistioni serve a far fantasticare le teste vuote. Fu pubblicato una volta che l’uomo altro non è che una «muffa vagabonda» come se ciò dovesse mutare il mondo: le teste vuote che confondono le cose con le parole credettero davvero che il mondo fosse mutato e l’uomo non fosse più ciò che era sempre stato nella storia, o non fosse modificato solo in senso progressivo, dato che avesse fatto una nuova scoperta reale che gli permettesse di conoscere meglio il mondo e i suoi rapporti col mondo.
Nella fisica di Eddington la sorpresa del lettore a‑filosofo dipende dal fatto che le parole adoperate per indicare determinati fatti sono arbitrariamente piegate a indicare fatti assolutamente diversi; un corpo rimane «massiccio», nel senso tradizionale, anche se la nuova fisica dimostra che quel corpo contiene un milione di parti di «vuoto» e solo 1 / 1 000 000 di materia; un corpo è «poroso» nel senso tradizionale e non nel nuovo senso, è «poroso» se si lascia penetrare dall’acqua ecc.
Q8 §171 Sul «Saggio popolare». La quistione di nomenclatura e di contenuto. Una caratteristica degli intellettuali come categoria sociale cristallizzata (come categoria sociale che concepisce se stessa come continuazione ininterrotta nella storia, quindi al di sopra delle lotte di gruppi e non come espressione di un processo dialettico, per cui ogni gruppo sociale dominante elabora una propria categoria di intellettuali) è appunto di ricongiungersi, nella sfera ideologica, a una precedente categoria intellettuale, attraverso una stessa nomenclatura di concetti. Una nuova situazione storica crea una nuova superstruttura ideologica, i cui rappresentanti (gli intellettuali) devono essere concepiti come anch’essi «nuovi intellettuali», nati dalla nuova situazione e non continuazione della precedente intellettualità. Se i «nuovi» intellettuali si pongono come continuazione diretta della precedente intellettualità essi non sono affatto «nuovi», essi non sono legati al nuovo gruppo sociale che rappresenta la nuova situazione storica, ma ai rimasugli del vecchio gruppo sociale di cui la vecchia intellettualità era espressione. Tuttavia avviene che nessuna nuova situazione storica, sia essa pur dovuta al mutamento più radicale, muta completamente il linguaggio, almeno nel suo aspetto esterno, formale. Ma il contenuto del linguaggio è mutato, e di questa mutazione è difficile avere una coscienza esatta immediatamente. D’altronde il fenomeno è storicamente complesso e complicato dalla diversa cultura tipica dei diversi strati del nuovo gruppo sociale, molti dei quali, nel terreno ideologico, sono ancora immersi nella cultura di situazioni storiche precedenti. Una classe, di cui molti strati sono ancora alla concezione tolemaica, può essere la rappresentante di una situazione storica molto progredita: questi strati, se ideologicamente arretrati, praticamente (cioè come funzione economica e politica) sono avanzatissimi ecc.
Se compito degli intellettuali è quello di determinare e organizzare la rivoluzione culturale, cioè di adeguare la cultura alla funzione pratica, è evidente che gli intellettuali «cristallizzati» sono reazionari ecc.
La quistione della nomenclatura filosofica è, per così dire, «attiva e passiva»: si accetta non solo l’espressione ma anche il contenuto di un concetto di una intellettualità superata, mentre si respinge la espressione di un’altra intellettualità passata, anche se essa ha mutato di contenuto ed è divenuta efficace a esprimere il nuovo contenuto storico‑culturale. Così è avvenuto per il termine «materialismo», accettato col contenuto passato, e per il termine «immanenza» respinto perché nel passato aveva un determinato contenuto storico‑culturale. La difficoltà di adeguare l’espressione letteraria al contenuto concettuale e di confondere le quistioni lessicali con le quistioni sostanziali e viceversa è caratteristica del dilettantismo filosofico, di una mancanza di senso storico nel cogliere i diversi momenti di un processo di sviluppo culturale e quindi storico in generale, cioè di concezione antidialettica, dogmatica prigioniera di schemi astratti di logica formale.
Q8 §172 Bibliografie. Vedere la bibliografia di A. Chiappelli (morto in questo novembre 1931). Verso la metà del decennio 90‑900 egli mi pare si sia occupato del materialismo storico (quando furono pubblicati i saggi di Antonio Labriola e di B. Croce) nel libro o saggio: Le premesse filosofiche del socialismo ecc.
Q8 §173 Sul «Saggio popolare». Un lavoro come il Saggio popolare, destinato a una comunità di lettori che non sono intellettuali di professione, dovrebbe partire dalla analisi e dalla critica della filosofia del senso comune, che è la «filosofia dei non filosofi», cioè la concezione del mondo assorbita acriticamente dai vari ambienti sociali in cui si sviluppa l’individualità morale dell’uomo medio. Il senso comune non è una concezione unica, identica nel tempo e nello spazio: esso è il «folclore» della filosofia, e come il folclore si presenta in forme innumerevoli: il suo carattere fondamentale è di essere una concezione del mondo disgregata, incoerente, inconseguente, conforme al carattere delle moltitudini di cui esso è la filosofia. Quando nella storia si elabora un gruppo sociale omogeneo, si elabora anche, contro il senso comune, una filosofia «omogenea», cioè sistematica. Gli elementi principali del senso comune sono dati dalle religioni, e non solo dalla religione attualmente dominante, ma dalle religioni precedenti, da movimenti ereticali popolari, da concezioni scientifiche passate ecc. Nel senso comune predominano gli elementi «realistici, materialistici», ciò che non è in contraddizione con l’elemento religioso, tutt’altro; ma questi elementi sono «acritici», «superstiziosi». Ecco un pericolo rappresentato dal Saggio popolare: esso conferma spesso questi elementi acritici, basati sulla mera percezione immediata, per cui il senso comune è ancora rimasto «tolemaico», antropomorfico e antropocentrico.
Nella cultura filosofica francese esistono trattazioni sul «senso comune» più che in altre culture: ciò è dovuto al carattere «popolare-nazionale» della cultura francese, cioè al fatto che gli intellettuali tendono, più che altrove, per determinate condizioni storiche, ad avvicinarsi al popolo per guidarlo ideologicamente e tenerlo legato al gruppo dirigente. Si potrà trovare quindi nella letteratura francese molto materiale sul senso comune utilizzabile: anzi l’atteggiamento della cultura filosofica francese verso il «senso comune» può offrire un modello di costruzione culturale egemonica; anche la cultura inglese e americana possono offrire molti spunti, ma non in modo così completo e organico come quella francese. Il «senso comune» è stato trattato in due modi: 1°) è stato messo a base della filosofia; 2°) è stato criticato dal punto di vista di un’altra filosofia; ma in realtà, nell’un caso e nell’altro, il risultato fu di superare un determinato «senso comune» per crearne un altro più aderente alla concezione del mondo del gruppo dirigente.
Atteggiamento del Croce verso il «senso comune»: non mi pare chiaro. Per il Croce, la tesi che «ogni uomo è un filosofo» ha finora troppo gravato sul giudizio intorno al «senso comune»; il Croce sembra spesso compiacersi perché determinate proposizioni filosofiche sono condivise dal senso comune, ma che cosa può ciò significare in concreto? Perché sia vero che «ogni uomo è un filosofo» non è necessario ricorrere, in questo senso, al senso comune. Il senso comune è un aggregato incomposto di concezioni filosofiche e vi si può trovare tutto ciò che si vuole. D’altronde in Croce, questo atteggiamento verso il senso comune non ha portato a un atteggiamento culturale fecondo dal punto di vista «popolare‑nazionale», cioè ad una concezione più concretamente storicistica della filosofia, che del resto può trovarsi solo nel materialismo storico.
Opere di Léon Brunschvieg: Les étapes de la philosophie mathématique, L’expérience humaine et la causalité physique, Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, La connaissance de soi, Introduction à la vie de l’esprit. Cito da un articolo di Henri Gouhier nelle «Nouvelles Littéraires» del 17‑10‑931 sul Brunschvicg: «Il n’y a qu’un seul et même mouvement de spiritualisation, qu’il s’agisse de mathématiques, de physique, de biologie, de philosophie et de morale; c’est l’effort par lequel l’esprit se débarrasse du sens commun et de sa métaphysique spontanée qui pose un monde de choses sensibles réelles et l’homme au milieu de ce monde».
Q8 §174 Sul «Saggio popolare». Si può avere dal Saggio una critica della metafisica? Mi pare che il concetto stesso di metafisica sfugga all’autore, in quanto gli sfugge il concetto di movimento storico, del divenire e quindi della dialettica. Pensare che una affermazione è vera per un periodo storico, cioè è l’espressione necessaria e inscindibile di una determinata azione, di una determinata praxis, ma diventerà «falsa» in un periodo storico successivo, senza perciò cadere nello scetticismo e nel relativismo (opportunismo morale e ideologico) è molto difficile. L’autore non riesce a sfuggire al dogmatismo, quindi alla metafisica: tutto il suo libro anzi è viziato di dogmatismo e di metafisica e ciò è chiaro dall’inizio, dall’impostazione del problema cioè della possibilità di costruire una «sociologia» del marxismo: sociologia significa appunto, in questo caso, metafisica. In una nota l’autore non sa rispondere all’obbiezione di alcuni teorici che sostengono il materialismo storico poter vivere solo in concrete opere di storia; egli non riesce a elaborare la concezione del materialismo storico come «metodologia storica» e questa come «filosofia», come la sola filosofia concreta, non riesce cioè a porsi e a risolvere dal punto di vista del materialismo storico il problema che Croce si è posto e ha cercato di risolvere dal punto di vista dell’idealismo. Invece di «metodologia storica», di «filosofia», egli costruisce una sociologia, cioè una «casistica» di problemi concepiti e risolti dogmaticamente, quando non empiricamente. Pare che per l’autore «metafisica» sia una determinata formulazione filosofica, e non ogni formulazione di soluzioni che si ponga come un universale astratto, fuori del tempo e dello spazio.
Q8 §175 Gentile. Vedere il suo articolo La concezione umanistica del mondo (nel corpo della rivista è stampato La concezione umanistica nel mondo ma nel sommario il «nel» è «del») nella «Nuova Antologia» del 1° giugno 1931. L’inizio dice: «La filosofia si potrebbe definire come un grande sforzo compiuto dal pensiero riflesso per conquistare la certezza critica delle verità del senso comune e della coscienza ingenua; di quelle verità che ogni uomo si può dire che senta naturalmente e che costituiscono la struttura solida della mentalità di cui egli si serve per vivere». Mi pare un altro esempio della rozzezza incondita del pensiero gentiliano, derivato «ingenuamente» da alcune affermazioni del Croce sul modo di pensare del popolo come riprova di determinate proposizioni filosofiche. La citazione può essere utilizzata per la rubrica del «senso comune». (Epigramma del Giusti: «Il buon senso, che un dì fu caposcuola, – or nelle nostre scuole è morto affatto – La scienza sua figliola – l’uccise per veder com’era fatto –»; bisogna vedere se non era necessario che la scienza uccidesse il «buon senso» tradizionale, per creare un nuovo «buon senso»). Così il Gentile parla di «natura umana» astorica, e di «verità del senso comune» come se nel «senso comune» non si potesse trovar tutto e come se esistesse un «solo senso comune» eterno e immutabile. «Senso comune» si dice in vari modi; per es. contro le astruserie, le macchinosità, le oscurità dell’esposizione scientifica e filosofica, cioè come «stile» ecc. L’articolo del Gentile può dare altre perle: un po’ più oltre si dice: «L’uomo sano crede in Dio e nella libertà del suo spirito», cosa per cui già ci troviamo di fronte a due «sensi comuni», quello dell’uomo sano e quello dell’uomo malato. (E cosa vorrà dire uomo sano? Fisicamente sano? Oppure non pazzo? ecc.). Quando Marx accenna alla «validità delle credenze popolari» fa un riferimento storico‑culturale per indicare la «saldezza delle convinzioni» e la loro efficacia nel regolare la condotta degli uomini, ma implicitamente afferma la necessità di «nuove credenze popolari», cioè di un nuovo «senso comune» e quindi di una nuova cultura ossia di una nuova filosofia.
Cfr Q 11 § 13
Q8 §176 La «nuova» scienza. «Considerando la insuperata minutezza di questi metodi di indagine ci tornava alla memoria la espressione di un membro dell’ultimo Congresso filosofico di Oxford il quale, secondo riferisce il Borgese, parlando dei fenomeni infinitamente piccoli cui l’attenzione di tanti è oggi rivolta, osservava che “essi non si possono considerare come esistenti indipendentemente dal soggetto che lo osserva”. Sono parole che inducono a molte riflessioni e che rimettono in campo, da punti di vista completamente nuovi, i grandi problemi dell’esistenza soggettiva dell’universo e del significato delle informazioni sensoriali nel pensiero scientifico». Così scrive Mario Camis nella Nuova Antologia del 10 novembre 1931 nella nota: «Scienze biologiche e mediche: Gösta Ekehorn, On the principles of renal function, Stockolm, 1931», p. 131. Il curioso è che proprio in questo articolo il Camis implicitamente spiega come quella espressione che tanto ha fatto vaneggiare il Borgese possa e debba intendersi in un senso meramente metaforico e non filosofico. Si tratta di elementi così piccoli che non possono essere descritti (e si intenda anche ciò in senso relativo) con parole per gli altri, e che l’esperimentatore perciò non riesce a scindere dalla propria personalità soggettiva: ogni esperimentatore deve giungere alla percezione con mezzi propri, direttamente. L’Ekehorn punge un glomerulo di rene della rana con una canula «la cui preparazione è opera di tanta finezza e tanto legata alle indefinibili ed inimitabili intuizioni manuali dello sperimentatore che lo stesso Ekehorn, nel descrivere l’operazione del taglio a sghembo del capillare di vetro dice di non poterne date i precetti a parole ma deve accontentarsi di una vaga indicazione». Se fosse vero che i fenomeni infinitamente piccoli in quistione «non si possono considerare esistenti indipendentemente dal soggetto che li osserva» essi non sarebbero «osservati» ma «creati» e cadrebbero nello stesso dominio dell’intuizione personale; non i fenomeni ma queste intuizioni sarebbero allora oggetto della scienza, come le «opere d’arte». Se il fenomeno si ripete e può essere osservato da vari scienziati, indipendentemente gli uni dagli altri, cosa significa l’affermazione se non appunto che si fa una metafora per indicare le difficoltà inerenti alla descrizione e alla rappresentazione dei fenomeni stessi? Difficoltà che può spiegarsi: 1°) con l’incapacità letteraria degli scienziati, didatticamente formati a descrivere e rappresentare i fenomeni macroscopici; 2°) con l’insufficienza del linguaggio comune, foggiato per i fenomeni macroscopici; 3°) col relativamente piccolo sviluppo di queste scienze minimoscopiche, che attendono un ulteriore sviluppo dei loro metodi per essere comprese dai molti per comunicazione letteraria (e non per visione diretta sperimentale).
Questa fase, transitoria, della scienza produce una forma di «sofistica» che richiama i classici sofismi di Achille e della tartaruga, del mucchio e del granello ecc., sofismi che rappresentarono tuttavia una fase nello sviluppo della filosofia e della logica. (Vedere nota precedente su stesso argomento: Borgese‑Eddington ecc.).
Q8 §177 La realtà «oggettiva». Cosa significa «oggettivo»? Non significherà «umanamente oggettivo» e non sarà perciò anche umanamente «soggettivo»? L’oggettivo sarebbe allora l’universale soggettivo, cioè: il soggetto conosce oggettivamente in quanto la conoscenza è reale per tutto il genere umano storicamente unificato in un sistema culturale unitario. La lotta per l’oggettività sarebbe quindi la lotta per l’unificazione culturale del genere umano; il processo di questa unificazione sarebbe il processo di oggettivazione del soggetto, che diventa sempre più un universale concreto, storicamente concreto. La scienza sperimentale è il terreno in cui una tale oggettivazione ha raggiunto il massimo di realtà; è l’elemento culturale che ha più contribuito a unificare l’umanità, è la soggettività più oggettivata e universalizzata concretamente.
Il concetto di oggettivo della filosofia materialistica volgare pare che voglia intendere una oggettività superiore all’uomo, che potrebbe essere conosciuta anche all’infuori dell’uomo: si tratta quindi di una forma banale di misticismo e di metafisicheria. Quando si dice che una certa cosa esisterebbe anche se non esistesse l’uomo, o si fa una metafora o si cade appunto nel misticismo. Noi conosciamo i fenomeni in rapporto all’uomo e siccome l’uomo è un divenire, anche la conoscenza è un divenire, pertanto anche l’oggettività è un divenire ecc.
Q8 §178 Gentile. Sulla filosofia del Gentile cfr l’articolo della «Civiltà Cattolica» Cultura e filosofia dell’ignoto (16 agosto 1930) che è interessante per vedere come con la logica scolastica si può criticare qualche banale sofisma dell’attualismo che vuole apparire la perfezione della dialettica. Ora perché la dialettica formale dovrebbe essere superiore alla logica formale? spesso si tratta di «strumenti» ben più primitivi di quelli della logica formale. Sarà perciò interessante leggere le critiche dei neoscolastici al Gentile.
Q8 §179 Stato etico o di cultura. Mi pare che ciò che di più sensato e concreto si possa dire a proposito dello Stato etico e di cultura è questo: ogni Stato è etico in quanto una delle sue funzioni più importanti è quella di elevare la grande massa della popolazione a un determinato livello culturale e morale, livello (o tipo) che corrisponde alle necessità di sviluppo delle forze produttive e quindi agli interessi delle classi dominanti. La scuola come funzione educativa positiva e i tribunali come funzione educativa repressiva e negativa sono le attività statali più importanti in tal senso: ma in realtà al fine tendono una molteplicità di altre iniziative e attività cosidette private che formano l’apparato dell’egemonia politica e culturale delle classi dominanti. La concezione di Hegel è propria di un periodo in cui lo sviluppo in estensione della borghesia poteva apparire illimitato, quindi l’eticità o universalità di essa poteva essere affermata: tutto il genere umano sarà borghese. Ma in realtà solo il gruppo sociale che pone la fine dello Stato e di se stesso come fine da raggiungere, può creare uno Stato etico, tendente a porre fine alle divisioni interne di dominati ecc. e a creare un organismo sociale unitario tecnico‑morale.
Q8 §180 Passato e presente. Le grandi idee. Le grandi idee e le formule vaghe. Le idee sono grandi in quanto sono attuabili, cioè in quanto rendono chiaro un rapporto reale che è immanente nella situazione e lo rendono chiaro in quanto mostrano concretamente il processo di atti attraverso cui una volontà collettiva organizzata porta alla luce quel rapporto (lo crea) o portatolo alla luce lo distrugge, sostituendolo. I grandi progettisti parolai sono tali appunto perché della «grande idea» lanciata non sanno vedere i vincoli con la realtà concreta, non sanno stabilire il processo reale di attuazione. Lo statista di classe intuisce simultaneamente l’idea e il processo reale di attuazione: compila il progetto e insieme il «regolamento» per l’esecuzione. Il progettista parolaio procede «provando e riprovando», della sua attività si dice che «fare e disfare è tutto un lavorare». Cosa vuol dire in «idea» che al progetto deve essere connesso un regolamento? Che il progetto deve essere capito da ogni elemento attivo, in modo che egli vede quale deve essere il suo compito nella sua realizzazione e attuazione; che esso suggerendo un atto ne fa prevedere le conseguenze positive e negative, di adesione e di reazione, e contiene in sé le risposte a queste adesioni o reazioni, offre cioè un terreno di organizzazione. È questo un aspetto dell’unità di teoria e di pratica.
Corollario: ogni grande uomo politico non può non essere anche un grande amministratore, ogni grande stratega un grande tattico, ogni grande dottrinario un grande organizzatore. Questo anzi può essere un criterio di valutazione: si giudica il teorico, il facitor di piani, dalle sue qualità di amministratore, e amministrare significa prevedere gli atti e le operazioni fino a quelle «molecolari» (e le più complesse, si capisce) necessarie per realizzare il piano.
Naturalmente, è giusto anche il contrario: da un atto necessario si deve saper risalire al principio corrispondente. Criticamente questo processo è di somma importanza. Si giudica da ciò che si fa, non da quel che si dice. Costituzioni statali > leggi > regolamenti: sono i regolamenti e anzi la loro applicazione (fatta in virtù di circolari) che indicano la reale struttura politica e giuridica di un paese e di uno Stato.
Q8 §181 Lo Hegelismo in Francia. Un Rapport sur l’état des études hégéliennes en France di A. Koyré è riprodotto nei Verhandlungen des ersten Hegelskongresses, vom 22 bis 25 April 1930 im Haag, Mohr, Tübingen, 1931, in 8° gr., pp. 243. Il Koyré, fra gli altri parla di «Luciano Herr, che ha passato venticinque anni della sua vita a studiare il pensiero hegeliano, e che è morto senza aver potuto scrivere il libro che si proponeva di darci e che avrebbe preso posto a lato di quelli del Delbos e di Xavier Léon» ma un saggio tuttavia ce ne ha lasciato, nell’articolo su Hegel pubblicato nella Grande Encyclopédie, notevole per lucidità e penetrazione. Su Luciano Herr ha pubblicato una Vie de Lucien Herr Charles Andler nell’«Europe» del 15 ottobre 1931 e seguenti. Scrive l’Andler: «Lucien Herr est présent dans tout le travail scientifique français depuis plus de quarante ans; et son action a été décisive dans la formation du socialisme en France».
Q8 §182 Struttura e superstrutture. La struttura e le superstrutture formano un «blocco storico», cioè l’insieme complesso e discorde delle soprastrutture sono il riflesso dell’insieme dei rapporti sociali di produzione. Se ne trae: che solo un sistema di ideologie totalitario riflette razionalmente la contraddizione della struttura e rappresenta l’esistenza delle condizioni oggettive per il rovesciamento della praxis. Se si forma un gruppo sociale omogeneo al 100% per l’ideologia, ciò significa che esistono al 100% le premesse per questo rovesciamento, cioè che il «razionale» è reale attuosamente e attualmente. Il ragionamento si basa sulla reciprocità necessaria tra struttura e superstrutture (reciprocità che è appunto il processo dialettico reale).
Q8 §183 Dialettica. Vedere il libretto Dialectica dei padri Liberatore‑Corsi S. I., Neapoli, Tip. commerciale, 1930, in 8° pp. 80, L. 7. Sarà composto di estratti del celebre polemista gesuita padre Liberatore. Può essere interessante per fissare cosa intendono per «dialettica» gli scolastici.
Q8 §184 Logica formale. Cfr Mario Govi, Fondazione della Metodologia. Logica ed Epistemologia, Torino, Bocca, 1929, pp. 579. Il Govi è un positivista; il suo libro appartiene alla tendenza di rinnovare il vecchio positivismo, di creare un neopositivismo. Mi pare che il tentativo possa avvicinarsi a quelli dei filosofi matematici come Bertrand Russell; ciò che è la «matematica» per il Russell è la «metodologia» per il Govi, cioè la costruzione di una nuova logica formale, astratta da ogni contenuto, anche dove egli tratta delle varie scienze che sono presentate nella loro particolare logica astratta (specializzata ma astratta) che il Govi chiama «Epistemologia». Il Govi appunto divide la Metodologia in due parti. Metodologia generale o Logica propriamente detta e Metodologia speciale o Epistemologia.
La Epistemologia ha come scopo primario e principale la conoscenza esatta di quello speciale scopo conoscitivo a cui ciascuna diversa ricerca è diretta, per poter poi determinare i mezzi e il procedimento per conseguirlo. Il Govi riduce a tre i diversi scopi conoscitivi legittimi delle ricerche umane; questi tre scopi costituiscono lo scibile umano e sono irriducibili a uno solo, ossia sono essenzialmente diversi. Due sono scopi conoscitivi finali: la conoscenza teoretica o della realtà; la conoscenza pratica o di ciò che si deve o non si deve fare; il terzo consiste nelle conoscenze le quali sono mezzi per l’acquisizione delle precedenti. Si hanno dunque tre parti nella Epistemologia: Scienza teorica o della realtà, Scienza pratica, Scienza strumentale. Da ciò tutta una analitica classificazione delle scienze. Il concetto di legittimo ha importanza grande nel sistema del Govi (esso è parte della Metodologia generale, o scienza dei giudizii): ogni giudizio, considerato in sé, è vero o falso: considerato soggettivamente, ossia come prodotto dell’attività del pensiero di chi lo fà, è legittimo o illegittimo. Un giudizio può essere conosciuto vero o falso solo in quanto è riconosciuto legittimo o illegittimo. Sono legittimi i giudizi che sono eguali in tutti gli uomini, che li abbiano o li facciano, e vengono formati in tutti egualmente: sono quindi legittimi i concetti primitivi formati naturalmente e senza dei quali non si può pensare, i concetti scientifici formati metodologicamente, i giudizi primitivi e i giudizi metodologicamente derivati dai giudizi legittimi. (È evidente la filiazione dal Russell, che viene «pasticciato» metodologicamente; nel Russell il riferimento alla matematica rende meno faticoso e farraginoso il sistema).
Ho tratto questi cenni da un articolo Metodologia o agnosticismo nella «Civiltà Cattolica» del 15 novembre 1930. Il libro del Govi pare sia interessante per il materiale storico che raccoglie specialmente intorno al contenuto della Logica generale e speciale, al problema della conoscenza e alle teorie sull’origine delle idee, alla classificazione delle scienze e alle varie divisioni dello scibile umano, alle varie concezioni e divisioni della Scienza teoretica, pratica ecc. La sua filosofia il Govi la chiama «empiristico‑integralista» distinguendola dalla concezione «religiosa» e da quella «razionalistica» nella quale primeggia la filosofia kantiana; la distingue anche, ma in modo subordinato, dalla concezione «empiristico‑particolaristica» che è il positivismo. Egli si distingue dal positivismo in quanto ne ribatte alcuni eccessi e cioè la negazione non solo di ogni metafisica religiosa o razionalistica, ma anche ogni possibilità e legittimità di una metafisica: il Govi ammette invece la legittimità di una metafisica, ma con fondamenti puramente empirici e costruita, in parte, dopo e sulla base delle scienze reali particolari.
Q8 §185 Fase economica‑corporativa dello Stato. Se è vero che nessun tipo di Stato non può non attraversare una fase di primitivismo economico‑corporativa, se ne deduce che il contenuto dell’egemonia politica del nuovo gruppo sociale che ha fondato il nuovo tipo di Stato deve essere prevalentemente di ordine economico: si tratta di riorganizzare la struttura e i rapporti reali tra gli uomini e il mondo economico o della produzione. Gli elementi di superstruttura non possono che essere scarsi e il loro carattere sarà di previsione e di lotta, ma con elementi «di piano» ancora scarsi: il piano culturale sarà soprattutto negativo, di critica del passato, tenderà a far dimenticare e a distruggere: la linee della costruzione saranno ancora «grandi linee», abbozzi, che potrebbero (e dovrebbero) essere cambiate in ogni momento, perché siano coerenti con la nuova struttura in formazione. Ciò appunto non si verifica nel periodo dei Comuni; anzi la cultura, che rimane funzione della Chiesa, è proprio di carattere antieconomico (dell’economia capitalistica nascente), non è indirizzata a dare l’egemonia alla nuova classe, ma anzi a impedire che questa l’acquisti: l’Umanesimo e il Rinascimento perciò sono reazionari, perché segnano la sconfitta della nuova classe, la negazione del mondo economico che le è proprio ecc.
Q8 §186 Sul «Saggio popolare». La filosofia del Saggio popolare è puro aristotelismo positivistico, cioè un riadattamento della logica formalistica secondo i metodi delle scienze naturali: la legge di causalità è sostituita alla dialettica; la classificazione astratta, la sociologia ecc. Se «idealismo» è scienza delle categorie a priori dello spirito, cioè è una forma di astrazione antistoricistica, questo saggio popolare è idealismo alla rovescia nel senso che alle categorie dello spirito sostituisce delle categorie empiriche altrettanto a priori e astratte. Causalismo e non dialettica. Ricerca della legge di «regolarità, normalità, uniformità» senza superamento, perché l’effetto non può essere superiore alla causa, meccanicamente.
Q8 §187 Intellettuali. Nella concezione non solo della scienza politica, ma in tutta la concezione della vita culturale e spirituale, ha avuto enorme importanza la posizione assegnata da Hegel agli intellettuali, che deve essere accuratamente studiata. Con Hegel si incomincia a non pensare più secondo le caste o gli «stati» ma secondo lo «Stato», la cui «aristocrazia» sono appunto gli intellettuali. La concezione «patrimoniale» dello Stato (che è il modo di pensare per «caste») è immediatamente la concezione che Hegel deve distruggere (polemiche sprezzanti e sarcastiche contro von Haller). Senza questa «valorizzazione» degli intellettuali fatta da Hegel non si comprende nulla (storicamente) dell’idealismo moderno e delle sue radici sociali.
Q8 §188 Gli intellettuali. Organizzazione della vita culturale. Studiare la storia della formazione e della attività della «Società Italiana per il progresso della Scienza». Sarà da studiare anche la storia della «Associazione britannica» che mi pare sia stato il prototipo di questo genere di organizzazioni private. La caratteristica più feconda della Società Italiana è nel fatto che essa raggruppa tutti gli «amici della scienza», chierici e laici, per così dire, specialisti e «dilettanti». Essa dà il tipo embrionale di quell’organismo che ho abbozzato in altre , nel quale dovrebbe confluire e rinsaldarsi il lavoro delle Accademie e delle Università con le necessità di cultura scientifica delle masse nazionali‑popolari, riunendo la teoria e la pratica, il lavoro intellettuale e quello industriale che potrebbe trovare la sua radice nella Scuola unica.
Lo stesso potrebbe dirsi del Touring Club, che è essenzialmente una grande associazione di amici della geografia e dei viaggi, in quanto si incorporano in determinate attività sportive (turismo = geografia + sport), cioè la forma più popolare e dilettantesca dell’amore per la geografia e per le scienze che vi si connettono (geologia, mineralogia, botanica, speleologia, cristallografia ecc.). Perché dunque il Touring Club non dovrebbe organicamente connettersi con gli Istituti di geografia e con le Società geografiche? C’è il problema internazionale: il Touring ha un quadro essenzialmente nazionale, mentre le Società geografiche si occupano di tutto il mondo geografico. Connessione del turismo con le società sportive, con l’alpinismo, canottaggio ecc., escursionismo in genere: connessione con le arti figurative e con la storia dell’arte in generale. In realtà potrebbe connettersi con tutte le attività pratiche, se le escursioni nazionali e internazionali si collegassero con periodi di ferie (premio) per il lavoro industriale e agricolo.
Q8 §189 Logica formale e metodologia. La logica formale o metodologia astratta è la «filologia» della filosofia, è l’«erudizione» (il metodo dell’erudizione) della storia. Estetica e filologia come dialettica e logica formale. Ma queste similitudini non danno un esatto concetto del posto che occupa la logica formale. Il paragone migliore sarebbe quello della matematica, ma esso è anche causa di infiniti errori, perché dà luogo a una estensione infinita della logica e delle figure logiche o metodologiche. La matematica ha potuto svilupparsi enormemente in varie direzioni (geometria, algebra, calcoli diversi) ciò che non può avvenire per la logica formale, che non deve e non può svilupparsi oltre i limiti delle necessità immediate (la matematica invece non è limitabile). (Concetto da approfondire.).
Q8 §190 Concetto di Stato. Curzio Malaparte nell’introduzione al suo volumetto sulla Tecnica del colpo di Stato pare affermi l’equivalenza della formula: «Tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato» con la proposizione: «dove c’è la libertà non c’è lo Stato». In questa proposizione il termine «libertà» non è inteso nel significato comune di «libertà politica, ossia di stampa ecc.», ma come contrapposto a «necessità» ed è in relazione alla proposizione di Engels sul passaggio dal regno della necessità al regno della libertà. Il Malaparte non ha neanche annasato il significato della proposizione.
Q8 §191 Egemonia e democrazia. Tra i tanti significati di democrazia, quello più realistico e concreto mi pare si possa trarre in connessione col concetto di egemonia. Nel sistema egemonico, esiste democrazia tra il gruppo dirigente e i gruppi diretti, nella misura in cui lo sviluppo dell’economia e quindi la legislazione che esprime tale sviluppo favorisce il passaggio molecolare dai gruppi diretti al gruppo dirigente. Nell’Impero Romano esisteva una democrazia imperiale‑territoriale nella concessione della cittadinanza ai popoli conquistati ecc. Non poteva esistere democrazia nel feudalismo per la costituzione dei gruppi chiusi ecc.
Q8 §192 Originalità e ordine intellettuale. Una massima di Vauvenargues: «È più facile dire cose nuove che metter d’accordo quelle che sono già state dette».
Q8 §193 Rapporti tra città e campagna. Per avere dei dati sui rapporti tra le nazioni industriali e quelle agrarie e quindi spunti per la quistione della situazione di semicolonie dei paesi agrari (e delle colonie interne nei paesi capitalistici) è da vedere il libro del Mihail Manoilesco, La teoria del protezionismo e dello scambio internazionale, Milano, Treves, 1931. Il Manoilesco scrive che «il prodotto del lavoro di un operaio industriale è in generale sempre scambiato con il prodotto del lavoro di parecchi operai agricoli, in media uno contro cinque». Perciò il Manoilesco parla di uno «sfruttamento invisibile» dei paesi industriali sui paesi agricoli. Il Manoilesco è attuale governatore della Banca nazionale rumena e il suo libro esprime le tendenze ultraprotezioniste della borghesia rumena.
Q8 §194 Logica formale. Vedere il libro di Tobias Dantzig, professore di matematica all’Università di Maryland, Le nombre (Payot, Parigi, 1931 – o 32 –): storia del numero e della successiva formazione dei metodi, delle nozioni, delle ricerche matematiche.
Q8 §195 La proposizione che «la società non si pone problemi per la cui soluzione non esistano già le premesse materiali». È il problema della formazione di una volontà collettiva che dipende immediatamente da questa proposizione e analizzare criticamente cosa la proposizione significhi importa ricercare come appunto si formino le volontà collettive permanenti, e come tali volontà si propongano dei fini immediati e mediati concreti, cioè una linea d’azione collettiva. Si tratta di processi di sviluppo più o meno lunghi, e raramente di esplosioni «sintetiche» improvvise. Anche le «esplosioni» sintetiche si verificano, ma, osservando da vicino, si vede che allora si tratta di distruggere più che ricostruire, di rimuovere ostacoli esteriori e meccanici allo sviluppo autoctono e spontaneo: così può assumersi come esemplare il Vespro Siciliano.
Si potrebbe studiare in concreto la formazione di un movimento storico collettivo, analizzandolo in tutte le sue fasi molecolari, ciò che di solito non si fa perché appesantirebbe ogni trattazione: si assumono invece le correnti d’opinione già costituite intorno a un gruppo o a una personalità dominante. È il problema che modernamente si esprime in termini di partito o di coalizione di partiti affini: come si inizia la costituzione di un partito, come si sviluppa la sua forza organizzata e di influenza sociale ecc. Si tratta di un processo molecolare, minutissimo, di analisi estrema, capillare, la cui documentazione è costituita da una quantità sterminata di libri, di opuscoli, di articoli di rivista e di giornale, di conversazioni e dibattiti a voce che si ripetono infinite volte e che nel loro insieme gigantesco rappresentano questo lavorio da cui nasce una volontà collettiva di un certo grado di omogeneità, di quel certo grado che è necessario e sufficiente per determinare un’azione coordinata e simultanea nel tempo e nello spazio geografico in cui il fatto storico si verifica.
Importanza delle utopie e delle ideologie confuse e razionalistiche nella fase iniziale dei processi storici di formazione delle volontà collettive: le utopie, il razionalismo astratto hanno la stessa importanza delle vecchie concezioni del mondo storicamente elaborate per accumulazione di esperienze successive. Ciò che importa è la critica a cui tale complesso ideologico viene sottoposto dai primi rappresentanti della nuova fase storica: attraverso questa critica si ha un processo di distinzione e di cambiamento nel peso relativo che gli elementi delle vecchie ideologie possedevano: ciò che era secondario e subordinato o anche incidentale, viene assunto come principale, diventa il nucleo di un nuovo complesso ideologico e dottrinale. La vecchia volontà collettiva si disgrega nei suoi elementi contradittori, perché di questi elementi quelli subordinati si sviluppano socialmente ecc.
Dopo la formazione del regime dei partiti, fase storica legata alla standardizzazione di grandi masse della popolazione (comunicazioni, giornali, grandi città ecc.) i processi molecolari avvengono più rapidamente che nel passato, ecc.
Q8 §196 «Saggio popolare». Un’osservazione che può farsi a molti riferimenti del Saggio è il misconoscimento delle possibilità dell’errore da parte di singoli autori citati. Ciò è legato a un criterio metodico più generale: che non è molto «scientifico» o più semplicemente «molto serio», scegliere i propri avversari tra i più stupidi e mediocri, o ancora, scegliere tra le opinioni dei propri avversari le meno essenziali e più occasionali e presumere d’aver distrutto «tutto» l’avversario perché si è distrutta una sua opinione secondaria e occasionale, o d’aver distrutto un’ideologia o una dottrina perché si è dimostrata l’insufficienza teorica dei suoi campioni di terzo o quarto ordine. Ancora, occorre essere giusti coi propri avversari, nel senso che bisogna sforzarsi di comprendere ciò che essi realmente hanno voluto dire e non fermarsi ai significati superficiali e immediati delle loro espressioni. Ciò si dica, se il fine propostosi è quello di elevare il tono e il livello intellettuale dei propri seguaci, e non quello immediato di fare il deserto intorno a sé, con ogni mezzo e maniera. Occorre porsi da questo punto di vista: che il proprio seguace debba discutere e sostenere il proprio punto di vista nei confronti di avversari capaci e intelligenti, e non solo di persone incolte e impreparate, che si convincono «autoritativamente» o per via «emozionale». La possibilità dell’errore deve essere affermata e giustificata, senza con ciò venir meno alla propria concezione, poiché ciò che importa non è già l’opinione di Tizio, Caio, Sempronio, ma quell’insieme di opinioni che sono diventate collettive, sono diventate un elemento e una forza sociale: queste occorre confutare, nei loro esponenti teorici più rappresentativi e degni per altezza di pensiero e anche per «disinteresse» immediato, e non già pensando di aver con ciò «distrutto» l’elemento e la forza sociale corrispondente (ciò che sarebbe puro razionalismo illuministico), ma solo di aver contribuito: 1) a mantenere nella propria parte lo spirito di scissione e di distruzione; 2) a creare il terreno perché la propria parte assorba e vivifichi una propria dottrina originale, corrispondente alle proprie condizioni di vita.
Q8 §197 «Saggio popolare». L’inizio, cioè la posizione del problema come una ricerca di leggi, di linee costanti, regolari, uniformi. Ciò legato al problema della prevedibilità degli accadimenti storici. Impostazione da scienze naturali astratte. Ciò che è solo prevedibile e la lotta, ma non i momenti concreti di essa, che risulteranno da equilibri di forze in continuo movimento, non riducibili a quantità fisse. Puro meccanicismo causalista, non dialettica. La prevedibilità solo per grandi generalizzazioni, corrispondente a grandi leggi di probabilità, alla legge dei grandi numeri. È il concetto stesso di «scienza» che occorre criticare nel Saggio popolare, che è preso di sana pianta dalle scienze naturali e ancora da alcune di esse, e da queste secondo la concezione positivista.
Q8 §198 Filosofia della Praxis. A p. 298 sgg. della Serie Prima delle Conversazioni critiche il Croce analizza alcune proposizioni delle Glosse al Feuerbach per giungere alla conclusione che non si può parlare di un Marx filosofo e quindi di una filosofia marxista, perché ciò che Marx si proponeva era appunto di «capovolgere» non tanto la filosofia di Hegel, quanto la filosofia in genere, di sostituire il filosofare con l’attività pratica ecc. Ma non pare che il Croce sia esatto obbiettivamente, né che egli riesca soddisfacente criticamente. Ammesso che il Marx volesse soppiantare la filosofia con l’attività pratica, come mai il Croce non ricorre all’argomento perentorio che non si può negare la filosofia se non filosofando, cioè riaffermando quel che si era voluto negare? È vero che lo stesso Croce nel volume Materialismo storico ecc., in una nota riconosce esplicitamente come giustificata l’esigenza di costruire sul marxismo una «filosofia della praxis» posta da Antonio Labriola. Se si esamina, in una veduta d’insieme, tutto ciò che il Croce ha scritto sul marxismo, sia in modo sistematico, sia incidentalmente, si può cogliere quanto egli sia contradditorio e incoerente da uno scritto all’altro, nei vari periodi della sua attività di scrittore.
Q8 §199 Unità della teoria e della pratica. Ricercare, studiare e criticare le varie forme in cui si è presentato nella storia delle idee il concetto di unità della teoria e della pratica. «Intellectus speculativus extensione fit practicus» di S. Tomaso: la teoria per semplice estensione si fa pratica, affermazione della connessione necessaria tra l’ordine delle idee e quello dei fatti, che si trova nell’aristotelismo e nella scolastica. Così l’altro aforisma sulla scienza (del Leibnitz) che sarebbe: «quo magis speculativa magis practica». La proposizione del Vico «verum ipsum factum», che il Croce svolge nel senso idealistico che il conoscere sia un fare e che si conosce ciò che si fa (cfr il libro del Croce su Vico e altri scritti polemici del Croce), da cui (nelle sue origini hegeliane e non nella derivazione crociana) certamente dipende il concetto del materialismo storico.
Q8 §200 Antonio Labriola. Per costruire un saggio compiuto su Antonio Labriola, occorre tener dinanzi anche gli elementi e i frammenti di conversazione riferiti dai suoi amici ed allievi. Nei libri del Croce, sparsamente, se ne possono racimolare parecchi. Così nelle Conversazioni Critiche (Serie seconda) pp. 60‑61: «“Come fareste a educare moralmente un papuano?”, domandò uno di noi scolari, tanti anni ... fa al prof. Labriola, in una delle sue lezioni di Pedagogia, obiettando contro l’efficacia della Pedagogia. “Provvisoriamente (rispose con vichiana e hegeliana asprezza l’herbartiano professore), provvisoriamente lo farei schiavo; e questa sarebbe la pedagogia del caso, salvo a vedere se pei suoi nipoti e pronipoti si potrà cominciare ad adoperare qualcosa della pedagogia nostra”». Questa risposta del Labriola è da avvicinare alla intervista da lui data sulla quistione coloniale (Libia) verso il 1903 e pubblicata nel volume degli Scritti vari di filosofia e politica. È da avvicinare anche al modo di pensare del Gentile nell’organamento della riforma scolastica, per cui si è introdotta nelle scuole primarie la religione ecc. Mi pare che si tratti di un pseudo‑storicismo, di un meccanicismo abbastanza empirico. Si potrebbe ricordare ciò che dice lo Spaventa a proposito di quelli che non vogliono mai che gli uomini escano di culla (cioè dal momento dell’autorità, che pure educa alla libertà i popoli immaturi) e pensano tutta la vita (degli altri) come una culla.
Mi pare sia storicamente da porre il problema in altro modo: se cioè, una nazione o un gruppo sociale, che è giunto a un grado superiore di civiltà non possa (e quindi debba) «accelerare» l’educazione civile delle nazioni e gruppi più arretrati, universalizzando la propria esperienza. Non mi pare insomma che il modo di pensare contenuto nella risposta del Labriola sia dialettico e progressivo, ma piuttosto retrivo: l’introduzione della religione nelle scuole elementari ha infatti come correlativo la concezione della «religione buona per il popolo» (popolo = fanciullo = fase arretrata della storia cui corrisponde la religione ecc.), cioè la rinunzia a educare il popolo ecc. È uno storicismo ben noto questo: è lo storicismo dei giuristi, per i quali lo knut non è un knut, quando è un «knut storico». D’altronde si tratta di un pensiero abbastanza nebbioso e confuso.
Che nelle scuole elementari sia necessaria una esposizione «dogmatica» delle nozioni scientifiche, non significa che si debba per dogma intendere quello «religioso confessionale». Che un popolo o un gruppo arretrato abbia bisogno di una disciplina «esteriore», coercitiva, di tipo militare, per essere educato civilmente, non significa che debba essere ridotto in schiavitù, a meno non si pensi che lo Stato è sempre «schiavitù», anche per la classe di cui esso è l’espressione ecc. Il concetto, per esempio, di «esercito del lavoro» dà il tipo di «pedagogia» per i «papuani» senza bisogno di ricorrere alla «schiavitù» o al colonialismo come tappa storica «meccanicamente» inevitabile ecc. Lo Spaventa, che si metteva dal punto di vista della borghesia liberale contro i sofismi «storicistici» delle classi retrive, esprimeva, nel suo sarcasmo, una concezione ben più progressiva e dialettica.
Q8 §201 «Saggio popolare». Sull’arte. Nella sezione dedicata all’arte, si afferma che anche le più recenti opere sull’estetica affermano l’identità di forma e contenuto. Questo può essere assunto come uno dei casi più vistosi dell’incapacità critica nello stabilire la storia dei concetti e nell’identificare il reale significato dei concetti stessi nel campo della cultura. Infatti l’identificazione di contenuto e forma è affermata dall’estetica idealistica (Croce), ma su presupposti idealistici e con terminologia idealistica. Né i termini «contenuto» e «forma» hanno quindi il significato che il Saggio suppone. Che forma e contenuto si identifichino significa solo che nell’arte il contenuto non è «l’astratto soggetto», cioè l’intrigo romanzesco o la particolare massa di sentimenti generici, ma che contenuto dell’arte è l’arte stessa, una categoria filosofica, un «momento distinto» dello spirito ecc. Né forma significa tecnica, come il Saggio suppone, ecc.
Q8 §202 «Saggio popolare». Che cosa si può intendere per «scienza» parlando del Saggio e in che non è accettabile il concetto di «scienza» che in esso è sostenuto o meglio ancora sottinteso? Si intenderà il metodo e non già il metodo in generale, che non esiste, o significa solo la filosofia in generale (per alcuni) e per altri la logica formale o il metodo matematico, ma un determinato metodo, proprio di una determinata ricerca, di una determinata scienza, e che si è sviluppato ed è stato elaborato insieme allo sviluppo e alla elaborazione di quella determinata ricerca e scienza e forma tutta una cosa con esse. Ma ci sono anche dei criteri generali che si può dire costituiscono la coscienza critica dello scienziato e devono sempre essere vigili e spontanei nel suo lavoro. Così si può dire che non è scienziato chi dimostra poca sicurezza nei suoi criteri, colui che non ha una piena intelligenza dei concetti adoperati, che ha scarsa intelligenza dello stato precedente dei problemi trattati, che non ha molta cautela nelle sue affermazioni, che non progredisce in modo necessario ma arbitrario e senza concatenamento, che non sa tener conto delle lacune che esistono nelle cognizioni raggiunte ma le sottace e si accontenta di soluzioni o nessi puramente verbali invece di dichiarare che si tratta di posizioni provvisorie che potranno essere riprese e sviluppate ecc. Ognuno di questi punti può essere sviluppato, con le opportune esemplificazioni ecc.
Q8 §203 Storia e antistoria. Osservare che l’attuale discussione su «storia e antistoria» non è altro che la ripresentazione nei termini della cultura moderna della discussione avvenuta alla fine del secolo scorso nei termini del naturalismo e positivismo, se cioè la storia e la natura procedano per «salti» o solo per evoluzione graduale e progressiva.
Q8 §204 Un’introduzione allo studio della filosofia. (cfr quad. III p. 5 bis). Per la compilazione di una introduzione o avviamento allo studio della filosofia occorrerà tener conto di alcuni elementi preliminari: 1°) Occorre distruggere il pregiudizio che la filosofia sia alcunché di molto difficile per il fatto che essa è una attività propria di una determinata categoria di scienziati, dei filosofi professionali o sistematici. Occorrerà pertanto dimostrare che tutti gli uomini sono filosofi, definendo i limiti e i caratteri di questa filosofia «spontanea» di «tutto il mondo», cioè il senso comune e la religione. Dimostrato che tutti sono filosofi, a loro modo, che non esiste uomo normale e sano intellettualmente, il quale non partecipi di una determinata concezione del mondo, sia pure inconsapevolmente, perché ogni «linguaggio» è una filosofia, si passa al secondo momento, al momento della critica e della consapevolezza. È preferibile «pensare» senza averne consapevolezza, in modo disgregato e occasionale, è preferibile «partecipare» a una concezione del mondo «imposta» dal di fuori, da un gruppo sociale (che può andare dal proprio villaggio alla propria provincia, che può avere l’origine nel proprio curato o nel vecchione patriarcale la cui «saggezza» detta legge, nella donnetta che costruisce delle stregonerie o nel piccolo intellettuale inacidito dalla propria stupidaggine e impotenza a operare) o è preferibile elaborare la propria concezione del mondo consapevolmente e criticamente e in connessione con tale lavorio del proprio intelletto scegliere il proprio mondo di attività, partecipare attivamente alla produzione della storia universale? ecc.
2°) Religione, senso comune, filosofia. Trovare le connessioni tra questi tre ordini intellettuali. Vedere come neanche religione e senso comune coincidono, ma la religione sia un elemento del disgregato senso comune. Non esiste un solo «senso comune», ma anche esso è un prodotto e un divenire storico. La filosofia è la critica della religione e del senso comune e il loro superamento: in tal senso, la filosofia coincide col «buon senso».
3°) Scienza e religione – senso comune.
4°) Ma non esiste neanche la «filosofia» in senso generale: esistono molte filosofie e occorrerà scegliere tra di esse. Come avverrà la scelta? Da quali criteri si partirà per fare la propria scelta? E perché in ogni tempo convivono molti sistemi o correnti di filosofia? Come nascono, come si diffondono, perché nella loro diffusione seguono certe linee di frattura e certe direzioni?
5°) La sistemazione della propria concezione del mondo e della vita. Ha importanza questa sistemazione? e che cosa occorre intendere per sistema?
6°) Trascendenza, immanenza, storicismo assoluto. Significato e importanza della storia della filosofia.
7°) La filosofia è indipendente dalla politica? Ideologia e filosofia (vedi n. 4).
Q8 §205 Determinismo meccanico e attività‑volontà. A proposito dello studio di Mirskij sulle recenti discussioni filosofiche. Come è avvenuto il passaggio da una concezione meccanicistica a una concezione attivistica e quindi la polemica contro il meccanicismo. L’elemento «deterministico, fatalistico, meccanicistico» era una mera ideologia, una superstruttura transitoria immediatamente, resa necessaria e giustificata dal carattere «subalterno» di determinati strati sociali. Quando non si ha l’iniziativa nella lotta e la lotta stessa quindi finisce con l’identificarsi con una serie di sconfitte, il determinismo meccanico diventa una forza formidabile di resistenza morale, di coesione, di perseveranza paziente. «Io sono sconfitto, ma la forza delle cose lavora per me a lungo andare». È un «atto di fede» nella razionalità della storia, che si traduce in un finalismo appassionato, che sostituisce la «predestinazione», la «provvidenza» ecc. della religione. In realtà esiste, anche in questo caso, un’attività volitiva, un intervento diretto sulla «forza delle cose», ma di un carattere meno appariscente, più velato. Ma quando il subalterno diventa dirigente e responsabile, il meccanicismo appare prima o poi un pericolo imminente, avviene una revisione di tutto il modo di pensare perché è avvenuto un mutamento nel modo di essere: i limiti e il dominio della «forza delle cose» vengono ristretti, perché? perché, in fondo, se il «subalterno» era ieri una «cosa», oggi non è più una «cosa», ma una «persona storica», se ieri era irresponsabile perché «resistente» a una volontà estranea, oggi è responsabile perché non «resistente», ma agente e attivo. Ma era stato mai mera «resistenza», mera «cosa», mera «irresponsabilità»? Certamente no, ed ecco perché occorre sempre dimostrare la futilità inetta del determinismo meccanico, del fatalismo passivo e sicuro di se stesso, senza aspettare che il subalterno diventi dirigente e responsabile. C’è sempre una parte del tutto che è «sempre» dirigente e responsabile e la filosofia della parte precede sempre la filosofia del tutto come anticipazione teorica.
Q8 §206 La storia del materialismo del Lange. Questa opera del Lange potrà essere più o meno utile oggi (dopo quasi tre quarti di secolo) da quando fu scritta (credo almeno che sia così vecchia) e dopo che la storia della filosofia ha prodotto tante opere nuove, almeno come studi particolari su filosofi materialisti. Ma in ogni modo essa è sempre utile per la storia della cultura, perché ad essa si sono riferiti, per informarsi sui precedenti e su una serie di concetti del materialismo, tutta una serie di materialisti storici. Sarà da ricercare quali e quante concezioni di un certo periodo del materialismo storico sono state suggerite dalla lettura della Storia del Lange: la ricerca sarà tanto più interessante in quanto il Lange ha del materialismo un concetto assai definito e limitato (per il Lange, non solo il materialismo storico, ma neanche la filosofia del Feuerbach non è materialista). Si potrà così vedere come la terminologia ha la sua importanza nel determinare errori e deviazioni, quando si dimentichi che la terminologia è convenzionale e che occorre sempre risalire alle fonti culturali per identificarne il valore esatto, poiché sotto una stessa formula convenzionale possono annidarsi contenuti differenti. Sarà da notare come il Marx sempre eviti di chiamare «materialistica» la sua concezione e come ogni volta che parla di filosofie materialistiche le critichi o affermi che sono criticabili. Marx poi non adopera mai la formula «dialettica materialistica» ma «razionale» in contrapposto a «mistica», ciò che dà al termine «razionale» un significato ben preciso.
Della Storia del Lange era annunziata una traduzione italiana presso la Casa ed. Athena di Milano in volumetti da 5 lire l’uno. La traduzione francese è stata la più diffusa in tutto questo tempo (non credo che esista una precedente traduzione italiana). Ne è stata pubblicata un’edizione presso il Monanni di Milano.
Q8 §207 Quistioni di terminologia. Il concetto di struttura e superstruttura, per cui si dice che l’«anatomia» della società è costituita dalla sua «economia», non sarà legato alle discussioni sorte per la classificazione delle specie animali, classificazione entrata nella sua fase «scientifica» quando appunto si prese a base l’anatomia e non caratteri secondari e accidentali? L’origine della metafora usata per indicare un concetto nuovamente scoperto, aiuta a comprendere meglio il concetto stesso, che viene riportato al mondo culturale e storicamente determinato in cui è sorto. Certo che le scienze sociali hanno sempre cercato di trovare un fondamento obbiettivo e scientificamente adatto a dar loro la stessa sicurezza ed energia delle scienze sperimentali e naturali: per cui è semplice pensare che a queste si sia ricorso per creare un linguaggio.
Ricordare l’altro spunto, legato allo sviluppo delle scienze giuridiche: «non si può giudicare un’epoca storica da ciò che essa pensa di se stessa» come un giudice non può giudicare l’imputato da ciò che l’imputato dice per spiegare il suo operato delittuoso o presunto tale.
Q8 §208 Traducibilità reciproca delle culture nazionali. L’osservazione fatta dal Marx nella Santa Famiglia che il linguaggio politico francese equivale al linguaggio filosofico tedesco, trova il riscontro nei versi del Carducci «decapitaro, Emmanuel Kant, Iddio – Massimiliano Robespierre, il re». A proposito di questo riavvicinamento carducciano, il Croce (Conversazioni Critiche, Serie II, p. 292) raccoglie una serie di «fonti» molto interessanti. Il Carducci attinse il motivo da Enrico Heine (terzo libro del Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland del 1834). Ma il paragone tra Kant e Robespierre non è originale dello Heine.
Il Croce ha ricercato l’origine del paragone e scrive di averne trovato un lontano accenno in una lettera del 21 luglio 1795 dello Hegel allo Schelling (Briefe von und an Hegel, Lipsia, 1887, I, 14‑16), svolto poi nelle lezioni che lo stesso Hegel tenne sulla storia della filosofia e sulla filosofia della storia. Nelle prime lezioni (di storia della filosofia) Hegel dice che «la filosofia del Kant, del Fichte e dello Schelling contiene in forma di pensiero la rivoluzione, alla quale lo spirito negli ultimi tempi ha progredito in Germania»; in una grande epoca cioè della storia universale, a cui «solo due popoli hanno preso parte, i Tedeschi e i Francesi, per opposti che siano tra loro, anzi appunto perché opposti»; sicché, laddove il nuovo principio in Germania «ha fatto irruzione come spirito e concetto» in Francia invece si è esplicato «come realtà effettuale» («Vorles. über die Gesch. d. Philos., 2 ed., Berlino, 1844, III, 485). Nelle lezioni di filosofia della storia, Hegel spiega che il principio della volontà formale, della libertà astratta, secondo cui «la semplice unità dell’autocoscienza, l’Io, è la libertà assolutamente indipendente e la fonte di tutte le determinazioni universali», «rimase presso i Tedeschi una tranquilla teoria, ma i Francesi vollero eseguirlo praticamente» (Vorles. über die Philosophie der Gesch., 3 ed., Berlino, 1848, pp. 531‑2). (Questo passo di Hegel mi pare sia appunto il riferimento letterale del Marx, dove nella Sacra Famiglia accenna a Proudhon contro il Bauer. Ma esso mi pare assai più importante ancora come «fonte» del pensiero espresso nelle Tesi su Feuerbach che i filosofi hanno spiegato il mondo e si tratta ora di mutarlo, cioè che la filosofia deve diventare «politica», «pratica», per continuare ad essere filosofia: la «fonte» per la teoria dell’unità di teoria e di pratica).
A. Ravà nel suo libro Introduzione allo studio della filosofia di Fichte (Modena, Formiggini, 1909, pp. 6‑8 n.) fa osservare al Croce che già nel 1791 il Baggesen in una lettera al Reinhold accostava le due rivoluzioni, che lo scritto del Fichte del 1792 sulla rivoluzione francese è animato da questo senso di affinità tra l’opera della filosofia e l’avvenimento politico e che nel 1794 lo Schaumann svolse particolarmente il paragone, notando che la rivoluzione politica di Francia «fa sentire dall’esterno il bisogno di una determinazione fondamentale dei diritti umani» e la riforma filosofica tedesca «mostra dall’interno i mezzi e la via per cui e sulla quale solamente questo bisogno può essere soddisfatto», anzi che lo stesso paragone dava motivo nel 1797 a una scrittura satirica contro la filosofia kantiana. Il Ravà conclude che «il paragone era nell’aria».
Il paragone venne ripetuto moltissime volte nel corso dell’800 (dal Marx, per es. nella Critica della filosofia del diritto di Hegel) e «dilatato» dallo Heine. In Italia, qualche anno prima del Carducci, lo si ritrova in una lettera di Bertrando Spaventa, dal titolo Paolottismo, positivismo e razionalismo, pubblicata nella «Rivista bolognese» del maggio 1868 (ristampata negli Scritti filosofici, ed. Gentile, p. 301).
Il Croce conclude facendo delle riserve sul paragone in quanto «affermazione di un rapporto logico e storico». «Perché se è vero che al Kant giusnaturalista risponde assai bene nel campo dei fatti la rivoluzione francese, è anche vero che quel Kant appartiene alla filosofia del secolo decimottavo, che precesse e informò quel moto politico; laddove il Kant che apre l’avvenire, il Kant della sintesi a priori, è il primo anello di una nuova filosofia, la quale oltrepassa la filosofia che s’incarnò nella rivoluzione francese». Si capisce questa riserva del Croce. Tutta la quistione sarebbe da rivedere, ristudiando i riferimenti dati dal Croce e dal Ravà e cercandone altri, per inquadrarli nella quistione che è oggetto della rubrica e cioè che due strutture simili hanno superstrutture equivalenti e traducibili reciprocamente. Di ciò avevano coscienza i contemporanei della rivoluzione francese e ciò è di sommo interesse.
Q8 §209 La religione, il lotto e l’oppio del popolo. Nelle Conversazioni critiche (Serie II, pp. 300‑301) il Croce ricerca la «fonte» del Paese di cuccagna di Matilde Serao e la trova in un pensiero del Balzac, che è interessante anche come probabile fonte dell’espressione «oppio del popolo» del Marx, il quale, come è noto, era un grande ammiratore di Balzac e anzi si propose, in un certo tempo, di scrivere un libro sulla sua opera letteraria. Nel racconto La Rabouilleuse, scritto nel 1841 e poi intitolato Un ménage de garçon, narrandosi di madama Descoings, la quale da ventun anno giocava un famoso suo terno, il «sociologo e filosofo romanziere» osserva: «Cette passion, si universellement condamnée, n’a jamais été étudiée. Personne n’y a vu l’opium de la misère. La loterie, la plus puissante fée du monde, ne développerait‑elle pas des espérances magiques? Le coup de roulette qui faisait voir aux joueurs des masses d’or et de jouissances ne durait que ce que dure un éclair: tandis que la loterie donnait cinq jours d’existence à ce magnifique éclair. Quelle est aujourd’hui, la puissance sociale qui peut, pour quarante sous, vous rendre heureux pendant cinq jours et vous livrer idéalement tous les bonheurs de la civilisation?».
Il Croce aveva già notato che il Paese di cuccagna (1890) aveva la sua idea generatrice in un brano del Ventre di Napoli (1884) della stessa Serao nel quale «si lumeggia il gioco del lotto come “il grande sogno di felicità” che il popolo napoletano “rifà ogni settimana”, vivendo “per sei giorni in una speranza crescente, invadente, che si allarga, esce dai confini della vita reale”; il sogno “dove sono tutte le cose di cui esso è privato, una casa pulita, dell’aria salubre e fresca, un bel raggio di sole caldo per terra, un letto bianco e alto, un comò lucido, i maccheroni e la carne ogni giorno, e il litro di vino, e la culla pel bimbo, e la biancheria per la moglie, e il cappello nuovo per il marito”».
Dell’ammirazione di Marx per Balzac ha scritto Lafargue nei suoi ricordi su Marx (cfr l’antologia del Riazanov, p. 114 dell’ed. francese): «Aveva una tale ammirazione per Balzac che si proponeva di scrivere un saggio critico sulla Commedia umana ecc.». vedi a p. 75).
Q8 §210 Storia e antistoria. Se la discussione (tra) storia e antistoria è la stessa che quella se la natura e la storia procedano anche per «salti» o solo «evolutivamente», sarà bene ricordare al Croce che anche la tradizione dell’idealismo moderno non è contro i «salti», cioè contro l’«antistoria». (Vedere nell’articolo di Plekhanov i riferimenti da Hegel in proposito). Si tratta poi della discussione tra riformisti e rivoluzionari sul concetto e il fatto dello svolgimento storico o del progresso. Tutto il materialismo storico è una risposta a tale quistione.
La quistione mal posta: si tratta in realtà della quistione tra ciò che è «arbitrario» e ciò che è «necessario», tra ciò che è «individuale» e ciò che è «sociale» o collettivo. Se bisogna assumere come «rivoluzioni» tutti quei movimenti che per darsi dignità e giustificarsi si chiamano da se stessi «rivoluzioni». C’è una inflazione di concetti e di fraseologia rivoluzionaria. Si crede che il berretto faccia la testa, che l’abito faccia il monaco. Già il De Sanctis aveva osservato e beffeggiato questo atteggiamento nel suo saggio sull’Ebreo di Verona. Bisogna anche vedere se la fraseologia di «rivoluzione» non sia voluta di proposito, per creare la «volontà di credere», «creazione» che è sostenuta da argomenti ben solidi «collaterali» (tribunali, polizia ecc.). Che i tanti mascherotti nicciani in rivolta contro tutto l’esistente, contro le convenzioni sociali ecc. abbiano finito collo stomacare e col togliere serietà a certi atteggiamenti, è verissimo, ma non bisogna lasciarsi guidare dai mascherotti nei propri giudizi: l’avvertimento della necessità di essere «sobri» nelle parole e negli atteggiamenti esteriori è fatto perché ci sia più forza sostanziale nel carattere e nella volontà concreta. Contro il velleitarismo, contro l’astrattismo, l’eroismo di maniera ecc. è una quistione di costume e di stile, non «teoretica».
Q8 §211 Il termine di «materialismo» occorre in certi periodi della storia della cultura intenderlo non nel significato tecnico filosofico stretto, ma nel significato che prese dalle polemiche culturali dell’Enciclopedia. Si chiamò materialismo ogni modo di pensare che escludesse la trascendenza religiosa e quindi in realtà tutto il panteismo e l’immanentismo e infine più modernamente, ogni forma di realismo politico. Nelle polemiche anche odierne dei cattolici si trova spesso usata la parola in questo senso: è materialismo ogni modo di pensare che non sia «spiritualismo» in senso stretto, cioè spiritualismo religioso: quindi tutto lo hegelismo e in generale la filosofia classica tedesca, oltre all’enciclopedismo e illuminismo francese. Così, nella vita sociale, si chiama «materialismo» tutto ciò che tende a trovare in questa terra, e non in paradiso, il fine della vita; l’interessante è che una tale concezione presa dal feudalismo culturale, è impiegata dai moderni industrialisti, contro i quali era stata rivolta. Ogni attività economica che uscisse dai limiti della produzione medioevale era «materialismo», perché pareva «fine a se stessa», l’economia per l’economia, l’attività per l’attività ecc. (tracce di questa concezione rimangono nel linguaggio: geistlich tedesco per «clericale», così in russo dukhoviez, in italiano «direttore spirituale»: spirito insomma era lo Spirito Santo).
Una delle ragioni, e forse la più importante, della riduzione al materialismo tradizionale del materialismo storico, è da ricercare in ciò che il materialismo storico non poteva non rappresentare una fase prevalentemente critica della filosofia, mentre si ha sempre «bisogno» di un sistema compiuto e perfetto. Ma i sistemi compiuti e perfetti sono sempre opera di singoli filosofi, e in essi accanto alla parte storica attuale, cioè corrispondente alle attuali condizioni di vita, esiste sempre una parte astratta, «astorica», nel senso che è legata alle precedenti filosofie (pensiero che crea pensiero astrattamente), che è dovuta a necessità esteriori e meccaniche di sistema (armonia interna e architettura del sistema) e che è dovuta a idiosincrasie personali. Ma la filosofia di un’epoca non è nessuna filosofia individuale o di gruppo: è l’insieme di tutte le filosofie individuali e di gruppo + le opinioni scientifiche + la religione + il senso comune. Si può formare una filosofia di tal genere «artificiosamente»? per opera individuale o di gruppo? La attività critica è la sola possibile, specialmente nel senso di porre e risolvere criticamente determinati problemi filosofici. Ma intanto occorre partire dal concetto che la nuova filosofia non è nessuna delle filosofie passate ecc.
Q8 §212 Gli studi di storia economica. Ricordare la polemica Einaudi‑Croce (Einaudi nella Riforma Sociale) quando uscì la 4a edizione del volume «Materialismo storico ed economia marxistica» con la nuova prefazione del 1917. Può essere interessante studiare per i vari paesi come si sono formate le varie correnti di studio e di ricerca di storia economico‑sociale, come si sono atteggiate ecc. Che sia esistita in Inghilterra una scuola di storia economica, legata all’economia classica, è certo, ma i suoi sviluppi ulteriori sono, oppure no, stati influenzati dal materialismo storico? (Il libro del Seligman in quanto rientra in questa corrente e in quanto esprime appunto il bisogno di essa di fare i conti col materialismo storico?) Così in Francia una corrente economico‑giuridica, che ha operato sul materialismo storico (Guizot, Thierry, Mignet) ma è poi stata influenzata a sua volta (Henri Pirenne, e i moderni francesi Henri See, Hauser ecc.). In Germania la corrente più strettamente legata all’economia (con List), ma Sombart ha subìto l’influsso del materialismo storico ecc. In Italia più strettamente legata al materialismo storico (ma influsso di Romagnosi e Cattaneo).
Q8 §213 Un’introduzione allo studio della filosofia.
I. Il problema dei «semplici». La forza delle religioni e specialmente del cattolicismo consiste in ciò che esse sentono energicamente la necessità dell’unità di tutta la massa religiosa e lottano per non staccare mai gli strati superiori dagli strati inferiori. La chiesa romana è la più tenace nella lotta per impedire che «ufficialmente» si formino due religioni, quella degli intellettuali e quella dei «semplici». La cosa non è stata e non è senza gravi inconvenienti, ma questi «inconvenienti» sono legati al processo storico che trasforma tutta la vita civile, non al rapporto razionale tra intellettuali e «semplici». La debolezza delle filosofie immanentistiche in generale consiste appunto nel non aver saputo creare una unità ideologica tra il basso e l’alto, tra gli intellettuali e la massa (cfr motivo «Rinascimento e Riforma»). I tentativi di movimenti culturali «verso il popolo» – Università popolari e simili – hanno sempre degenerato in forme paternalistiche: d’altronde mancava in essi ogni organicità sia di pensiero filosofico, sia di centralizzazione organizzativa. Si aveva l’impressione che rassomigliassero ai contatti tra i mercanti inglesi e i negri dell’Africa: si dava merce di paccotiglia per avere pepite d’oro. Tuttavia il tentativo va studiato: esso ebbe fortuna, cioè rispondeva a una necessità popolare.
La quistione è questa: un movimento filosofico è tale solo in quanto si applica a svolgere una cultura specializzata per un ristretto gruppo di intellettuali o invece è tale solo in quanto, nel lavoro di elaborazione di un pensiero superiore, scientificamente organato, non dimentica mai di rimanere in contatto coi «semplici» e anzi trova in questi contatti la sorgente dei problemi da studiare e risolvere? Solo per questi contatti una filosofia diventa «storica», si depura degli elementi di origine «individuale», si fa «vita».
II. Religione cristiana. «La fede in un sicuro avvenire, nell’immortalità dell’anima destinata alla beatitudine, nella sicurezza di poter arrivare al godimento eterno, fu la molla di propulsione per un lavoro di intensa perfezione interna, e di elevazione spirituale. Il vero individualismo cristiano ha trovato qui l’impulso alle sue vittorie. Tutte le forze del cristiano furono raccolte intorno a questo fine nobile. Liberato dalle fluttuazioni speculative che snervano l’anima nel dubbio, e illuminato da principii immortali, l’uomo senti rinascere le speranze, sicuro che una forza superiore lo sorreggeva nella lotta contro il male, egli fece violenza a se stesso e vinse il mondo» (Individualismo pagano e individualismo cristiano in «Civiltà Cattolica» del 5 marzo 1932). Cioè, per un certo periodo storico e in condizioni storiche determinate, il cristianesimo fu una «necessità» per il progresso: esso fu la forma determinata di «razionalità del mondo e della vita» e dette i quadri generali per l’attività pratica dell’uomo. Questo brano può essere paragonato con quello del Croce (in Etica e Politica, «Religione e serenità»).
III. Filosofia e senso comune o buon senso. Forse è utile distinguere «praticamente» la filosofia dal senso comune per poter meglio mostrare ciò che si vuole ottenere: filosofia significa più specialmente una concezione del mondo con caratteri individuali spiccati, senso comune è la concezione del mondo diffusa in un’epoca storica nella massa popolare. Si vuol modificare il senso comune, creare un «nuovo senso comune», ecco perché si impone l’esigenza del tener conto dei «semplici».
Q8 §214 «Saggio popolare». Spunti di estetica e di critica letteraria. Raccogliere tutti gli spunti di estetica e di critica letteraria sparsi nel Saggio popolare e cercare di ragionarvi su. Uno spunto è quello riguardante il Prometeo di Goethe. Il giudizio datone è superficiale ed estremamente generico. L’autore non conosce, a quanto pare, né la storia esatta di questa ode del Goethe, né la storia della fortuna del mito di Prometeo prima di Goethe e specialmente nel periodo precedente e contemporaneo a Goethe. Eppure, si può dare un giudizio come quello dato dall’autore, senza conoscere proprio questi elementi? Come altrimenti distinguere ciò che è personale del Goethe da ciò che è un elemento rappresentativo di un’epoca e di un gruppo sociale? Questo genere di giudizi in tanto sono giustificati in quanto sono non generici, ma specifici, precisi, dimostrati: altrimenti sono destinati solo a diffamare la teoria e a suscitare dei faciloni superficiali, i quali credono d’avere tutta la storia in tasca perché sanno sciacquarsi la bocca con delle formule che sono fatte diventare delle frasi fatte, delle banalità (richiamate sempre la frase di Engels nella sua lettera a uno studente pubblicata nell’«Accademico Socialista»).
(Si potrebbe fare una esposizione della fortuna letteraria e artistica e ideologica del mito di Prometeo, studiando come questo si atteggia nei vari tempi e quale complesso di sentimenti e di idee serve a esprimere sinteticamente volta per volta). Per ciò che riguarda il Goethe riassumo alcuni elementi iniziali, togliendoli da un articolo di Leonello Vincenti (Prometeo, nel «Leonardo» del marzo 1932): Nell’ode voleva Goethe fare della semplice «mitologia» versificata o esprimeva un suo atteggiamento attuale e vivo verso la divinità, verso il dio cristiano? Nell’autunno del 1773 (quando scrisse il Prometeo) Goethe respingeva nettamente i tentativi di conversione del suo amico Lavater: «Ich bin kein Christ». Un critico moderno (H. A. Korff) osserva (secondo le parole del Vincenti): «Si pensino quelle parole dirette contro un (!) Dio cristiano, si sostituisca al nome di Giove il concetto anonimo (!!) di Dio e si sentirà di quanto spirito rivoluzionario sia carica l’ode». (Inizio dell’ode: «Copri il tuo cielo, Giove, con veli di nuvole ed esercitati, simile al fanciullo che decapita cardi, su querce e vette di monti! Devi a me la mia terra pur lasciare e la mia capanna, che tu non hai costruita, e il mio focolare, per la cui fiamma m’invidii. Nulla io conosco di più misero sotto il, sole di voi, dei!») Storia religiosa di Goethe. Sviluppo del mito di Prometeo nel secolo XVIII, dalla prima formulazione dello Shaftesbury («a poet is indeed a second maker, a just Prometheus under Jove») a quella degli Stürmer und Dränger, che trasporta Prometeo nell’esperienza artistica da quella religiosa. Il Walzel ha sostenuto appunto il carattere puramente artistico della creazione goethiana. Ma opinione comune è che il punto di partenza sia stata l’esperienza religiosa.
Il Prometeo deve essere collocato in un gruppo di scritti (il Maometto, il Prometeo, il Satyros, l’Ebreo Errante, il Faust) degli anni 1773‑74. Il Goethe voleva scrivere un dramma su Prometeo, di cui rimane un frammento. Julius Richter (Zur Deutung der Goetheschen Prometheusdichtung nel «Jahrbuch des freien deutschen Hochstifts», 1928) sostiene che l’ode precede il dramma, di cui anticipa solo alcuni elementi, mentre prima, con E. Schmidt, si credeva che l’ode è la quintessenza del frammento drammatico omonimo, quintessenza tratta dal poeta, quando aveva ormai abbandonato il tentativo del dramma. (Questa precisazione è importante psicologicamente: Si può vedere come l’ispirazione goethiana si attenua: 1°) prima parte dell’ode, in cui predomina l’elemento titanico, della ribellione; 2°) la seconda parte dell’ode, in cui Prometeo piega su se stesso, e hanno il sopravvento gli elementi di una certa debolezza umana; 3°) il tentativo del dramma, che non riesce, forse perché il Goethe non riesce più a trovare il fulcro della sua immagine, che già nell’ode si era spostato e aveva creato una contraddizione intima).
Il Richter cerca le concordanze tra l’opera letteraria e gli stati psicologici del poeta, attestati dalle sue lettere e da Poesia e Verità. Nella Poesia e Verità si parte da un’osservazione generale: gli uomini alla fine devono sempre contare sulle sole loro forze; la divinità stessa pare non possa ricambiare la venerazione, la fiducia, l’amore degli uomini proprio nei momenti di maggior bisogno: bisogna aiutarsi da sé. «La più sicura base d’autonomia mi risultò sempre essere il mio talento creatore». «Questa situazione si concretò in un’immagine... l’antica figura mitologica di Prometeo che, separatosi dagli dei, dalla sua officina popolò un mondo. Sentivo assai bene che si può produrre qualcosa di notevole soltanto isolandosi. Dovendo io escludere l’aiuto degli uomini, mi separai, al modo di Prometeo, anche dagli Dei», – come volevano i suoi stati d’animo estremi ed esclusivi – aggiunge il Vincenti, ma non mi pare che in Goethe si possa parlare di estremismo ed esclusività. «Mi ritagliai l’abito antico del Titano alla misura del mio dorso, e senza pensarci tanto su incominciai a scrivere un dramma nel quale è rappresentata l’inimicizia in cui Prometeo cade con gli dei foggiando uomini di propria mano e dando loro vita col favore di Minerva...» (Scrive il Vincenti: «Quando Goethe scriveva queste parole il frammento drammatico era da molti anni scomparso – cosa vuol dire “scomparso”? – ed egli non lo rammentava più bene. Credeva che l’ode, rimastagli, dovesse figurarvi come un monologo»).
L’ode presenta una situazione propria, diversa da quella del frammento. Nell’ode la ribellione matura nel momento in cui è annunziata: è la dichiarazione di guerra, la quale si chiude con l’apertura delle ostilità: «Qui siedo, formo uomini ecc.». Nel dramma la guerra è già aperta. Logicamente, il frammento è posteriore all’ode, ma il Vincenti non è categorico come il Richter. Per lui «se è vero che, ideologicamente, il frammento drammatico rappresenta un progresso sopra l’ode, non è men vero che la fantasia dei poeti può aver dei ritorni su posizioni che parevano superate e ricreare da esse qualcosa di nuovo. Abbandoniamo pure l’idea che l’ode sia la quintessenza del dramma, ma accontentiamoci di dire che le situazioni di questo e di quella stanno tra loro come il più complesso al più semplice». Il Vincenti nota l’antinomia esistente nell’ode: le prime due strofe di scherno e l’ultima di sfida, ma il corpo centrale di diverso tono: Prometeo ricorda la sua fanciullezza, gli smarrimenti, i dubbi, le angosce giovanili: «parla un deluso d’amore». «Questi sogni fioriti non ce li farà dimenticare più il cipiglio ripreso nell’ultima strofa. Aveva parlato da Titano in principio Prometeo;ma ecco poi spuntare sotto la maschera titanica i teneri (!) tratti d’un giovane dal cuore affamato d’amore». Un brano di Poesia e Verità è specialmente significativo per la personalità di Goethe: «Lo spirito titanico e gigantesco, eversore del cielo non offriva materia al mio poetare. Meglio mi si confaceva rappresentare quella resistenza pacifica, plastica e al più paziente, che riconosce il potere dell’autorità, ma vorrebbe porlesi a lato» (questo brano giustifica il breve scritto di Marx su Goethe e lo illumina).
Il frammento drammatico mostra, secondo me, che il titanismo di Goethe deve appunto essere collocato nella sfera letteraria e collegato all’aforisma: «In principio era l’azione», se per azione si intende l’attività propria del Goethe, la creazione artistica. Osservazione del Croce, che cerca di rispondere alla domanda del perché il dramma sia rimasto incompiuto: «forse nella linea stessa di quelle scene si vede la difficoltà e l’ostacolo al compimento, il dualismo cioè tra il Goethe ribelle e il Goethe critico della ribellione». (Nel caso rivedere lo studio del Vincenti, che, anche ricco come è di imprecisioni e di contraddizioni, offre notazioni particolari acute).
In realtà il frammento drammatico mi pare da studiare a sé: esso è molto più complesso dell’ode e il suo rapporto con l’ode è dato più dal mito esterno di Prometeo, che da un legame intimo e necessario. La ribellione di Prometeo è «costruttiva», Prometeo appare non solo nel suo aspetto di Titano in rivolta, ma specialmente come «homo faber», consapevole di se stesso e del significato dell’opera sua. Per il Prometeo del frammento gli dei non sono affatto infiniti, onnipotenti. «Potete l’armi stringere nel pugno il vasto spazio del cielo e della terra? Potete separarmi da me stesso? Potere dilatarmi fino ad abbracciare il mondo?» Mercurio risponde con una spallucciata: il destino! E dunque anche gli dei sono vassalli. Ma Prometeo non si sente già felice nella sua officina, tra le sue creazioni? «Qui il mio mondo, il mio tutto! Qui io mi sento!» A Mercurio aveva detto d’aver preso coscienza, fanciullo, della propria esistenza fisica quando aveva avvertito che i suoi piedi reggevano il corpo e che le sue mani si stendevano a toccare nello spazio. Epimeteo lo aveva accusato di particolarismo, di misconoscere la dolcezza di formare un tutto con gli Dei e gli affini e il mondo e il cielo. «La conosco questa storia!» risponde Prometeo perché egli non può più contentarsi di quell’unità che l’abbraccia dall’esterno, deve crearsene una che sorga dall’interiore. E questa può sorgere solo «dal cerchio riempito dalla sua attività».
Q8 §215 «Saggio popolare». La realtà del mondo esterno. Tutta la polemica sulla «realtà del mondo esterno» mi pare male impostata e in gran parte oziosa (mi riferisco anche alla memoria presentata al congresso di storia delle scienze di Londra).
1°) Dal punto di vista di un «saggio popolare» essa è una superfetazione e un bisogno (prurito) da intellettuale più che una necessità: infatti il pubblico popolare è ben lungi dal porsi il problema se il mondo esterno esista obbiettivamente o sia una costruzione dello spirito. Il pubblico popolare «crede» che il mondo esterno sia obbiettivo ed è questa «credenza» che occorre analizzare, criticare, superare scientificamente. Questa credenza è infatti d’origine religiosa, anche quando chi «crede» è religiosamente indifferente. Poiché per secoli si è creduto che il mondo è stato creato da dio prima dell’uomo, e l’uomo ha già trovato il mondo creato e catalogato, definito una volta per tutte, questa credenza diventa un dato del «senso comune», anche quando il sentimento religioso è spento o addormentato. Ecco allora che fondarsi su questa esperienza del senso comune per distruggere col ridicolo le teorie dell’idealismo, ha un significato piuttosto «reazionario», di ritorno implicito al sentimento religioso: infatti gli scrittori cattolici ricorrono allo stesso mezzo per ottenere lo stesso effetto di comicità corrosiva.
2°) Ricercare il perché sono sorte le teorie che non riconoscono la realtà obbiettiva del mondo. Sono state manifestazioni di pazzia, di delirio ecc.? Troppo semplicistico. Il materialismo storico non solo spiega e giustifica se stesso, ma spiega e giustifica tutte le teorie precedenti ecc., e in questo è la sua forza. Ora le teorie idealistiche sono il più grande tentativo di riforma morale e intellettuale che si sia verificato nella storia per eliminare la religione dal campo della civiltà. A questo è legato il problema del come e in che misura la concezione delle superstrutture nel materialismo storico sia appunto una realizzazione dell’idealismo e della sua affermazione che la realtà del mondo è una costruzione dello spirito.
3°) La posizione delle scienze naturali o esatte nel quadro del materialismo storico. Questo è il problema più interessante e urgente da risolvere, per non cadere in un feticismo che è appunto una rinascita della religione sotto altre spoglie.
Q8 §216 relle di economia. Ugo Spirito e C. L’accusa all’economia politica tradizionale di essere concepita «naturalisticamente» e «deterministicamente». Accusa senza fondamento, perché gli economisti classici non si debbono essere preoccupati molto della quistione «metafisica» del determinismo e tutte le loro deduzioni e calcoli sono basati sulla premessa del «supposto che». Cos’è questo «supposto che»? Lo Jannacone, recensendo nella Riforma Sociale il libro dello Spirito, definisce il «supposto che» come un «mercato determinato» e questo è giusto secondo il linguaggio degli economisti classici. Ma cos’è il «mercato determinato» e da che cosa appunto è determinato? Sarà determinato dalla struttura fondamentale della società in quistione e allora occorrerà analizzare questa struttura e identificarne quegli elementi che, relativamente costanti, determinano il mercato ecc., e quegli altri «variabili e in isviluppo» che determinano le crisi congiunturali fino a quando anche gli elementi relativamente costanti ne vengono modificati e si ha la crisi organica.
L’economia classica è la sola «storicista» sotto l’apparenza delle sue astrazioni e del suo linguaggio matematico, mentre proprio lo Spirito dissolve lo storicismo e annega la realtà economica in un diluvio di parole e di astrazioni. Tuttavia la tendenza rappresentata dallo Spirito e dagli altri del suo gruppo è un «segno dei tempi». La rivendicazione di una «economia secondo un piano» e non solo nel terreno nazionale, ma su scala mondiale, è interessante di per sé, anche se la sua giustificazione sia puramente verbale: è «segno dei tempi»; è l’espressione ancora «utopistica» di condizioni in via di sviluppo che, esse, rivendicano l’«economia secondo un piano».
L’interesse attuale di scrittori come lo Spirito risalta ancor più per l’accostamento con certi scrittori di economia classica come Einaudi. Gli articoli dell’Einaudi sulla crisi, ma specialmente quelli pubblicati nella «Riforma Sociale» del gennaio‑febbraio 1932 sono spesso delle arguzie da rammollito. Einaudi ristampa brani di economisti di un secolo fa e non si accorge che il «mercato» è cambiato, che i «supposto che» non sono più quelli. La produzione internazionale si è sviluppata su tale scala e il mercato è talmente divenuto complesso, che certi ragionamenti appaiono infantili, letteralmente.
Forse che in questi anni non sono nate nuove industrie? Basta citare quella della seta artificiale e quella dell’alluminio. Ciò che dice Einaudi è genericamente giusto, perché significa che le crisi passate sono state superate: 1°) allargando il circolo mondiale della produzione capitalistica; 2°) elevando il tenore di vita di determinati strati della popolazione o relativamente di tutti gli strati. Ma Einaudi non tiene conto che sempre più la vita economica si è venuta incardinando su una serie di produzioni di grande massa e queste sono in crisi: controllare questa crisi è impossibile appunto per la sua ampiezza e profondità, giunte a tale misura che la quantità diviene qualità, cioè crisi organica e non più di congiuntura. Einaudi fa ragionamenti appropriati per le crisi di congiuntura, perché vuol negare che esista una crisi organica, ma questa è «politica immediata», non analisi scientifica, è «volontà di credere», «medicina per le anime» e ancora esercitata in modo puerile e comico.
Q8 §217 Realtà del mondo esterno. Nelle sue Linee di filosofia critica, p. 159, Bernardino Varisco scrive: «Apro un giornale per informarmi delle novità; vorreste sostenere che le novità le ho create io con l’aprire il giornale?» Ciò che è stupefacente in questa proposizione è che sia stata scritta dal Varisco, il quale, se oggi si è orientato verso la trascendenza religiosa e il dualismo, è stato «idealista», dopo essere partito dal positivismo. Possibile che il Varisco ritenga che l’idealismo significa una cosa così banale e triviale? E quando era idealista, come concepiva la «soggettività» del reale? (Occorrerà leggere questo libro del Varisco per conoscerne la parte critica). La proposizione del Varisco ricorda ciò che scrive L. Tolstoi nelle sue Memorie d’infanzia e di giovinezza: il Tolstoi racconta che si faceva venire il capogiro, voltandosi improvvisamente per osservare se ci fosse stato un momento del «nulla» prima che il suo «spirito» avesse «creato» la realtà (o qualche cosa di simile: il brano del Tolstoi è molto interessante letterariamente). Che il Tolstoi desse alla proposizione dell’idealismo un significato così immediato e materiale può spiegarsi: ma il Varisco? È da osservare che proprio queste forme di critica del «senso comune» sono trascurate dai filosofi idealisti, mentre esse sono di estrema importanza per la diffusione di un modo di pensare e di una cultura.
Ricordare l’affermazione del Missiroli, riportata dall’«Italia Letteraria», e ricordare la «polemica sulla zucca» di Roberto Ardigò contenuta negli Scritti vari di R. A. raccolti e ordinati da G. Marchesini (Lemonnier, 1922): in un giornaletto religioso, il polemista (un prete della Curia vescovile) per distruggere l’Ardigò di fronte al pubblico popolare lo chiamò su per giù «uno di quei filosofi che credono che il duomo (o la cattedrale locale) esiste perché essi lo pensano, e quando non lo pensano più, il duomo sparisce», con quale effetto di comicità nei lettori è facile immaginare e con risentimento dell’Ardigò che è positivista ed è d’accordo coi cattolici nel modo di concepire la realtà fisica.
Occorre dimostrare che la concezione «soggettivistica» trova la sua interpretazione «storica» e non speculativa (e il suo superamento) nella concezione delle superstrutture: essa ha servito per superare la trascendenza da una parte e il «senso comune» dall’altra, ma nella sua forma speculativa è un mero romanzo filosofico. Un accenno a una interpretazione più realistica del soggettivismo della filosofia classica tedesca si può trovare nella recensione di G. De Ruggiero a degli scritti di B. Constant (mi pare) sulla Germania e sulla filosofia tedesca (recensione pubblicata nella «Critica» qualche anno fa).
Q8 §218 Alessandro Levi. Ricercare i suoi scritti di filosofia e di storia. Come R. Mondolfo, anche il Levi è d’origine «positivistica» (della scuola padovana di R. Ardigò). Riporto come punto di riferimento un brano del suo studio su Giuseppe Ferrari («Nuova Rivista Storica», 1931, p. 387): «No; a me non pare che nel Nostro ci sia “un certo”, e nemmeno… un incerto, materialismo storico. A me sembra, invece, che vaneggi proprio l’abisso tra la concezione ferrariana della storia e della sua pretesa filosofia della storia ed il materialismo storico, rettamente inteso, cioè non come un mero economismo (ed anche di questo, per verità, ci sono nel Ferrari assai più vaghe tracce che non nella concreta storia di un Carlo Cattaneo), bensì come quella dialettica reale, che intende la storia superandola con l’azione, e non scinde storia e filosofia, ma, rimettendo gli uomini in piedi, fa di questi gli artefici consapevoli della storia, e non i giocattoli della fatalità, in quanto i loro principii, cioè i loro ideali, scintille che sprizzano dalle lotte sociali, sono precisamente stimolo alla praxis che, per opera loro, si rovescia. Superficiale conoscitore della logica hegeliana, il Ferrari era un critico troppo precipitoso della dialettica ideale per riuscire a superarla con la dialettica reale del materialismo storico».
Q8 §219 «Saggio popolare». Residui di metafisica. Il modo di giudicare le concezioni passate filosofiche come delirio non è solo un errore di antistoricismo, cioè la pretesa anacronistica che nel passato si dovesse pensare come oggi, ma è un vero e proprio residuo di concezioni metafisiche, perché suppone un pensiero dogmatico valido in tutti i tempi e in ogni paese, alla cui stregua si giudica tutto il passato. In realtà l’«antistoricismo» in senso metodico è nient’altro che un residuo metafisico. La caducità storica dei sistemi filosofici passati è un concetto che non esclude che essi siano stati validi storicamente: la loro caducità è considerata dal punto di vista dell’intero svolgimento storico e della dialettica vita‑morte; che essi fossero degni di cadere, non è un giudizio morale o di «verità» obiettiva, ma dialettico-storico. (Cfr la presentazione fatta da Engels della proposizione hegeliana «tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale»): nel Saggio si giudica il passato come «irrazionale» e «mostruoso», la storia del passato è un trattato di teratologia, perché si parte da una concezione «metafisica» (ecco invece perché nel Manifesto è contenuto il più alto elogio del mondo che pure si presenta come morituro).
Così è da dire della concezione di una «oggettività» esteriore e meccanica, che corrisponde a una specie di «punto di vista del cosmo in sé», che è poi quello del materialismo filosofico, del positivismo e di certo scientismo. Ma che cos’è questo punto di vista, se non un residuo del concetto di dio, appunto nella sua concezione mistica di un «dio ignoto»?
Q8 §220 Un’introduzione allo studio della filosofia. Una filosofia della prassi non può presentarsi inizialmente che in atteggiamento polemico, come superamento del modo di pensare preesistente. Quindi come critica del «senso comune» (dopo essersi basata sul senso comune per mostrare che «tutti» sono filosofi e che non si tratta di introdurre ex‑novo una scienza nella vita individuale di «tutti», ma di innovare e rendere «critica» un’attività già esistente) e della filosofia degli intellettuali, che è quella che dà luogo alla storia della filosofia. Questa filosofia, in quanto «individuale» (e si sviluppa infatti essenzialmente nell’attività di singoli individui singolarmente dotati) può considerarsi come le «punte» di progresso del «senso comune», per lo meno del senso comune degli strati più colti della società. Ecco quindi che un avviamento o introduzione allo studio della filosofia deve esporre sinteticamente i «problemi» suscitatisi nel processo storico della filosofia, per criticarli, dimostrarne il valore reale (se ancora l’hanno) o il significato che hanno avuto come anelli di una catena e fissare i problemi nuovi attuali.
Il rapporto tra filosofia «superiore» e senso comune è assicurato dalla «politica» così come è assicurato dalla politica il rapporto tra il cattolicismo degli intellettuali e quello dei «semplici». Che la Chiesa debba affrontare un problema dei «semplici» significa appunto che c’è stata rottura nella comunità dei fedeli, rottura che non può essere sanata con l’elevazione dei semplici al livello degli intellettuali (la Chiesa almeno non si propone più questo compito, «economicamente» impari alle sue forze attuali) ma con una «disciplina» di ferro sugli intellettuali perché non oltrepassino certi limiti nella «distinzione» e non la rendano catastrofica e irreparabile. Nel passato queste «rotture» nella comunità dei fedeli determinavano la nascita di nuovi ordini religiosi, intorno a forti personalità (Domenico, Francesco, Caterina ecc.).
Dopo la Controriforma questo pullulare di forze nuove è stato isterilito: la Compagnia di Gesù è l’ultimo grande ordine, con carattere però repressivo e «diplomatico», che ha iniziato l’irrigidimento dell’organismo ecclesiastico. (Cfr la lista di nuovi ordini citati dal Papini per obbiettare al Croce: sono ordini di scarsissimo significato «religioso» e di grande significato «disciplinare» sulla massa dei «semplici», ramificazioni e tentacoli della Compagnia di Gesù, strumenti di «resistenza passiva» di conservazione delle posizioni acquisite, non forze rinnovatrici in isviluppo; il « modernismo» non ha creato «ordini religiosi» ma «ordini politici», la democrazia cristiana). Ricordare l’aneddoto, raccontato dallo Steed nelle sue Memorie del cardinale che al protestante inglese filocattolico spiega che i miracoli di S. Gennaro sono utili per il popolino napoletano, non per gli intellettuali, che anche nell’Evangelo ci sono delle «esagerazioni» e alla domanda: «ma siete cristiano?» risponde: «noi siamo prelati», cioè «politici» della religione cattolica.
Q8 §221 Gentile col suo seguito di Volpicelli, Spirito ecc., si può dire che hanno instaurato un secentismo filosofico. (Cfr anche il paragone con Bruno Bauer e Sacra Famiglia).
Q8 §222 Introduzione allo studio della filosofia. Sul concetto di regolarità e di legge nei fatti storici. Cfr a p. 40 la nota Scienza economica.
Q8 §223 Croce e Loria. A rifletterci su si conclude che tra Croce e Loria la distanza non è poi molto grande nel modo di interpretare il materialismo storico. Anche il Croce, riducendo il materialismo storico a un canone pratico di interpretazione storica col quale si attira l’attenzione degli storici sui fatti economici, non ha fatto che creare una forma di riduzione del materialismo storico ad un «economismo» parziale. Se si spoglia il Loria di tutte le sue bizzarrie stilistiche e sfrenatezze fantasmagoriche (e certo molto di ciò che è caratteristico del Loria si viene così a perdere) si vede che egli si avvicina al Croce nel nucleo della sua interpretazione.
Q8 §224 Teologia – metafisica – speculazione. Il Croce cerca sempre di mettere in rilievo come egli, nella sua attività di pensatore, abbia cercato di «espellere» dal campo della filosofia ogni residuo di teologia e di metafisica, fino a negare ogni «sistema» filosofico, presentando la filosofia come la soluzione dei problemi filosofici che lo sviluppo storico presenta e impone nel suo svolgimento. Ma ogni filosofia «speculativa» non è essa stessa una teologia e una metafisica? Questo «residuo» non è un residuo, è un «tutto», è tutto il metodo del filosofare, e per esso ogni affermazione di «storicismo» è vana, perché si tratta di «storicismo» speculativo, del «concetto» di storia e non della storia. (Tuttavia la critica del Croce ai residui di teologia e di metafisica deve essere riassunta e studiata attentamente),
Q8 §225 Punti per un saggio su B. Croce. 1) Quali sono gli interessi intellettuali e morali (e quindi sociali) che predominano oggi nell’attività culturale del Croce? Per comprenderli occorre ricordare l’atteggiamento del Croce verso la guerra mondiale. Egli lottò contro l’impostazione popolare (e la conseguente propaganda) che faceva della guerra una guerra di civiltà e quindi a carattere religioso. Dopo la guerra viene la pace e la pace può costringere ad aggruppamenti ben diversi da quelli della guerra; ma come sarebbe possibile una collaborazione tra popoli dopo lo scatenamento dei fanatismi «religiosi» della guerra? Il Croce vede nel momento della pace quello della guerra, e nel momento della guerra quello della pace, e lotta perché la possibilità di mediazione tra i due momenti non sia mai distrutta. Nessun criterio immediato di politica può essere innalzato a principio universale.
2) Croce come leader delle tendenze revisionistiche: nel primo momento (fine dell’800, ispiratore del Bernstein e del Sorel); e in questo secondo momento, non più di revisione ma di liquidazione (storia etico‑politica contrapposta a storia economico‑giuridica).
3) (cfr n. 7) Perché Croce è «popolare» e come e per quali vie si diffonde non il suo pensiero centrale, ma determinate sue soluzioni di problemi particolari. Stile di Croce – paragone errato con Manzoni – la prosa di Croce deve essere riattaccata alla prosa scientifica del Galilei – atteggiamento goethiano nel dopoguerra, cioè mentre tanta gente perde la testa, il Croce è imperturbabile nella sua serenità e nella sua credenza che metafisicamente il male non può prevalere e che la storia è razionalità. Perciò Croce popolare tra gli anglosassoni che hanno sempre preferito una concezione del mondo non a grandi sistemi, come i tedeschi, ma che si presenti come espressione del senso comune, come soluzione di problemi morali e pratici. Il Croce fa circolare il suo pensiero idealistico in tutti i suoi scritti minori, ma ognuno di essi si presenta come a se stante, e sembra accettabile anche se non si accetta il sistema. Ecco perché molte teorie di Croce sono penetrate tra i cattolici da una parte (Olgiati, Chiocchetti) e tra i positivisti dall’altra. Una delle ragioni della fortuna di Croce, legata alla sua serenità, è che egli non ha fatto concessioni al misticismo e alla religione (sebbene come ministro abbia riconosciuto necessaria l’introduzione della religione nella scuola elementare). Tuttavia i cattolici sono oggi i suoi maggiori avversari, appunto perché capiscono che l’importanza del Croce non è del tipo dei vecchi filosofi, ma di un riformatore religioso che mantiene il distacco tra gli intellettuali e la religione. Articoli della Nuova Antologia dovuti a due cattolici militanti, Papini e Ferrabino.
4) Tradizione italiana dei moderati. Teoria della rivoluzione‑restaurazione, una dialettica addomesticata, perché presuppone «meccanicamente» che l’antitesi debba essere conservata dalla tesi per non distruggere il processo dialettico, che pertanto viene «preveduto» come ripetentesi meccanicamente all’infinito. Invece nella storia reale l’antitesi tende a distruggere la tesi: il risultato è un superamento, ma senza che si possa a priori «misurare» i colpi come in un «ring» di lotta convenzionalmente regolamentata. Quanto più l’antitesi sviluppa se stessa implacabilmente, tanto più la tesi svilupperà se stessa, cioè dimostrerà tutte le sue possibilità di vita (la posizione del Croce è come quella di Proudhon criticata nella Miseria della filosofia: hegelismo addomesticato). (continua al 6).
5) Papini – gli ordini religiosi – Croce ha ragione poiché dopo il Concilio di Trento e i gesuiti nessun grande ordine religioso: il giansenismo e il modernismo non hanno prodotto ordini o rinnovato i vecchi. Futilità e arguzie inette di Papini, vecchio avversario di Croce (immagine dell’asinello e del somaro): in Papini giovane la polemica pareva promettere un «nobile destriero» ma è diventata «somaro». Ipocrisia repugnante: fa ricordare i versi di Strapaese agli italiani.
6) Continua il 4. Questa concezione fa porre il problema se per il Croce non sia necessaria e giustificata anche la posizione che egli combatte e quindi di quali siano i limiti e i caratteri della sua lotta. La posizione del Croce è concepita come la posizione propria degli intellettuali. Nel caso della guerra, non è certo che il Croce non ritenesse necessaria «politicamente», cioè immediatamente, quella tal forma di propaganda per avere dal popolo il massimo rendimento militare: egli però non vorrebbe che gli intellettuali cadano nell’errore di pensare come «eterno» ciò che è solo contingente: e si tratta, forse, in fondo di una nuova forma di interpretare l’affermazione che la religione è uno strumento di politica, ed è buona per il popolo.
7) continua il 3. Una ragione della diffusione di determinate opinioni crociane è data dal presentarsi l’attività del Croce come una attività critica che comincia col distruggere una serie di pregiudizi tradizionali, col dichiarare «falsi» una serie di problemi ecc., quindi come «integratrice» del buon senso.
Q8 §226 Più grassa Minerva. Leon Battista Alberti: «Quelli (i matematici) col solo ingegno, separata ogni materia, misurano le forme delle cose. Noi perché vogliamo le cose essere poste da vedere, per questo useremo più grassa Minerva».
Q8 §227 Punti per un saggio su Croce. 8) Cosa significa storia «etico‑politica»? Storia dell’aspetto «egemonia» nello Stato e, poiché gli intellettuali hanno la funzione di rappresentare le idee che costituiscono il terreno in cui l’egemonia si esercita, storia degli intellettuali, e anzi dei grandi intellettuali, fino al massimo, a quell’intellettuale che ha espresso il nucleo centrale d’idee che in un dato periodo sono dominanti. Poiché «egemonia» significa un determinato sistema di vita morale concezione della vita ecc, ecco che la storia è storia «religiosa», secondo il principio «Stato‑Chiesa» del Croce.
Ma è esistito mai Stato senza «egemonia»? E allora perché non fare la storia del principio di autorità (imperiale) per cui i contadini croati combatterono contro i liberali milanesi e i contadini lombardo-veneti contro i liberali viennesi? E il Borbone non rappresentava anche un’egemonia sui lazzari e sui contadini meridionali? («abbiamo scritto in bronte, evviva Francische seconde»). C’è lotta tra due egemonie, sempre. E perché una trionfa? Per sue doti intrinseche di carattere «logico»? La combinazione in cui l’elemento egemonico etico‑politico si presenta nella vita statale e nazionale è il «patriottismo» e il «nazionalismo» che è la «religione popolare», cioè il nesso per cui si verifica l’unità tra dirigenti e diretti.
Q8 §228 La religione, il lotto e l’oppio del popolo (vedi a p. 66). Un altro elemento da comprendere in questo «argomento» potrebbe essere quello del così detto «pari» di Pascal, che avvicina la religione al gioco d’azzardo. È da riflettere che Pascal è stato molto fine nel dare una forma letteraria e una giustificazione logica a questo argomento della scommessa, che in realtà è un modo di pensare di molti verso la religione, ma un modo di pensare «che si vergogna di se stesso» perché sembra indegno e basso. Pascal ha affrontato la «vergogna» e ha cercato di dare dignità e giustificazione al modo di pensare popolare. (Quante volte non si è inteso dire: che cosa ci perdi ad andare in chiesa, a credere in Dio ecc.? Se non c’è, pazienza; ma se c’è, vedi come ti sarà utile aver creduto ecc.) Questo modo di pensare – e anche il «pari» di Pascal – sente di volterrianismo e ricorda il modo buffonesco di dire di Heine: «credo che il padre eterno ci prepari una bella sorpresa dopo la morte» o qualcosa di simile.
Vedere come gli studiosi di Pascal spiegano il «pari». Mi pare che ci sia uno studio di P. P. Trompeo nel suo volume Rilegature gianseniste, in cui si parla del «pari» in rapporto al Manzoni.
Sarà anche da vedere se l’argomento pascaliano del «pari» abbia avuto una particolare rifioritura e diffusione nel periodo stesso in cui il Balzac si servì della sua espressione a proposito della lotteria. Questo elemento potrà essere accertato anche attraverso le ricerche sul giansenismo manzoniano pubblicate recentemente dagli studiosi più serii come il Ruffini e il Trompeo.
Q8 §229 «Saggio popolare». Nelle osservazioni sul Saggio popolare, in quanto sono complessive, riguardano il metodo generale, si può ricordare quella della superficialità logica inerente al sistema orale di diffusione della cultura e della scienza (nel Saggio prefazione si ricorda come titolo d’onore l’origine «parlata» della trattazione). Si può ricordare il principio logico dell’ignorantia elenchi e della mutatio elenchi, poiché molti esempi si possono dare e dell’uno e dell’altro.
Q8 §230 La religione, il lotto e l’oppio del popolo. È stata pubblicata in questo scorcio di tempo (forse nel 1931) una lettera inedita di Engels dove si parla diffusamente del Balzac e dell’importanza che occorre attribuirgli. L’argomento del «pari» è stato svolto dal Pascal nelle Pensées, che sono i frammenti di una Apologie de la Religion chrétienne che Pascal non condusse a termine (cfr in fine del quaderno). Linea del pensiero di Pascal (secondo Lanson, Storia della letteratura francese, 19a ed., p. 464): «Les hommes ont mépris pour la religion, ils en ont haine et peur qu’elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n’est point contraire à la raison; ensuite, qu’elle est vénérable, en donner respect; la rendre ensuite aimable, faire souhaiter aux bons qu’elle fût vraie, et puis montrer qu’elle est vraie».
Dopo il discorso contro l’indifferenza degli atei che serve come una introduzione generale dell’opera, Pascal esponeva la sua tesi dell’impotenza della ragione, incapace di saper tutto, e di saper qualcosa con certezza, ridotta a giudicare delle apparenze offerte dall’ambiente delle cose. La fede è un mezzo superiore di conoscenza; essa si esercita oltre i limiti cui può giungere la ragione. Ma anche se ciò non fosse, anche se nessun mezzo si avesse per giungere a Dio, attraverso la ragione o attraverso una qualsiasi altra via, nell’assoluta impossibilità di sapere, bisognerebbe tuttavia operare come se si sapesse. Poiché, secondo il calcolo delle probabilità, c’è vantaggio a scommettere che la religione è vera, e a regolare la propria vita come se essa fosse vera. Vivendo cristianamente si rischia infinitamente poco, qualche anno di piaceri torbidi (plaisir mêlé), per guadagnare l’infinito, la gioia eterna.
Da un articolo dell’on. Arturo Marescalchi (Durare! Anche nella bachicoltura, «Corriere della Sera» del 24 aprile 1932): «Per ogni mezza oncia di seme messo in allevamento si concorre a premi che da modesta cifra (ve ne sono 400 da mille lire) arrivano in parecchi da 10 e 20 mila lire e cinque che vanno da 25 mila a 250 mila lire. Nel popolo italiano è sempre vivo il senso del tentare la sorte; nelle campagne tutt’oggi non v’è chi si astenga dalle “pesche” e dalle “tombole”. Qui si avrà gratis il biglietto che permette di tentare la fortuna».
Connessione del lotto e della religione, anzi della superstizione verso qualche particolare santo; la vincita dovrebbe essere una particolare grazia del Santo o della Madonna (la vincita mostra che si è stati «eletti»). Si potrebbe fare il confronto tra la concezione attivistica della grazia dei protestanti che ha suscitato e ha dato la forma morale allo spirito d’intrapresa e la concezione passiva e lazzaronesca della grazia propria del popolino cattolico. Vedere anche se Baudelaire nel titolo Paradisi artificiali, e anche nella trattazione, si ispira all’«oppio del popolo»: magari la formula gli può essere giunta indirettamente dalla letteratura.
Q8 §231 Introduzione allo studio della filosofia. Rapporto tra struttura e superstruttura. Cfr nella «Critica» del 20 marzo 1932 (recensione di G. de Ruggiero di un libro di Arthur Feiler), p. 133: «… si presenta il fatto paradossale, di una ideologia grettamente, aridamente materialistica, che dà luogo, in pratica, a una passione dell’ideale, a una foga di rinnovamento, a cui non si può negare una certa sincerità. Tutto ciò è vero in linea di massima, ed è anche provvidenziale, perché mostra che l’umanità ha grandi risorse interiori, che entrano in gioco nel momento stesso che una ragione superficiale pretenderebbe negarle». Ma in verità non c’è niente di paradossale e di provvidenziale (questi filosofi speculativi quando non sanno spiegarsi un fatto, tiran fuori la solita astuzia della provvidenza) e di superficiale c’è solo l’informazione «filologica» del De Ruggiero, che si vergognerebbe di non conoscere tutti i documenti su un minuscolo fatto di storia della filosofia, ma trascura le informazioni complete su avvenimenti giganteschi come quelli sfiorati in questa recensione.
La posizione di cui parla il De Ruggiero per cui un’ideologia «grettamente ecc.», dà luogo in pratica a una passione dell’ideale ecc., non è nuova nella storia, e dovrà essere spiegata in altro modo da ciò che fa il De Ruggiero. Si può accennare alla teoria della predestinazione e della grazia propria dei protestanti e al suo dar luogo a una vasta espansione di spirito d’iniziativa. In termini religiosi è lo stesso fenomeno cui accenna il De Ruggiero, la cui mentalità «cattolica» gli impedisce di penetrare il fatto. Cfr Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, nei «Nuovi Studi» del 1931 (specialmente puntata del fascicolo novembre‑dicembre 1931) per una rappresentazione degli sviluppi della teoria della grazia che può servire a una rappresentazione del fenomeno accennato dal De Ruggiero (che a tale comprensione si opponga una mentalità cattolica si può vedere da Jemolo – storia del Giansenismo – che ignorava questa conversione attivistica della teoria della grazia e si domandava donde l’Anzilotti avesse preso una tale corbelleria).
Q8 §232 «Saggio popolare». Giudizio sulle filosofie passate. Concepire come delirio il pensiero del passato non ha nessun significato teorico, anzi è una deviazione dalla filosofia della prassi. Avrà un significato educativo, energetico? Non pare, perché esso si ridurrebbe a credere di essere «qualcosa» solo perché si è nati nel tempo presente, invece che in uno dei secoli passati. Ma in ogni tempo c’è stato un passato e una contemporaneità e l’essere «contemporaneo» è un titolo solo per barzelletta. (Si racconta l’aneddoto di un borghesuccio francese che aveva nel suo biglietto da visita «contemporaneo»; egli aveva scoperto di essere «contemporaneo» e se ne vantava).
Q8 §233 Punti per un saggio su Croce. 9) La religione: «dopo Cristo siamo tutti cristiani», cioè le dottrine morali del cristianesimo, in quanto necessità storica e non elementi ecclesiastico‑corporativi, sono stati incorporati nella civiltà moderna e circolano in essa. Se opposizione è tra Stato e Chiesa, è opposizione tra due politiche, non tra religione e politica; ma esiste un’opposizione eterna tra Stato e Chiesa in senso speculativo, cioè tra morale e politica, opposizione anch’essa speculativa, che è la sostanza dialettica del processo di sviluppo della stessa civiltà: la concezione dello Stato come egemonia porta ad affermazioni paradossali: che non sempre lo Stato è da ricercare là dove esso sembrerebbe essere «istituzionalmente»; infatti lo Stato, in questo senso, si identifica con gli intellettuali «liberi» e con quel gruppo di essi, appunto che rappresenta il principio etico‑politico intorno a cui si verifica l’unità sociale per il progresso della civiltà. La politica momento della forza, ma o prepara alla vita morale o è strumento e forma di vita morale, quindi non conflitto tra politica e morale ma quasi identificazione.
Q8 §234 «Apparenze» e superstrutture. È vero che è esistita la tendenza a giudicare le superstrutture come mere e labili apparenze.
Mi pare si possa dire che una tale tendenza si riduce essenzialmente a un atteggiamento psicologico, in cui il contenuto teorico è scarsissimo e predomina la immediata passione polemica contro una esagerazione e deformazione in senso inverso. Si potrebbe paragonare tale atteggiamento a quello che si è verificato verso la «donna» e l’amore in certe epoche. Appare una graziosa giovinetta, bianca e rosea ecc. ecc. L’uomo «pratico» valuta la sua struttura «scheletrica», l’ampiezza del «bacino», cerca di conoscere sua madre o sua nonna, per vedere quale probabile processo di deformazione ereditaria la giovinetta subirà con gli anni, per vedere quale «moglie» egli avrà fra 10 o 20 o 30 anni. Il giovinetto «satanico», con atteggiamento pessimistico o ultrarealistico, osserva la giovinetta con occhi «stecchettiani»; anch’essa è un sacco di sterco, la immagina morta e sotterrata, in putrefazione, dalle occhiaie fetenti e vuote brulicheranno i vermi, il roseo sarà cadaverico pallore, la snellezza sarà disfacimento, l’eleganza delle mosse, gioco di ossa e di tendini, sarà un sacchetto di ossa inerti ecc. È questo un atteggiamento psicologico che è legato agli anni giovanili, alle prime riflessioni. Tuttavia viene superato dalla vita, e una «determinata» donna non farà più pensare in quel modo ecc.
Q8 §235 Introduzione allo studio della filosofia. Oltre la serie «trascendenza, teologia, speculazione – filosofia speculativa», l’altra serie «trascendenza, immanenza, storicismo speculativo – filosofia della praxis». Sono da rivedere e da criticare tutte le teorie storicistiche di carattere speculativo. Da questo punto di vista bisognerebbe scrivere un nuovo Antidühring, che potrebbe essere un AntiCroce, poiché in esso potrebbe riassumersi non solo la polemica contro la filosofia speculativa, ma anche, implicitamente, quella contro il positivismo e le teorie meccanicistiche, deteriorazione della filosofia della praxis.
Q8 §236 Punti per un saggio su Croce. 10) Posto che la Storia d’Europa è come un paradigma per la cultura mondiale di storia etico‑politica, la critica del libro necessaria. Si può osservare che la «gherminella» fondamentale del Croce consiste in ciò: nell’iniziare la sua storia dopo la caduta di Napoleone. Ma esiste «secolo XIX» senza la Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche? Gli avvenimenti trattati dal Croce possono essere concepiti organicamente senza questi precedenti? Il libro del Croce è un trattato di rivoluzioni passive, per dirla con l’espressione del Cuoco, che non possono giustificarsi e comprendersi senza la rivoluzione francese, che è stata un evento europeo e mondiale e non solo francese. (Può avere questa trattazione un riferimento attuale? Un nuovo «liberalismo», nelle condizioni moderne, non sarebbe poi precisamente il «fascismo»? Non sarebbe il fascismo precisamente la forma di «rivoluzione passiva» propria del secolo XX come il liberalismo lo è stato del secolo XIX? All’argomento ho accennato in altra nota, e tutto l’argomento è da approfondire). (Si potrebbe così concepire: la rivoluzione passiva si verificherebbe nel fatto di trasformare la struttura economica «riformisticamente» da individualistica a economia secondo un piano (economia diretta) e l’avvento di una «economia media» tra quella individualistica pura e quella secondo un piano in senso integrale, permetterebbe il passaggio a forme politiche e culturali più progredite senza cataclismi radicali e distruttivi in forma sterminatrice. Il «corporativismo» potrebbe essere o diventare, sviluppandosi, questa forma economica media di carattere «passivo»). Questa concezione potrebbe essere avvicinata a quella che in politica si può chiamare «guerra di posizione» in opposizione alla guerra di movimento. Così nel ciclo storico precedente la Rivoluzione francese sarebbe stata «guerra di movimento» e l’epoca liberale del secolo XIX una lunga guerra di posizione.
Q8 §237 Introduzione allo studio della filosofia. Uno dei concetti fondamentali da fissare è quello di «necessità» storica. Nel senso speculativo‑astratto. Nel senso storico‑concreto: la necessità è data dall’esistenza di una premessa efficiente, che sia diventata operosa come una «credenza popolare» nella coscienza collettiva. Nella premessa sono contenute le condizioni materiali sufficienti per la realizzazione dell’impulso di volontà collettiva.
Altro concetto da ridurre da speculativo a storicistico è quello di «razionalità» nella storia (e quindi di «irrazionalità»), concetto legato a quello di «provvidenza» e di «fortuna», nel senso in cui è adoperato (speculativamente) dai filosofi idealisti italiani e specialmente dal Croce. Occorrerà perciò vedere l’opera del Croce su G. B. Vico, in cui il concetto di «provvidenza» è appunto «speculativizzato», dando inizio così all’interpretazione idealistica della filosofia del Vico. Per il significato di «fortuna» nel Machiavelli cfr L. Russo, in nota alla sua edizione major del Principe (p. 23).
(Per Machiavelli «fortuna» ha un duplice significato, uno obbiettivo e un altro soggettivo. La «fortuna» è la forza naturale delle cose, la concorrenza propizia degli eventi, quella che sarà la Provvidenza del Vico, oppure è quella potenza trascendente di cui favoleggiava la vecchia dottrina medioevale, cioè dio, e per il Machiavelli ciò non è poi che la virtù stessa dell’individuo e la sua potenza ha radice nella stessa volontà dell’uomo. La virtù del Machiavelli, come dice il Russo, non è più la virtù degli scolastici, la quale ha un carattere etico e ripete la sua forza dal cielo, e nemmeno quella di Tito Livio, che sta a significare per lo più il valore militare, ma la virtù dell’uomo del Rinascimento, che è capacità, abilità, industria, potenza individuale, sensibilità, fiuto delle occasioni e misura delle proprie possibilità).
Il Russo ondeggia in seguito nella sua analisi. Per lui il «concetto di fortuna, come forza delle cose, che nel Machiavelli come negli umanisti serba ancora un carattere naturalistico e meccanico, troverà il suo inveramento e approfondimento storico solo nella razionale provvidenza di Vico e di Hegel. Ma è bene avvertire che tali concetti nel Machiavelli, non hanno mai un carattere metafisico come nei filosofi veri e propri dell’Umanesimo ma sono semplici e profonde intuizioni (quindi filosofia!) di vita, e come simboli di sentimenti vanno intesi e spiegati». Sulla lenta formazione metafisica di questi concetti, nel periodo premachiavellico, il Russo rimanda al Gentile, Giordano Bruno e il pensiero del Rinascimento («Il concetto dell’uomo nel Rinascimento» e l’Appendice) (Firenze, Vallecchi).
Sugli stessi concetti nel Machiavelli cfr F. Ercole, La politica di Machiavelli.
Q8 §238 Introduzione allo studio della filosofia. Filosofia speculativa. Si può riflettere su questo punto: se l’elemento «speculazione» sia proprio di ogni filosofia o sia una fase di un pensiero filosofico in isviluppo secondo il processo generale di un determinato periodo storico. Si potrebbe allora dire che ogni cultura ha il suo momento speculativo o religioso, che coincide col periodo di completa egemonia del gruppo sociale che esprime, e forse coincide proprio col momento in cui l’egemonia reale si disgrega ma il sistema di pensiero si perfeziona e si raffina come avviene nelle epoche di decadenza. La critica risolve la speculazione nei suoi termini reali di ideologia, ma la critica stessa avrà una sua fase speculativa, che ne segnerà l’apogeo. La quistione è questa: se questo apogeo non sarà l’inizio di una fase storica in cui necessità‑libertà essendosi compenetrate organicamente, nel tessuto sociale, non ci sarà altra dialettica che quella ideale.
Q8 §239 Saggio popolare. Teleologia. In altra nota ho citato un epigramma di Goethe contro il teleologismo. Questo stesso spunto Goethe ripete in altra forma (cercare dove) e dice di averlo derivato da Kant: «Il Kant è il più eminente dei moderni filosofi, quello le cui dottrine hanno maggiormente influito nella mia coltura. La distinzione del soggetto dall’oggetto ed il principio scientifico che ogni cosa esiste e si svolge per ragion sua propria ed intrinseca (che il sughero, a dirla proverbialmente, non nasce per servir di turacciolo alle nostre bottiglie) ebb’io comune col Kant, ed io in seguito applicai molto studio alla sua filosofia».
Q8 §240 Punti per un saggio su Croce. Storia etico‑politica o storia speculativa? Si può sostenere che la storia in atto del Croce non è neanche etico‑politica, ma storia speculativa, un ritorno, sia pure in forme letterarie rese più accorte e meno ingenue dallo sviluppo dell’attività critica, a forme già verificatesi nel passato e cadute in discredito come vuote e retoriche. La storia etico‑politica non può prescindere neanche essa dalla concezione di un «blocco storico», in cui l’organismo è individualizzato e reso concreto dalla forma etico‑politica, ma non può essere concepito senza il suo contenuto «materiale» o pratico. Bisogna dimostrare che contenuto e forma sono identici, ma bisogna dimostrarlo ogni volta in atto, individualmente, altrimenti si fanno dei filosofemi e non si fa storia. Nella scienza naturale ciò equivarrebbe a ritornare ad un periodo in cui le classificazioni avvenivano per il colore della pelle o del piumaggio o del pelo, e non sull’anatomia. La storia non è scienza naturale, e il suo fine non è di classificare; quindi il riferimento alle scienze naturali e alla necessità di una «anatomia» della società, non era che una metafora e un impulso ad approfondire le ricerche metodologiche e filosofiche. Nella storia umana in atto, il «colore della pelle» non è un accidente, perché non si tratta di classificare o di polemizzare ma di ricostruire e si sa che in ogni individuo il colore della pelle è «blocco» con la struttura anatomica e con tutte le funzioni fisiologiche; non si può pensare un individuo «scuoiato» come il vero individuo; vero vorrebbe dir morto, elemento non più attivo e operante ma oggetto da tavolo anatomico. Ma l’estremo opposto è altrettanto erroneo e astratto e antistorico. Si vede nella Storia d’Europa nel fatto che il periodo scelto è monco, è il periodo delle rivoluzioni passive, per dirla col Cuoco, il periodo della ricerca delle forme superiori, della lotta per le forme, perché il contenuto si è già affermato con le rivoluzioni inglesi, con quelle francesi, con le guerre napoleoniche.
Cfr p. 36. Altro punto: il concetto di «libertà» identico a storia e a processo dialettico, e quindi presente sempre in ogni storia e il concetto di libertà come ideologia o religione (o fanatismo, secondo i clericali per es.): confusione pericolosa, secondo la filosofia del Croce, tra filosofia e ideologia, per cui anche la filosofia diventa «strumento di politica», (cioè «errore» d’origine pratica o illusione secondo il materialismo storico, cioè formazione d’origine immediata e immediatamente transeunte). (Uno scultore, Rodin, dice – secondo M. Barrès, in Mes Cahiers, IV serie –: «Si nous n’étions pas prévenus contre le squelette, nous verrions comme il est beau»).
Q8 §241 Le Pensées di Pascal furono stampate la prima volta nel 1670 dai suoi amici di Port‑Royal molto scorrettamente. Il testo manoscritto autentico è stato segnalato nel 1843 da Victor Cousin e stampato nel 1844 dall’editore Faugère.
Q8 §242 1° Origini popolaresche del «superuomo». Lo si trova nel basso romanticismo del romanzo d’appendice: in Dumas padre: Conte di Montecristo, Athos, Giuseppe Balsamo, per esempio. Ora: molti sedicenti nicciani non sono che... dumasiani che più tardi, con imparaticci nicciani, hanno «giustificato» lo stato d’animo creato dalla lettura del Conte di Montecristo.
Q8 §243 2° Risorgimento Italiano. Derivazioni del sistema
d’interpretazioni del Risorgimento sono
un certo settarismo della mentalità italiana e la tendenza
a credersi malgiudicati e mal compresi.
Q8 §244 3° Machiavelli. Contro il «volontarismo» o garibaldinismo. Contro, naturalmente, se vuole perpetuare se stesso come forma organica di attività storico‑politica, non come momento iniziale di un periodo organico. Così contro le «avanguardie» senza esercito dietro, contro gli arditi senza fanteria e artiglieria, ma non contro avanguardie e arditi se funzioni di organismo complesso e regolare, così contro intellettuali senza massa, ma non contro intellettuali di una massa. Per formazioni omogenee, formate di blocchi sociali compatti, e per intellettuali, avanguardia, arditi che a suscitare tali blocchi lavorano e non a perpetuare il loro dominio zingaresco.
Q8 §245 4° Letteratura popolare. Se è vero che la biografia romanzata continua il romanzo storico tipo Dumas ecc., si può dire che da questo punto di vista, in questo particolare settore, in Italia si sta «colmando una lacuna». Cfr pubblicazioni del «Corbaccio», di storia romanzata ecc. Ma la letteratura popolare solo in questo ha in Italia uno sviluppo, perché non è più popolare, in senso stretto, ma si rivolge solo a certi strati popolari più snobistici, di piccoli intellettuali o aspiranti tali. Romanzo poliziesco, di varie forme, zero, eppure questo è il moderno romanzo popolare. Romanzo «d’avventura» in senso largo, zero.
QUADERNO 9
Q9 §1 Nozioni enciclopediche. Il galletto rosso. Dal francese le coq rouge, termine che deve essere d’origine contadina e indica l’incendio appiccato per ragioni politiche nelle lotte di fazione e nelle jacqueries. Si potrebbe ricordare la così detta tattica del fiammifero predicata da Michelino Bianchi e Umberto Pasella nelle campagne emiliane durante il predominio sindacalista verso il 1906.
Q9 §2 I nipotini di padre Bresciani. Una sfinge senza enigmi. Nell’«Ambrosiano» dell’8 marzo 1932 Marco Ramperti aveva scritto un articolo La Corte di Salomone in cui, tra l’altro scriveva: «Stamattina mi sono destato sopra un “logogrifo” di quattro righe, intorno a cui avevo vegliato nelle ultime sette ore di solitudine, senza naturalmente venirne a capo di nulla. Ombra densa! Mistero senza fine! Al risveglio mi accorsi, però, che nell’atonia febbrile avevo scambiato la Corte di Salomone con l’Italia Letteraria, il “logogrifo” enigmatico con un carme del poeta Ungaretti…». A queste eleganze del Ramperti l’Ungaretti risponde con una lettera pubblicata nell’«Italia Letteraria» del 10 aprile e che mi pare un «segno dei tempi». Se ne possono ricavare quali «rivendicazioni» l’Ungaretti ponga al «suo paese» per essere compensato dei suoi meriti nazionali e mondiali. (L’Ungaretti non è che un buffoncello di mediocre intelligenza): «Caro Angioletti, di ritorno da un viaggio faticoso per guadagnare lo scarso pane dei miei bimbi, trovo i numeri dell’“Ambrosiano” e della “Stampa” nei quali un certo signor Ramperti ha creduto di offendermi. Potrei rispondergli che la mia poesia la capivano i contadini, miei fratelli, in trincea; la capisce il mio Duce che volle onorarla di una prefazione; la capiranno sempre i semplici e i dotti di buona fede. Potrei dirgli che da 15 anni tutto ciò che di nuovo si fa in Italia e fuori, porta in poesia l’impronta dei miei sogni e del mio tormento espressivo; che i critici onesti, italiani e stranieri, non si fanno pregare per riconoscerlo; e, del resto, non ho mai chiesto lodi a nessuno. Potrei dirgli che una vita durissima come la mia, fieramente italiana e fascista, sempre, davanti a stranieri e connazionali, meriterebbe almeno di non vedersi accrescere le difficoltà da parte di giornali italiani e fascisti. Dovrei dirgli che se c’è cosa enigmatica nell’anno X (vivo d’articoli nell’assoluta incertezza del domani, a quaranta anni passati!), è solo l’ostinata cattiveria verso di me da parte di gente di… spirito. – Con affetto – Giuseppe Ungaretti». La lettera è un capolavoro di tartuferia letteraria e di melensaggine presuntuosa.
Q9 §3 Nozioni enciclopediche. Angherie. Il termine è ancora usato in Sicilia per indicare certe obbligazioni alle quali è sottoposto il lavoratore nei suoi rapporti col proprietario o gabellotto o subaffittario nei contratti così detti di mezzadria (e che sono contratti a partecipazione o di semplice affitto con pagamento in natura fissato con la metà del raccolto o anche più, oltre le «prestazioni speciali» o angherie). Il termine è ancora quello dei tempi feudali, da cui è derivato il suo significato nel linguaggio comune (vessazione, ecc.). Per ciò che riguarda la Toscana è da citare un brano di un articolo di F. Guicciardini (Nuova Antologia, 16 aprile 1907), Le recenti agitazioni agrarie in Toscana e i doveri della proprietà: «Fra i patti accessori del contratto colonico, non accenno ai patti che chiamerò angarici, in quanto costituiscono oneri del colono, che non hanno per corrispettivo alcun vantaggio speciale; tali sarebbero i bucati gratuiti, la tiratura dell’acqua, la segatura di legna e fascinotti per le stufe del padrone, il contributo in grasce a favore del guardiano, la somministrazione di paglia e fieno per la scuderia di fattoria e in generale tutte le somministrazioni gratuite in favore del padrone. Io non potrei affermare se questi fatti siano ultimi resti del regime feudale sopravvissuti alla distruzione dei castelli e alla liberazione dei coloni, oppure se siano incrostazioni formatesi per abuso dei padroni e ignavia dei coloni, in tempi più vicini a noi sul tronco genuino del contratto». Secondo il Guicciardini queste prestazioni sono sparite pressoché ovunque (nel 1907), ma la cosa è dubbia. Non solo in Toscana, ma in Piemonte (almeno per gli schiavandari) fino al 1906 era diffuso il diritto del padrone di chiudere i coloni dentro casa a una certa ora della sera e così avveniva nell’Umbria ecc.
Q9 §4 Storia delle classi subalterne. De Amicis. Del De Amicis sono da vedere la raccolta di discorsi Speranze e Glorie e il volume su Lotte civili. La sua attività letteraria e di oratore in questo senso va dal 90 al 900 ed è da vedere per ricercare l’atteggiamento di certe correnti intellettuali del tempo in confronto della politica statale. Si può vedere quali erano i motivi dominanti, le preoccupazioni morali e gli interessi di queste correnti. Del resto non si tratta di una corrente unica. Sebbene si debba parlare di un socialnazionalismo o socialpatriottismo nel De Amicis, è evidente la sua differenza dal Pascoli, per esempio: il De Amicis era contro la politica africanista, il Pascoli invece era un colonialista di programma.
Q9 §5 Risorgimento italiano. Sommossa di Palermo del 1866. Era prefetto a Palermo Luigi Torelli, sul quale cfr Antonio Monti, Il conte Luigi Torelli, Milano, R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 1931, in 8° pp. 513, L. 30. Dopo la repressione il Torelli ebbe la medaglia d’oro al valor civile. Si dovrà vedere il libro anche perché il Torelli ebbe una funzione abbastanza significativa in tutto il Risorgimento.
Q9 §6 Argomenti di cultura. Il movimento e il fine. È possibile mantenere un movimento senza che si abbia una previsione del fine? Il principio di Bernstein secondo cui il movimento è tutto e il fine è nulla, sotto un’apparenza di interpretazione «ortodossa» della dialettica, nasconde una concezione puramente meccanicistica del movimento, per cui le forze umane sono considerate come passive e non consapevoli, come elementi non dissimili dalle cose materiali. Ciò è interessante notare perché il Bernstein ha cercato le sue armi nel revisionismo idealistico, che avrebbe dovuto portarlo invece a valutate l’intervento degli uomini come decisivo nello svolgimento storico. Ma se si analizza a fondo, si vede che nel Bernstein l’intervento umano è valutato, sia pure implicitamente, ma in modo unilaterale, poiché è considerato come «tesi» ma non come «antitesi»; efficiente come tesi, ossia nel momento della resistenza e della conservazione, è rigettato come antitesi, ossia come iniziativa e come spinta progressiva. Possono esistere «fini» per la resistenza e la conservazione, non per il progresso e l’iniziativa. La passività è la conseguenza di tale concezione, poiché invece proprio l’antitesi (che presuppone il risveglio di forze ancora latenti e addormentate) ha bisogno di fini, immediati e mediati, per il movimento. Senza la prospettiva dei fini concreti, non si riesce a mantenere il movimento.
Q9 §7 Argomenti di cultura. Il male minore. Si potrebbe trattare in forma di apologo. Il concetto di male minore è dei più relativi. C’è sempre un male ancora minore di quello precedentemente minore e in confronto di un pericolo maggiore in confronto di quello precedentemente maggiore. Ogni male maggiore diventa minore in confronto di un altro ancor maggiore e così all’infinito. Si tratta dunque niente altro che della forma che assume il processo di adattamento a un movimento regressivo, di cui una forza efficiente conduce lo svolgimento, mentre la forza antitetica è decisa a capitolare progressivamente, a piccole tappe, e non d’un solo colpo, ciò che gioverebbe, per l’effetto psicologico condensato, a far nascere una forza concorrente attiva, o a rinforzarla se già esistesse. Poiché è giusto il principio che i paesi più avanzati in un certo svolgimento sono l’immagine di ciò che avverrà negli altri paesi dove il movimento è agli inizi, la comparazione è d’obbligo.
Q9 §8 Passato e presente. Azioni e obbligazioni. Quale radicale mutamento porterà nell’orientamento del piccolo e medio risparmio l’attuale depressione se si prolunga ancora per qualche tempo? Si può osservare che la caduta del mercato azionario ha determinato uno smisurato spostamento di ricchezza e un fenomeno mai visto, di espropriazione «simultanea» di vastissime masse della popolazione, specialmente in America, ma un po’ da per tutto. Il sistema introdotto dal governo italiano pare il più razionale e organico, per certi gruppi di paesi, almeno, ma quali conseguenze potrà avere?
Si osserva una differenza tra le azioni e le obbligazioni industriali, e una differenza ancora tra azioni e obbligazioni del mercato libero e obbligazioni di Stato. Il pubblico cerca di disfarsi completamente delle azioni, svalutate in misura inaudita, preferisce le obbligazioni industriali alle azioni, ma preferisce le obbligazioni di Stato alle une e alle altre. Si può dire che il pubblico rompe ogni legame diretto col regime capitalistico, ma non rifiuta la fiducia allo Stato; vuole partecipare all’attività economica, ma attraverso lo Stato, che garantisca un interesse modico, ma sicuro. Lo Stato assume così una funzione di primo ordine come capitalista, come azienda che concentra il risparmio da porre a disposizione dell’industria e dell’attività privata, come investitore a medio e lungo termine. (Istituto di credito mobiliare). Ma assunta questa funzione può lo Stato disinteressarsi dell’organizzazione produttiva? Lasciarla, come prima, all’iniziativa della concorrenza privata? Se ciò avvenisse, la sfiducia che oggi colpisce l’industria, travolgerebbe lo Stato: una nuova depressione che costringesse lo Stato a svalutare le sue obbligazioni come si sono svalutate le azioni e le obbligazioni industriali sarebbe catastrofica per l’insieme dell’organizzazione politico‑sociale.
Lo Stato deve intervenire per controllare se i suoi investimenti sono bene amministrati. Si capisce lo sviluppo di un aspetto almeno del regime corporativo. Ma il puro controllo non sarà sufficiente. Non si tratta infatti di conservare l’apparato produttivo così come è in un momento dato. Bisogna svilupparlo parallelamente all’aumento della popolazione e dei bisogni collettivi. In questi sviluppi necessari è il pericolo maggiore dell’iniziativa privata e qui sarà maggiore l’intervento statale.
Se lo Stato si preoccupasse di iniziare un processo per cui la produzione del risparmio da funzione di una classe parassitaria diventasse funzione dello stesso organismo produttivo, questi sviluppi sarebbero progressivi, rientrerebbero in un disegno comprensivo di razionalizzazione integrale: bisognerebbe condurre una riforma agraria (abolizione della rendita terriera e incorporazione di essa nell’organismo produttivo, come risparmio collettivo di ricostruzione e neocostruzione) e una riforma industriale, per condurre tutti i redditi a necessità tecnico‑industriali e non più a necessità giuridiche di diritto quiritario.
In questa situazione generale è la giustificazione storica delle tendenze corporative, che si manifestano come esaltazione dello Stato in generale, concepito in assoluto, e come diffidenza e avversione alle forme tradizionali capitalistiche. Quindi base sociale‑politica dello Stato affermata e cercata nella piccola borghesia e negli intellettuali, ma in realtà struttura plutocratica e legami col capitale finanziario. Le due cose non sono contraddittorie, tutt’altro, come dimostra un paese esemplare, la Francia, dove appunto non si comprenderebbe il dominio del capitale finanziario senza la base politica di una democrazia di redditieri piccoli borghesi e di piccoli contadini. Tuttavia la Francia, per ragioni complesse, ha ancora una composizione sociale abbastanza sana, perché contribuisce a formarla la piccola e media proprietà coltivatrice. In altri paesi invece, i risparmiatori sono staccati dalla produzione e dal lavoro; il risparmio è «socialmente» caro, perché ottenuto con un livello di vita troppo basso dei lavoratori sia industriali, sia specialmente agricoli. Se la nuova struttura del credito consolidasse questa situazione, in realtà la peggiorerebbe, perché se il risparmio parassitario non corresse più neanche le alee generali del mercato normale, ci sarebbe la tendenza a un assalto della proprietà terriera parassitaria da una parte e le obbligazioni industriali dall’altra finirebbero coll’assicurare il dividendo legale a spese del lavoro in modo troppo gravoso.
Q9 §9 Passato e presente. Le prigioni dello Stato pontificio. Nel fascicolo aprile‑settembre 1931 della «Rassegna Storica del Risorgimento» è pubblicato da Giovanni Maioli un capitolo di una autobiografia inedita di Bartolo Talentoni, patriotta forlivese. Il capitolo si riferisce alle procedure giudiziarie e alla prigionia patita dal Talentoni, quando fu arrestato nel 1855 come cospiratore e favoreggiatore di sétte in Romagna. Carcere di Bologna. Tra l’altro si può stralciare questo: «Tutto colà era calcolato né mai ci lasciavano un momento tranquilli...» Perché un sonno riparatore non rafforzasse lo spirito e il corpo dei detenuti si ricorreva ai mezzi più impensati. La sentinella faceva rimbombare la prigione cogli urrà, durante la notte il catenaccio era fatto scorrere con la più rumorosa violenza, ecc. (Questi cenni sono presi dal «Marzocco» del 25 ottobre 1931).
Q9 §10 I nipotini di padre Bresciani. C. Malaparte. Cfr nell’«Italia Letteraria» del 3 gennaio 1932 l’articolo del Malaparte: Analisi cinica dell’Europa. Negli ultimi giorni del 1931 nei locali dell’«École de la Paix» a Parigi l’ex Presidente Herriot tenne un discorso sui mezzi migliori per organizzare la pace europea. Dopo Herriot parlò il Malaparte in contradditorio: «Siccome anche voi, sotto certi aspetti (sic), siete un rivoluzionario, dissi tra l’altro a Herriot (scrive il Malaparte nel suo articolo), penso che siate in grado di capire che il problema della pace dovrebbe essere considerato non solo dal punto di vista del pacifismo accademico, ma anche da un punto di vista rivoluzionario. Soltanto lo spirito patriottico e lo spirito rivoluzionario (se è vero, come è vero, ad esempio, nel fascismo, che l’uno non esclude l’altro) possono suggerire i mezzi di assicurare la pace europea. – Io non sono un rivoluzionario, mi rispose Herriot; sono semplicemente un cartesiano. Ma voi, caro Malaparte, non siete che un patriota».
Così per Malaparte, anche Herriot è un rivoluzionario, almeno per certi aspetti, e allora si fa anche più difficile sapere cosa significa «rivoluzionario» per Malaparte. Se nel linguaggio comune rivoluzionario stava assumendo sempre più il significato di «attivista», di «interventista», di «volontarista», «dinamico», è difficile dire come Herriot possa esserne qualificato, ed Herriot con molto spirito ha risposto di essere un «cartesiano». Per Malaparte «rivoluzionario» mi pare possa intendersi essere ormai un complimento, come una volta «gentiluomo», o «grande galantuomo», «vero galantuomo» ecc. E anche questo è Brescianesimo; dopo il 48 ci furono i veri liberali e i libertini e demagoghi.
Q9 §11 I nipotini di padre Bresciani. Giovanni Ansaldo. Con un posticino a parte, nella rubrica deve entrare anche Giovanni Ansaldo. Ricordare il suo dilettantismo politico‑letterario, come quello di voler essere «in pochi», di voler formare un’aristocrazia: i suoi atteggiamenti erano dunque «snob», più che convinzione etico‑politica, un modo di fare della letteratura distinta. E così l’Ansaldo è diventato la «Stelletta nera» del «Lavoro», che ci tiene a che si vedano che ha solo cinque punte per non essere confusa con quella che nei «Problemi del Lavoro» indica Franz Weiss e che ha sei punte (che l’Ansaldo ci tenga alle cinque punte appare dall’Almanacco delle Muse del 1931, Almanacco dell’Alleanza del Libro – rubrica genovese). Per Ansaldo tutto diventa eleganza letteraria; l’erudizione, la precisione della coltura è eleganza letteraria; la stessa serietà morale non è serietà ma eleganza, fiore all’occhiello. Anche questo atteggiamento si può chiamare ed è gesuitismo, un culto del proprio «particulare» nell’ordine dell’intelletto, una esteriorità da sepolcro imbiancato.
Q9 §12 Lorianesimo. Enrico Ferri. Può darsi che la conferenza di Ferri su Zola in cui è contenuta l’affermazione dell’«obbiettività» consistente nell’ignoranza sia lo scritto Emilio Zola, artista e cittadino contenuto nel volume I delinquenti nell’arte ed altre conferenze pubblicato dall’Unione Tipogr. Ed. Torinese nel 1926 (seconda ediz. interamente rifatta in 8°, pp. XX‑350, L. 35). Nel volume si potrà forse trovare qualche altro spunto «loriano» non meno caratteristico di quello «musicale». Nel volume d’altronde sono contenuti scritti che avranno significato per altre rubriche, come i Ricordi di giornalismo e La scienza e la vita nel secolo XIX.
Q9 §13 Argomenti di coltura. Max Nordau. Grande diffusione dei libri del Nordau in Italia negli strati più colti del popolo e della piccola borghesia urbana. Le menzogne convenzionali della nostra civiltà e Degenerazione erano giunti rispettivamente all’ottava edizione (nel 1921) e alla quinta edizione (nel 1923) nella pubblicazione regolare dovuta ai Fratelli Bocca di Torino; ma questi libri passarono nel dopoguerra ai librai tipo Madella e Barion e furono lanciati dai venditori ambulanti a bassissimo prezzo in quantità molto voli. Hanno contribuito così a far entrare nell’ideologia popolare (senso comune) una certa serie di credenze e di «canoni critici» che appaiono come il non plus ultra dell’intellettualità e dell’alta cultura, così come vengono concepite dal popolo.
Q9 §14 Passato e presente. Franz Weiss e i suoi proverbi. Cfr Don Quijote, seconda parte, cap. XXXIV: «Maldito seas de Dios y de todos sus santos, Sancho maldito – dijo Don Quijote –; y cuándo será el d’a, como otras muchas veces he dicho, donde yo te vea hablar sin refranes una razón corriente y concertada» (confr. quad. I, p. 47). Nei consigli che Don Chisciotte dà a Sancio prima di diventar governatore dell’isola, un paragrafo è dedicato contro i troppi proverbi cap. XLIII: «También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles; que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos, que mas parecen disparates que sentencias. – Eso Dios lo puede remediar, respondió Sancho, porque sé mas refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos á la boca cuando hablo, que riñen por salir unos con otros; pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan á pelo». Nello stesso capitolo XLIII: «Oh, maldito seas de Dios, Sancho! …. Sesenta mil satanases te lleven á t’ y à tus refranes! …. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un dia á la horca». E Sancio: «¿A qué diablos se pudre de que yo me sirva de mi hacienda, que ninguna otra tengo, ni otro caudal alguno, sino refranes y mas refranes?». Al capitolo l, il curato del pueblo di Don Chisciotte dice: «Yo no puedo creer sino que todos los deste linaje de los Panzas nacieron cada uno con un costal de refranes en el cuerpo: ninguno dellos he visto que no los derrame á todas horas y en todas las pláticas que tienen», dopo aver sentito che anche Sanchicha, figlia di Sancio, snocciola proverbi. Si può dunque sostenere che Franz Weiss è disceso dai lombi de los Panzas e che, quando vorrà latinizzare tutto il suo nome, oltre a Franz, non dovrà chiamarsi Bianco ma Panza, o Pancia ancor più italianamente.
Q9 §15 Folclore. Raffaele Corso chiama il complesso dei fatti folcloristici una «preistoria contemporanea», ciò che è solo un bisticcio per definire un fenomeno complesso che non si lascia definire brevemente. Si può ricordare in proposito il rapporto tra le così dette «arti minori» e le così dette «arti maggiori», cioè tra l’attività dei creatori d’arte e quella degli artigiani (delle cose di lusso o per lo meno non immediatamente utilitarie). Le arti minori sono sempre state legate alle arti maggiori e ne sono state dipendenti. Così il folclore è sempre stato legato alla cultura della classe dominante, e, a suo modo, ne ha tratto dei motivi che sono andati a inserirsi in combinazione con le precedenti tradizioni. Del resto niente di più contraddittorio e frammentario del folclore.
In ogni modo si tratta di una «preistoria» molto relativa e molto discutibile e niente sarebbe più disparato che voler trovare in una stessa area folcloristica le diverse stratificazioni. Ma anche il confronto tra aree diverse, sebbene sia il solo indirizzo metodico razionale, non può permettere conclusioni tassative, ma solo congetture probabili, poiché è difficile fare la storia delle influenze che ogni area ha accolto e spesso si paragonano entità eterogenee. Il folclore, almeno in parte, è molto più mobile e fluttuante della lingua e dei dialetti, ciò che del resto si può dire per il rapporto tra cultura della classe colta e lingua letteraria: la lingua si modifica, nella sua parte sensibile, molto meno del contenuto culturale; e solo nella semantica si può, naturalmente, registrare una adesione tra forma sensibile e contenuto intellettuale.
Q9 §16 Grande potenza. Politica estera. «Così la politica estera italiana, mirando sempre alla stessa mèta, è stata sempre rettilinea, e le sue pretese oscillazioni sono state in realtà determinate soltanro dalle incertezze e dalle contraddizioni altrui, com’è inevitabile nel campo internazionale dove infiniti sono gli elementi in contrasto» (Aldo Valori, «Corriere della Sera» del 12 maggio 1932). Che siano infiniti gli elementi di equilibrio di un sistema politico internazionale, è vero, ma appunto per ciò il sistema deve essere stabilito in modo che, nonostante le fluttuazioni «esterne», la propria linea non oscilli. La linea di uno Stato egemonico (cioè di una grande potenza) non oscilla perché esso stesso determina la volontà altrui, e non ne è determinato, perché si fonda su ciò che vi è di permanente e non di casuale e immediato nelle altrui volontà.
Q9 §17 Passato e presente. Bibliografia. Nel «Corriere della Sera» del 12 maggio 1932 Arturo Marescalchi (Come vivono i rurali) parla di due libri, senza darne le indicazioni bibliografiche: uno del dott. Guido Mario Tosi studia il bilancio di una famiglia di piccoli proprietari nel Bergamasco (il bilancio è passivo); l’altro studio, diretto dal prof. Ciro Papi e compiuto dai dottori Filippo Scarponi e Achille Grimaldi tratta del bilancio di una famiglia di mezzadri in provincia di Perugia nella media valle del Tevere. La famiglia del mezzadro è in condizioni migliori di quella del piccolo proprietario, ma anche questo bilancio è tutt’altro che sicuro. Si tratta di due pubblicazioni dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria, che ha pubblicato anche un’inchiesta sulla nuova formazione di piccola proprietà coltivatrice nel dopoguerra. I libri sono in vendita presso Treves‑Treccani‑Tumminelli.
Q9 §18 Passato e presente. Santi Sparacio. Nel capitolo XXII della seconda parte del Don Chisciotte: «l’humanista» che accompagna Don Chisciotte e Sancio alla «cueva de Montesinos». «En el camino preguntó Don Quijote al primo de qué género y calidad eran sus ejercicios, sus profesion y estudios. A lo que él respond’o que su profesion era ser humanista, sus ejercicios y estudios componer libros para dar á la estampa, todos de gran provecho y no menos entretenimiento para la repòblica: que el uno se intitulaba El de las libreas, donde pintaba setecientas y tre libreas con sus colores, motes y cifras, de donde podian sacar y tomar las que quisiesen en tiempo de festas y regocijos los caballeros cortesanos, sin andarlas mendigando de nadie, ni lambicando, como dicen, el cerbelo por sacarlas conformes á sus deseos y intenciones; porque doy al zeloso, al desdeñado, al olvidado y al ausente las que les convienen, que les vendrán mas justas que pecadoras. Otro libro tengo tambien, á quien he de llamar, Metamorfóseos, ó, Ovidio español, de invencion nueva y rara; porque en él, imitando á Ovidio à lo burlesco, pinto quién fué la Giralda de Sevilla y el ángel de la Magdalena, quién el caño de Vecinguerra de Córdoba, quién es los toros de Guisando, la Sierra Morena, las fuentes de Leganitos y Lavapiés en Madrid, no olvidándome de la del Piojo, de la del Caño dorado y de la Priora; y esto con sus alegor’as, metáforas y translaciones, de modo que alegran, suspenden y enseñan á un mismo punto. Otro libro tiengo, que le llamo Suplemento á Virgilio Polidoro, que trata de la invencion de las cosas, que es de grande erudicion y estudio, á causa que las cosas que se dejó de decir Polidoro de gran sustancia, las averiguo yo, y las declaro por gentil estilo. Olvidósele à Virgilio de declararnos quién fué el primero que tuvo catarro en el mundo, y el primero que tomó las unciones para curarse del mor bo gálico, y yo lo declaro al pie de la letra, y lo autorizo con mas de veinte y cinco autores, porque vea vuesa merced si he trabajado bien, y si ha de ser òtil el tal libro á todo el mundo».
Sancio si interessa, com’è naturale, specialmente a quest’ultimo libro, e pone delle quistioni all’«humanista»: «¿Quién fué el primero que se rascó en la cabeza?» …. «¿quién fué el primer volteador del mundo?» e risponde che il primo fu Adamo, che avendo testa e capelli, certo tal olta dovette grattarsi la testa, e il secondo Lucifero, che espulso dal cielo, cadde «volteando» fino agli abissi dell’inferno.
Il tipo mentale dell’humanista ritratto dal Cervantes si è conservato finora e così si son conservate nel popolo le «curiosità» di Sancio, e ciò spesso appunto viene chiamato «scienza». Questo tipo mentale, in confronto a quelli tormentati, per esempio, dal problema del moto perpetuo, è poco conosciuto e troppo poco messo in ridicolo, perché in certe regioni è un vero flagello. Al carcere di Palermo, nel dicembre 1926, ho visto una dozzina di volumi, scritti da siciliani, e stampati in Sicilia stessa, ma alcuni in America da emigrati (certo inviati in omaggio al carcere o al cappellano). Il più tipico di essi era un volume di certo Santi Sparacio, impiegato della ditta Florio, il quale appariva autore anche di altre pubblicazioni. Non ricordo il titolo principale del libro; ma nei sottotitoli si affermava che si voleva dimostrare: I l’esistenza di Dio, II la divinità di Gesù Cristo, III l’immortalità dell’anima. Nessuna di queste quistioni era realmente trattata, ma invece nelle circa 300 pagine del volume, si contenevano le quistioni più disparate su tutto lo scibile: per esempio si trattava come fare per impedire la masturbazione nei ragazzi, come evitare gli scontri tranviari, come evitare che nelle case si rompano tanti vetri alle finestre ecc. Questo della «rottura dei vetri» era trattato così: si rompono tanti vetri, perché si pongono le sedie con lo schienale troppo vicino ai vetri, e, sedendosi, per il peso lo schienale si abbassa e il vetro è rotto. Quindi bisogna curare, ecc.; ciò per pagine e pagine. Dal tono del libro si capiva che lo Sparacio nel suo ambiente era ritenuto un gran saggio e sapiente e che molti ricorrevano a lui per consigli ecc.
Q9 §19 Machiavelli. Politica ed arte militare. Lo scrittore militare italiano (generale) De Cristoforis nel suo libro Che cosa sia la guerra dice che per «distruzione dell’esercito nemico» (fine strategico) non si intende «la morte dei soldati, ma lo scioglimento del loro legame come massa organica». La formula mi pare felice anche per la terminologia politica. In politica il legame organico è dato dalla economia, cioè dai rapporti di proprietà e di organizzazione giuridica che su quei rapporti di proprietà si fondano (partiti, sindacati, ecc.).
Q9 §20 I nipotini di padre Bresciani. G. Prezzolini. Cfr articolo di Giuseppe Prezzolini, Monti, Pellico, Manzoni, Foscolo veduti da viaggiatori americani, in «Pègaso» del maggio 1932. Prezzolini riporta un brano del critico d’arte americano H. Y. Tuckermann (The Italian Sketch‑Book, 1848, p. 123): «Alcuni dei giovani elementi liberali, in Italia, si dimostrano assai disillusi perché uno, il quale stava per diventare un martire della loro causa, si sia voltato invece alla devozione, e si mostrano spiacenti che egli abbia ad impiegar la sua penna per scrivere inni cattolici e odi religiose». Così commenta il Prezzolini: «Il dispetto che i più accesi provavano per non aver trovato in Pellico uno strumento di piccola polemica politica, è dipinto in queste osservazioni». Perché si dovesse trattare di volgare «dispetto» e perché, prima del 48, la polemica contro le persecuzioni austriache e clericali fosse «piccola» è appunto un mistero della mentalità brescianesca.
Q9 §21 Machiavelli. Storia della burocrazia. Il fatto che nello svolgimento storico e delle forme economiche e politiche si sia venuto formando il tipo del funzionario tecnico ha una importanza primordiale. È stata una necessità o una degenerazione, come sostengono i liberisti? Ogni forma di società ha avuto il suo problema dei funzionari, il suo modo di impostare e risolvere il problema, un suo sistema di selezione, un suo «tipo» di funzionario da educare. Ricercare lo svolgimento di tutti questi elementi è di importanza capitale. In parte questo problema coincide col problema degli intellettuali. Ogni rapporto nuovo di proprietà ha avuto bisogno di un nuovo tipo di funzionario, cioè ogni nuova classe dirigente ha impostato in modo nuovo il proprio problema dei funzionari, ma non ha potuto prescindere, per un certo tempo, dalla tradizione e dagli interessi costituiti, cioè dai gruppi di funzionari già precostituiti al suo avvento.
Unità del lavoro manuale e intellettuale come motivo per un indirizzo nuovo nella risoluzione del problema degli intellettuali e dei funzionari.
Q9 §22 Passato e presente. Dal discorso del ministro della guerra Gazzera tenuto in Senato il 19 maggio 1932 (Cfr «Corriere della Sera» del 20 maggio): «Il regime di disciplina del nostro Esercito per virtù del Fascismo appare oggi una norma direttiva che ha valore per tutta la Nazione. Altri Eserciti hanno avuto e tuttora conservano una disciplina formale e rigida. Noi teniamo sempre presente il principio che l’Esercito è fatto per la guerra e che a quella deve prepararsi; la disciplina di pace dev’essere quindi la stessa del tempo di guerra, che nel tempo di pace deve trovare il suo fondamento spirituale. La nostra disciplina si basa su uno spirito di coesione tra i capi e i gregari che è frutto spontaneo del sistema seguito. Questo sistema ha resistito magnificamente durante una lunga e durissima guerra fino alla vittoria; è merito del Regime fascista di aver esteso a tutto il popolo italiano una tradizione disciplinare così insigne. Dalla disciplina dei singoli dipende l’esito della concezione strategica e delle operazioni tattiche. La guerra ha insegnato molte cose, e anche che vi è un distacco profondo tra la preparazione di pace e la realtà della guerra. Certo è che, qualunque sia la preparazione, le operazioni iniziali della campagna pongono i belligeranti innanzi a problemi nuovi che danno luogo a sorprese da una parte e dall’altra. Non bisogna trarne però la conseguenza che non sia utile avere una concezione a priori e che nessun insegnamento possa derivarsi dalla guerra passata. Se ne può ricavare una dottrina di guerra che dev’essere intesa con disciplina intellettuale e come mezzo per promuovere modi di ragionamento non discordi e uniformità di linguaggio tale da permettere a tutti di comprendere e di farsi comprendere. Se, talvolta, l’unità di dottrina ha minacciato di degenerare in schematismo, si è subito reagito prontamente, imprimendo alla tattica, anche per i progressi della tecnica, una rapida rinnovazione. Tale regolamentazione quindi non è statica, non è tradizionale, come taluno crede. La tradizione è considerata solo come forza e i regolamenti sono sempre in corso di revisione non per desiderio di cambiamento, ma per poterli adeguare alla realtà».
Q9 §23 Argomenti di coltura. Individualismo e individualità (coscienza della responsabilità individuale) o personalità. È da vedere quanto ci sia di giusto nella tendenza contro l’individualismo e quanto di erroneo e pericoloso. Atteggiamento contraddittorio necessariamente. Due aspetti, negativo e positivo, dell’individualismo. Quistione quindi da porre storicamente e non astrattamente, schematicamente. Riforma e controriforma. La quistione si pone diversamente nei paesi che hanno avuto la riforma o che sono stati paralizzati dalla controriforma. L’uomo‑collettivo o conformismo imposto e l’uomo‑collettivo o conformismo proposto (ma si può chiamare più conformismo allora?) Coscienza critica non può nascere senza una rottura del conformismo cattolico o autoritario e quindi senza un fiorire della individualità: il rapporto tra l’uomo e la realtà deve essere diretto o attraverso una casta sacerdotale (come il rapporto tra uomo e dio nel cattolicismo? che è poi una metafora del rapporto tra l’uomo e la realtà)? Lotta contro l’individualismo è contro un determinato individualismo, con un determinato contenuto sociale, e precisamente contro l’individualismo economico in un periodo in cui esso è diventato anacronistico e antistorico (non dimenticare però che esso è stato necessario storicamente e fu una fase dello svolgimento progressivo). Che si lotti per distruggere un conformismo autoritario, divenuto retrivo e ingombrante, e attraverso una fase di sviluppo di individualità e personalità critica si giunga all’uomo‑collettivo è una concezione dialettica difficile da comprendere per le mentalità schematiche e astratte. Come è difficile da comprendere che si sostenga che attraverso la distruzione di una macchina statale si giunga a crearne un’altra più forte e complessa ecc.
Q9 §24 Passato e presente. Aneddoto contenuto nell’Olanda di De Amicis. Un generale spagnolo mostra a un contadino olandese un arancio: «Questi frutti il mio paese li produce due volte all’anno». Il contadino mostra al generale un pane di burro: «E il mio paese produce due volte al giorno questi altri frutti».
Q9 §25 Argomenti di coltura. Il Machiavellismo di Stenterello. Stenterello è molto più furbo di Machiavelli. Quando Stenterello aderisce a una iniziativa politica, vuol far sapere a tutti di essere molto furbo e che a lui nessuno gliela fa, neanche se stesso. Egli aderisce all’iniziativa, perché è furbo, ma è ancor più furbo perché sa di esserlo e vuol farlo sapere a tutti. Perciò egli spiegherà a tutti che cosa significa «esattamente» l’iniziativa alla quale ha aderito: si tratta, manco a dirlo, di una macchina ben montata, ben congegnata e la sua maggiore astuzia consiste nel fatto che è stata preparata nella persuasione che tutti siano degli imbecilli e si lasceranno intrappolare. Appunto: Stenterello vuol far sapere che non è che lui si lasci intrappolare, lui così furbo; l’accetta perché intrappolerà gli altri, non lui. E siccome fra gli altri qualche furbo c’è, Stenterello a questo ammicca e spiega, e analizza: «Sono dei vostri, veh!, noi ci intendiamo. Badate di non credere che io creda… Si tratta di una “machiavellica”, siamo intesi?» E Stenterello così passa per essere il più furbo dei furbi, il più intelligente degli intelligenti, l’erede diretto, e senza cautela d’inventario, della tradizione di Machiavelli.
Altro aspetto della quistione: quando si fa la proposta di una iniziativa politica, Stenterello non si cura di vedere l’importanza della proposta, per accettarla e lavorare a divulgarla, difenderla, sostenerla. Stenterello crede che la sua missione è quella di essere la Vestale del sacro fuoco. Riconosce che l’iniziativa non è contro le sacre tavole e così crede di aver esaurito la sua parte. Egli sa che siamo circondati di traditori, di deviatori, e sta col fucile spianato per difendere l’altare e il focolare. Applaude e spara e così ha fatto la storia bevendoci sopra un mezzo litro.
(Intorno a questa rubrica, in forma di bozzetti su Stenterello politico, si possono raggruppare altri motivi, come quello della svalutazione dell’avversario fatta per politica, ma che diventa una convinzione e quindi porta alla superficialità e alla sconfitta ecc.).
Q9 §26 Passato e presente. Economismo, sindacalismo, svalutazione di ogni movimento culturale ecc. Ricordare polemica, prima del 1914, tra Tasca e Amadeo, con riflesso nell’«Unità» di Firenze. Si dice spesso che l’estremismo «economista» era giustificato dall’opportunismo culturalista (e ciò si dice per tutta l’area di conflitto), ma non si potrebbe anche dire il viceversa, che l’opportunismo culturalista era giustificato dall’estremismo economicistico? In realtà né l’uno né l’altro erano «giustificabili» e sono mai da giustificare. Saranno da «spiegare» realisticamente come i due aspetti della stessa immaturità e dello stesso primitivismo.
Q9 §27 Argomenti di cultura. Il Machiavellismo di Stenterello. Stenterello pensa specialmente all’avvenire. Il presente lo preoccupa meno dell’avvenire. Ha un nemico contro cui dovrebbe combattere. Ma perché combattere, se tanto il nemico dovrà necessariamente sparire, travolto dalla fatalità della storia. C’è ben altro da fare che combattere il nemico immediato. Più pericolosi sono i nemici mediati, quelli che insidiano l’eredità di Stenterello, quelli che combattono lo stesso nemico di Stenterello, pretendendo che saranno loro gli credi. Che pretese son queste? Come si osa dubitare che Stenterello sarà l’erede? Dunque Stenterello non combatte il nemico immediato, ma coloro che pretendono di combattere questo stesso nemico per succedergli. Stenterello è così furbo che solo lui comprende che questi sono i veri e soli nemici. La sa lunga, Stenterello!
Q9 §28 Lorianismo. Il signor Nettuno. All’inizio di questa serie di sul lorianismo potrà essere citata la novella raccontata dal barbiere nei primi capitoli della seconda parte del Don Chisciotte. Il pazzo che ricorre al vescovo per essere liberato dal manicomio, sostenendo, in una lettera assennatissima, di essere savio e quindi tenuto arbitrariamente segregato dal mondo. L’arcivescovo che invia un suo fiduciario, che si convince di aver da fare realmente con un sano di mente, finché, nel congedarsi del presunto savio dai suoi amici del manicomio, non avviene la catastrofe. Un pazzo, che dice di essere Giove, minaccia che se l’amico se ne andrà, egli non farà più piovere sulla terra, e l’amico, temendo che l’inviato del vescovo non si spaurisca, dice: Non si spaventi, perché se il signor Giove non farà più piovere, io che sono Nettuno, troverò ben modo di rimediare. Ebbene, queste appunto riguardano scrittori che in uno o in molti istanti della loro attività scientifica, hanno dimostrato di essere il «signor Nettuno».
Q9 §29 Azione Cattolica. Francia. Nei volumi che raccolgono gli atti delle varie sessioni delle Settimane Sociali, venne pubblicato l’indice alfabetico ed analitico delle ma terie trattate in tutte le Settimane Sociali precedenti. La XXIII sessione, del 1931, tenuta a Mulhouse, ha trattato de La Morale Chrétienne et les Affaires (Lyon, J. Gabalda, 1931, in 8°, pp. 610, fr. 30). In questo volume non ci sono gli indici suddetti, che sono pubblicati a parte.
Q9 §30 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. Il 6 aprile 1932 è stata iscritta nell’Indice l’opera di Felix Sartiaux, Joseph Turmel, prêtre, historien des dogmes. Parigi, Ed. Rieder. È una difesa del Turmel dopo gli ultimi mirabolanti casi capitati a questo esemplare eccezionale del mondo clericale francese.
Q9 §31 Azione Cattolica. Lotta intorno alla filosofia neoscolastica. Polemiche recenti di cattolici come Gorgerino e Siro Contri (sono la stessa persona?) contro padre Gemelli. Il Gemelli ha scritto nel 1932 Il mio contributo alla filosofia neoscolastica, Milano, Vita e Pensiero, in 8°, pp. 106, L. 5. Siro Contri scrive che la filosofia dell’Università Cattolica deve chiamarsi ormai «Archeoscolastica», perché pare che dopo i tentativi di conciliare col tomismo prima il positivismo e poi l’idealismo, per aggiornare il pensiero cattolico alle esigenze della vita moderna, il Gemelli (aiutato dai gesuiti, che nella «Civiltà Cattolica» l’hanno difeso contro gli attacchi del Gorgerino) voglia ritornare al «tomismo» puro delle origini. È da vedere se questa «conversione» del Gemelli non sia connessa al Concordato, e alla posizione eccezionale di monopolio che i cattolici, date le loro possibilità di concentrazione delle forze intellettuali, possono conquistare in Italia nel mondo dell’alta cultura ufficiale e scolastica. Per ciò è certo necessario tagliare ogni legame e rinunziare a ogni forma di combinazione con filosofie acattoliche (come invece era necessario prima fare) e presentarsi come filosofia intransigente ed esclusivista. Dalle pubblicazioni del Contri appare che il Gemelli nel cuor suo si infischia santamente di ogni filosofia: per lui la filosofia è una «balla». I suoi interessi sono puramente pratici, di conquista del mercato culturale da parte del cattolicismo e la sua attività è rivolta ad assicurare al Vaticano quel potere indiretto sulla Società e sullo Stato che è l’essenziale fine strategico dei gesuiti e fu teorizzato dall’attuale loro santo Roberto Bellarmino.
(Il Contri ha iniziato o sta per iniziare la pubblicazione di una nuova rivista «Criterion» di «vera» neo‑scolastica, e ha pubblicato una Piccola Enciclopedia filosofica. Editore Galleri, Bologna, 12 l.).
Q9 §32 Economia nazionale. Tutta l’attività economica di un paese può essere giudicata solo in rapporto al mercato internazionale, «esiste» ed è da valutarsi in quanto è inserita in una unità internazionale. Da ciò l’importanza del principio dei costi comparati e la saldezza che mantengono i teoremi fondamentali dell’economia classica di contro alle critiche verbalistiche dei teorici di ogni nuova forma di mercantilismo (protezionismo, economia diretta, corporativismo ecc.). Non esiste un «bilancio» puramente nazionale dell’economia, né per il suo complesso, e neppure per una attività particolare. Tutto il complesso economico nazionale si proietta nell’eccedente che viene esportato in cambio di una corrispondente importazione, e se nel complesso economico nazionale una qualsiasi merce o servizio costa troppo, è prodotta in modo antieconomico, questa perdita si riflette nell’eccedente esportato, diventa un «regalo» che il paese fa all’estero, o per lo meno (giacché non sempre può parlarsi di «regalo») una perdita secca del paese, nei confronti con l’estero, nella valutazione della sua statura relativa e assoluta nel mondo economico internazionale.
Se il grano in un paese è prodotto a caro prezzo, le merci industriali esportate e prodotte da lavoratori nutriti con quel grano, a prezzo uguale con l’equivalente merce estera, contengono congelata una maggior quantità di lavoro nazionale, una maggior quantità di sacrifizi di quanto contenga la stessa merce estera. Si lavora per l’«estero» a sacrifizio; i sacrifizi sono fatti per l’estero, non per il proprio paese. Le classi che all’interno si giovano esse di tali sacrifizi, non sono la «nazione» ma rappresentano uno sfruttamentoesercitato da «stranieri» sulle forze realmente nazionali ecc.
Q9 §33 Passato e presente. Élite e decimo sommerso. È da porsi la domanda se in qualsivoglia società sia possibile la costituzione di una élite, senza che in essa confluiscano una gran quantità di elementi appartenenti al «decimo sommerso» sociale. Ma la domanda diviene necessaria se la élite si costituisce sul terreno di una dottrina che può essere interpretata fatalisticamente: allora affluiscono credendo di poter giustificare idealmente la loro povertà d’iniziativa, la loro deficiente volontà, la loro mancanza di paziente perseveranza e concentrazione degli sforzi, tutti i falliti, i mediocri, gli sconfitti, i malcontenti che la manna non piova dal cielo e le siepi non producano salsicce, che anche essi sono una forma di «decimo sommerso» delle società in cui la lotta per l’esistenza è accanita e nei paesi poveri, in cui ci si può fare un posto al sole solo dopo lotte accanite. Così si può avere una élite alla rovescia, una avanguardia di invalidi, una testa‑coda.
Q9 §34 Giornalismo. Riviste tipo. Per essere veramente accessibile alla cultura media del lettore medio, ogni fascicolo di rivista dovrebbe avere due appendici: 1) una rubrica in cui tutti i nomi e le parole straniere che possono essere state usate nei vari articoli dovrebbero essere rappresentate in una trascrizione fonetica, la più esatta possibile, della lingua italiana. Quindi la necessità di costruire, con criteri pratici e unitari quali la struttura dell’italiano scritto permette, una tabella di traducibilità dei fonemi stranieri in fonemi italiani; 2) una rubrica in cui sia dato il significato delle parole specializzate nei vari linguaggi (filosofico, politico, scientifico, religioso ecc.) o specializzate nell’uso di un determinato scrittore.
L’importanza di questi sussidi tecnici non viene di solito valutata perché non si riflette alla remora che costituiscono nel ricordare e specialmente nell’esprimere le proprie opinioni l’ignoranza del come si pronunziano certi nomi e del significato di certi termini. Quando il lettore si incontra in troppi «Carneade» di pronunzia o di significato, si arresta, si sfiducia delle proprie forze e attitudini e non si riesce a farlo uscire da uno stato di passività intellettuale in cui impaluda la sua intelligenza.
Q9 §35 Passato e presente. Nel «Corriere della Sera» del 1° giugno sono riassunte dalla pubblicazione ufficiale le nuove norme per l’impiego delle truppe regolari in servizio di P. S. Alcune disposizioni innovatrici sono di grande importanza, come quella per cui l’autorità militare può decidere il suo intervento di propria iniziativa, senza essere chiamata dall’autorità politica. Così l’altra disposizione per cui la truppa interviene solo con le armi cariche, per agire, e, come pare, non può perciò essere impiegata alla formazione di cordoni ecc.
Q9 §36 Passato e presente. Sull’apoliticismo del popolo italiano. Tra gli altri elementi che mostrano manifestamente questo apoliticismo sono da ricordare i tenaci residui di campanilismo e altre tendenze che di solito sono catalogate come manifestazioni di un così detto «spirito rissoso e fazioso» (lotte locali per impedire che le ragazze facciano all’amore con giovanotti «forestieri» cioè anche di paesi vicini ecc.). Quando si dice che questo primitivismo è stato superato dai progressi della civiltà, occorrerebbe precisare che ciò è avvenuto per il diffondersi di una certa vita politica di partito che allargava gli interessi intellettuali e morali del popolo. Venuta a mancare questa vita, i campanilismi sono rinati, per esempio attraverso lo sport e le gare sportive, in forme spesso selvagge e sanguinose. Accanto al «tifo» sportivo, c’è il «tifo campanilistico» sportivo.
Q9 §37 Letteratura popolare. P. Ginisty, Eugène Sue (Grandes vies aventureuses), Parigi, Berger‑Levrault, 1932, in 16°, pp. 228, 10 franchi.
Q9 §38 Funzione cosmopolita degli intellettuali italiani. Sull’Algarotti. Dall’articolo “Nicolino” e l’Algarotti di Carlo Calcaterra, nel «Marzocco» del 29 maggio 1932: «Impedisce tuttora nell’animo di molti un’equa valutazione degli scritti d’arte dell’Algarotti la considerazione che egli fu il consigliere e il provveditore di Augusto III di Sassonia negli acquisti per la galleria di Dresda, onde si rimprovera a lui di avere impoverito l’Italia a beneficio di corti straniere. Ma giustamente è stato detto dal Panzacchi e da altri studiosi che nel cosmopolitismo settecentesco quell’opera di diffusione dell’arte italiana, come di bellezza appartenente a tutta Europa, ha un aspetto meno odioso di quello che con tutta facilità può esserle oggi attribuito».
L’osservazione del cosmopolitismo settecentesco, che è esatta, va approfondita e specificata: il cosmopolitismo degli intellettuali italiani è esattamente della stessa natura del cosmopolitismo degli altri intellettuali nazionali? Questo è il punto: per gli italiani è in funzione di una particolare posizione che viene attribuita all’Italia a differenza degli altri paesi, cioè l’Italia è concepita come complementare di tutti gli altri paesi, come produttrice di bellezza e di coltura per tutta Europa.
Q9 §39 Argomenti di coltura. Elementi di vita politica francese. I monarchici hanno costruito la dottrina storico-politica (che cercano di rendere popolare) secondo la quale l’Impero e la Repubblica hanno significato finora l’invasione del territorio nazionale francese. Due invasioni connesse con la politica di Napoleone I (del 1814 e del 1815), una con la politica di Napoleone III (1870‑71) e una con quella della Terza Repubblica (1914) danno il materiale d’agitazione. I repubblicani si servono anch’essi degli stessi materiali, ma naturalmente il loro punto di vista non è quello dei monarchici, che può sembrare persino disfattista, in quanto pone le cause dell’invasione nelle istituzioni francesi e non invece, come i repubblicani sostengono, nei nemici ereditari della Francia, in prima linea la Prussia (più che la Germania; e questa distinzione ha importanza perché dipende dalla politica francese tendente a isolare la Prussia e a fare alleati della Francia la Baviera e i tedeschi meridionali, compresi gli austriaci). Questo modo di porre la quistione dinanzi alle masse popolari da parte di tutte le varie tendenze del nazionalismo è tutt’altro che privo di efficacia. Ma è storicamente esatto? Quante volte la Germania è stata invasa dai francesi? (Bisognerebbe contare tra le invasioni francesi anche l’occupazione della Ruhr del 1923). E quante volte l’Italia è stata invasa dai francesi? E quante volte la Francia è stata invasa dagli inglesi ecc.? (Le invasioni inglesi: la lotta della nazione francese per espellere l’invasore e liberare il territorio ha formato la nazione francese prima della Rivoluzione; è scontata dal punto di vista del patriottismo e del nazionalismo, sebbene il motivo antinglese, a cause delle guerre della rivoluzione e di Napoleone, si sia trascinato, specialmente nella letteratura per i giovani – Verne ecc. – fin nell’epoca della Terza Repubblica e non sia completamente morto). Ma dopo il 1870 il mito nazionalistico del pericolo prussiano ha assorbito tutta o quasi l’attenzione dei propagandisti di destra e ha creato l’atmosfera di politica estera che soffoca la Francia.
Q9 §40 Machiavelli. Rapporti di forza ecc. Nello studio del terzo grado o momento del sistema dei rapporti di forza esistenti in una determinata situazione, si può ricorrere al concetto che nella scienza militare è chiamato della «congiuntura strategica» ossia, con più precisione, del grado di preparazione strategica del teatro della lotta, uno dei cui elementi principali è dato dalle condizioni qualitative del personale dirigente e delle forze attive che si possono chiamare di prima linea (comprese in esse quelle d’assalto). Il grado di preparazione strategica può date la vittoria a forze «apparentemente» inferiori a quelle avversarie. (Si può dire che questa preparazione tende a ridurre a zero i così detti «imponderabili», cioè le reazioni immediate, in un momento dato, delle forze tradizionalmente passive o semipassive). (Tra gli elementi di questa preparazione strategica sono da porre quelli considerati nelle osservazioni fatte su un «ceto militare» che fiancheggia l’organismo tecnico dell’esercito, la cui preparazione è curata da tutti i paesi: ufficiali in congedo, associazioni di corpi militari in congedo, che mantengono lo spirito di corpo anche dopo la fine del servizio militare attivo ecc.).
Altro elemento da aggiungere al paragrafo sull’economismo è questo: come esemplificazione della così detta intransigenza, l’avversione rigida di principio al compromesso con la sua manifestazione subordinata della «paura dei pericoli». L’avversione al compromesso è strettamente legata all’economismo, in quanto la concezione su cui si basa questa avversione non può essere che un fatale verificarsi di certe situazioni favorevoli senza bisogno di «prepararle» con iniziative volontarie e predisposte secondo un piano; c’è inoltre l’elemento di affidarsi ciecamente e scriteriatamente alla virtù delle armi. Non si tiene conto del fattore tempo e non si tiene conto, in ultima analisi, della stessa «economia» nel senso che non si capisce come in certi momenti la spinta dovuta al fattore economico è rallentata o impastoiata da un elemento ideologico tradizionale, che c’è una lotta, nell’interno di certi blocchi sociali economico‑politici, tra le esigenze della posizione economica di massa e la fortuna politica dei dirigenti tradizionali, e che una iniziativa politica appropriata da parte di una forza estranea al blocco è «necessaria» per liberare la spinta economica dalla pastoia politica e mutare la direzione tradizionale con una nuova direzione conforme al contenuto economico sviluppatosi in una fase più progressiva ecc. Due forze «simili» non possono fondersi in organismo nuovo che attraverso una serie di compromessi, oppure con la forza delle armi; alleandosi su un piano di eguaglianza o subordinando una forza all’altra con la coercizione. Se l’unità delle due forze è necessaria per vincere una terza forza, evidentemente il ricorso alla coercizione (dato che se ne abbia la disponibilità) è una pura ipotesi metodologica e l’unica possibilità concreta è un compromesso.
Q9 §41 Nozioni enciclopediche. «Paritario». Il siginficato di paritario è dei più interessanti e curiosi. Paritario significa che 1 000 000 ha gli stessi diritti di 10 000 ecc., talvolta che 1 ha gli stessi diritti di 50 000. Cosa significa paritario nelle officine Schneider del Creusot? Cosa significa nel Consiglio nazionale per l’industria delle miniere di carbone, esistente in Inghilterra? Cosa significa nel Consiglio direttivo dell’U.I.L. di Ginevra? ecc.
Q9 §42 I nipotini di padre Bresciani. Per quali forme di attività hanno «simpatia» i letterati italiani? Perché l’attività economica, il lavoro come produzione individuale e di gruppo non li interessa? Se nei libri si tratta di argomento economico, è il momento della «direzione», del «dominio», del «comando», di un «eroe» sui produttori che li interessa. Oppure li interessa la generica produzione, il generico lavoro in quanto elemento di vita e di potenza nazionale, in quanto elemento per tirate retoriche. La vita del contadino occupa un maggior spazio, ma anche qui non come lavoro, ma del contadino come «folclore», come pittoresco rappresentante di sentimenti e costumi curiosi e bizzarri. Perciò la «donna» ha molto spazio, coi problemi sessuali nel loro aspetto più esteriore e romantico. Il «lavoro» dell’impiegato è fonte di comicità. Il lavoro dell’intellettuale poco spazio oppure presentato nella sua espressione di «dominio», di retorica.
Non si può certo imporre a una o a molte generazioni di scrittori di aver «simpatia» per uno o altro aspetto della vita, ma che una o molte generazioni di scrittori abbiano certe simpatie e non altre ha pure un significato, indica un certo indirizzo piuttosto che altri nell’interesse degli intellettuali. Anche il verismo italiano (eccetto, in parte, il Verga) si distingue dalle correnti realistiche degli altri paesi in quanto si limita alla «bestialità» della «natura umana» (al «verismo» inteso in senso gretto) e non offre apprezzabili rappresentazioni del lavoro e della fatica. Ha qualche merito culturale come parziale reazione alle sdolcinatezze e ai languori romantici di maniera tradizionali, ma crea subito un suo cliché altrettanto manierato. Ma non basta che gli scrittori non ritengano degna di «cronaca e di storia» un’attività che pure assorbe i 9/10, per quasi tutta la vita, della nazione; se se ne occupano, il loro atteggiamento è quello del padre Bresciani ecc. (Vedere gli scritti di L. Russo sul Verga e sull’Abba).
G. C. Abba può essere citato come esempio italiano di scrittore «popolare‑nazionale», pur non essendo «popolaresco» o non appartenendo a nessuna corrente che critichi per ragioni di «partito» o settarie la posizione della classe dirigente. Possono analizzarsi non solo gli scritti dell’Abba che hanno un valore poetico e artistico, ma altri libri come quello rivolto ai soldati, che pure fu premiato da enti govemativi e militari e fu per qualche tempo diffuso tra le truppe. In questa direzione può citarsi lo studio del Papini pubblicato in «Lacerba» dopo gli avvenimenti del giugno 1914. La posizione di Alfredo Oriani è anche da rilevare, ma essa è astratta e retorica e annegata nel suo «titanismo» di genio incompreso.
È da rilevare qualcosa negli scritti di Piero Jahier (ricordare le simpatie dello Jahier per il Proudhon), anche di carattere militare (in questo lo Jahier si può collegare coll’Abba), deturpata dallo stile biblico e claudelliano dello scrittore, che lo rende meno efficace e indisponente, perché maschera una forma snobistica di retorica. (Tutta la letteratura di Strapaese dovrebbe essere «nazionale‑popolare» come programma, ma appunto lo è per programma ed è una manifestazione deteriore della cultura; il Longanesi deve aver scritto anche un libriccino per le reclute, ciò che dimostrerebbe come la tendenza nasca anche da preoccupazioni militari).
La preoccupazione nazionale‑popolare nell’impostazione del problema critico‑estetico appare in Luigi Russo (del quale è da vedere il volumetto su i Narratori) come risultato di un ritorno all’esperienza del De Sanctis dopo il punto di arrivo del crocianesimo.
Osservare che il Brescianesimo è in fondo «individualismo» antistatale e antinazionale anche quando e quantunque si veli di un nazionalismo e statalismo frenetico. «Stato» significa specialmente direzione consapevole delle grandi moltitudini nazionali, quindi necessario «contatto» sentimentale e ideologico con esse e in certa misura «simpatia» e comprensione dei loro bisogni ed esigenze. Infatti l’assenza di una letteratura popolare‑nazionale, dovuta all’assenza di preoccupazioni per questi bisogni ed esigenze, ha lasciato il «mercato» letterario aperto alle influenze dei gruppi intellettuali di altri paesi, che, «popolari‑nazionali» in patria, lo diventavano all’estero perché le esigenze e i bisogni erano simili. Così il popolo italiano si è appassionato attraverso il romanzo storico‑popolare francese, alle tradizioni francesi, monarchiche e rivoluzionarie francesi e conosce gli amori di Enrico IV, la Rivoluzione dell’89, le invettive vittorughiane contro Napoleone III, si appassiona per un passato non suo, si serve nel suo linguaggio e nel suo pensiero di metafore e di riferimenti francesi ecc., è culturalmente più francese che italiano.
Per l’indirizzo nazionale‑popolare dato dal De Sanctis alla cultura italiana è da vedere anche il libro del Russo (F. De Sanctis e la cultura napoletana, 1860‑1885, La Nuova Italia editrice, 1928) e il saggio del De Sanctis La Scienza e la Vita: mi pare che il De Sanctis abbia fortemente sentito il contrasto Riforma‑Rinascimento, cioè appunto il contrasto tra Vita e Scienza che era nella tradizione italiana come una debolezza della struttura nazionale‑statale e abbia cercato di reagire contro di esso. Quindi il fatto che ad un certo punto lo porta a staccarsi dall’idealismo speculativo e ad avvicinarsi al positivismo e al verismo in letteratura (simpatie per Zola, come il Russo per il Verga e per S. Di Giacomo), e come pare osservi il Russo nel suo libro (Cfr Marzot, nella «Nuova Italia» del maggio 1932), «il segreto dell’efficacia di De Sanctis è tutto da cercare nella sua spiritualità democratica, la quale lo fa sospettoso e nemico di ogni movimento o pensiero che assuma carattere assolutistico e privilegiato …; e nella tendenza e nel bisogno di concepire lo studio come momento di un’attività più vasta, sia spirituale che pratica, racchiusa nella formula di un suo famoso discorso La Scienza e la Vita».
Antidemocrazia negli scrittori brescianeschi non ha altro significato che di opposizione al movimento popolare‑nazionale, cioè è spirito «economico‑corporativo», «privilegiato», di casta e non di classe, di carattere politico‑medioevale e non moderno.
Q9 §43 I nipotini di padre Bresciani. Libri di guerra. Quali riflessi ha avuto la tendenza «brescianistica» nella letteratura di guerra? La guerra ha costretto i diversi strati sociali ad avvicinarsi, a conoscersi, ad apprezzarsi nella sofferenza comune. I letterati cosa hanno imparato dalla guerra? E in generale cosa hanno imparato dalla guerra quei ceti da cui sorgono normalmente i più numerosi intellettuali e scrittori? Due linee di ricerca. La prima, quella riguardante la classe sociale generale, può seguire il materiale già scelto dal professor Adolfo Omodeo nella pubblicazione Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti che esce a puntate nella «Critica» già da parecchio tempo. La raccolta dell’Omodeo presenta un materiale già selezionato, nel senso nazionale‑popolare, poiché l’Omodeo si propone di dimostrare come già nel 1915 una coscienza nazionale‑popolare si fosse già formata e nella guerra abbia avuto l’occasione di manifestarsi e non già l’origine palingenetica. Che l’Omodeo riesca a dimostrare il suo assunto è altra quistione: intanto l’Omodeo ha una sua concezione di ciò che è coscienza nazionale‑popolare, le cui origini culturali sono facili da rintracciare; egli è un epigone della tradizione liberale moderata, e il paternalismo democratico o popolaresco si confonde spesso in lui con quella particolare forma di coscienza nazionale‑popolare che è più moderna e meno borbonizzante.
La letteratura di guerra propriamente detta, cioè dovuta a scrittori «professionali» ha avuto varia fortuna in Italia. Subito dopo la guerra è stata scarsa, e ha cercato la sua fonte di ispirazione nel Feu di Barbusse. C’è stata una seconda ondata, prodottasi dopo il successo internazionale del libro di Remarque e con il proposito internazionale di opporsi alla mentalità della letteratura pacifista tipo Remarque. Questa letteratura è in genere mediocre, in tutti i sensi, come arte e come «cultura», cioè come creazione pratica di «masse di sentimenti» da far trionfare nel popolo. Molta di questa letteratura rientra perfettamente nel «Brescianesimo». Esempio tipico il libro di C. Malaparte La rivolta dei santi maledetti che è stato presentato nella prima edizione come barbussiano ed è diventato brescianesco in una seconda edizione.
È da vedere l’apporto dato a questa letteratura dal gruppo di scrittori che sogliono essere chiamati «vociani» e che già prima del 1914 lavoravano per creare una coscienza nazionale‑popolare moderna: credo che da questo gruppo siano stati dati i libri migliori, per esempio il diario di Giani Stuparich. Il libro di Ardengo Soffici, sebbene il Soffici, esteriormente «vociano», ha una sua retorica repugnante. Una rassegna di questa letteratura di guerra sotto la rubrica del Brescianesimo sarebbe molto interessante.
Q9 §44 Argomenti di coltura. Discussioni, spaccare il pelo in quattro ecc. Atteggiamento da intellettuali è quello di prendere a noia le discussioni troppo lunghe e sottili, che si sbriciolano analiticamente nei minuti particolari e mostrano di non voler finire se non quando tra i dissertanti si sia venuti a un accordo perfetto su tutto il piano di attrito o per lo meno le opinioni in contrasto si siano affrontate totalmente. L’intellettuale crede sufficiente un accordo sommario, sui principii generali, sulle linee direttrici fondamentali e presuppone che il lavorio individuale di riflessione porterà necessariamente all’accordo sulle «minuzie». Perciò nelle discussioni tra intellettuali si procede spesso per accenni rapidi: si tasta, per così dire, la formazione culturale reciproca, il «linguaggio» reciproco, e fatta la scoperta che ci si trova su un terreno comune, con un linguaggio comune, con modi di ragionamento comuni, si procede oltre rapidamente. La quistione appunto è che le discussioni non avvengono sempre tra intellettuali professionali, ma anzi un terreno comune culturale, un linguaggio comune, modi di ragionamento comuni occorre creare tra non intellettuali, che non hanno acquistato l’abito professionale e la disciplina intellettuale necessari per la rapida connessione di concetti apparentemente disparati, come viceversa per la rapida analisi, scomposizione, scoperta delle differenze essenziali tra concetti apparentemente simili.
Spesso in questa rubrica si è accennato alla formazione «parlata» della cultura, e ai suoi inconvenienti per rispetto allo scritto. Osservazioni giuste ma che occorre integrare con queste fatte ora, cioè con la necessità, per diffondere organicamente una forma culturale, della parola parlata e della discussione minuziosa e «pedantesca». (Questo si osserva nei rapporti tra intellettuali professionali e non intellettuali, che poi è il caso tipico in ogni grado di scuola, dalle elementari all’Università). Il non tecnico del lavoro intellettuale, nel suo lavoro «individuale», coi libri, intoppa in una difficoltà, che lo arresta, perché non ne può avere subito la soluzione, che invece è possibile avere nelle discussioni a voce immediatamente. Perciò deve esserci un giusto contemperamento del lavoro individuale (scritto e con lo scritto) e del lavoro «orale», di discussione ecc.
Q9 §45 Passato e presente. La politica del meno peggio. Ma «peggio non è mai morto» dice un proverbio popolare, e ci sarà un «meno peggio» all’infinito, poiché il peggio di domani sarà «meno peggio» del «peggio» di dopodomani e così via.
Q9 §46 Ricciotti Garibaldi. Non è apparso nelle cerimonie commemorative del 1932 (almeno il suo nome non si trova nel «Corriere» di quei giorni). Ma si trova in Italia. In una cronaca di Luciano Ramo nel «Secolo Illustrato» dell’11 giugno 1932 Garibaldi fra le quinte… (dove si descrivono le prove per un dramma, Garibaldi di Italo Sulliotti) si accenna al fatto della presenza di Ricciotti (le prove si facevano a Milano).
Q9 §47 Nozioni enciclopediche. Tempo. In molte lingue straniere, la parola italiana tempo, introdotta attraverso il linguaggio musicale, ha assunto un significato, anche nella terminologia politica, determinato, che la parola tempo in italiano, per la sua genericità, non può esprimere (occorrerebbe dire «Tempo» in senso musicale, nel senso in cui è adoperato in musica ecc.) e che pertanto occorre tradurre; «velocità del ritmo», mi pare la spiegazione del termine tempo nel senso musicale, che può dare questa traduzione, che però sarà solo «ritmo» quando il termine tempo è aggettivato: «ritmo accellerato», «ritmo rallentato» ecc. (velocità del ritmo in senso ellittico, «misura di velocità del ritmo»).
Q9 §48 I nipotini di padre Bresciani, Leonida Répaci. È uscito il primo volume di un romanzo ciclico di Leonida Répaci, I fratelli Rupe (Milano, Ceschina, 1932, L. 15) che, nel suo complesso dovrebbe rappresentare lo sviluppo della vita italiana in questi trent’anni del secolo, vista dalla Calabria (in una prefazione il Répaci presenta il piano dell’opera). È da domandarsi se la Calabria abbia avuto in questo senso una funzione nazionale rappresentativa, E in generale se la provincia italiana abbia avuto una funzione progressiva, o qualunque altra, nel dirigere un qualsiasi movimento del paese, nel selezionare i dirigenti, nel rinfrescare l’ambiente chiuso e corrotto dei centri di vita nazionale. La provincia era in realtà (come dirigenti) molto più corrotta del centro e i provinciali hanno apportato una nuova corruzione: esempio i fratelli Répaci, andati da Palmi a Torino e a Milano. I fratelli Rupe, si capisce, sono i fratelli Répaci; ma, se si eccettua Mariano, dov’è il carattere rupestre di Ciccio e di Leonida: il carattere ricotta e fango è prevalente. Il Répaci non ha nessuna fantasia creatrice: ha una certa disposizione ad ampliare meccanicamente (per aggregazione, o per inflazione) dei fattarelli successi nella sua famiglia, che è assunta a «mito» della sua arte. Questo processo di gonfiamento meccanico può essere dimostrato analiticamente. Ed è poi uno strano mito quello del Répaci, privo di umanità, di dignità, di decoro, per non dire di grandezza. L’Ultimo Cireneo, con le scene del dibattersi osceno del fratello impotente, mostra di quale umanità sia provvisto Répaci (anche in questo Fratelli Rupe c’è un impotente); il quale, pare, sarebbe capace di commettere incesto, per poter scrivere un romanzo sull’incesto e dire che la sua famiglia ha conosciuto tutte le tragedie anche quella di Fedra o di Edipo.
Q9 §49 Apologhi. Il Cadì, il sacchetto rubato, i due Benedetti e i cinque noccioli d’olive. Rifare la novellina delle Mille e una Notte.
Q9 §50 I nipotini di padre Bresciani. Arnaldo Frateili. È il critico letterario della «Tribuna», ma appartiene alla schiera dei Forges e non dei Baldini. Ha scritto un romanzo Capogiro (Milano, Bompiani, 1932). Il Frateili mi si presenta alla fantasia come l’ho visto in una caricatura‑ritratto: una faccia da fesso pretenzioso con la goccetta al naso. (Prende tabacco il Frateili? Ha il cimurro A. Frateili?) Perché quella goccetta? Si tratta di un errore di riproduzione? Di un colpo di matita fuori programma? E perché il disegnatore non ha cancellato la goccetta? Angosciosi problemi, i soli che interessano a proposito del Frateili.
Q9 §51 Passato e presente. In un articolo di Mario Bonfantini, L’arte di Carlo Bini, nell’«Italia Letteraria» del 22 maggio 1932, sono citati questi due versi (o quasi): «La prigione è una lima sì sottile, – che temprando il pensier ne fa uno stile». Chi ha scritto così? Lo stesso Bini? Ma il Bini è stato davvero in prigione (forse non molto). La prigione è una lima così sottile, che distrugge completamente il pensiero; oppure fa come quel mastro artigiano, al quale era stato consegnato un bel tronco di legno d’olivo stagionato per fare una statua di S. Pietro, e taglia di qua, togli di là, correggi, abbozza, finì col ricavarne un manico di lesina.
Q9 §52 Passato e presente. Nel secondo volume delle sue Memorie (ed. francese, II, pp. 233 sgg.) W. Steed [Henry Wickam Steed, direttore del Times da 1919 al 1922 ndc] racconta come il 30 ottobre 1918 il dottor Kramář, capo del partito giovane‑czeco, che era stato imprigionato e condannato a morte in Austria, si incontrò a Ginevra con Benèš. I due fecero una grande fatica a «comprendersi». Dal 1915 Benèš aveva vissuto e lavorato nei paesi dell’Intesa e si era assimilato il modo di pensare di essi, mentre Kramář, restato in Austria, aveva, nonostante tutto, ricevuto la maggior parte delle sue impressioni di guerra per il tramite della cultura e della propaganda tedesca e austriaca. «A mano a mano che la conversazione durava, Benèš comprese quale largo fossato separasse i punti di vista di guerra degli alleati e dell’Europa centrale. Mi comunicò le sue impressioni al suo ritorno a Parigi ed io compresi che se la differenza di pensiero poteva essere così grande tra due patriotti czechi, tanto più grande doveva essere tra gli alleati e i popoli germanici, così grande, invero, da escludere ogni possibilità d’intesa tra essi finché non fosse stato formulato un vocabolario o un gruppo di pensieri comuni». Perciò Steed propone a Northcliffe di trasformare l’ufficio di propaganda e di dedicarlo a questo fine: creare la possibilità di far comprendere ai tedeschi ciò che era successo e perché, in modo, per così dire, da «disincantare» il popolo tedesco e renderlo passibile di accettare come necessaria la pace che l’Intesa avrebbe imposto.
Si tratta, come si vede, di due ordini di fatti e di osservazioni: 1°) Che uomini il cui pensiero sia fondamentalmente identico, dopo aver vissuto staccati e in condizioni di vita tanto diverse, finiscono col durar fatica ad intendersi, creandosi così la necessità di un periodo di lavoro comune necessario per riaccordarsi allo stesso diapason. Se non si capisce questa necessità si incorre nel rischio banale di impostare polemiche senza sugo, su quistioni di «vocabolario», quando ben altro occorrerebbe fare. Ciò rinforza il principio che in ogni movimento il grado di preparazione del personale non deve essere inteso astrattamente (come fatto esteriormente culturale, di elevazione culturale) ma come preparazione «concorde» e coordinata, in modo che nel personale, come visione, esista identità nel modo di ragionare e quindi rapidità di intendersi per operare di concerto con speditezza. 2°) Che non solo due campi nemici non si comprenderanno più per lungo tempo dopo la fine della lotta, ma non si comprenderanno neanche gli elementi affini tra loro che esistono nei due campi come massa e che dopo la lotta dovrebbero amalgamarsi rapidamente. Che non bisogna pensare che, data l’affinità, la riunione sia per avvenire automaticamente, ma occorre predisporla con un lavoro di lunga mano su tutta l’area, cioè in tutta l’estensione del dominio culturale e non astrattamente, cioè partendo da principii generali sempre validi, ma concretamente, sull’esperienza dell’immediato passato e dell’immediato presente, da cui i principii devono sembrar scaturire come ferrea necessità e non come a priori.
Q9 §53 Passato e presente. Un dialogo. Qualcosa c’è di mutato fondamentalmente. E si può vedere. Che cosa? Prima tutti volevano essere aratori della storia, avere le parti attive, ognuno avere una parte attiva. Nessuno voleva essere «concio» [concime ndc] della storia. Ma può ararsi senza prima ingrassare la terra? Dunque ci deve essere l’aratore e il «concio». Astrattamente tutti lo ammettevano. Ma praticamente? «Concio» per «concio» tanto valeva tirarsi indietro, rientrare nel buio, nell’indistinto. Qualcosa è cambiato, perché c’è chi si adatta «filosoficamente» ad essere concio, che sa di doverlo essere, e si adatta. È come la quistione dell’uomo in punto di morte, come si dice. Ma c’è una grande differenza, perché in punto di morte si è ad un atto decisivo che dura un attimo; invece nella quistione del concio, la quistione dura a lungo, e si ripresenta ogni momento. Si vive una volta sola, come si dice; la propria personalità è insostituibile. Non si presenta, per giocarla, una scelta spasmodica, di un istante, in cui tutti i valori sono apprezzati fulmineamente e si deve decidere senza rinvio. Qui il rinvio è di ogni istante e la decisione deve ripetersi ogni istante. Perciò si dice che qualcosa è cambiato. Non è neanche la quistione di vivere un giorno da leone o cento anni da pecora. Non si vive da leone neppure un minuto, tutt’altro: si vive da sottopecora per anni e anni e si sa di dover vivere così. L’immagine di Prometeo che invece di essere aggredito dall’aquila, è invece divorato dai parassiti. Giobbe l’hanno potuto immaginare gli ebrei: Prometeo potevano solo immaginarlo i greci; ma gli ebrei sono stati più realisti, più spietati, e anche hanno dato una maggiore evidenza al loro eroe.
Q9 §54 Nozioni enciclopediche. Bibliografia. Société française de philosophie. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, publié par A. Lalande, ive édition, augmentée, Parigi, Alcan, 1932, in 8°, volumi tre, Fr. 180.
Q9 §55 Rinascimento e Riforma. Cfr A. Oriani, La lotta politica (p. 128, edizione milanese): «La varietà dell’ingegno italiano, che nella scienza poteva andare dal sublime buon senso di Galileo alle abbaglianti e bizzarre intuizioni di Cardano, si colora nullameno alla Riforma, e vi si scorgono tosto Marco Antonio Flaminio poeta latino, Jacopo Nardi storico, Renata d’Este moglie del duca Ercole II; Lelio Socini, ingegno superiore a Lutero e a Calvino, che la porta ben più alto fondando la setta degli unitari; Bernardo Ochino e Pietro Martire Vermiglio teologo, che passeranno, questi alla università di Oxford, quegli nel capitolo di Canterbury; Francesco Burlamacchi che ritenterà l’impossibile impresa di Stefano Porcari e vi perirà martire eroe; Pietro Carnesecchi e Antonio Palcario che vi perderanno entrambi nobilmente la vita. Ma questo moto incomunicato al popolo è piuttosto una crisi del pensiero filosofico e scientifico, naturalmente ritmata sulla grande rivoluzione germanica, che un processo di purificazione e di elevazione religiosa. Infatti Giordano Bruno e Tommaso Campanella riassumendolo, per quanto vissuti e morti entro l’orbita di un ordine monastico, sono due filosofi trascinati dalla speculazione oltre i confini non solo della Riforma ma del cristianesimo stesso. Quindi il popolo rimane così insensibile alla loro tragedia che sembra quasi ignorarla».
Ma cosa significa tutto ciò? Forse che anche la Riforma non è una crisi del pensiero filosofico e scientifico, cioè dell’atteggiamento verso il mondo, della concezione del mondo? Bisogna quindi dire che, a differenza degli altri paesi, neanche la religione in Italia era elemento di coesione tra il popolo e gli intellettuali, e perciò appunto la crisi filosofica degli intellettuali non si prolungava nel popolo, perché non aveva origini nel popolo, perché non esisteva un «blocco nazionale‑popolare» nel campo religioso. In Italia non esisteva «chiesa nazionale», ma cosmopolitismo religioso, perché gli intellettuali italiani erano collegati a tutta la cristianità immediatamente come dirigenti anazionali. Distacco tra scienza e vita, tra religione e vita popolare, tra filosofia e religione; i drammi individuali di Giordano Bruno ecc. sono del pensiero europeo e non italiano.
Q9 §56 Passato e presente. Il culto provinciale dell’intelligenza e la sua retorica. Cfr la lettera‑prefazione di Emilio Bodrero alla rivista «Accademie e Biblioteche d’Italia», vol. I, p. 5, dove si dice press’a poco che l’Italia «non ha nulla da esportare se non intelligenza». (Cfr «il rutto del pievano» di Maccari). Nei libri di Oriani questo elemento è frenetico. Ricordare l’aneddoto di Oriani che domandato se aveva da daziare risponde: «se l’intelligenza paga dazio, qui ce n’è a quintali». Sarà da notare che tale atteggiamento è degli intellettuali mediocri e falliti.
Q9 §57 La cultura come espressione della società. Una affermazione del Baldensperger, che i gruppi umani «creano le glorie secondo le necessità e non secondo i meriti», è giusta e va meditata. Essa può estendersi anche oltre il campo letterario.
Q9 §58 La «nuova» scienza. Borgese e Michel Ardan. Nel romanzo di Verne Dalla terra alla Luna Michel Ardan nel suo discorso, dice liricamente che «lo spazio non esiste» perché gli astri sono talmente vicini gli uni agli altri che si può pensare l’universo come un tutto solido, le cui reciproche distanze possono paragonarsi alle distanze esistenti fra le molecole del metallo più compatto come l’oro o il platino. Il Borgese, sulle traccie di Eddington ha capovolto il ragionamento del Verne e sostiene che la «materia solida» non esiste perché il vuoto nell’atomo è tale che un corpo umano, ridotto alle parti solide, diverrebbe un corpuscolo visibile solo al microscopio. È la fantasia di Verne applicata alla «Scienza» degli scienziati e non più a quella dei ragazzi. (Il Verne immagina, nel momento in cui l’Ardan espone le sue tesi, che Maston, una delle figurette con cui rende arguti i suoi libri, nel gridare con entusiasmo: «Sì, le distanze non esistono!» stia per cadere e provare così, sulla sua pelle, se le distanze esistono o no).
Q9 §59 Nozioni enciclopediche. Empirismo. Significato equivoco del termine. Si adopera il termine di empirismo, comunemente, nel senso di non‑scientifico. Ma lo si adopera anche nel senso di non categorico (proprio delle categorie filosofiche) e quindi di «concreto» e reale nel senso «corposo» della parola. Realtà empirica e realtà categorica ecc. Per il Croce, per esempio le scienze filosofiche sono le sole e vere scienze, mentre le scienze fisiche o esatte sono «empiriche» e astratte, perché per l’idealismo la natura è una astrazione convenzionale, di «comodo», ecc.
Q9 §60 Passato e presente. Del sognare a occhi aperti e del fantasticare. Prova di mancanza di carattere e di passività. Si immagina che un fatto sia avvenuto e che il meccanismo della necessità sia stato capovolto. La propria iniziativa è divenuta libera. Tutto è facile. Si può ciò che si vuole, e si vuole tutta una serie di cose di cui presentemente si è privi. È, in fondo, il presente capovolto che si proietta nel futuro. Tutto ciò che è represso si scatena. Occorre invece violentemente attirare l’attenzione nel presente così come è, se si vuole trasformarlo. Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà.
Q9 §61 Passato e presente. Inghilterra e Germania. Un raffronto dei due paesi per riguardo al loro comportamento di fronte alla crisi di depressione del 1929 sgg. Da questa analisi dovrebbe risultare la reale struttura dell’uno e dell’altro e la reciproca posizione funzionale nel complesso economico mondiale, elemento della struttura che non è, di solito, attentamente osservato. Si può iniziare l’analisi dal fenomeno della disoccupazione. Le masse di disoccupati in Inghilterra e in Germania hanno lo stesso significato? Il teorema delle «proporzioni definite» nella divisione del lavoro interno si presenta allo stesso modo nei due paesi? Si può dire che la disoccupazione inglese, pur essendo inferiore numericamente a quella tedesca, indica che il coefficiente «crisi organica» è maggiore in Inghilterra che in Germania, dove invece il coefficiente «crisi ciclica» è più importante. Cioè nell’ipotesi di una ripresa «ciclica», l’assorbimento della disoccupazione sarebbe più facile in Germania che in Inghilterra. Da quale elemento della struttura dipende questa differenza: dalla maggiore importanza che ha in Inghilterra il commercio in confronto della produzione industriale, cioè dall’esistenza in Inghilterra di una massa di «proletari» legati alla funzione commerciale superiore a quella tedesca, dove invece è maggiore la massa industriale. Composizione della popolazione attiva e sua distribuzione nelle diverse attività. Molti commercianti (banchieri, agenti di cambio, rappresentanti ecc.) determinano un largo impiego di personale per i loro servizi quotidiani: aristocrazia più ricca e potente che in Germania. Più numerosa la quantità di «parassiti rituali» cioè di elementi sociali impiegati non nella produzione diretta, ma nella distribuzione e nei servizi personali delle classi possidenti.
Q9 §62 Machiavelli. Il teorema delle proporzioni definite. Questo principio può essere impiegato per rendere più chiari molti ragionamenti riguardanti l’organizzazione e anche la politica generale (nelle analisi delle situazioni, dei rapporti di forza ecc., nel problema degli intellettuali). S’intende che occorre ricordare sempre come il ricorso al principio delle proporzioni definite ha un valore metaforico, e non può essere applicato meccanicamente. Ogni organismo ha un suo principio ottimo di proporzioni definite. Ma la scienza dell’organizzazione specialmente deve ricorrere a questo principio. Nell’esercito si vede con chiarezza l’applicazione del principio. Ma ogni società ha un suo esercito e ogni tipo di esercito ha un suo principio di proporzioni definite, ed è in continuo svolgimento anche come tipo. L’esercito attuale è già diverso da quello che era agli inizi dello sviluppo della attuale forma sociale ecc. Rapporto tra truppa, graduati di truppa, sottufficiali, ufficiali subalterni, ufficiali superiori, Stato maggior generale ecc. Rapporto delle armi speciali. Rapporto dei servizi d’intendenza ecc. Ogni mutamento di ognuno degli elementi porta a squilibri nelle altre parti ecc.
Politicamente il principio si può studiare nei partiti, nelle fabbriche e vedere come ogni gruppo sociale ha le sue proprie proporzioni, a seconda del livello di coltura, di indipendenza mentale, di spirito d’iniziativa dei suoi membri più arretrati e periferici.
La legge delle proporzioni definite è riassunta così dal Pantaleoni nei Principii di Economia Pura: «… I corpi si combinano chimicamente soltanto in proporzioni definite e ogni quantità di un elemento che superi la quantità richiesta per una combinazione con altri elementi, presenti in quantità definite, resta libera; se la quantità di un elemento è deficiente per rapporto alla quantità di altri elementi presenti, la combinazione non avviene che nella misura in cui è sufficiente la quantità dell’elemento che è presente in quantità minore degli altri».
Si potrebbe servirsi metaforicamente di questa legge per far capire come un «movimento» diventa partito, cioè forza politica efficiente, nella misura in cui possiede «dirigenti» di vario grado e nella misura in cui questi dirigenti sono «capaci». L’automatismo storico di una certa premessa viene potenziato politicamente dai partiti e dagli uomini «capaci»: la loro assenza o deficienza (quantitativa e qualitativa) rende «sterile» l’automatismo stesso: c’è la premessa, ma le conseguenze non si realizzano. Perciò si può dire che i partiti hanno il compito di creare dirigenti, sono la funzione di massa che seleziona, sviluppa e moltiplica i dirigenti necessari perché la massa determinata (che è una quantità «fissa», in quanto si può assumere e fissare quanti sono i membri di un certo gruppo sociale) si articoli e diventi, da caos tumultuoso, esercito politico organicamente predisposto. Quando in elezioni successive dello stesso grado o di grado diverso (in Germania per esempio: elezioni per il presidente della repubblica, per le diete dei Länder, per il Reichstag, per i consigli comunali e giù giù fino ai comitati d’azienda), quando un partito ondeggia nella sua massa di suffragi da massimi a minimi che sembrano arbitrari si può dedurre che i suoi quadri sono manchevoli per quantità e per qualità, o per quantità e non per qualità (relativamente) o per qualità e non per quantità. Un partito che ha molti voti sindacali e meno politici, è deficiente qualitativamente nella sua direzione: possiede molti subalterni, o almeno in numero, sufficiente, ma non possiede i gradi superiori proporzionatamente ecc. Si può fare una analisi di tal genere che è già stata accennata in altre annotazioni.
Q9 §63 Passato e presente. Contro il bizantinismo. Si può chiamare bizantinismo o scolasticismo la tendenza degenerativa a trattare le quistioni così dette teoriche come se avessero un valore di per se stesse, indipendentemente da ogni pratica determinata. Un esempio tipico di bizantinismo sono le così dette tesi di Roma, in cui alle quistioni viene applicato il metodo matematico come nella economia pura. Si pone la quistione se una verità teorica scoperta in corrispondenza di una determinata pratica può essere generalizzata e ritenuta universale in una epoca storica. La prova della sua universalità consiste appunto in ciò che essa diventa: 1) stimolo a conoscere meglio la realtà effettuale in un ambiente diverso da quello in cui fu scoperta, e in ciò è il suo primo grado di fecondità; 2) avendo stimolato e aiutato questa migliore comprensione della realtà effettuale, si incorpora a questa realtà stessa come se ne fosse espressione originaria. In questo incorporarsi è la sua concreta universalità, non meramente nella sua coerenza logica e formale e nell’essere uno strumento polemico utile per confondere l’avversario.
Insomma deve sempre vigere il principio che le idee non nascono da altre idee, che le filosofie non sono partorite da altre filosofie, ma che esse sono espressione sempre rinnovata dello sviluppo storico reale. L’unità della storia, ciò che gli idealisti chiamano unità dello spirito, non è un presupposto, ma un continuo farsi progressivo. Uguaglianza di realtà effettuale determina identità di pensiero e non viceversa. Se ne deduce ancora che ogni verità, pur essendo universale, e pur potendo essere espressa con una formula astratta, di tipo matematico (per la tribù dei teorici), deve la sua efficacia all’essere espressa nei linguaggi delle situazioni concrete particolari: se non è esprimibile in lingue particolari è un’astrazione bizantina e scolastica, buona per i trastulli dei rimasticatori di frasi.
Q9 §64 Machiavelli (storia delle classi subalterne). Importanza e significato dei partiti. Quando si scrive la storia di un partito, si affronta tutta una serie di problemi. Cosa sarà la storia di un partito? Sarà la mera narrazione della vita interna di una organizzazione politica, come essa nasce, i primi gruppi che la costituiscono, le polemiche ideologiche attraverso le quali nasce il suo programma e la sua concezione del mondo e della vita? Sarebbe, in tal caso, la storia di ristretti gruppi intellettuali e talvolta la biografia politica di una sola personalità. Il quadro dovrà essere più largo: sarà la storia di una determinata massa di uomini che avrà seguito quegli uomini, li avrà sorretti con la sua fiducia, criticati «realisticamente» con le sue dispersioni e le sue passività. Ma questa massa sarà solamente costituita dai soci del partito? Occorrerà seguire i congressi, le votazioni ecc. tutto l’insieme di modi di vita con cui una massa di partito manifesta la sua volontà; ma sarà sufficiente? Bisognerà evidentemente tener conto del gruppo sociale di cui il partito è l’espressione e la parte più avanzata, e la storia di un partito non potrà non essere la storia di un determinato gruppo sociale. Ma questo gruppo non è isolato nella società, ha amici, affini, avversari, nemici.
Solo dal complesso quadro di tutto l’insieme sociale risulterà la storia di un determinato partito, e pertanto si può dire che scrivere la storia di un partito significa scrivere la storia generale di un paese da un punto di vista monografico, per metterne in risalto un aspetto caratteristico. Un partito avrà avuto maggiore o minore importanza, maggiore o minore significato nella misura appunto in cui la sua particolare attività avrà avuto maggiore o minore peso nella determinazione della storia di un paese. Ecco che dal modo di scrivere la storia di un partito risulta quale concetto si abbia di ciò che un partito sia e debba essere. Il settario si esalterà nei fatterelli interni, che avranno per lui un significato esoterico e lo riempiranno di entusiasmo mistico. Uno storico‑politico darà a questi fatti l’importanza che essi hanno nel quadro generale e insisterà sull’efficienza reale del partito, sulla sua forza determinante, positiva o negativa, nell’aver contribuito a determinare un evento e anche nell’averne impedito il compimento.
Q9 §65 Passato e presente. La storia maestra della vita, le lezioni dell’esperienza ecc. Anche Benvenuto Cellini (Vita, Libro secondo, ultime parole del paragrafo XVII), scrive: «Gli è ben vero che si dice: tu imparerai per un’altra volta. Questo non vale, perché la (fortuna) viene sempre con modi diversi e non mai immaginati».
Si può forse dire che la storia è maestra della vita e che l’esperienza insegna ecc. non nel senso che si possa, dal modo come si è svolto un nesso di avvenimenti, trarre un criterio sicuro d’azione e di condotta per avvenimenti simili, ma solo nel senso che, essendo la produzione degli avvenimenti reali il risultato di un concorrere contradditorio di forze, occorre cercare di essere la forza determinante. Ciò che va inteso in molti sensi, perché si può essere la forza determinante non solo per il fatto di essere la forza quantitativamente prevalente (ciò che non è sempre possibile e fattibile) ma per il fatto di essere quella qualitativamente prevalente, e questo può aversi se si ha spirito d’iniziativa, se si coglie il «momento buono», se si mantiene uno stato continuo di tensione alla volontà, in modo da essere in grado di scattare in ogni momento scelto (senza bisogno di lunghi apprestamenti che fanno passare l’istante più favorevole) ecc. Un aspetto di tal modo di considerare le cose si ha nell’aforisma che la miglior tattica difensiva è quella offensiva.
Noi siamo sempre sulla difensiva contro il «caso», cioè il concorrere imprevedibile di forze contrastanti che non possono sempre essere identificate tutte (e una sola trascurata impedisce di prevedere la combinazione effettiva delle forze che dà sempre originalità agli avvenimenti) e possiamo «offenderlo» nel senso che interveniamo attivamente nella sua produzione, che, dal nostro punto di vista, lo rendiamo meno «caso» o «natura» e più effetto della nostra attività e volontà.
Q9 §66 Letteratura popolare. Ho accennato in altra nota come in Italia la musica abbia in una certa misura sostituito, nella cultura popolare, quella espressione artistica che in altri paesi è data dal romanzo popolare e come i genii musicali abbiano avuto quella popolarità che invece è mancata ai letterati. È da ricercare: 1°) se la fioritura dell’opera in musica coincide in tutte le sue fasi di sviluppo (cioè non come espressione individuale di singoli artisti geniali, ma come fatto, manifestazione storico‑culturale) con la fioritura dell’epica popolare rappresentata dal romanzo. Mi pare di sì: il romanzo e il melodramma hanno l’origine nel settecento e fioriscono nel primo 50° del secolo XIX, cioè essi coincidono con la manifestazione e l’espansione delle forze democratiche popolari‑ nazionali in tutta l’Europa. 2°) Se coincidono l’espansione europea del romanzo popolare anglo‑francese e quella del melodramma italiano.
Perché la «democrazia» artistica italiana ha avuto una espressione musicale e non «letteraria»? Che il linguaggio non sia stato nazionale, ma cosmopolita, come è la musica, può connettersi alla deficienza di carattere popolare‑nazionale degli intellettuali italiani? Nello stesso momento in cui in ogni paese avviene una stretta nazionalizzazione degli intellettuali indigeni, e questo fenomeno si verifica anche in Italia, sebbene in misura meno larga (anche il settecento italiano, specialmente nella seconda metà, è più «nazionale» che cosmopolita), gli intellettuali italiani continuano la loro funzione europea attraverso la musica. Si potrà forse osservare che la trama dei libretti non è mai «nazionale» ma europea, in due sensi: o perché l’«intrigo» del dramma si svolge in tutti i paesi d’Europa e più raramente in Italia, muovendo da leggende popolari o da romanzi popolari; o perché i sentimenti e le passioni del dramma riflettono la particolare sensibilità europea settecentesca e romantica, cioè una sensibilità europea, che non pertanto coincide con elementi cospicui della sensibilità popolare di tutti i paesi, da cui del resto aveva attinto la corrente romantica. (È da collegare questo fatto con la popolarità di Shakespeare e anche dei tragici greci, i cui personaggi, travolti da passioni elementari – gelosia, amor paterno, vendetta, ecc. – sono essenzialmente popolari in ogni paese). Si può perciò dire che il rapporto melodramma italiano ‑ letteratura popolare anglo‑francese non è sfavorevole criticamente al melodramma, poiché il rapporto è storico‑popolare e non artistico-critico.
Verdi non può essere paragonato, per dir così, a Eugenio Sue, come artista, se pure occorre dire che la fortuna popolare di Verdi può solo essere paragonata a quella del Sue, sebbene per gli estetizzanti (wagneriani) aristocratici della musica, Verdi occupi lo stesso posto nella storia della musica che Sue nella storia della letteratura. La letteratura popolare in senso deteriore (tipo Sue e tutta la sequela) è una degenerazione politico‑commerciale della letteratura nazionale‑popolare, il cui modello sono appunto i tragici greci e Shakespeare.
Questo punto di vista sul melodramma può anche essere un criterio per comprendere la popolarità del Metastasio che fu tale specialmente come scrittore di libretti.
Q9 §67 Passato e presente. Nell’esposizione critica degli avvenimenti successivi alla guerra e dei tentativi costituzionali (organici) per uscire dallo stato di disordine e di dispersione delle forze, mostrare come il movimento per valorizzare la fabbrica in contrasto (o meglio autonomamente) con la (dalla) organizzazione professionale corrispondesse perfettamente all’analisi che dello sviluppo del sistema di fabbrica è fatta nel primo volume della Critica dell’Economia Politica. Che una sempre più perfetta divisione del lavoro riduca oggettivamente la posizione del lavoratore nella fabbrica a movimenti di dettaglio sempre più «analitici», in modo che al singolo sfugge la complessità dell’opera comune, e nella sua coscienza stessa il proprio contributo si deprezzi fino a sembrare sostituibile facilmente in ogni istante; che nello stesso tempo il lavoro concertato e bene ordinato dia una maggiore produttività «sociale» e che l’insieme della maestranza della fabbrica debba concepirsi come un «lavoratore collettivo» sono i presupposti del movimento di fabbrica che tende a fare diventare «soggettivo» ciò che è dato «oggettivamente».
Cosa poi vuol dire in questo caso oggettivo? Per il lavoratore singolo «oggettivo» è l’incontrarsi delle esigenze dello sviluppo tecnico con gli interessi della classe dominante. Ma questo incontro, questa unità fra sviluppo tecnico e gli interessi della classe dominante è solo una fase storica dello sviluppo industriale, deve essere concepito come transitorio. Il nesso può sciogliersi; l’esigenza tecnica può essere pensata concretamente separata dagli interessi della classe dominante, non solo ma unita con gli interessi della classe ancora subalterna. Che una tale «scissione» e nuova sintesi sia storicamente matura è dimostrato perentoriamente dal fatto stesso che un tale processo è compreso dalla classe subalterna, che appunto per ciò non è più subalterna, ossia mostra di tendere a uscire dalla sua condizione subordinata. Il «lavoratore collettivo» comprende di essere tale e non solo in ogni singola fabbrica ma in sfere più ampie della divisione del lavoro nazionale e internazionale e questa coscienza acquistata dà una manifestazione esterna, politica, appunto negli organismi che rappresentano la fabbrica come produttrice di oggetti reali e non di profitto.
Q9 §68 Machiavelli. Centralismo organico e centralismo democratico. Sono da studiare i reali rapporti economici e politici che trovano la loro forma organizzativa, la loro articolazione e la loro funzionalità nelle manifestazioni di centralismo organico e di centralismo democratico in una serie di campi: nella vita statale (unitarismo, federalismo ecc.), nella vita interstatale (alleanze, forme varie di costellazioni politiche internazionali), nella vita dei partiti politici e delle associazioni sindacali economiche (in uno stesso paese, tra paesi diversi ecc.).
Le polemiche sorte nel passato (prima del 1914) a proposito del predominio tedesco nella vita di alcune forze politiche internazionali. Era poi reale questa predominanza o in che cosa essa realmente consisteva? Mi pare si possa dire: 1°) che nessun nesso organico e disciplinare stabiliva un tale predominio, il quale pertanto era un mero fatto di influenza culturale e ideologica astratta; 2°) che tale influenza culturale non toccava per nulla l’attività pratica effettiva, la quale viceversa era disgregata, localistica, senza indirizzo d’insieme. Non si può parlare in tal caso di alcun centralismo, né organico né democratico, né d’altro genere o misto. L’influenza culturale era risentita e subita da scarsi gruppi intellettuali, senza legami con le masse e appunto questa assenza di legame caratterizzava la situazione. Tuttavia questo stato di cose è degno di studio perché serve a spiegare il processo che ha portato alle teorie del centralismo organico, che è appunto una critica unilaterale e da intellettuali di quel disordine e dispersione di forze.
Occorre intanto distinguere appunto nelle teorie del centralismo organico tra quelle che velano un preciso programma politico di predominio reale di una parte sul tutto (sia questa parte costituita da uno strato come quello degli intellettuali, sia costituita da un gruppo territoriale privilegiato) e quelle che sono una pura posizione unilaterale (anch’essa propria d’intellettuali), cioè un fatto settario o di fanatismo, immediatamente, e che, pur nascondendo un programma di predominio, è però meno accentuato come fatto politico cosciente.
Il nome più esatto è quello di centralismo burocratico: l’organicità non può essere che del centralismo democratico, il quale appunto è un «centralismo in movimento» per così dire, cioè una continua adeguazione dell’organizzazione al movimento storico reale ed è organico appunto perché tiene conto del movimento, che è il modo organico di manifestarsi della realtà storica. Inoltre è organico perché tiene conto di qualcosa di relativamente stabile e permanente o per lo meno che si muove in una direzione più facile a prevedersi ecc. Questo elemento di stabilità negli Stati si incarna nello sviluppo organico della classe dirigente così come nei partiti si incarna nello sviluppo organico del gruppo sociale egemone; negli Stati il centralismo burocratico indica che si è formato un gruppo angustamente privilegiato che tende a perpetuare i suoi privilegi regolando e anche soffocando il nascere di forze contrastanti alla base, anche se queste forze sono omogenee di interessi agli interessi dominanti (esempio nel fatto del protezionismo in lotta col liberismo). Nei partiti rappresentanti gruppi socialmente subalterni l’elemento di stabilità rappresenta la necessità organica di assicurare l’egemonia non a gruppi privilegiati: ma alle forze sociali progressive, organicamente progressive in confronto di altre forze alleate ma composte e oscillanti tra il vecchio e il nuovo.
In ogni caso ciò che importa notare è che nelle manifestazioni di centralismo burocratico spesso la situazione si è formata per deficienza d’iniziativa, cioè per la primitività politica, delle forze periferiche, anche quando esse sono omogenee con il gruppo territoriale egemone. Specialmente negli organismi territoriali internazionali il formarsi di tali situazioni è estremamente dannoso e pericoloso.
Il centralismo democratico è una formula elastica, che si presta a molte «incarnazioni»; essa vive in quanto è interpretata continuamente e continuamente adattata alle necessità: essa consiste nella ricerca critica di ciò che è uguale nell’apparente disformità e distinto e opposto nell’apparente uniformità, e nell’organizzare e connettere strettamente ciò che è simile, ma in modo che tale organizzazione e connessione appaia una necessità pratica «induttiva», sperimentale, e non il risultato di un procedimento razionalistico, deduttivo, astrattistico, cioè appunto proprio di intellettuali «puri». Questo lavorio continuo per sceverare l’elemento «internazionale» e «unitario» nella realtà nazionale e localistica è in realtà l’operazione politica concreta, l’attività sola produttiva di progresso storico. Essa richiede una organica unità tra teoria e pratica, tra strati intellettuali e massa, tra governanti e governati. Le formule di unità e federazione perdono gran parte del loro significato da questo punto di vista: esse invece hanno il loro veleno nella concezione «burocratica», per la quale in realtà non esiste unità ma palude stagnante superficialmente calma e «muta», e non federazione ma sacco di patate, cioè giustapposizione meccanica di «unità» singole senza rapporto tra loro.
Q9 §69 Machiavelli. (Il numero e la qualità nei regimi rappresentativi). Uno dei luoghi comuni più banali che si vanno ripetendo contro il sistema elettivo di formazione degli organi statali è quello che il «numero sia in esso legge suprema» e che la «opinione di un qualsiasi imbecille che sappia scrivere (e anche di un analfabeta, in certi paesi) valga, agli effetti di determinare il corso politico dello Stato, esattamente quanto quella di chi allo Stato e alla Nazione dedichi le sue migliori forze» ecc. (Le formulazioni sono molte, alcune anche più felici di questa riportata, che è di Mario da Silva, nella «Critica Fascista» del 15 agosto 1932, ma il contenuto è sempre uguale). Non è certo vero che il numero sia legge suprema, né che il peso dell’opinione di ogni elettore sia «esattamente» uguale. I numeri, anche in questo caso, sono un semplice valore strumentale, che danno una misura e un rapporto e niente di più. E che cosa poi si misura? Si misura proprio l’efficacia e la capacità di espansione e di persuasione delle opinioni di pochi, delle minoranze attive, delle élites, delle avanguardie ecc. ecc., cioè la loro razionalità o storicità o funzionalità concreta. Ciò vuol dire anche che non è vero che il peso delle opinioni dei singoli sia esattamente uguale. Le idee e le opinioni non «nascono» spontaneamente nel cervello di ogni singolo: hanno avuto un centro di irradiazione e di diffusione, un gruppo di uomini o anche un uomo singolo che le ha elaborate e le ha presentate nella forma politica di attualità.
La numerazione dei «voti» è la manifestazione terminale di un lungo processo in cui l’influsso massimo appartiene proprio a quelli che «dedicano allo Stato e alla Nazione le loro migliori forze» (quando lo sono). Se questi presunti ottimati, nonostante le forze materiali sterminate che possiedono, non hanno il consenso delle maggioranze, saranno da giudicare inetti e non rappresentanti gl’interessi «nazionali», che non possono non essere prevalenti nell’indurre le volontà in un senso piuttosto che in un altro. «Disgraziatamente» ognuno è portato a confondere il proprio particolare con l’interesse nazionale e quindi a trovare orribile ecc. che sia la «legge del numero» a decidere. Non si tratta quindi di chi «ha molto» che si sente ridotto al livello di uno qualsiasi, ma proprio di «chi ha molto» che vuole togliere a ogni qualsiasi anche quella frazione infinitesima di potere che questo possiede di decidere sul corso della vita dello Stato.
Dalla critica (di origine oligarchica) al regime parlamentarista (che invece dovrebbe essere criticato proprio perché la «razionalità storicistica» del consenso numerico è sistematicamente falsificata) queste affermazioni banali sono state estese a ogni forma di sistema rappresentativo, anche non parlamentaristico e non foggiato secondo i canoni della democrazia astratta. Tanto meno questa formulazione è esatta. In questi altri regimi il consenso non ha nel momento del voto una fase terminale: tutt’altro. Il consenso è supposto permanentemente attivo, fino al punto che i consenzienti potrebbero essere considerati come «funzionari» dello Stato e le elezioni un modo di arruolamento volontario di funzionari statali di un certo tipo, che in un certo tempo potrebbe ricollegarsi (in piani diversi) a self‑government. Le elezioni avvenendo non su programmi generici e vaghi ma su programmi di lavoro immediati, chi consente si impegna a fare qualcosa di più del comune cittadino legale, per realizzarli, a essere cioè un’avanguardia di lavoro attivo e responsabile. L’elemento «volontarietà» nell’iniziativa non potrebbe essere stimolato in altro modo per le più larghe moltitudini e quando queste non siano formate di amorfi cittadini ma di elementi produttivi qualificati, si può intendere l’importanza che la manifestazione può e deve avere. (Queste osservazioni potrebbero essere svolte più ampiamente e organicamente, mettendo in rilievo anche altre differenze tra i diversi tipi di elezionismo, a seconda che mutano i rapporti generali sociali e politici).
Q9 §70 Machiavelli. Sull’origine delle guerre. Come si può dire che le guerre tra nazioni hanno la loro origine nelle lotte dei gruppi nell’interno di ogni singola nazione? È certo che in ogni nazione deve esistere una certa (e determinata per ogni nazione) espressione della legge delle proporzioni definite. I vari gruppi cioè devono essere in certi rapporti di equilibrio, il cui turbamento radicale potrebbe condurre a una catastrofe sociale. Questi rapporti variano a seconda che un paese è agricolo o industriale e a seconda dei diversi gradi di sviluppo delle forze produttive. La classe dirigente cercherà di mantenere l’equilibrio migliore per il suo permanere, non solo, ma per il suo permanere in determinate condizioni di floridezza e anzi per incrementare queste condizioni. Ma siccome l’area sociale di ogni paese è limitata, sarà portata a estenderla nelle zone coloniali e quindi a entrare in conflitto con altre classi dirigenti che aspirano allo stesso fine, o ai cui danni l’espansione della prima dovrebbe necessariamente avvenire, poiché anche il globo è limitato. Ogni classe dirigente tende in astratto ad allargare la base della società lavoratrice da cui preleva plusvalore, ma la tendenza da astratta diventa concreta e immediata quando il prelevamento del plusvalore nella sua base tradizionale è diventato difficile e pericoloso oltre certi limiti che sono insufficienti.
Q9 §71 Passato e presente. (Cfr p. 58). Un aspetto essenziale della struttura del paese è l’importanza che nella sua composizione ha la burocrazia. Quanti sono gli impiegati dell’amministrazione statale e locale? E quale frazione della popolazione vive coi proventi degli impieghi statali e locali? È da vedere il libro del dottor Renato Spaventa, Burocrazia, ordinamenti amministrativi e Fascismo, 1928, editori Treves. Egli riporta il giudizio di un «illustre economista» che 17 anni prima, cioè quando la popolazione era sui 35 milioni, calcolava che «coloro che traggono sostentamento da un impiego pubblico, oscillano sui due milioni di persone». Pare che in esse non fossero calcolati gli impiegati degli enti locali, mentre pare fossero calcolati gli addetti alle ferrovie e alle industrie monopolizzate che non possono calcolarsi come impiegati amministrativi, ma devono essere considerati a parte, perché bene o male, producono beni controllabili e sono assunti per necessità industriali controllabili con esattezza. Il paragone tra i vari Stati può essere fatto per gli impiegati amministrativi centrali e locali e per la parte di bilancio che consumano (e per la frazione di popolazione che tappresentano), non per gli addetti alle industrie e ai servizi statizzati che non sono simili e omogenei tra Stato e Stato. Per questa stessa ragione non possono includersi fra gli impiegati statali i maestri di scuola, che devono essere considerati a parte ecc. Bisogna isolare e confrontare quegli elementi di impiego statale e locale che esistono in ogni Stato moderno, anche nel più «liberistico», e considerare a parte tutte le altre forme di impiego ecc.
Q9 §72 Argomenti di cultura. Americanismo e fordismo. (Cfr p. 58). In alcune sparse in diversi quaderni sono stati segnati alcuni aspetti del fenomeno industriale rappresentato dal fordismo, specialmente per ciò che riguarda il significato degli «alti salari» pagati dal Ford. La tesi è questa: che tutta l’ideologia fordiana degli alti salari è un fenomeno derivato da una necessità obbiettiva dell’industria giunta a un determinato grado di sviluppo e non un fenomeno primario (ciò che non esonera dallo studio dell’importanza e delle ripercussioni che l’ideologia può avere per conto suo). Intanto cosa significa «alto salario»? È «alto» il salario pagato dal Ford solo in confronto alla media dei salari americani, o è alto come prezzo della forza di lavoro che gli operai impiegati dal Ford consumano nelle fabbriche Ford? Questa ricerca non consta sia stata ancora fatta sistematicamente, ma pure essa sola potrebbe dare una risposta conclusiva. La ricerca è certo difficile, ma le cause stesse di questa difficoltà sono una risposta indiretta.
La risposta è difficile perché la maestranza Ford è molto instabile. Non è perciò possibile stabilire una media di mortalità razionale tra di esse da porre in confronto con la media delle altre industrie. Ma perché questa instabilità? Come mai un operaio preferisce un salario più basso a quello dato dal Ford? Non significa cio che i così detti alti salari sono meno convenienti a ricostituire la forza di lavoro consumata di quanto non siano i salari più bassi delle altre industrie? Questa stessa instabilità dimostra che le condizioni normali di concorrenza tra gli operai non operano per ciò che riguarda l’industria Ford che entro limiti ristretti: non opera il livello diverso tra le medie di salario e non opera la armata di riserva di disoccupati. Ciò significa che nell’industria Ford è da ricercare un elemento nuovo, che sarà la ragione reale sia degli «alti salari» che degli altri fenomeni accennati (instabilità ecc.). Questo elemento non può essere ricercato che in ciò: l’industria Ford richiede una discriminazione nei suoi operai che le altre industrie non richiedono, un tipo di qualifica di nuovo genere, una forma di consumo di forze e una quantità di forza consumata nello stesso tempo medio che è più gravosa e più grave che altrove e che il salario non riesce a compensare, a ricostituire nelle condizioni date dalla società.
Poste queste ragioni, si presenta il problema: se il tipo di industria e di organizzazione della produzione e del lavoro proprio del Ford sia «razionale», possa e debba cioè generalizzarsi, o se invece si tratta di un fenomeno morboso da combattere con la forza sindacale e con la legislazione. Se cioè sia possibile, con la pressione materiale della società, condurre gli operai come massa a subire tutto il processo di trasformazione necessario per ottenere che il tipo medio dell’operaio Ford diventi il tipo medio dell’operaio moderno o se ciò sia impossibile perché porterebbe alla degenerazione fisica e al deterioramento della razza, cioè distruggerebbe l’operaio come tale, ogni forza di lavoro sociale.
Q9 §73 Passato e presente. La burocrazia (cfr p. 55). Studio analitico di F. A. Leonida Rèpaci), Il costo della burocrazia dello Stato nella «Riforma sociale» del maggio‑giugno 1932. È indispensabile per approfondire l’argomento. Elabora il materiale complesso dei volumi statistici sulla burocrazia pubblicati dallo Stato.
Q9 §74 Argomenti di coltura. Americanismo e Fordismo. (Cfr p. 56). In misura piccola, ma tuttavia rilevante, fenomeni simili a quelli che si verificano presso il Ford, si verificavano e si verificano in determinati rami di industrie o in singoli stabilimenti. Formare una maestranza di fabbrica o una squadra di lavorazione specializzata non è cosa semplice e una volta formate esse finiscono talvolta col beneficiare di un salario di monopolio, non solo, ma non vengono licenziate in caso di arresto temporaneo della produzione, perché gli elementi che la costituiscono si disperderebbero e sarebbe impossibile riaccozzarli insieme, mentre la ricostruzione con elementi nuovi, di fortuna, costerebbe tentativi e spese non indifferenti. Poiché non funziona mai e non funzionava una legge di equiparazione perfetta della produzione e dei metodi produttivi in tutte le aziende di un determinato ramo, ne viene che ogni azienda, almeno in una certa misura, è unica e si forma una maestranza con una qualifica di azienda particolare (segreto di fabbricazione e di lavoro ecc.); spesso si tratta di «trucchi» che sembrano trascurabili, ma che, ripetuti infinità di volte, hanno una portata economica ingente. Un caso particolare si può vedere nel lavoro dei porti, specialmente in quelli in cui esiste squilibrio tra imbarco e sbarco di merci o dove si verificano ingorghi stagionali di lavoro. È necessario creare una maestranza che sia sempre disponibile (non si allontani, come avviene per gli avventizi) per il minimo di lavoro stagionale o d’altro genere, quindi i ruoli chiusi, gli alti salari e altri privilegi in contrapposizione ai così detti avventizi.
Q9 §75 Bibliografie. Al XII Congresso Internazionale di Scienze Storiche che si terrà a Varsavia dal 21 al 28 agosto 1933 saranno presentate, da studiosi italiani, queste relazioni che interessano alcune rubriche trattate in questi quaderni:
1°) Piero Pieri, La scienza militare italiana nel Rinascimento (per le sul Machiavelli).
2°) F. Chabod, Il Rinascimento nelle più recenti interpretazioni (per la rubrica «Riforma e Rinascimento» e sul carattere cosmopolitico degli intellettuali italiani).
3°) Aldo Ferrabino, La Storia come scienza della politica.
Q9 §76 Passato e presente. Nelle Satire (satira IX) l’Alfieri scrisse dei napoletani che sono «bocche senza testa». Ma di quanta altra gente si potrebbe ciò dire, mentre non è certo si possa dire dei napoletani.
Q9 §77 Loria. Nell’introduzione all’articolo sul «Fascismo» pubblicato dall’«Enciclopedia Italiana», introduzione scritta dal Capo del Governo, si legge: «Una siffatta concezione della vita porta il fascismo ad essere la negazione recisa di quella dottrina che costituì la base del socialismo cosiddetto scientifico o marxiano: la dottrina del materialismo storico, secondo il quale la storia delle civiltà umane si spiegherebbe soltanto con la lotta di interessi tra i diversi gruppi sociali e col cambiamento dei mezzi e strumenti di produzione. Che le vicende dell’economia – scoperte di materie prime, nuovi metodi di lavoro, invenzioni scientifiche – abbiano una loro importanza, nessuno nega; ma che esse bastino a spiegare la storia umana escludendone tutti gli altri fattori, è assurdo; il fascismo crede ancora e sempre nella santità e nell’eroismo, cioè in atti nei quali nessun motivo economico – lontano o vicino – agisce».
L’influsso delle teorie di Loria è evidente.
Q9 §78 Bibliografie. Michel Mitzakis, Les Grands Problèmes italiens, 1931, fr. 80; Gustave Le Bon, Bases scientifiques d’une philosophie de l’histoire (15 fr.). (Il capo del governo è un grande ammiratore del Le Bon; cfr l’intervista del Le Bon nelle «Nouvelles Littéraires» con F. Lefèvre).
Q9 §79 I nipotini di padre Bresciani. Letteratura di guerra. Cfr il capitolo IX: «Guerre et Littérature» nel volume di B. Cremieux, Littérature Italienne (ed. Kra, 1928, pp. 243 sgg.). Per il Cremieux la letteratura di guerra segna una scoperta del popolo da parte dei letterati. Ma il Cremieux esagera! Tuttavia il capitolo è interessante e da rileggere.
Q9 §80 Passato e presente. Quando fu pubblicata la prima edizione del Chi è?, dizionario biografico italiano dell’editore Formiggini, il Capo del Governo osservò che mancava un paragrafo per il generale Badoglio. Questa accuratezza del Capo del Governo fu riportata dal Formiggini nell’«Italia che scrive» del tempo, ed è un tratto psicologico di grande rilievo.
Q9 §81 Storia delle classi subalterne. David Lazzaretti. Giuseppe Fatini richiama l’attenzione sulle reliquie del lazzarettismo nell’«Illustrazione Toscana» (cfr «Marzocco» del 31 gennaio 1932). Si credeva che dopo l’esecuzione del Lazzaretti da parte dei carabinieri, le traccie del lazzarettismo si fossero per sempre disperse anche nelle pendici dell’Armata grossetana. Invece i lazzarettisti o cristiani giurisdavidici, come amano chiamarsi, continuano a vivere; raccolti per lo più nel villaggio arcidossino di Zancona, con qualche proselite sparso nelle borgate adiacenti, trassero dalla guerra mondiale nuovo alimento per stringersi sempre più fra loro nella memoria di Lazzaretti, che secondo i seguaci aveva tutto previsto dalla guerra mondiale a Caporetto, dalla vittoria del popolo latino alla nascita della Società delle Nazioni. Di quando in quando quei fedeli si fanno vivi fuor del loro piccolo cerchio con opuscoli di propaganda, indirizzandoli ai «fratelli del popolo latino»; e in essi raccolgono qualcuno dei tanti scritti, anche poetici, che il Maestro ha lasciato inediti, e che i seguaci custodiscono gelosamente.
Ma che cosa vogliono i cristiani giurisdavidici? A chi non è ancora tocco dalla grazia di poter penetrare nei segreti del linguaggio del Santo non è facile comprendere la sostanza della loro dottrina. La quale è un risveglio di dottrine religiose d’altri tempi con una buona dose di massime socialistoidi e con generici accenni alla redenzione morale dell’uomo; redenzione che non potrà attuarsi se non col pieno rinnovamento dello spirito e della gerarchia della chiesa cattolica. L’articolo XXIV che chiude il «Simbolo dello Spirito Santo», costituente come il «Credo» dei lazzarettisti, dichiara che «il nostro istitutore David Lazzaretti, l’unto del Signore, giudicato e condannato dalla Curia Romana, è realmente il Cristo Duce e Giudice nella vera e viva figura della seconda venuta di nostro Signor Gesù Cristo sul mondo, come figlio dell’uomo venuto a portare compimento alla Redenzione copiosa su tutto il genere umano in virtù della terza legge divina del Diritto e Riforma generale dello Spirito Santo, la quale deve riunire tutti gli uomini alla fede di Cristo in seno alla cattolica Chiesa in un sol punto e in una sola legge in conferma delle divine promesse». Parve per un certo momento, nel dopoguerra, che i lazzarettisti si incanalassero «per una via pericolosa»; ma seppero ritrarsene a tempo e dettero piena adesione ai vincitori. Non certo per la sua divergenza con la Chiesa cattolica – «la setta dell’Idolatria papale» –, ma per la tenacia con cui essi difendono il Maestro e la Riforma, il Fatini ritiene degno di attenzione e di studio il fenomeno religioso amiatino.
Q9 §82 Passato e presente. Luigi Orsini, Casa paterna. Ricordi d’infanzia e di adolescenza, Treves, 1931. Luigi Orsini è nipote di Felice. Ricorda le descrizioni sull’adolescenza di Felice, narrate dal fratello, padre di Luigi. Pare che il libro sia interessante per il quadro della vita romagnola di villaggio di qualche decina di anni fa.
Q9 §83 Bibliografie. Sull’Impero Britannico: 1) Alfred Zimmerman, Il terzo Impero Britannico, traduzione di Mario Zecchi, Roma, Formiggini, 1931; 2) Fabio Mann, La posizione dei Dominions e dell’India nel Commonwealth Britannico, Roma, Società Ed. del Foro Italiano, 1931. (Pare che siano molto ben fatti e di grande interesse. Il Mann è della scuola dello Jemolo che ha scritto la prefazione per il volume postumo del suo allievo).
Q9 §84 Carattere cosmopolita degli intellettuali italiani. Cesare Balbo aveva scritto: «Una storia intiera e magnifica e peculiare all’Italia sarebbe a fare degli Italiani fuori d’Italia». Nel 1890 fu pubblicato un saggio di Dizionario degli Italiani all’Estero, come opera postuma di Leo Benvenuti (uno studioso modesto). Nella prefazione il Benvenuti osservava che date le condizioni delle ricerche bibliografiche al suo tempo, non sarebbe stato possibile andare oltre a un indice che avrebbe poi dovuto servire a chi si fosse accinto a scrivere la storia. Le categorie in cui il Benvenuti suddivide l’elenco onomastico (le principali) sono: Ambasciatori, antiquari, architetti, artisti (drammatici, coreografici, acrobati), astronomi, botanici, cantanti, eruditi, filosofi, fisici, geografi, giureconsulti, incisoti, ingegneri (civili e militari), linguisti, insegnanti, matematici, medici e chirurghi, maestri di musica, mercanti, missionari, naturalisti, nunzi apostolici, pittori scultori e poeti, soldati di mare, soldati di terra, sovrani, storici, teologi, uomini di chiesa, viaggiatori, statisti. (Come si vede il Benvenuti non aveva altro punto di vista che quello della nazionalità e l’opera sua, se completa, sarebbe stata un censimento degli italiani all’estero; secondo me la ricerca deve essere di carattere qualitativo e cioè studiare come le classi dirigenti – politiche e culturali – di una serie di paesi, furono rafforzate da elementi italiani i quali contribuirono a crearvi una civiltà nazionale, mentre in Italia appunto una classe nazionale mancava e non riusciva a formarsi: è questa emigrazione di elementi dirigenti che rappresenta un fatto storico peculiare, corrispondente all’impossibilità italiana di utilizzare e unificare i suoi cittadini più energici e intraprendenti). Il Benvenuti prendeva le mosse dall’anno 1000.
Promossa dal Capo del Governo, affidata al Ministero degli Affari Esteri, con la collaborazione del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, è in preparazione una voluminosissima pubblicazione intitolata L’Opera del Genio italiano all’estero. L’idea pare sia stata suggerita da Gioacchino Volpe che deve avere scritto il programma dell’opera (in un discorso all’Accademia, annotato in altro quaderno, il Volpe preannunziò questo lavoro). Nel programma si legge: «La Storia del Genio italiano all’Estero che noi vogliamo narrare trascura i tempi antichi staccati da noi da secoli oscuri e muove dalla civiltà, che spuntata dopo il mille, ha raggiunto, sia pure tra soste e sussulti, i nostri giorni, rinnovellata da conquiste ideali e da conquiste politiche, donde l’odierna unità dell’anima e della patria italiana. Sarà opera oggettiva, scevra di antagonismi e di polemiche, ma di giusta celebrazione per quanto il genio italiano, considerato nel suo complesso, operò nel mondo per il bene di tutti». L’opera sarà divisa in dodici serie le quali sono indicate in ordine progressivo, avvertendosi che ogni serie comprenderà uno o più volumi distribuiti in massima secondo il criterio geografico. Le 12 serie sarebbero: 1°’ Artisti di ogni arte; 2° Musicisti; 3° Letterati; 4° Architetti militari; 5° Uomini di guerra; 6° Uomini di mare; 7° Esploratori e Viaggiatori; 8° Principi; 9° Uomini politici; 10° Santi sacerdoti missionari; 11° Scienziati; 12° Banchieri mercanti colonizzatori. L’opera sarà riccamente illustrata. La Commissione Direttiva è composta del prof. Giulio Quirino Giglioli, di S. E. Vincenzo Loiacono e del Sen. Corrado Ricci. Segretario generale della Commissione è il barone Giovanni Di Giura. L’edizione sarà di 1000 esemplari di cui 50 di lusso. (Queste notizie sono ricavate dal «Marzocco» del 6 marzo 1932).
Q9 §85 Passato e presente. Tendenza al pettegolezzo, alla maldicenza, alle insinuazioni perfide e calunniose in contrapposto alla possibilità di discussione libera ecc. Istituto della «farmacia di provincia» che ha una sua concezione del mondo che si impernia sul cardine principale che se le cose vanno male, significa che il diavolo ci ha messo la coda, e gli avvenimenti sono giudicati dagli uomini, che sono tutti mascalzoni, ladri ecc. Se poi si scopre che un uomo politico è corrotto, tutto diventa chiaro.
Richiamare il costume della così detta «briglia della comare» che era un modo di mettere alla berlina le donne pettegole, mettimale e rissose. Alla donna si applicava un meccanismo che, fissato alla testa e al collo, le teneva fermo sulla lingua un listello di metallo che le impediva di parlare.
Q9 §86 Letteratura di funzionari. Il ministro plenipotenziario Antonino D’Alia ha scritto un Saggio di scienza politica (Roma, Treves, 1932, in 8°, pp. XXXII‑710) che sarebbe insieme una storia universale e un manuale di Politica e di Diplomazia (secondo Alberto Lumbroso, che lo esalta nel «Marzocco» del 17 aprile 1932).
Q9 §87 Intellettuali. relle di cultura inglese. Guido Ferrando nel «Marzocco» del 4 ottobre 1931 pubblica un articolo Educazione e Colonie da cui traggo alcuni spunti. Il Ferrando ha assistito a un grande convegno «The British Commonwealth Education Conference» a cui parteciparono centinaia d’insegnanti di ogni grado, dai maestri elementari a professori universitari, provenienti da tutte le parti dell’Impero, dal Canadà e dall’India, dal Sud Africa e dall’Australia, dal Kenja e dalla Nuova Zelanda, e che ebbe luogo a Londra alla fine di luglio. Il Congresso si propose di discutere i vari aspetti del problema educativo «in a changing Empire», in un impero in trasformazione; erano presenti vari ben noti educatori degli Stati Uniti.
Uno dei temi fondamentali del Congresso era quello dell’interracial understanding, del come promuovere e sviluppare una migliore intesa tra le diverse razze, specialmente tra gli europei colonizzatori e gli africani e asiatici colonizzati. «Era interessante vedere con quanta franchezza e quanto acume dialettico, i rappresentanti dell’India rimproverassero agli inglesi la loro incomprensione dell’anima indiana, che si rivela, per esempio, in quel senso quasi di disgusto, in quell’attitudine di sprezzante superiorità che la maggioranza del popolo britannico ha ancor oggi verso gli indiani, e che perfino durante la guerra spingeva gli ufficiali inglesi ad allontanarsi da tavola e a lasciar la stanza quando entrava un ufficiale indiano».
Tra i tanti temi discussi fu quello della lingua. Si trattava cioè di decidere se fosse opportuno insegnare anche alle popolazioni semiselvagge dell’Africa a leggere prendendo per base l’inglese anziché il loro idioma nativo, se fosse meglio mantenere il bilinguismo o tendere, per mezzo dell’istruzione, a far scomparire la lingua indigena. Ormsby Gore, ex sottosegretario alle colonie, sostenne che era un errore il tentare di snaturalizzare le tribù africane e si dichiarò favorevole ad una educazione tendente a dare agli africani il senso della propria dignità di popolo e la capacità di governarsi da sé. Nel dibattito che seguì la comunicazione dell’Ormsby «mi colpirono le brevi dichiarazioni di un africano, credo che fosse uno zulù, il quale tenne ad affermare che i suoi, diciamo così, connazionali, non avevano alcuna voglia di diventar europei; si sentiva nelle sue parole una punta di nazionalismo, un leggero senso di orgoglio di razza».
«Non vogliamo esser inglesi»: a questo grido che prorompeva spontaneo dal petto dei rappresentanti degli indigeni delle colonie britanniche dell’Africa e dell’Asia, faceva eco l’altro grido dei rappresentanti dei Dominions: «Non ci sentiamo inglesi». Australiani e canadesi, cittadini della Nuova Zelanda e dell’Africa del Sud erano tutti concordi nell’affermare questa loro indipendenza non solo politica, ma anche spirituale. Il prof. Cillie, preside della facoltà di lettere in una università sudafricana, aveva argutamente osservato che l’Inghilterra, tradizionalista e conservatrice, viveva nello ieri, mentre essi, i sud‑africani, vivevano nel domani.
Q9 §88 Machiavelli. Grandi potenze. La misura suprema della grande potenza è data dalle guerre. Il concetto di grande potenza è strettamente legato alle guerre. Entrando in alleanze per una guerra, e oggi ogni guerra presuppone dei sistemi di forze antagonistiche, è grande potenza quella che al momento della pace è riuscita a conservare il rapporto delle forze con gli alleati, per essere in grado di far mantenere i patti e, le promesse fatte all’entrata in guerra. Ma uno Stato che per entrare in guerra ha bisogno di grossi prestiti, che ha bisogno continuo di armi e munizioni per i soldati, di vettovaglie per l’esercito e per la popolazione civile, di navi per il trasporto, che cioè non può fare la guerra senza l’aiuto continuo degli alleati, che per qualche tempo dopo la pace ha ancora bisogno di aiuti specialmente di vettovaglie e in prestiti o altre forme di aiuti finanziari, come può essere uguale ai suoi alleati e imporsi perché mantengano le promesse? Un simile Stato non è considerato grande potenza altro che nelle carte diplomatiche, ma nella realtà è considerato come un semplice fornitore di soldati per la coalizione che ha i mezzi non solo di sopportare la guerra coi mezzi propri, ma ha mezzi esuberanti di cui disporre.
Finisce qui il primo gruppo di del Quaderno 9 (XIV).
SUL Risorgimento ITALIANO.
Q9 §89 Due lavori: uno sull’Età del Risorgimento e uno di Introduzione al Risorgimento.
L’Introduzione dovrebbe essere una raccolta di saggi sulle epoche della storia mondiale nei loro riflessi italiani, dopo la caduta dell’Impero Romano: Medio Evo (o età dei Comuni o epoca della formazione molecolare dei nuovi gruppi sociali cittadini); Età del Mercantilismo e delle Monarchie assolute (o epoca in cui questi nuovi gruppi si inseriscono potentemente nella struttura statale, ricreando questa struttura e introducendo un nuovo equilibrio di forze che permette il loro sviluppo rapidamente progressivo) precedente all’Età del Risorgimento. Un saggio anche sul periodo di storia romana in quanto crea la cornice culturale della futura nazione italiana (diversi significati della parola «Italia» secondo il noto saggio di Carlo Cipolla).
Questi saggi devono essere concepiti per un pubblico determinato, col fine di distruggere in esso concezioni antiquate e retoriche formatesi empiricamente e passivamente per la penetrazione delle idee diffuse in un dato ambiente di cultura popolaresca e per suscitare interesse scientifico per le quistioni stesse trattate, che saranno perciò presentate come viventi e operanti anche nel presente, come forze in movimento sempre attuali.
1. Età del Risorgimento. L’opera dell’Ornodeo mi pare fallita nel suo complesso. Mantiene molto del manuale scolastico, cioè la descrizione dei fatti è pura enunziazione da catalogo, senza nessi di necessità storica; lo stile è pessimo, urtante. Per ciò che riguarda l’Italia, l’intenzione dell’Omodeo pare avrebbe dovuto essere quella di mostrare che il Risorgimento è fatto essenzialmente italiano, le cui origini devono trovarsi in Italia e non solo o prevalentemente nelle conseguenze della Rivoluzione francese e dell’invasione francese. Ma questa intenzione non è attuata altro che nel dare inizio alla narrazione dal 1740 e non dal 1789 o dal 1799. Il periodo delle monarchie illuminate non è in Italia un fatto autoctono e non è «originale» italiano il movimento di pensiero connesso (Giannone e regalisti). La monarchia illuminata, mi pare, è la prima derivazione politica dell’età del mercantilismo che annunzia i tempi nuovi, la civiltà moderna; ma in Italia c’è stata un’età del mercantilismo come fenomeno nazionale?
Il mercantilismo avrebbe, se organicamente sviluppato, reso ancora più profonde, e forse definitive, le divisioni in Stati regionali.
Mi pare poi che nella conversione del suo lavoro da manuale scolastico a libro di coltura generale col titolo di Età del Risorgimento l’Omodeo avrebbe dovuto mutarne tutta l’economia, riducendo la parte europea e dilatando la parte italiana. Dal punto di vista europeo, l’età è quella della «Rivoluzione francese» e non del Risorgimento italiano, del «liberalismo» come concezione generale della vita e come nuova civiltà e non solo di una sua frazione, del «liberalismo nazionale» cioè. È certo possibile parlare di un’età del Risorgimento, ma allora occorre restringere la prospettiva e mettere al fuoco l’Italia e non l’Europa, trattando della storia europea e mondiale quei nessi che modificano la struttura generale dei rapporti di forza internazionale che si opponevano alla formazione di un grande Stato unitario nella penisola, mortificandone le iniziative in questo senso e soffocandole in sul nascere, e quelle correnti che invece dal mondo internazionale influivano in Italia, incoraggiandone le forze autonome e locali della stessa natura e rendendole più valide. Esiste cioè un’Età del Risorgimento nella storia della penisola italiana, non esiste nella storia dell’Europa e del mondo; in questa corrisponde l’Età della Rivoluzione francese e del liberalismo (come è stata trattata dal Croce, in modo manchevole, perché nel quadro del Croce manca la premessa, la rivoluzione in Francia e le guerre di Napoleone, e sono presentate le derivazioni storiche come fatto a sé, autonomo, che ha in sé le proprie ragioni di essere e non come parte di uno stesso nesso storico con la rivoluzione e le guerre napoleoniche).
Sullo sviluppo autonomo di una nuova vita civile e statale in Italia prima del Risorgimento sta preparando un lavoro Raffaele Ciasca. Ne è stata pubblicata l’introduzione: Raffaele Ciasca, Germogli di vita nuova nel 700 italiano (negli «Annali della Facoltà di Filosofia e Lettere della R. Università di Cagliari», 1930‑31), in 8°, pp. 21. Il Ciasca studia la «trasformazione che nel corso del secolo XVIII e specialmente nella seconda metà di esso si va compiendo nella vita di quasi tutte le regioni d’Italia, e che non si limita a riforme frammentarie imposte da principi illuminati e poco sentite dalla popolazione, ma investe tutta la costituzione statale, tutta la struttura economica del paese, tutti i rapporti fra le classi e si manifesta nelle correnti predominanti nel pensiero politico, sociale ed economico» («Nuova Rivista Storica», 1931, p. 577). Le riforme amministrative e finanziarie, la politica ecclesiastica, la storia del pensiero erano già state studiate; il Ciasca porta un contributo nuovo per lo studio della vita economica del tempo.
2. Interpretazioni del Risorgimento italiano. Ne esiste un bel mucchio e il loro studio non è privo di interesse e di significato. Il loro valore è di carattere politico e ideologico, non storico, la portata nazionale è scarsa, sia per la troppa tendenziosità, sia per l’assenza di ogni apporto costruttivo, sia per il carattere troppo astratto, spesso bizzarro e romanzato. Si può vedere che queste interpretazioni fioriscono nei periodi più caratteristici di crisi politico‑sociale e sono conati per determinare una riorganizzazione delle forze politiche esistenti, per suscitare nuove correnti intellettuali nei vecchi organismi di partito, o per esalare sospiri e gemiti di disperazione e di nero pessimismo. Mi pare che tale letteratura possa dividersi provvisoriamente in due grandi gruppi: 1. Quello delle interpretazioni propriamente dette, come sarebbe quella contenuta nella Lotta politica in Italia e negli altri scritti di polemica politica di Alfredo Oriani, che ne ha determinato altre attraverso le opere di Mario Missiroli, come quella di Gobetti e di Guido Dorso. Accanto ad esse le interpretazioni di Curzio Malaparte (sull’Italia barbara; lotta contro la Riforma protestante ecc.); e di Carlo Curcio (L’eredità del Risorgimento, Firenze, La Nuova Italia, 1931, pp. 114, L. 12). Bisogna ricordare gli scritti di F. Montefredini (vedi saggio del Croce in proposito nella Letteratura della nuova Italia) per le «bizzarrie» e quelli di Aldo Ferrari (nella «Nuova Rivista Storica» e in volumi e volumetti) come «bizzarrie» e romanzo nel tempo stesso.
2. Un altro gruppo è rappresentato dal libro di Gaetano Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare pubblicato la prima volta nel 1883 e ristampato nel 1925 (Milano, Soc. An. Istituto Editoriale Scientifico, in 8°, pp. 301, L. 25); dal libro di Pasquale Turiello, Governo e governati; di Leone Carpi, L’Italia vivente; di Luigi Zini, Dei criteri e dei modi di governo; Giorgio Arcoleo, Governo di Gabinetto; Marco Minghetti, I partiti politici e la loro influenza nella giustizia e nell’amministrazione; libri di stranieri come quello del Laveleye, Lettere d’Italia; di von Loher, La nuova Italia, e anche del Brachet, L’Italie qu’on voit et l’Italie qu’on ne voit pas; oltre ad articoli della «Nuova Antologia» (e della «Rassegna settimanale» di Sonnino ecc.), di P. Villari, di R. Bonghi, del Palma, ecc. (fino all’articolo del Sonnino Torniamo allo Statulo!). Questa letteratura è una conseguenza della caduta della Destra, dell’avvento al potere della Sinistra e delle innovazioni «di fatto» introdotte nel regime parlamentare. In gran parte sono lamentele, recriminazioni, giudizi pessimistici e catastrofici sulla situazione italiana. Di questo fenomeno parla il Croce nei primi capitoli della sua Storia d’Italia dal 1871 al 1915. Ad essa fa pendant la letteratura degli epigoni del Partito d'Azione (tipico il libro di Luigi Anelli stampato recentemente da Arcangelo Ghisleri) sia in volumi, che in opuscoli e in articoli di riviste.
Si può osservare questo nesso tra le varie epoche di tale attività pseudo critica: 1) letteratura dovuta a elementi conservatori, furiosi per la caduta della Destra e della Consorteria (cioè per la diminuita importanza nella vita statale dei grandi proprietari terrieri e dell’aristocrazia, ché di una sostituzione di classe non si può parlare), legatosa, biliosa, acrimoniosa, senza elementi costruttivi, perché nel passato non esiste nessun punto di riferimento reazionario che possa proporsi di restaurare con un certo pudore e qualche dignità; nel passato ci sono i vecchi regimi regionali, l’influenza del Papa e dell’Austria. L’accusa che il regime parlamentare è «copiato» da altre nazioni, non è italiano, ecc., rimane una vuota recriminazione senza costrutto: il riferimento a una «tradizione» italiana di governo è necessariamente vago e astratto, poiché questa tradizione non ha prospettive storicamente apprezzabili: in tutto il passato non è esistita mai una unità territoriale‑statale italiana, la prospettiva dell’egemonia papale (propria del Medio Evo e fino al periodo dei domini stranieri) è già stata travolta col neoguelfismo. (Vediamo infatti che infine questa prospettiva sarà trovata nell’epoca romana, con ondeggiamenti, secondo i partiti, tra la Roma repubblicana e la Roma cesarea, ma il fatto avrà un nuovo significato e sarà caratteristico di nuovi indirizzi delle ideologie popolari).
Questa letteratura precede quella del gruppo Oriani‑Missiroli, che ha un significato più popolare‑nazionale e questa precede quella del gruppo Gobetti‑Dorso che ha ancora un altro significato più attuale. In ogni modo anche queste due nuove tendenze mantengono un carattere astratto e letterario: uno dei punti più interessanti è il problema della mancanza di una riforma protestante o religiosa in Italia, che è visto in modo meccanico ed esteriore e ripete uno dei canoni storici del Masaryk nei suoi studi di storia della Russia.
Tutta questa letteratura ha una importanza «documentaria» per i tempi in cui è apparsa. I libri dei «destri» dipingono la corruzione politica e morale nel periodo della sinistra ma la letteratura degli epigoni del Partito d'Azione non presenta come molto migliore il periodo del governo della destra. Risulta che non c’è stato nessun cambiamento essenziale nel passaggio dalla Destra alla Sinistra: il marasma in cui si trova il paese non è dovuto al regime parlamentare (che forse rende solo pubblico ciò che prima rimaneva nascosto o quasi) ma alla debolezza generale della classe dirigente, e alla grande miseria del paese. Politicamente la situazione è assurda: a destra stanno i clericali, il partito del Sillabo, che negano in tronco tutta la civiltà moderna e boicottano lo Stato, impedendo che si costituisca un vasto partito conservatore; nel centro stanno tutte le gamme liberali, dai moderati ai repubblicani, sui quali operano tutti i ricordi degli odi dei tempi delle lotte e che si dilaniano implacabilmente; a sinistra il paese misero, arretrato, ignorante, esprime sia pure in forma sporadica una serie di tendenze sovversive anarcoidi, senza consistenza e indirizzo politico, che mantengono uno stato febbrile senza avvenire costruttivo. Non esiste un «partito economico», ma dei gruppi di ideologi declassés di tutte le classi: galli che annunziano un sole che mai non sorgerà.
I libri del gruppo Mosca‑Turiello incominciavano a essere rimessi in voga negli anni precedenti alla guerra (si può vedere nella «Voce» il richiamo continuo al Turiello) e il libro di Mosca fu ristampato nel 1925 con qualche nota dell’autore per ricordare che si tratta di idee del 1883 e che l’autore nel ’25 non è più d’accordo con lo scrittore ventiquattrenne del 1883. La ristampa del libro del Mosca è uno dei tanti episodi dell’incoscienza e del dilettantismo politico dei liberali nel primo e secondo dopoguerra. Il libro è rozzo, incondito, scritto affrettatamente da un giovane che vuole «distinguersi» nel suo tempo con un atteggiamento estremista e con parole grosse e spesso triviali in senso reazionario. I concetti politici dell’autore sono vaghi e ondeggianti, la sua preparazione filosofica è nulla (e tale è rimasta in tutta la carriera letteraria del Mosca), i suoi principi di tecnica politica sono anch’essi vaghi e astratti e hanno carattere piuttosto giuridico. Il concetto di «classe politica», la cui affermazione diventerà il centro di tutti gli scritti di scienza politica del Mosca, è di estrema labilità e non è ragionato né giustificato teoricamente. Tuttavia il libro del Mosca è utile come documento. L’autore vuole essere spregiudicato per programma, non avere peli sulla lingua e così finisce per mettere in vista molti aspetti della vita italiana del tempo, che altrimenti non trovano documento. Sulla burocrazia civile e militare, sulla polizia ecc. egli offre dei quadri talvolta di maniera, ma con una sostanza di verità (per esempio sui sottufficiali nell’esercito, sui delegati di pubblica sicurezza ecc.). Le sue osservazioni sono specialmente valide per la Sicilia, per l’esperienza diretta del Mosca di quell’ambiente. Nel 1925 il Mosca aveva cambiato punti di vista e prospettive, il suo materiale era sorpassato, tuttavia egli ristampò il libro per vanità letteraria, pensando di immunizzarlo con qualche rella palinodica.
Bibliografia Sulla situazione politica italiana proprio nel 1883 e sull’atteggiamento dei clericali si può trovare qualche spunto interessante nel libro del Maresciallo Lyautey Lettres de Jeunesse, Parigi, Grasset (1931). Secondo il Lyautey molti italiani, tra i più devoti al Vaticano non credevano nell’avvenire del regno; ne prevedevano la decomposizione, da cui sarebbe nata un’Alta Italia con Firenze capitale, un’Italia meridionale con capitale Napoli, e Roma in mezzo, con sbocco al mare. Sull’esercito italiano d’allora, che in Francia era poco apprezzato, il Lyautey riferisce il giudizio del conte di Chambord: «Ne vous y trompez pas. Tout ce que j’en sais (dell’esercito italiano), me la (armée) fait juger très sérieuse, très digne d’attention. Sous leurs façons un peu théâtrales et leurs plumets, les officiers y sont fort instruits, fort appliqués. C’est d’ailleurs l’opinion de mon neveu de Parme qui n’est pas payé pour les aimer».
Q9 §90 Le sètte nel Risorgimento. Cfr Pellegrino Nicolli, La Carboneria in Italia, Vicenza, Edizioni Cristofari (1931). Il Nicolli cerca di distinguere nella Carboneria le diverse correnti, che spesso la componevano, e di dare un quadro delle diverse sètte che pullularono in Italia nella prima parte del secolo XIX. Dal «Marzocco» del 25 ottobre 1931 che recensisce la pubblicazione del Nicolli, riporto questo brano: «È un groviglio di nomi strani, di emblemi, di riti, di cui si ignorano il più delle volte le origini; un confuso mescolarsi di propositi disparati, che variano non soltanto da società a società, ma nella stessa società, la quale, secondo i tempi e le circostanze, muta metodi e programmi. Dal vago sentimento nazionale si arriva alle aberrazioni del comunismo e, per converso, si hanno sètte che, ispirandosi agli stessi sistemi dei rivoluzionari, assumono la difesa del trono e dell’altare. Sembra che rivoluzione e reazione abbiano bisogno di battersi in un campo chiuso, dove non penetra occhio profano, tramando congiure al lume di fiaccole fumose e maneggiando pugnali. Un filo che ci guidi in mezzo a questo labirinto non c’è ed è vano chiederlo al Nicolli, che pure ha fatto del suo meglio per trovarlo. Si tenga anche soltanto presente la Carboneria, che è in certo modo il gran fiume nel quale convogliano tutte le altre società segrete». Il Nicolli si è proposto di «raccogliere sinteticamente quanto da valenti storici è stato finora scritto» sulle società segrete nel Risorgimento.
Q9 §91 2. Interpretazioni del Risorgimento. Bisogna ricordare anche lo scritto di Vincenzo Cardarelli Parole all’Italia (ediz. Vallecchi, 1931).
Q9 §92 Correnti popolari nel Risorgimento (storia delle classi subalterne). Carlo Bini. (Cfr Le più belle pagine di Carlo Bini raccolte da Dino Provenzal). Giovanni Rabizzani in uno studio su Lorenzo Sterne in Italia (forse in edizione di Rocco Carabba di raccolta di brani dello Sterne sull’Italia nella collezione – di prima della guerra – dell’«Italia negli scrittori stranieri») ricorda il Bini e rileva un notevole contrasto tra i due: lo Sterne più inclinato alle analisi sentimentali e meno scettico, il Bini più attento ai problemi sociali, tanto che il Rabizzani lo chiama addirittura socialista. In ogni caso è da notare che Livorno fu delle pochissime città (se non la sola) che nel 48‑49 vide un profondo movimento popolare, un intervento di masse che ebbe vaste ripercussioni in tutta la Toscana e che mosse a spavento i gruppi moderati e conservatori (ricordare le Memorie di Giuseppe Giusti). Il Bini è da vedere perciò, accanto al Montanelli, anche nel quadro del 1849 toscano.
Q9 §93 Risorgimento e quistione orientale. In una serie di scritti si dà importanza alle manifestazioni letterarie nel periodo del Risorgimento in cui la quistione orientale è concepita in funzione dei problemi italiani. Disegno di inorientamento e balcanizzazione dell’Austria per compensarla del Lombardo‑Veneto perduto a profitto della rinascita nazionale italiana. Non mi pare che questi disegni siano prova di grande capacità politica, come si pretende. Mi pare che debbano essere interpretati come sintomi di passività politica e di scoraggiamento di fronte alle difficoltà dell’impresa nazionale, scoraggiamento che si vela di disegni tanto più grandiosi quanto più astratti e vaghi in quanto non dipendeva dalle forze italiane di portarli a compimento. Poiché «balcanizzare» l’Austria significava poi creare una situazione politico‑diplomatica europea (e implicitamente militare) in forza della quale l’Austria si fosse lasciata «balcanizzare»; significava cioè avere l’egemonia politica e diplomatica dell’Europa; una cosa da nulla, come si vede. Non si vede perché l’Austria non potesse, conservando il Lombardo‑Veneto, cioè la supremazia in Italia e una posizione dominante nel Mediterraneo centrale, conquistare anche una maggiore influenza nei Balcani e quindi nel Mediterraneo orientale. Questo anzi sarebbe stato l’interesse dell’Inghilterra, che basava sull’Austria un sistema di equilibrio europeo contro la Francia e contro la Russia. Ma lo stesso scarso sentimento di iniziativa politica autonoma e la sfiducia nelle proprie forze che erano implicate nel disegno del Balbo, dovevano rendere sorda l’Inghilterra a tali disegni.
Solo un forte Stato italiano che avesse potuto sostituire l’Austria nella sua funzione antifrancese nell’Europa centrale e nel Mediterraneo centrale avrebbe potuto muovere l’Inghilterra a simpatie italiane, come avvenne infatti dopo la politica delle annessioni nell’Italia centrale e l’impresa dei Mille contro i Borboni (cioè, prima dei fatti reali, solo un grande partito pieno di audacia e sicuro delle proprie mosse perché radicato nelle aspirazioni delle grandi masse popolari avrebbe ottenuto forse lo stesso risultatoIntegrato secondo il testo C., ma ciò appunto non esisteva, e il Balbo coi suoi amici non volevano che si formasse). La balcanizzazione dell’Austria dopo la perdita dell’egemonia nella penisola italiana, avrebbe avuto conseguenze gravi per la politica inglese nel Mediterranco. Lo Stato napoletano sarebbe diventato un feudo russo, cioè la Russia avrebbe avuto la possibilità di un’azione politica militare di primo ordine proprio nel centro del Mediterraneo. (La quistione dei rapporti tra i Borboni di Napoli e lo Zarismo è tutto un aspetto della storia dal 1799 al 1860 da studiare e approfondire: dal libro di Nitti sul Capitale straniero in Italia stampato nel 1915 dai Laterza, si vede che ancora prima della guerra esistevano nell’Italia Meridionale per circa 150 milioni di lire di obbligazioni statali russe, ciò che indica il residuo di un lavorio non trascurabile di connessione tra l’Italia meridionale e la Russia). Non bisogna dimenticare che la Quistione d’oriente non ha le sue essenziali ragioni di essere nei Balcani e in Turchia, ma è la forma politico‑diplomatica della lotta tra Inghilterra e Russia: è la quistione dell’India, la quistione del Mediterraneo, la quistione dell’Asia prossima e centrale, la quistione dell’Impero inglese ecc.
Il libro in cui il Balbo sosteneva la sua tesi, Le speranze d’Italia, fu pubblicato nel 1844 e la tesi stessa non ebbe nessun’altra efficacia se non quella di far conoscere la quistione orientale attirando l’attenzione su di essa e quindi di facilitare (forse) la politica del Cavour a proposito della guerra di Crimea. Non ebbe nessuna efficacia nel 59 (quando il Piemonte e l’Italia pensarono di suscitare nemici all’Austria nei Balcani per illanguidirne la forza militare) perché questa azione fu circoscritta, di poco respiro e in ogni caso si ridusse a un episodio di organizzazione dell’attività militare franco‑piemontese in Italia: lo stesso si dica per il 1866, quando qualcosa di simile fu pensato dal governo italiano e da Bismarck per la guerra contro l’Austria. Cercare, in caso di guerra, di indebolire il nemico suscitandogli nemici all’interno e su tutto il perimetro dei confini politico‑militari non è elemento di un piano politico per l’Oriente, ma fatto di ordinaria amministrazione della guerra. Del resto, dopo il 60 e la formazione di uno Stato italiano di notevole importanza, l’inorientamento dell’Austria aveva un ben diverso significato internazionale e trovava consenziente tanto l’Inghilterra che la Francia napoleonica.
Q9 §94 Bibliografia. Gli scritti del padre Curci, dopo la sua conversione al cattolicesimo liberale, sono utili per stabilire la situazione intorno al 1880. La conversione del Curci, celebre e battagliero gesuita della «Civiltà Cattolica», rappresenta forse, dopo il 1870, il più gran colpo ricevuto dalla politica vaticana di boicottaggio del nuovo Stato unitario e l’inizio di quel processo molecolare che trasformerà il mondo cattolico fino alla fondazione del Partito Popolare. Scritti del nuovo periodo nell’attività del padre Carlo Maria Curci: Il moderno dissidio tra la Chiesa e l’Italia, considerato per occasione di un fatto particolare, IIa ed. migliorata ed accresciuta, in 8°, pp. XII‑276, 1878, L. 4,50; La nuova Italia e i vecchi zelanti. Studi utili ancora all’ordinamento dei partiti parlamentari, in 8°, pp. VIII‑256, 1881, L. 5,25; Il Vaticano Regio, tarlo superstite della Chiesa Cattolica. Studi dedicati al giovane clero ed al laicato credente, in 8°, pp. VIII-336, 1883, L. 4,50; Lo scandalo del «Vaticano Regio», duce la Provvidenza, buono a qualcbe cosa, in 8°, pp. XVI‑136, 1884, L. 2,25 (questi libri sono ancora in vendita presso l’Utet di Torino, secondo il catalogo del 1928).
Q9 §95 Argomenti di coltura. La tendenza a diminuir l’avversario. (cfr Quad. I, p. 48 bis). Cfr il cap. XIV della seconda parte del Don Chisciotte. Il cavaliere degli Specchi sostiene di aver vinto Don Chisciotte: «y héchole confesar que es más hermosa mi Casildea que su Dulcinea; y en solo este vencimiento hago cuenta que he vencido á todos los caballeros del mundo, porque el tal Don Quijote que digo, los ha vencido á todos; y habiéndole yo vencido á él, su gloria, su fama, y su honra, se ha tranferido y pasado á mi persona,
Y tanto el vencedor es más honrado
cuanto más el vencido es reputado;
así que ya corren por mi cuenta y son m’as las innumerables hazañas del ya referido Don Quijote».
Q9 §96 Caratteri popolareschi del Risorgimento. Volontari e intervento popolare. Nel numero del 24 maggio di «Gioventù Fascista» (riportato dal «Corriere» del 21 maggio 1932) è pubblicato questo messaggio dell’on. Balbo: «Le creazioni originali della storia e della civiltà italiana, dal giorno in cui risorse dal letargo secolare ad oggi, sono dovute al volontariato della giovinezza. La santa canaglia di Garibaldi, l’eroico interventismo del ’15, le Camicie Nere della Rivoluzione fascista hanno dato unità e potenza all’Italia: hanno fatto, di un popolo disperso, una nazione. Alle generazioni che ora si affacciano alla vita sotto il segno del Littorio, il compito di dare al secolo nuovo il nome di Roma». L’affermazione centrale dell’on. Balbo, che l’Italia moderna è caratterizzata dal volontariato, è giusta (si può aggiungere l’arditismo di guerra), ma occorre notare che il volontariato, pur nel suo pregio storico che non può essere diminuito, è stato un surrogato dell’intervento popolare, e in questo senso è una soluzione di compromesso con la passività delle grandi masse. Volontariato‑passività vanno insieme più di quanto si creda. La soluzione col volontariato è una soluzione di autorità, legittimata «formalmente» da un consenso, come si dice, dei «migliori». Ma per costruire storia duratura non bastano i «migliori», occorrono le più vaste e numerose energie nazionali‑popolari.
Q9 §97 Marx‑Engels e l’Italia. Una raccolta sistematica di tutti gli scritti (anche dell’epistolario) che riguardano l’Italia e considerano problemi italiani. Ma una raccolta che si limitasse a questa scelta non sarebbe organica e compiuta. Esistono scritti di Marx ed Engels che pure non riguardando specificatamente l’Italia, hanno importanza per l’Italia, importanza non generica, s’intende, perché altrimenti tutte le opere dei due scrittori riguardano l’Italia. Il piano dell’opera potrebbe essere costruito secondo questi criteri: 1) scritti che riguardano specificatamente l’Italia; 2) scritti che riguardano argomenti «specifici» di critica storica e politica, che pur non riguardando l’Italia, hanno attinenza coll’Italia. Esempi: l’articolo sulla costituzione spagnola del 1812 ha attinenza con l’ltalia, per la funzione politica che tale costituzione ha avuto nei movimenti italiani fino al 48. Così ha attinenze con l’Italia la critica della Miseria della filosofia contro la falsificazione della dialettica hegeliana fatta da Proudhon, che corrisponde a corrispondenti movimenti intellettuali italiani (Gioberti, l’hegelismo dei moderati, rivoluzione passiva, dialettica di rivoluzione, restaurazione). Così lo scritto di Engels sui movimenti libertari spagnoli del 1873 (dopo l’abdicazione di Amedeo di Savoia) ha attinenza con l’Italia ecc. Forse di questa seconda serie di scritti non bisogna fare l’antologia, ma è sufficiente uno studio analitico‑ critico. Ma il piano più organico sarebbe quello di tre volumi: introduzione storico‑critica generale; scritti sull’Italia; scritti attinenti indirettamente l’Italia.
Q9 §98 Mazzini e Garibaldi. Cfr l’articolo di A. Luzio nel «Corriere della Sera» del 31 maggio 1932, Garibaldi e Mazzini.
Q9 §99 1. L’età del Risorgimento dell’Omodeo e le origini dell’Italia moderna. Cosa significa o può significare il fatto che l’Omodeo inizia la sua narrazione dalla pace di Aquisgrana, che pose termine alla guerra per la successione di Spagna? L’Omodeo non «ragiona» questo suo criterio metodico, non mostra che esso sia l’espressione del fatto che un determinato nesso storico europeo è nello stesso tempo nesso storico italiano, necessariamente da inserire nello sviluppo della vita nazionale italiana. Questo può e deve invece essere «dichiarato». La personalità nazionale (come la personalità individuale) è un’astrazione fuori del nesso internazionale (e sociale). La personalità nazionale esprime un «distinto» del complesso internazionale, pertanto è legata ai rapporti internazionali. C’è un periodo di dominio straniero in Italia, diretto per un certo tempo, di carattere egemonico posteriormente (o misto, di dominio straniero e di egemonia). La caduta dell’Italia sotto la dominazione straniera nel Cinquecento aveva già provocato come reazione l’indirizzo politico, nazionale‑democratico, del Machiavelli, che esprimeva nello stesso tempo il rimpianto per la perduta indipendenza in una determinata forma (equilibrio interno fra gli Stati italiani sotto l’egemonia della Firenze di Lorenzo il Magnifico) e la volontà iniziale di lottare per riacquistarla in una forma storicamente superiore, come monarchia assoluta nazionale sul tipo della Spagna e della Francia. Nel Settecento l’equilibrio europeo Austria‑Francia entra in una fase nuova per rispetto all’Italia; c’è un indebolimento reciproco delle due grandi Potenze e sorge una terza grande potenza «la Prussia». Pertanto le origini del moto del Risorgimento, cioè il processo di formazione delle condizioni e dei rapporti internazionali che permetteranno all’Italia di riunirsi in nazione e alle forze interne nazionali di svilupparsi ed espandersi, non sarà da ricercare in questo o quell’evento concreto registrato sotto una o l’altra data, ma appunto nello stesso processo storico di trasformazione del precedente sistema europeo.
Questo processo intanto non è indipendente dai fatti interni italiani; un elemento importante e talvolta decisivo dei sistemi europei era sempre stato il Papato. Nel corso del Settecento l’indebolimento della posizione del Papato come potenza europea è addirittura catastrofico. Colla Controriforma il Papato aveva modificato essenzialmente la struttura della sua potenza: si era allontanato dalle masse popolari, si era fatto fautore di guerre europee sterminatrici, si era confuso con le classi dominanti in modo irrimediabile. Aveva perduto perciò la capacità di dominare indirettamente sulle classi dirigenti attraverso la sua influenza sulle classi popolari fanatiche e fanatizzate: è notevole che proprio mentre il Bellarmino elaborava la sua teoria del dominio indiretto della Chiesa, la Chiesa con la sua attività concreta, distruggeva le condizioni di ogni suo dominio e specialmente del dominio indiretto, staccandosi dalle classi popolari. La politica regalista delle monarchie illuminate è questa esautorazione della Chiesa come potenza europea e quindi italiana, e inizia anch’essa il Risorgimento, se è vero, come è vero, che il Risorgimento era in funzione di un indebolimento del Papato sia come potenza europea che come potenza italiana, cioè come possibile forza che riorganizzasse gli Stati della penisola sotto la sua egemonia. Ma sono elementi condizionanti; una dimostrazione storicamente valida, che già nel Settecento si fossero costituite in Italia delle forze che concretamente tendessero a fare della penisola un organismo politico unitario e indipendente, non è stata ancora fatta in modo valido.
Q9 §100 Bibliografia. Francesco Lemmi, Le origini del Risorgimento italiano, Milano, Hoepli. Dello stesso Lemmi, La Bibliografia del Risorgimento italiano, Società Anonima Romana. C. Morandi, Idee e formazioni politiche in Lombardia dal 1748 al 1814, Torino, Bocca. Massimo Lelj, Il Risorgimento dello spirito Italiano (1725-1861), Milano, L’Esame, Edizioni di storia moderna, 1928.
Q9 §101 2. Origini del Risorgimento. Le ricerche sulle origini del moto nazionale del Risorgimento sono quasi sempre viziate dalla tendenziosità politica immediata, non solo da parte degli scrittori italiani, ma anche da parte di quelli stranieri, specialmente francesi. C’è una «dottrina» francese sulle origini del Risorgimento, cioè la nazione italiana deve la sua fortuna alla Francia, ai due Napoleoni e questa dottrina ha anche il suo aspetto negativo‑polemico: i nazionalisti monarchici (Bainville) rimproverano ai Napoleoni di avere indebolito la posizione relativa della Francia in Europa con la loro politica nazionalitaria, cioè di essere stati contro la tradizione e gli interessi della nazione francese, rappresentati dalla monarchia e dai partiti di destra (clericali) sempre antitaliani.
In Italia le quistioni «tendenziali e tendenziose» poste a questo proposito sono: 1) la tesi democratico‑francofila: il moto è dovuto alla Rivoluzione francese, ne è una derivazione, che ha determinato l’opposta tesi: 2) la Rivoluzione francese col suo intervento nella penisola ha interrotto il movimento «veramente» nazionale, tesi che ha un doppio aspetto: quello gesuitico (per cui i sanfedisti erano «nazionalisti») e quello moderato che si riferisce piuttosto ai principi riformatori. Qualcuno poi aggiunge: 3) il movimento riformatore era stato interrotto per la paura degli avvenimenti di Francia, quindi l’intervento degli eserciti francesi in Italia non interruppe il movimento indigeno ma anzi ne rese possibile la ripresa e il compimento.
Questi elementi si trovano svolti in quelle pubblicazioni a cui si è accennato sotto la rubrica di «Interpretazioni del Risorgimento italiano» e che, come si è detto, hanno significato nella storia della cultura politica e non della storiografia.
In un articolo di Gioacchino Volpe, Una scuola per la storia dell’Italia moderna («Corriere della Sera», 9 gennaio 1932) assai notevole, è scritto: «Tutti lo sanno: per capire il “Risorgimento” non basta spingersi al 1815 e neppure al 1796, l’anno in cui Napoleone irruppe nella Penisola e vi suscitò la tempesta. Il “Risorgimento”, come ripresa di vita italiana, come formazione di una nuova borghesia, come consapevolezza crescente di problemi non solo municipali e regionali ma nazionali, come sensibilità a certe esigenze ideali, bisogna cercarlo parecchio prima della Rivoluzione: è anche esso sintomo, uno dei sintomi, di una rivoluzione in marcia, non solo francese, ma, in certo senso, mondiale. Tutti egualmente sanno che la storia del Risorgimento non si studia solo coi documenti italiani e come fatto solamente italiano, ma nel quadro della vita europea; trattisi di correnti di cultura, di trasformazioni economiche, di situazioni internazionali nuove, che sollecitano gli italiani a nuovi pensieri, a nuove attività, a nuovo assetto politico».
Tutto ciò nel libro dell’Omodeo rimane sconnesso ed esteriore. Si ha l’impressione che sia per il titolo, che per l’impostazione cronologica, il libro dell’Omodeo abbia solo voluto fare omaggio alla tendenziosità storica e non alla storia, per ragioni di opportunismo poco chiare e poco lodevoli.
Nel Settecento, mutate le condizioni relative della penisola italiana nel quadro dei rapporti europei, sia per ciò che riguarda la pressione egemonica delle grandi potenze che non potevano permettere il sorgere di uno Stato unitario italiano, sia per ciò che riguarda la posizione di potenza politica (in Italia) e culturale (in Europa) del Papato (e tanto meno le grandi potenze europee potevano permettere uno Stato unificato italiano sotto la supremazia del Papa, cioè permettere che la funzione culturale della Chiesa e la sua diplomazia, già abbastanza ingombranti e limitative del potere statale nei paesi cattolici, si rafforzassero appoggiandosi a un grande Stato territoriale e ad un esercito corrispondente), muta anche l’importanza e il significato della tradizione letterario‑retorica esaltante il passato romano, la gloria dei comuni e del Rinascimento, la funzione universale del Papato italiano. Questa atmosfera culturale italiana finora era rimasta indistinta e generica: essa giovava specialmente al Papato, formava il terreno ideologico della potenza papale nel mondo, l’elemento per la selezione del personale ecclesiastico e laico‑ecclesiastico di cui il Papato aveva bisogno per la sua organizzazione pratica di centralizzazione dell’organismo ecclesiastico, e per tutto l’insieme delle attività politiche, filosofiche, giuridiche, pubblicistiche, culturali, che costituiva la macchina per l’esercizio del «potere indiretto», dopo che nel periodo precedente alla Riforma, era servito all’esercizio del potere diretto, o di quelle funzioni di potere diretto che poterono concretamente attuarsi nei rapporti di forza interni di ogni singolo paese cattolico.
Nel Settecento si inizia un processo di distinzione in questa corrente tradizionale: una parte sempre più coscientemente si connette con l’istituto del Papato come espressione di una funzione intellettuale (etico‑politica di egemonia) dell’Italia nel mondo civile, e finirà con l’esprimere il Primato giobertiano e il neoguelfismo (attraverso una serie di movimenti minori, più o meno equivoci, come il sanfedismo, che sono esaminati nella rubrica dell’«Azione Cattolica» e le sue origini) e con il concretarsi in forma organica, sotto la direzione dello stesso Papato, nel movimento di Azione Cattolica, in cui la funzione dell’Italia come nazione è ridotta al minimo (all’apporto di quella parte del personale centrale vaticano che è italiano, ma non può mettere in prima linea, come una volta, il suo essere italiano); e si sviluppa una parte «laica», anzi in opposizione al Papato, che cerca rivendicare una funzione di primato italiano e di missione italiana nel mondo indipendentemente dal Papato. Questa seconda parte, che non può riferirsi a un organismo ancora così potente come la Chiesa romana, e manca pertanto di un punto di riferimento centralizzatore, non ha la stessa compattezza del primo, ha varie linee spezzate di sviluppo e si può dire confluisca nel mazzinianismo. Ma ciò che è importante storicamente è che nel Settecento questa tradizione incominci a concretarsi e a distinguersi, a muoversi con dialettica intima: significa che questa tradizione letterario‑rettorica sta diventando un elemento politico, sta diventando il suscitare del terreno ideologico in cui le forze politiche effettive riusciranno a determinare lo schieramento delle più grandi masse popolari necessarie per raggiungere i fini loro proprii, riusciranno a mettere in iscacco e il Papato stesso e le altre forze di reazione esistenti nella penisola accanto al Papato. Che il liberalismo sia riuscito a creare la forza cattolico‑liberale e a ottenere che lo stesso Pio IX si ponesse, sia pure per poco, nel terreno del liberalismo (quanto fu sufficiente per disgregare l’apparato politico cattolico e togliergli la fiducia in se stesso) fu il capolavoro politico del Risorgimento e uno dei punti più importanti di risoluzione dei vecchi nodi che avevano impedito fino allora di pensare concretamente alla possibilità di uno Stato unitario italiano. (Se questo elemento della trasformazione della tradizione culturale italiana lo si pone come elemento necessario nello studio delle origini del Risorgimento, e il suo disfacimento è concepito come fatto positivo, come condizione necessaria per il sorgere e lo svilupparsi dell’elemento positivo liberale-nazionale, allora acquistano un certo significato, non trascurabile, movimenti come quello «giansenistico», che altrimenti apparirebbero come mere curiosità da eruditi. Si tratterebbe insomma di uno studio dei «corpi catalitici» nel campo storico‑politico italiano, elementi catalitici che non lasciano traccia di sé, ma hanno avuto una insostituibile funzione strumentale nel creare il nuovo organismo storico).
Q9 §102 Il 1849 a Firenze. Nella «Rassegna Nazionale» Aldo Romano ha pubblicato una lettera di R. Bonghi e una di Cirillo Monzani scritte a Silvio Spaventa nel 1849 da Firenze durante il periodo della dittatura Guerrazzi‑Montanelli (cfr «Marzocco» del 21 febbraio, e quindi si tratterà della «Rassegna Nazionale» del febbraio 1932), che sono interessanti per giudicare quale fosse l’atteggiamento dei moderati verso il periodo democratico della rivoluzione italiana 1848‑49 e anche per trarne qualche elemento obbiettivo di fatto. Colpisce appunto come questi due moderati si mostrino estranei agli avvenimenti, spettatori incuriositi e malevoli e non attori interessati. Ecco un brano del Bonghi, scritto quindici giorni dopo la fuga del Granduca: «La fazione repubblicana intende a rizzare dovunque quell’albero con così poco concorso rizzato a Firenze, insino dalla sera che si seppe il proclama di De Laugier, e mediante l’opera di alcuni livornesi fatti venire a bella posta. Questo rizzamento ha poco o nessun contrasto nelle città principali o più popolose; ma ne ha molto nelle più piccole e moltissimo nelle campagne. Ier sera si voleva rizzare fuori Porta Romana; furori grida di evviva; poi contrasto di chi voleva e di chi non voleva; poi colpi di coltello e fucilate; infine un grande sconquasso. I contadini dei dintorni, credendo che fosse una baldoria che si facesse per il ritorno del granduca, o che fossero già istigati e preparati alla reazione, o comechessia, cominciarono anch’essi a fare gli evviva a Leopoldo II, a tirar fucilate, a cavar bandiere, ad agitar fazzoletti, a sparar mortaletti e cose simili».
Più sintomatico è lo scritto del Monzania, che meglio dà uno scampolo di quella che doveva essere la propaganda disfattista dei moderati: «La cecità e, quel che è peggio, la mala fede, l’astuzia, il raggiro, mi paiono giunti al colmo. Si parla molto di patria, di libertà, ma pochi hanno in cuore la patria, e saprebbero fare estremi sacrifizi, ed esporre le vite a salvamento di essa. Questi santissimi nomi sono purtroppo profanati, ed i più se ne servono come pala ad ottenere o potenza o ricchezza. Forse m’ingannerò, ma l’aspettarsi salvezza da costoro mi parrebbe il medesimo che aspettarla dal turco. Io non sono avvezzo ad illudermi, né a correr dietro ai fantasmi, ché troppo gli italiani si sono lasciati prendere al laccio delle chimere e dalle utopie di certi apostoli, i quali ormai sono troppo dannosi alla nostra disgraziata patria». Le due lettere furono sequestrate allo Spaventa al momento dell’arresto. I Borboni erano troppo arretrati per servirsene contro i liberali, facendole commentare dai loro pennaioli (i Borboni odiavano troppo i pennaioli per averne anche al proprio servizio), si limitarono a passarle agli atti del processo Spaventa. (Tutto lo spirito del Bonghi è riposto in quel continuo ripetere «rizzare» e «rizzamento» alla napoletana!)
Q9 §103 Momenti di vita intensamente collettiva e unitaria nella vita del popolo italiano. Cercare nella storia italiana dal 1800 ad oggi tutti i momenti in cui al popolo italiano si è posto da risolvete un compito potenzialmente comune, in cui avrebbe potuto verificarsi un’azione o un movimento collettivi (in profondità e in complessità) e unitari. Questi momenti, nelle diverse fasi storiche, possono essere stati di diversa natura, di diversa portata e importanza nazionale‑popolare. Ciò che importa nella ricerca è il carattere potenziale (e quindi la misura in cui questa «potenzialità» si è tradotta in atto) di collettività e di unitarietà, cioè la diffusione territoriale (la regione risponde bene a questo carattere, se non addirittura la provincia) e la diffusione di massa (cioè la maggiore o minore moltitudine di partecipanti, la maggiore o minore ripercussione attiva e passiva – o negativa per le reazioni suscitate – che l’azione ha avuto nei diversi strati della popolazione).
Questi momenti possono aver avuto carattere e natura diversa: guerre, rivoluzioni, plebisciti, elezioni generali di particolare importanza e significato. Guerre: 1848, 1859, 1860, 1866, 1870, guerra d’Africa (Eritrea), guerra libica (1911‑12), guerra mondiale (1915‑18). Rivoluzioni: 1820‑21, 1831, 1848‑49, 1860, fasci siciliani, 1898, 1904, 1914, 1919‑20, 1924‑25. Plebisciti per la formazione del Regno: 1859‑60, 1866, 1870. Elezioni generali con diversa misura di suffragio allargato. Elezioni tipiche: quella che porta la Sinistra al potere nel 1876, quella dopo l’allargamento del suffragio dopo il 1880, quella dopo il 1898, per il primo periodo; quella del 1913 è la prima elezione con caratteri popolari spiccati per la larga partecipazione di massa; 1919 è la più importante di tutte per il carattere proporzionale e regionale, che obbliga i partiti a raggrupparsi e perché in tutto il territorio, per la prima volta, si presentano gli stessi partiti con gli stessi (all’ingrosso) programmi. In misura molto maggiore e più organica che nel 1913 (quando il collegio uninominale restringeva le possibilità e falsificava le posizioni politiche di massa) nel 1919 in tutto il territorio, in uno stesso giorno, tutta la parte più attiva del popolo italiano si pone le stesse quistioni e cerca di risolverle nella sua coscienza storico‑politica. Il significato delle elezioni del 1919 è dato dal complesso di elementi «unificatori» che vi confluiscono: la guerra era stata un elemento unificatore di primo ordine in quanto aveva dato la coscienza alle grandi masse dell’importanza che ha per il destino di ogni singolo individuo la costruzione dell’apparato di governo oltre all’aver posto una serie di problemi concreti, generali e particolari, che riflettevano l’unità popolare‑nazionale.
Si può dire che le elezioni del 1919 ebbero per il popolo un carattere di Costituente (questo carattere lo ebbero anche le elezioni del 1913, come può ricordare chiunque abbia assistito alle elezioni nei centri regionali dove maggiore era stata la trasformazione del corpo elettorale e come fu dimostrato dall’alta percentuale di partecipazione attiva: si era diffusa una convinzione mistica che tutto doveva cambiare col voto, di una vera e propria palingenesi sociale; così almeno in Sardegna), quantunque non l’avessero certo per «nessun» partito politico del tempo: in questa contraddizione tra il popolo e i partiti popolari è consistito il dramma storico del 1919, che fu capito immediatamente solo dai gruppi dirigenti più accorti e intelligenti (e che avevano più da temere per il loro futuro). È da notare che proprio il partito tradizionale della costituente in Italia, il partito repubblicano, dimostrò il minimo di sensibilità storica e di capacità politica, e si lasciò imporre il proprio programma e il proprio indirizzo (cioè difesa astratta e retrospettiva dell’intervento in guerra) dalle classi dirigenti. Il popolo, a suo modo, guardava all’avvenire (e in ciò è il carattere implicito di costituente che il popolo diede alle elezioni del 1919); i partiti guardavano al passato (solo al passato) concretamente e all’avvenire «astrattamente», «genericamente», come «abbiate fiducia nel vostro partito» e non come concezione storico‑politica concreta, ricostruttiva. Tra le altre differenze tra le elezioni del 13 e quelle del 19 occorre porre la partecipazione «attiva» dei cattolici, con uomini proprii, con un proprio partito, con un proprio programma. Anche nel 1913 i cattolici parteciparono alle elezioni, ma attraverso il patto Gentiloni, in modo sornione e che in gran parte falsificava lo schieramento e la forza delle potenze politiche tradizionali. Per il 1919 è da ricordare l’atteggiamento dei giolittiani quale risulta dalle campagne di Luigi Ambrosini nella «Stampa» per influenzare i cattolici. In realtà i giolittiani furono «storicamente» i vincitori, nel senso che essi impressero il carattere di costituente senza costituente alle elezioni e riuscirono a tirar gli sguardi dall’avvenire al passato.
Q9 §104 [2]. Tutto il lavorio di interpretazione del passato italiano e la serie di costruzioni ideologiche e di romanzi storici che ne sono derivati è legato alla «pretesa» di trovare un’unità nazionale, almeno di fatto, in tutto il periodo da Roma ad oggi. Come è nata questa pretesa? È un segno di forza o di debolezza? È il riflesso di una formazione sociale nuova, sicura di sé, e che cerca a se stessa e si crea titoli di nobiltà nel passato, oppure è invece il riflesso di «una volontà di credere», un elemento di fanatismo ideologico che deve appunto rimediare alle debolezze di struttura e impedire il tracollo? Mi pare questa la giusta interpretazione, unita al fatto della eccessiva importanza relativa degli intellettuali, cioè dei piccoli borghesi, in confronto delle classi economiche arretrate e politicamente incapaci. La formazione nazionale è sentita come aleatoria, perché forze ignorate, selvagge, elementarmente distruttive si agitano alla sua base. La dittatura di ferro degli intellettuali e di alcuni gruppi urbani con la proprietà turale sulla campagna si mantiene solo unita, sovraeccitandosi con questo mito di fatalità storica, più forte di ogni manchevolezza e ogni inettitudine politica e militare. È su questo terreno che all’adesione popolare‑nazionale allo Stato si sostituisce una selezione di «volontari» della nazione. Nessuno ha pensato che appunto il problema posto da Machiavelli col proclamare la necessità di milizie nazionali contro i mercenari non è risolto finché anche il «volontarismo» non sarà superato dal «fatto popolare‑nazionale», poiché il volontatismo è soluzione intermedia, equivoca, altrettanto pericolosa che il mercenarismo.
Q9 §105 2. La quistione italiana. Cfr i discorsi tenuti dall’on. Grandi al Parlamento sulla politica estera nel 1932 e le discussioni derivate nella stampa italiana ed estera. L’on. Grandi pose la quistione italiana come quistione mondiale, da risolvere insieme alle altre che formano l’espressione politica della crisi iniziata nel 1929 e cioè il problema francese della sicurezza, il problema tedesco della parità dei diritti, il problema dell’assetto degli Stati danubiani e balcanici. Tentativo quindi di costringere ogni possibile Congresso mondiale chiamato a risolvere questi problemi, ad occuparsi della quistione italiana come elemento fondamentale della ricostruzione e pacificazione europea e mondiale. In che consiste la quistione italiana secondo questa impostazione? Consiste nel fatto che l’incremento demografico del paese è in contrasto con la povertà relativa del paese, cioè nell’esistenza di un superpopolamento. Occorrerebbe perciò che all’Italia fosse data la possibilità di espandersi, sia economicamente che demograficamente ecc. Aggiunte necessarie all’analisi della situazione italiana.
Se è vero che i rapporti generali internazionali sono sfavorevoli all’Italia (specialmente il nazionalismo economico che impedisce la libera circolazione del lavoro umano) è anche da domandare se a costruire tali rapporti non contribuisce la stessa politica italiana. La ricerca principale deve essere in questo senso: il basso saggio individuale di reddito nazionale è dovuto alla povertà «naturale» del paese oppure a fattori storico‑sociali creati e mantenuti da un determinato indirizzo politico? Lo Stato, cioè, non costa troppo caro, intendendo per Stato non solo l’amministrazione dei servizi statali, ma anche l’insieme delle classi che lo compongono e lo dominano? E, pertanto, è possibile pensare che senza un mutamento di questi rapporti interni, la situazione possa mutarsi anche se internazionalmente i rapporti migliorassero? E la proiezione nel campo internazionale della quistione non è forse un mezzo per crearsi un alibi di fronte alle grandi masse del paese?
Che il reddito nazionale sia basso può concedersi, ma non viene poi esso in gran parte distrutto (divorato) da troppa popolazione passiva, rendendo impossibile ogni capitalizzazione progressiva sia pure con ritmo rallentato? Dunque la quistione demografica deve essere a sua volta analizzata e occorre fissare se la composizione demografica sia «sana» anche per un regime capitalistico e di proprietà. La povertà relativa dei singoli paesi, nella civiltà moderna, ha un’importanza relativa: tutt’al più impedirà certi profitti marginali di «posizione» geografica. La ricchezza è data dalla divisione internazionale del lavoro, e dall’aver saputo selezionare tra le possibilità che questa divisione offre, quella più redditizia. Si tratta dunque anche di «capacità direttiva» della classe dirigente economica, del suo spirito di iniziativa e di organizzazione. Se queste qualità mancano, esse non possono essere sostituite da nessun accordo internazionale. Non si ha esempio, nella storia moderna, di colonie di «popolamento». Esse non esistono. L’emigrazione e la colonizzazione seguono il flusso di capitali investiti nei vari paesi e non viceversa. La crisi attuale, che si verifica specialmente come caduta dei prezzi delle materie prime e dei cereali, mostra che il problema non è di «ricchezza naturale» per i vari paesi del mondo, ma di organizzazione sociale e di trasformazione delle materie prime per certi scopi e non per altri.
Che si tratti di organizzazione e di indirizzo politico‑economico appare dal fatto che ogni paese ha avuto «emigrazione» in certe fasi del suo sviluppo economico, ma tale emigrazione è poi stata riassorbita, o almeno è cessata. Che non si vogliano mutare i rapporti interni e neppure rettificarli razionalmente (o che non si possa) si vede dalla politica del debito pubblico, che aumenta continuamente il peso della passività demografica, proprio quando la parte attiva della popolazione è ristretta dalla disoccupazione e dalla crisi. Diminuisce il reddito nazionale, aumentano i parassiti, il risparmio si restringe ed è, anche così ristretto, riversato nel debito pubblico, cioè fatto causa di nuovo parassitismo relativo e assoluto.
Q9 §106 2. Storia feticistica. Si potrebbe chiamare così il modo di rappresentare gli avvenimenti storici nelle «interpretazioni» ideologiche della formazione italiana, per cui diventano protagonisti dei personaggi astratti e mitologici. Nella Lotta politica di Oriani si ha il più popolare di questi schemi mitologici, quello che ha prodotto e partorito una più lunga serie di figli degeneri. Vi troviamo la Federazione l’Unità, la Rivoluzione, l’Italia ecc. ecc. Nell’Oriani è chiara una delle cause di questo modo di concepire la storia. Il canone di ricerca che gli avvenimenti successivi gettano luce su quelli precedenti, che cioè tutto il processo storico è un «documento» storico di se stesso, viene meccanizzato ed esteriorizzato e ridotto, in fondo, a una legge deterministica di «rettilineità» e di «unilinearità». Il problema di ricercare le origini storiche di un fatto concreto e circostanziato, la formazione dello Stato moderno italiano nel secolo XIX, viene trasformato in quello di vedere questo «Stato», come unità o come nazione o genericamente come Italia, in tutta la storia precedente, come il pollo nell’uovo fecondato.
Per questa trattazione sono da vedere le osservazioni critiche di Antonio Labriola negli Scritti vari (pp. 487‑90; pp. 317‑442 passim, e nel primo dei Saggi sul materialismo storico pp. 50‑52). (Su questo punto vedi anche Croce, Storia della storiografia, II, pp. 227‑28 e in tutto questo lavoro lo studio dell’origine «sentimentale e poetica» e «la critica impossibilità» di una «Storia generale d’Italia»). Altre osservazioni connesse a queste sono quelle di A. Labriola a proposito di una storia generale del Cristianesimo, che al Labriola sembrava inconsistente come tutte le costruzioni storiche che assumono a soggetto enti inesistenti (III Saggio, p. 113).
Una reazione concreta nel senso indicato dal Labriola si può vedere negli scritti storici del Salvemini, il quale non vuol sapere di «guelfi» e «ghibellini», uno partito della nobiltà e dell’impero, e l’altro del popolo e del papato, perché egli li conosce solo come «partiti locali», combattenti per ragioni affatto locali, che non coincidevano con quelle del Papato e dell’Impero. Nella prefazione al suo volume della Rivoluzione francese si può vedere teorizzato questo atteggiamento del Salvemini con tutte le esagerazioni antistoriche che porta con sé. «L’innumerevole varietà degli eventi rivoluzionari» si suole attribuire in blocco a un ente «Rivoluzione», invece di «assegnare ciascun fatto all’individuo o ai gruppi d’individui reali, che ne furono autori». Ma se la storia si riducesse solo a questa ricerca, sarebbe ben misera cosa e diventerebbe, tra l’altro, incomprensibile. Sarà da vedere come il Salvemini concretamente risolve le incongruenze che risultano dalla sua impostazione troppo unilaterale del problema metodologico, tenendo conto di questa cautela critica: se non si conoscesse da altre opere la storia qui raccontata, e avessimo solo questo libro, ci sarebbe essa storia comprensibile ? Cioè si tratta di una storia «integrale» o di una storia «polemica» che si propone solo (o ottiene senza proporselo, necessariamente) di aggiungere qualche pennellata a un quadro già abbozzato da altri? Questa cautela dovrebbe sempre essere presente in ogni critica, poiché infatti spesso si ha che fare con opere che da «sole» non sarebbero soddisfacenti, ma che sono molto utili nel quadro generale di una determinata cultura, come «integrative» di altri lavori o ricerche.
Q9 §107 2. Adolfo Omodeo. Cfr «Critica» del 20 luglio 1932 p. 280: «Ai patrioti offriva la tesi che allora aveva rimessa in circolazione il Salvemini: della storia del Risorgimento come piccola storia, non sufficientemente irrorata di sangue; dell’unità, dono più di una propizia fortuna che meritato acquisto degli italiani; del Risorgimento, opera di minoranze contro l’apatia della maggioranza. Questa tesi generata dall’incapacità del materialismo storico di apprezzare in sé la grandezza morale, senza la statistica empirica delle bigonce di sangue versato e il computo degli interessi (aveva una speciosità facile ed era destinata a correre per tutte le riviste e i giornali, e a far denigrare dagli ignoranti l’opera dura del Mazzini e del Cavour), questa tesi serviva di base al Marconi per un’argomentazione moralistica di stile vociano». (L’Omodeo scrive di Piero Marconi morto nella guerra, e della sua pubblicazione Io udii il comandamento, Firenze, senza data).
Ma l’Omodeo, nel suo libro L’età del Risorgimento non è riuscito a dare una interpretazione e una ricostruzione che non sia estrinseca e di parata. Che il Risorgimento sia stato l’apporto italiano al grande movimento europeo del secolo XIX non dimostra che l’egemonia del movimento fosse in Italia. Del resto si può osservare: se la storia del passato non si può non scrivere con gli interessi e per gli interessi attuali, la formula critica che bisogna fare la storia di ciò che il Risorgimento è stato concretamente non è insufficiente e troppo ristretta? Spiegare come il Risorgimento si è fatto concretamente, quali sono le fasi del processo storico necessario che hanno culminato in quel determinato evento è un nuovo modo di ripresentare la così detta «obbiettività» esterna e meccanica. Si tratta spesso di una rivendicazione «politica» di chi è soddisfatto e nel «processo» al passato vede giustamente un processo al presente, una critica al presente. Del resto queste discussioni, in quanto sono puramente di metodologia empirica, sono inconclusive.
E se scrivere storia significa fare storia presente, è grande libro di storia quello che nel presente crea forze in isviluppo più consapevoli di se stesse e quindi più concretamente attive e fattive. Il difetto massimo di tutte queste interpretazioni ideologiche del Risorgimento italiano consiste nel fatto che esse sono state meramente ideologiche, cioè che non si rivolgevano a forze politiche attuali concrete. Lavori di letteratura, dilettantesche costruzioni ad opera di gente che voleva far sfoggio di intelligenza o di talento: oppure rivolte a piccole cricche intellettuali senza avvenire, oppure scritte per giustificare forze reazionarie, imprestando loro intenzioni che non avevano e fini immaginari, e quindi cioè piccoli servizi da lacché intellettuali (il tipo più compiuto di questi lacché è il Missiroli) e da mercenari della scienza.
Queste interpretazioni ideologiche della formazione nazionale e statale italiana sono da studiare anche da questo punto di vista: il loro succedersi «acritico» per spinte individuali di personalità più o meno «geniali» è un documento della primitività dei partiti politici italiani, dell’empirismo immediato di ogni azione costruttiva (compresa quella dello Stato), dell’assenza nella vita italiana di ogni movimento «vertebrato» che abbia in sé possibilità di sviluppo permanente e continuo. La mancanza di prospettiva storica nei programmi di partito, prospettiva ricostruita «scientificamente», cioè con serietà scrupolosa, per basare su tutto il passato i fini da raggiungere nell’avvenire e da proporre al popolo come una necessità cui collaborare consapevolmente, ha permesso appunto il fiorire di tanti romanzi ideologici, che sono in realtà la premessa di un movimento politico che si suppone astrattamente necessario, ma per creare il quale in realtà non si fa niente di pratico. È questo un fenomeno molto utile per facilitare le «operazioni» di quelle che spesso si chiamano le «forze occulte» o «irresponsabili», che operano attraverso i «giornali indipendenti», creano «artificialmente» moti d’opinione occasionali, mantenuti in vita fino al raggiungimento di un determinato scopo e poi lasciati illanguidire e morire. Sono appunto «compagnie di ventura» ideologiche, pronte a servire i gruppi plutocratici o d’altra natura, spesso appunto fingendo di lottare contro la plutocrazia. Organizzatore tipico di tali «compagnie» è stato Pippo Naldi, discepolo anch’egli di Oriani e organizzatore dei giornali di M. Missiroli.
Q9 §108 2. Origini del Risorgimento. Alberto Pingaud, autore di un libro su Bonaparte, président de la Republique Italienne e che sta preparando un altro libro su Le premier Royaume d’Italie (che è già stato pubblicato quasi tutto sparsamente in diversi periodici) è tra quelli che «collocano nel 1814 il punto di partenza e in Lombardia il focolare del movimento politico che ebbe termine nel 1870 con la presa di Roma». Baldo Peroni, che nella «Nuova Antologia» del 16 agosto 1932 passa in rassegna questi scritti ancora sparsi del Pingaud, osserva: «Il nostro Risorgimento – inteso come risveglio politico – comincia quando l’amor di patria cessa di essere una vaga aspirazione sentimentale o un motivo letterario e diventa pensiero consapevole, passione che tende a tradursi in realtà mediante un’azione che si svolge con continuità e non s’arresta dinanzi ai più duri sacrifici. Ora, siffatta trasformazione è già avvenuta nell’ultimo decennio del settecento, e non soltanto in Lombardia ma anche a Napoli, in Piemonte; in quasi tutte le regioni d’Italia. I “patrioti” che tra l’89 e il ’96 sono mandati in esilio o salgono il patibolo, hanno cospirato, oltre che per istaurare la repubblica, anche per dare all’Italia indipendenza e unità; e negli anni successivi è l’amore dell’indipendenza che ispira e anima l’attività di tutta la classe politica italiana, sia che collabori coi francesi e sia che tenti dei moti insurrezionali allorché appare evidente che Napoleone non vuol concedere la libertà solennemente promessa».
Il Peroni, in ogni modo, non ritiene che il moto italiano sia da ricercarsi prima del 1789, cioè afferma una dipendenza del Risorgimento dalla Rivoluzione francese, tesi che non è accettata dalla storiografia nazionalistica. Tuttavia appare vero quanto il Peroni afferma, se si considera il fatto specifico e di importanza decisiva, della formazione di un gruppo politico che si svilupperà fino alla formazione dell’insieme dei partiti che saranno i protagonisti del Risorgimento. Se nel caso del Settecento incominciano ad apparire e a consolidarsi le condizioni obbiettive, internazionali e nazionali, che fanno dell’unificazione nazionale un compito storicamente concreto (cioè non solo possibile ma necessario) è certo che solo dopo l’89 questo compito diventa consapevole in gruppi di uomini disposti alla lotta. Cioè la Rivoluzione francese è uno degli eventi europei che maggiormente operano per approfondire un movimento già iniziato nelle «cose», rafforzando le condizioni positive del movimento stesso e funzionando come centro di aggregazione e centralizzazione delle forze umane dispersc in tutta la penisola e che altrimenti molto avrebbero tardato a «incontrarsi» e comprendersi tra loro.
Su questo stesso argomento è da vedere l’articolo di Gioacchino Volpe Storici del Risorgimento a Congresso nell’«Educazione Fascista» del luglio 1932. Il Volpe informa sul Ventesimo Congresso della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento tenuto a Roma nel maggio‑giugno 1932. La Storia del Risorgimento fu prima concepita prevalentemente come «storia del patriottismo italiano». Poi essa cominciò ad approfondirsi, «ad essere vista come vita italiana del XIX secolo e quasi dissolta nel quadro di quella vita, presa tutta in un processo di trasformazione, coordinazione, unificazione, ideali e vita pratica, coltura e politica, interessi privati e pubblici». Dal secolo XIX si risalì al secolo XVIII e si videro nessi prima nascosti ecc, Il secolo XVIII «fu visto dall’angolo visuale del Risorgimento, anzi come Risorgimento anch’esso: con la sua borghesia ormai nazionale; con il suo liberalismo che investe la vita economica e la vita religiosa e poi quella politica e che non è tanto un “principio” quanto una esigenza di produttori; con quelle prime concrete aspirazioni ad “una qualche forma di unità” (Genovesi), per la insufficienza dei singoli Stati, ormai riconosciuta, a fronteggiare, con la loro ristretta economia, la invadente economia di paesi tanto più vasti e forti. Nello stesso secolo si delineava anche una nuova situazione internazionale. Entravano cioè nel pieno giuoco forze politiche europee interessate ad un assetto più indipendente e coerente e meno staticamente equilibrato della penisola italiana. Insomma una “realtà” nuova italiana ed europea, che dà significato e valore al nazionalismo dei letterati, riemerso dopo il cosmopolitismo dell’età precedente».
Il Volpe non accenna specificamente al rapporto nazionale e internazionale rappresentato dal Vaticano, che anch’esso subisce nel secolo XVIII una radicale trasformazione: scioglimento dei gesuiti in cui culmina il rafforzarsi dello Stato laico contro l’ingerenza religiosa ecc. Si può dire che oggi, per la storiografia del Risorgimento, per il nuovo influsso esercitato dal Vaticano dopo il Concordato, il Vaticano è diventato una delle maggiori, se non la maggiore, forza di remora scientifica e di maltusianesimo metodico. Precedentemente accanto a questa forza, che è stata sempre molto rilevante, esercitavano una funzione di restrizione dell’orizzonte storico la monarchia e la paura del separatismo. Molti lavori storici non furono pubblicati per queste ragioni (Storia della Sardegna dopo il 1830) del barone Manno, episodio Bollea durante la guerra ecc.). I pubblicisti repubblicani si erano specializzati nella storia «libellistica», sfruttando ogni opera storica che ricostruisse scientificamente gli avvenimenti del Risorgimento e perciò ne conseguì una limitazione delle ricerche e un prolungarsi delle storie apologetiche e rettoriche, la impossibilità di sfruttare gli archivi ecc., tutta la meschinità della storiografia del Risorgimento quando la si paragona a quella della Rivoluzione francese. Oggi le preoccupazioni monarchiche e separatiste si sono andate assottigliando, ma sono cresciute quelle vaticanesche e clericali. Una gran parte degli attacchi alla Storia dell’Europa del Croce sono evidentemente di questa origine.
Nel Ventesimo Congresso sono stati trattati argomenti molto interessanti per questa rubrica. Pietro Silva: Il problema italiano nella diplomazia europea del XVIII secolo. Così il Volpe riassume lo studio del Silva: «Il XVIII secolo vuol dire influenza di grandi potenze in Italia, ma anche loro contrasti: e perciò, progressiva diminuzione del dominio diretto straniero e sviluppo di due forti organismi statali a nord e a sud. Col trattato di Aranjuez tra Francia e Spagna, 1752, e subito dopo, col ravvicinamento Austria‑Francia, si inizia una stasi di quarant’anni per i due regni, pur con molti sforzi di rompere il cerchio Austro‑francese, tentando approcci con Prussia, Inghilterra, Russia. Ma il quarantennio segna anche lo sviluppo di quelle forze autonome che, con la Rivoluzione e con la rottura del sistema austro-francese, scenderanno in campo per una soluzione in senso nazionale ed unitario del problema italiano. Ed ecco le riforme ed i principi riformatori, oggetto, gli ultimi tempi, di molti studi, per il regno di Napoli e di Sicilia, per la Toscana, Parma e Piacenza, Lombardia». Carlo Morandi: Le riforme settecentesche nei risultati della recente storiografia, ha studiato la posizione delle riforme italiane nel quadro del riformismo europeo, e il rapporto tra riforme e Risorgimento.
Per il rapporto tra Rivoluzione francese e Risorgimento il Volpe scrive: «È innegabile che la Rivoluzione (francese), vuoi come ideologie, vuoi come passioni (!), vuoi come forza armata, vuoi come Napoleone, immette elementi nuovi nel flusso in movimento della vita italiana. Non meno innegabile che l’Italia del Risorgimento, organismo vivo, assimilando l’assimilabile di quel che veniva dal di fuori e che, in quanto idee, era un po’ anche rielaborazione altrui di ciò che già si era elaborato in Italia, reagisce, insieme, ad esso, lo elimina e lo integra, in ogni modo lo supera. Essa ha tradizioni proprie, mentalità propria, problemi propri, soluzioni proprie: che son poi la vera e profonda radice, la vera caratteristica del Risorgimento, costituiscono la sua sostanziale continuità con l’età precedente, lo rendono capace alla sua volta di esercitare anche esso una sua azione su altri paesi: nel modo come tali azioni si possono, non miracolisticamente ma storicamente, esercitare, entro il cerchio di popoli vicini e affini».
Queste osservazioni del Volpe non sono esatte: come si può parlare di «tradizioni, mentalità, problemi, soluzioni» propri dell’Italia? O almeno, cosa significa? Le tradizioni, la mentalità, i problemi, le soluzioni erano molteplici, contraddittori e non erano visti unitariamente. Le forze tendenti all’unità erano scarsissime, disperse, senza legami tra loro e senza capacità di crearseli. Le forze contrastanti a quelle unitarie erano potentissime, coalizzate, e specialmente come Chiesa assorbivano in sé una gran parte delle energie nazionali che altrimenti sarebbero state unitarie, dando loro un indirizzo cosmopolita‑clericale. I fattori internazionali e specialmente la Rivoluzione francese stremando queste forze reazionarie e logorandole, potenziano per contraccolpo le forze nazionali in se stesse scarse e inefficienti. È questo il contributo più importante della Rivoluzione, molto difficile da valutare e definire, ma che s’intuisce di peso decisivo nel dare l’avviata al moto del Risorgimento.
Tra le altre memorie presentate al Congresso è da notare quella di Giacomo Lumbroso su La reazione popolare contro i francesi alla fine del 1700. Il Lumbroso sostiene che «le masse popolari, specialmente contadinesche, reagirono non perché sobillate dai nobili e neppure per amor di quieto vivere (difatti, impugnarono le armi!) ma, in parte almeno, per un oscuro e confuso amor patrio o attaccamento alla loro terra, alle loro istituzioni, alla loro indipendenza (!?): donde il frequente appello al sentimento nazionale degli italiani, che fanno i “reazionari”, già nel 1799», ma la quistione è mal posta così e piena di equivoci. Cosa vuol dire la parentesi ironica del Volpe che non si possa parlare di amor di quieto vivere perché si impugnano le armi? Non c’è per nulla contraddizione, perché «quieto vivere» è inteso in senso politico di misoneismo e conservatorismo e non esclude la difesa armata delle proprie posizioni sociali. Inoltre la quistione dell’atteggiamento delle masse popolari non può essere impostata indipendentemente da quella delle classi dirigenti, perché le masse popolari si muovevano per ragioni immediate e contingenti contro gli «stranieri» invasori in quanto nessuno aveva loro insegnato a conoscere un indirizzo politico diverso da quello localistico e ristretto. Le reazioni spontanee delle masse popolari servono a indicare la forza didirezione delle classi alte; in Italia i liberali‑borghesi trascurarono sempre le masse popolari ecc.
Q9 §109 Bibliografia. Al XII Congresso internazionale di Scienze Storiche che si terrà a Varsavia dal 21 al 28 agosto 1933 saranno presentate le seguenti relazioni sul Risorgimento: 1°) G. Volpe, I rapporti politici diplomatici tra le grandi potenze europee e l’Italia durante il Risorgimento; 2°) A. C. Jemolo, L’Italia religiosa del secolo XVIII; 3°) Pietro Silva, Forze e iniziative nazionali ed influenze straniere nell’opera dell’assolutismo illuminato in Italia.
Q9 §110 Rodolfo Morandi, Storia della grande industria in Italia (ed. Laterza, Bari, 1931). Nella «Riforma Sociale» del maggio‑giugno 1932 è pubblicata una severa recensione del lavoro del Morandi, recensione che contiene alcuni spunti metodici di un certo interesse (la recensione è anonima, ma autore potrebbe esserne il De Viti De Marco). Si obbietta prima di tutto al Morandi che egli non tiene conto di ciò che è costata l’industria italiana: «All’economista non basta che gli vengano mostrate fabbriche che danno lavoro a migliaia di operai, bonifiche che creano terre coltivabili, ed altri simili fatti di cui il pubblico generalmente si contenta nei suoi giudizi su un paese, su un’epoca. L’economista sa bene che lo stesso risultato può rappresentare un miglioramento o un peggioramento di una certa situazione economica a seconda che sia ottenuto con un complesso di sacrifici minori o maggiori». (È giusto il criterio generale che occorre studiare quanto sia costata l’introduzione di una certa industria in un paese, chi ne abbia fatto le spese, chi ne abbia ricavato i vantaggi, e se i sacrifizi fatti non potevano essere fatti in altra direzione più utilmente, ma non è giusto sempre che l’introduzione dell’industria peggiori la situazione generale. D’altronde il solo criterio economico non è sufficiente per studiare il passaggio da una forma di Stato a un’altra; occorre tener conto anche del criterio politico, in quanto obbiettivamente necessario e corrispondente a un interesse generale. Che l’unificazione della penisola dovesse costare sacrifizi a una parte della popolazione, per le necessità inderogabili di un grande Stato moderno, è da ammettere; ma bisogna vedere come tali sacrifizi furono distribuiti e in che misura potevano essere risparmiati. Che l’introduzione del capitalismo in Italia non sia avvenuta da un punto di vista nazionale, ma da angusti punti di vista regionali e di ristretti gruppi e che abbia fallito ai suoi compiti, determinando un’emigrazione morbosa non mai riassorbita e rovinando economicamente intere regioni, è certissimo).
Il Morandi non riesce a valutare il significato del protezionismo nello sviluppo della grande industria italiana. Così il Morandi rimprovera assurdamente alla borghesia «il proposito deliberato e funestissimo di non aver tentato l’avventura salutare del sud, … dove malamente la produzione agricola può ripagare i grandi sforzi che all’uomo richiede». Il Morandi non si domanda se la miseria del Sud non fosse determinata dalla legislazione protezionistica che ha consentito lo sviluppo industriale del Nord e come poteva esistere un mercato interno da sfruttare coi dazi e altri privilegi, se il sistema protettivo si fosse esteso a tutta la penisola, trasformando l’economia rurale del Sud in economia industriale.
Si rimprovera al Morandi l’eccessiva severità con cui giudica e condanna uomini e cose del passato, poiché basta fare un confronto tra le condizioni prima e dopo l’indipendenza per vedere che qualcosa si è pur fatta.
Pare dubbio che si possa fare una storia della grande industria astraendo dai principali fattori (sviluppo demografico, politica finanziaria e doganale, ferrovie ecc.) che hanno contribuito a determinare le caratteristiche economiche del periodo considerato. (Critica molto giusta. Una gran parte dell’attività della vecchia destra da Cavour al 1876 fu infatti dedicata a creare le condizioni tecniche generali in cui una grande industria fosse possibile e un grande capitalismo potesse diffondersi e prosperare: solo con l’avvento della sinistra e specialmente con Crispi si ha la «fabbricazione dei fabbricanti» attraverso il protezionismo e i privilegi. La politica finanziaria della destra tendente a pareggiare il bilancio rende possibile la politica «produttivistica» successiva). «Così, ad esempio, non si riesce a capire come mai vi fosse tanta abbondanza di mano d’opera in Lombardia nei primi decenni dopo la unificazione, e quindi il livello dei salari rimanesse tanto basso, se si rappresenta il capitalismo come una piovra che allunga i suoi tentacoli per far sempre nuove prede nelle campagne, invece di tener conto della trasformazione che contemporaneamente avviene nei contratti agrari ed in genere nell’economia rurale. Ed è facile concludere semplicisticamente sulla caparbietà e sulla ristrettezza di mente delle classi padronali osservando la resistenza che esse fanno ad ogni richiesta di miglioramento delle condizioni delle classi operaie, se non si tiene anche presente quello che è stato l’incremento della popolazione rispetto alla formazione di nuovi capitali». (La quistione però non è così semplice. Il saggio del risparmio o di capitalizzazione era basso perché i capitalisti avevano preferito mantenere tutta l’eredità di parassitismo del periodo precedente, perché non venisse meno la forza politica della loro classe).
Critica della definizione di «grande industria» data dal Morandi, il quale non si sa perché ha escluso dal suo studio molte delle più importanti attività industriali (trasporti, industrie alimentari ecc.). Eccessiva simpatia del Morandi per i colossali organismi industriali, considerati troppo spesso, senz’altro, come forme superiori di attività economica, malgrado siano ricordati i crolli disastrosi dell’Ilva, dell’Ansaldo, della Banca di Sconto, della Snia Viscosa, dell’Italgas. «Un altro punto di dissenso, il quale merita di essere rilevato, perché nasce da un errore molto diffuso, è quello in cui l’A. considera che un paese debba necessariamente rimaner soffocato dalla concorrenza degli altri paesi se inizia dopo di essi la propria organizzazione industriale. Questa inferiorità economica, a cui sarebbe condannata anche l’Italia, non sembra affatto dimostrata, perché le condizioni dei mercati, della tecnica, degli ordinamenti politici, sono in continuo movimento e quindi le mète da raggiungere e le strade da percorrere si spostano tanto spesso e subitamente che possono trovarsi in vantaggio individui e popoli che erano rimasti più indietro, o quasi non s’erano mossi. Se ciò non fosse si spiegherebbe male come continuamente possono sorgere e prosperare nuove industrie accanto alle più vecchie nello stesso paese, e come abbia potuto realizzarsi l’enorme sviluppo industriale del Giappone alla fine del secolo scorso».
Q9 §111 2. Missiroli e la storia italiana moderna. Occorre compilare una bibliografia completa del Missiroli. Alcuni libri sono: La monarchia socialista (1913), Polemica liberale, Opinioni, Il colpo di Stato (1925), Una battaglia perduta, Italia d’oggi (1932), La repubblica degli accattoni (su Molinella), Amore e fame, Date a Cesare… (1929), (un libro sul papa nel 1917).
I motivi principali posti in circolazione dal Missiroli sono: 1°) che il Risorgimento è stato una conquista regia e non un movimento popolare; 2°) che il Risorgimento non ha risolto il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, motivo che è legato al primo poiché «un popolo che non aveva sentito la libertà religiosa non poteva sentire la libertà politica. L’ideale dell’indipendenza e della libertà diventò patrimonio e programma di una minoranza eroica, che concepì l’unità contro l’acquiescenza delle moltitudini popolari». La mancanza della Riforma protestante in Italia spiegherebbe in ultima analisi tutto il Risorgimento e la storia moderna nazionale.
Il Missiroli applica all’Italia il criterio ermeneutico applicato dal Masaryk per interpretare la storia russa (sebbene il Missiroli accettasse la critica di Antonio Labriola contro il Masaryk storico). Come il Masaryk, il Missiroli (nonostante le sue relazioni con G. Sorel) non comprende che la «riforma» moderna di carattere popolare è stata la diffusione delle idee marxiste, sia pure in forma di letteratura da opuscoletto. Né egli tenta di analizzare perché la minoranza che ha guidato il moto del Risorgimento non sia «andata al popolo» né «ideologicamente» (ciò che poteva avvenire in Italia sulla base della «riforma agraria» dato che il contadiname era quasi tutto il popolo di allora – d’altronde non bisogna dimenticare che molte istituzioni operaie di mutuo soccorso furono fondate per impulso dei liberali: l’A.G.O. di Torino ha avuto tra i fondatori Cavour –, mentre la Riforma religiosa tedesca ha coinciso con una guerra di contadini) né economicamente appunto con la Riforma agraria. «L’unità non aveva potuto attuarsi col Papato, di sua natura universale ed organicamente ostile a tutte le libertà moderne; ma non era nemmeno riuscita a trionfare del Papato, contrapponendo all’idea cattolica un’idea altrettanto universale che rispondesse ugualmente alla coscienza individuale e alla coscienza del mondo rinnovato dalla Riforma e dalla Rivoluzione». (Affermazioni astratte e in gran parte prive di senso. Quale idea universale contrappose al cattolicismo la Rivoluzione francese? Perché dunque in Francia il moto fu popolare e in Italia no? La famosa minoranza italiana, «eroica» per definizione, che condusse il moto unitario, in realtà si interessava di interessi economici più che di formule ideali e combatté più per impedire che il popolo intervenisse nella lotta e la facesse diventare sociale che non contro i nemici dell’unità.
Il Missiroli scrive che il nuovo fattore apparso nella storia italiana dopo l’unità, il socialismo, è stata la forma più potente assunta dalla reazione antiunitaria e antiliberale (ciò che è una sciocchezza). Come il Missiroli stesso scrive: «Il socialismo non solo non ringagliardì la passione politica, ma aiutò potentemente ad estinguerla; fu il partito dei poveri e delle plebi affamate: le quistioni economiche dovevano prendere rapidamente il sopravvento, i principii politici cedere il campo agli interessi materiali»; veniva creata «una remora, lanciando le masse alle conquiste economiche ed evitando tutte le quistioni istituzionali». Cioè il socialismo fece l’errore (alla rovescia) della famosa minoranza: questa parlava solo di idee astratte e di istituzioni politiche, quello trascurò la politica per la mera economia.
In realtà il Missiroli è solo quello che si chiama uno scrittore brillante: si ha l’impressione che egli si infischi delle sue idee, dell’Italia, e di tutto: lo interessa solo il gioco momentaneo di alcuni concetti astratti e lo interessa di cadere sempre in piedi con una nuova coccarda in petto.
Q9 §112 L’industria italiana. Nel fare l’analisi della relazione della Banca Commerciale Italiana all’assemblea sociale per l’esercizio 1931, Attilio Cabiati (Riforma Sociale, luglio‑agosto 1932, p. 464) scrive: «Risalta da queste considerazioni il vizio fondamentale che ha sempre afflitto la vita economica italiana: la creazione e il mantenimento di una impalcatura industriale troppo superiore sia alla rapidità di formazione di risparmio nel paese, che alla capacità di assorbimento dei consumatori interni; vivente quindi per una parte cospicua solo per la forza del protezionismo e di aiuti statali di svariate forme. Ma il patrio protezionismo, che in taluni casi raggiunge e supera il cento per cento del valore internazionale del prodotto, rincarando la vita rallentava a sua volta la formazione del risparmio, che per di più veniva conteso all’industria dallo Stato stesso, spesso stretto dai suoi bisogni, sproporzionati alla nostra impalcatura. La guerra, allargando oltre misura tale impalcatura, costrinse le nostre banche, come scrive la relazione precitata, “ad una politica di tesoreria coraggiosa e pertinace”, la quale consisté nel prendere a prestito “a rotazione” all’estero, per prestare a più lunga scadenza all’interno. “Una tale politica di tesoreria aveva però – dice la relazione – il suo limite naturale nella necessità per le banche di conservare ad ogni costo congrue riserve di investimenti liquidi o di facile realizzo”. Quando scoppiò la crisi mondiale, gli “investimenti liquidi” non si potevano realizzare se non ad uno sconto formidabile: il risparmio estero arrestò il suo flusso: le industrie nazionali non poterono ripagare. Sicché, exceptis excipiendis, il sistema bancario italiano si trovò in una situazione per più aspetti identica a quella del mercato finanziario inglese nella metà del 1931. … (l’errore) antico consisteva nell’aver voluto dare vita ad un organismo industriale sproporzionato alle nostre forze, creato con lo scopo di renderci “indipendenti dall’estero”: senza riflettere che, a mano a mano che non “dipendevamo” dall’estero per i prodotti, si rimaneva sempre più dipendenti per il capitale».
Si pone il problema se in un altro stato di cose si potrà allargare la base industriale del paese senza ricorrere all’estero per i capitali. L’esempio di un altro paese mostra di sì: ogni forma di società ha una sua legge di accumulazione del risparmio ed è da ritenere che anche in Italia si può ottenere una più rapida accumulazione. L’Italia è il paese, nelle condizioni createsi nel secolo scorso, col Risorgimento, che ha il maggior numero di popolazione parassitaria, che vive senza intervenire per nulla nella vita produttiva, è il paese di maggior quantità di piccola e media borghesia rurale e urbana che consuma una frazione grande di ricchezza per risparmiarne una piccola parte.
Q9 §113 Pubblicazione di libri e memorie dovute agli antiliberali, «antifrancesi» nel periodo della Rivoluzione e di Napoleone e reazionari nel periodo del Risorgimento. Queste pubblicazioni sono certo necessarie, in quanto le forze avverse al moto liberale italiano erano anch’esse una parte della realtà, ma occorre tener conto di alcuni criteri: 1°) molte pubblicazioni, come il Memorandum del Solaro della Margarita e forse anche volumi curati dal Lovera e dal gesuita Rinieri, hanno o uno scopo attuale, di rafforzare certe tendenze reazionarie nell’interpretazione del Risorgimento (rappresentate specialmente dai gesuiti della «Civiltà Cattolica») o sono presentati come testi per l’azione attuale (come il Memorandum del Solaro, il Papa di De Maistre ecc.). 2°) Le descrizioni degli interventi francesi in Italia sotto il Direttorio sono dovuti, specialmente per certe parti d’Italia, solo a reazionari: i giacobini si arruolavano e quindi avevano altro da fare che scrivere memoriali. I quadri sono pertanto sempre tendenziosi e sarebbe molto ingenuo ricostruire la realtà su tali documenti. Di queste pubblicazioni cfr Ranuccio Ranieri, L’invasione francese degli Abruzzi nel 1798‑99, ed una memoria del tempo inedita di Giovanni Battista Simone, Pescara, Edizioni dell’«Adriatico», 1931. Dalla narrazione del Simone, un antigiacobino e legittimista, appare che in Chieti città la forza giacobina era di una certa forza, ma nella campagna (salvo eccezioni dovute a rivalità municipali e al desiderio di aver l’occasione di fare delle vendette) prevalevano le forze reazionarie nella lotta contro Chieti. Pare che più della memoria del Simone, enfatica e verbosa, sia interessante l’esposizione del Ranieri che ricostruisce la situazione dell’Abruzzo in quel periodo di storia.
Q9 §114 Merimée e il 48. Nella «Revue des deux Mondes» (fasc. 15 maggio 1932) è pubblicato un manipolo di lettere di Prospero Merimée alla Contessa De Boigne (autrice delle famose Memorie).
Sul 48 in Italia: «I Piemontesi non si preoccupano affatto del nostro aiuto e noi impediamo gli italiani di aiutarli col promettere il rinforzo del nostro invincibile esercito: un viaggiatore che viene di Lombardia racconta che il paese, come in pieno Medio Evo, è diviso in tante piccole repubbliche quanti sono i borghi e i villaggi, ostili l’uno all’altro nell’attesa di prender le armi». Il Merimée era favorevole all’unità italiana. Racconta aneddoti piccanti sulla situazione francese: per esempio i contadini, votando per Luigi Napoleone, credevano di votare per Napoleone I. Inutilmente si cerca di spiegare loro che la salma dell’Imperatore è sepolta agli Invalidi. (Che l’equivoco di un possibile aiuto dell’esercito francese abbia nel 48 influito nel non deterininare un maggior movimento di volontari ecc. è possibile: si spiegherebbe meglio così il motto dell’«Italia farà da sé», ma non si spiegherebbe lo stesso l’inerzia militare anche del Piemonte e l’assenza di una chiara direzione politico‑militare, nel senso altrove spiegato).
Q9 §115 La rivoluzione del 1831. Nell’«Archiginnasio» (4‑6, anno XXVI, 1932) Albano Sorbelli pubblica e commenta il testo del Piano politico costitutivo della rivoluzione del 1831 scritto da Ciro Menotti. Il documento era già stato pubblicato da Enrico Ruffini nel 1909 nell’«Archivio Emiliano del Risorgimento Nazionale», Fasc. 10 e 11. Anche il volume di Arrigo Solmi sui fatti del 31 si basa su questo piano. Ora si è potuto, con un reagente, far rivivere lo scritto del Menotti e fotografarlo per L’Archiginnasio.
Q9 §116 Carlo Felice. È da leggerne la biografia scrittane da Francesco Lemmi per la «Collana storica sabauda» dell’editore Paravia. Punti: avversione di Carlo Felice contro il ramo Carignano: in alcune lettere scritte al fratello Vittorio Emanuele nel 1804 si leggono contro i genitori di Carlo Alberto parole roventi che, dettate da non si sa quale risentimento, giungono a scongiurare come una vergogna quella non desiderata successione. 1821. – Nota il Lemmi che Carlo Felice non fece una politica italiana, ma mirò ad estendere i suoi possessi.
Q9 §117 Martino Beltrani Scalia, Giornali di Palermo nel 1848‑1849, con brevi accenni a quelli delle altre principali città d’Italia nel medesimo periodo, a cura del figlio Vito Beltrani Palermo, Sandron, 1931. Si tratta di una esposizione condensata in poche linee del contenuto di singoli periodici pubblicati a Palermo nel 1848 e 1849 e anche nell’anno precedente, nonché di numerosi giornali del continente (di Napoli, di Roma, della Toscana, del Piemonte) e della Svizzera (cioè dell’«Italia del popolo» di Mazzini), esposizione fatta generalmente giorno per giorno. Per i giornali non siciliani si dava importanza a ciò che riguardava la Sicilia. Nel 1847 i giornali palermitani erano appena sei; nel 1848‑49 il Beltrani Scalia ne annovera centoquarantuno e non è da escludere che gliene sia sfuggito qualcuno. Dai sunti del Beltrani Scalia appare l’assenza dei partiti permanenti: si tratta per lo più di opinioni personali, spesso contraddittorie nello stesso foglio. Pare che il saggio del Beltrani Scalia dimostri che aveva ragione il La Farina quando nella Storia documentata della rivoluzione siciliana scrisse che «la stampa periodica, salvo scarse ed onorevoli eccezioni, non rispose mai all’altezza del suo ministero: fu scandalo, non forza».
Q9 §118 La posizione geopolitica dell’Italia. La possibilità dei blocchi. Nella sesta seduta della Conferenza di Washington (23 dicembre 1921) il delegato inglese Balfour, a proposito della posizione geopolitica dell’Italia, disse: «L’Italia non è un’isola, ma può considerarsi come un’isola. Mi ricordo dell’estrema difficoltà che abbiamo avuto a rifornirla anche con il minimo di carbone necessario per mantenere la sua attività, i suoi arsenali e le sue officine, durante la guerra. Dubito che essa possa nutrirsi e approvvigionarsi, o continuare ad essere una effettiva unità di combattimento, se fosse realmente sottomessa ad un blocco e se il suo commercio marittimo fosse arrestato. L’Italia ha cinque vicini nel Mediterraneo. Spero e credo che la pace, pace eterna, possa regnare negli antichi focolari della civiltà.
Ma noi facciamo un esame freddo e calcolatore come quello di un membro qualsiasi dello Stato Maggiore Generale. Questi, considerando il problema senza alcun pregiudizio politico e soltanto come una questione di strategia, direbbe all’Italia: voi avete cinque vicini, ciascuno dei quali può, se vuole, stabilire un blocco delle vostre coste senza impiegare una sola nave di superficie. Non sarebbe necessario che sbarcasse truppe e desse battaglia. Voi perireste senza essere conquistati». È vero che Balfour parlava specialmente sotto l’impressione della guerra sottomarina e prima dei grandi passi fatti dall’aviazione di bombardamento, che non pare possa perinettere un blocco immune da rappresaglie, tuttavia per alcuni aspetti la sua analisi è abbastanza giusta.
Finisce qui il blocco di sul Risorgimento italiano iniziato con il Q9 § 89.
Q9 §119 Quistioni scolastiche. Nel «Marzocco» del 13 settembre 1931, G. Ferrando esamina un lavoro di Carleton Washburne, pedagogista americano, che è venuto appositamente in Europa per vedere come funzionano le nuove scuole progressiste, ispirate al principio dell’autonomia dell’alunno e della necessità di soddisfare per quanto è possibile i suoi bisogni intellettuali (New Schools in The old World by Carleton Washburne, New York, The John Day Company, 1930). Il Washburne descrive dodici scuole, tutte diverse fra loro, ma tutte animate da uno spirito riformatore, che in alcune è temperato e si innesta sul vecchio tronco della scuola tradizionale, mentre in altre assume un carattere addirittura rivoluzionario. Cinque di queste scuole sono in Inghilterra, una nel Belgio, una in Olanda, una in Francia, una in Svizzera, una in Germania e due in Cecoslovacchia e ognuna ci presenta un aspetto del complesso problema educativo.
La Public School di Oundle, una delle più antiche scuole inglesi, si differenzia dalle scuole dello stesso tipo solo perché accanto ai corsi teorici di materie classi che, ha istituito dei corsi manuali e pratici. Tutti gli studenti sono obbligati a frequentare a loro scelta un’officina meccanica o un laboratorio scientifico: il lavoro manuale si accompagna col lavoro intellettuale e sebbene non ci sia nessuna relazione diretta tra i due, pure l’alunno impara ad applicare le sue cognizioni e sviluppa le sue capacità pratiche. (Questo esempio mostra come sia necessario definire esattamente il concetto di scuola unitaria in cui il lavoro e la teoria sono strettamente riuniti: l’accostamento meccanico delle due attività può essere uno snobismo. Si sente dire di grandi intellettuali che si divagano facendo i tornitori, i falegnami, i legatori di libri ecc.: non si dirà per questo che siano un esempio di unità del lavoro manuale e intellettuale. Molte di tali scuole moderne sono appunto di stile snobistico che non ha niente che vedere – altro che superficialmente – colla quistione di creare un tipo di scuola che educhi le classi strumentali e subordinate a un ruolo dirigente nella società, come complesso e non come singoli individui).
La scuola media femminile di Streatham Hill applica il sistema Dalton (che il Ferrando chiama «uno sviluppo del metodo Montessori»); le ragazze sono libere di seguire le lezioni, pratiche e teoriche, che desiderano, purché alla fine di ogni mese abbiano svolto il programma loro assegnato; la disciplina delle varie classi è affidata alle alunne. Il sistema ha un grande difetto: le allieve in genere rimandano agli ultimi giorni del mese lo svolgimento del loro compito, ciò che nuoce alla serietà della scuola e costituisce un inconveniente serio per le insegnanti che debbono aiutarle e sono sopraffatte dal lavoro, mentre nelle prime settimane hanno poco o nulla da fare. (Il sistema Dalton non è che l’estensione alle scuole medie del metodo di studio seguito nelle Università italiane, che all’alunno lasciano tutta la libertà per lo studio: in certe facoltà si danno venti esami al quarto anno di Università e poi la laurea, e il professore non conosce neanche l’alunno).
Nel piccolo villaggio di Kearsley E. F. O’Neill ha fondato una scuola elementare in cui è abolito «ogni programma e ogni metodo didattico». Il maestro cerca di rendersi conto di quello che i bambini hanno bisogno di apprendere e comincia poi a parlare su quel dato argomento, mirando a risvegliare la loro curiosità e il loro interesse; appena vi è riuscito, lascia che essi continuino per conto proprio, limitandosi a rispondere alle loro domande e a guidarli nella loro ricerca. Questa scuola, che rappresenta una reazione contro tutte le formule, contro l’insegnamento dommatico, contro la tendenza a rendere l’istruzione meccanica, «ha dato risultati sorprendenti»: i bambini si appassionano talmente alle lezioni che talvolta rimangono a scuola fino a sera tardi, si affezionano ai loro maestri che sono per loro dei compagni e non degli autocratici pedagoghi e ne subiscono l’influenza morale; anche intellettualmente il loro progresso è assai superiore a quello degli alunni delle scuole comuni (è molto interessante come tentativo, ma potrebbe essere universalizzato? si troverebbero i maestri sufficienti numericamente allo scopo? e non ci saranno inconvenienti che non sono riferiti, come per esempio quello di bambini che devono abbandonare la scuola ecc.? Potrebbe essere una scuola di élites o un sistema di «doposcuola», in sostituzione della vita famigliare).
Un gruppo di scuole elementari ad Amburgo: libertà assoluta ai bambini; nessuna distinzione di classi, non materie di studio, non insegnamento nel senso preciso della parola. L’istruzione dei bambini deriva solo dalle domande che essi rivolgono ai maestri e dall’interesse che dimostrano per un dato fatto. Il direttore di queste scuole, signor Gläser, sostiene che l’insegnante non ha diritto neppure di stabilire quello che i ragazzi debbono imparare; egli non può sapere quello che essi diverranno nella vita, come ignora per quale tipo di società essi debbono essere preparati; l’unica cosa che egli sa è che essi «posseggono un’anima che deve esser sviluppata e quindi egli deve cercare di offrir loro tutte le possibilità di manifestarsi». Per Gläser l’educazione consiste «nel liberare l’individualità di ogni alunno, nel permettere alla sua anima di aprirsi e di espandersi». In otto anni gli allievi di queste scuole hanno ottenuto risultati buoni.
Le altre scuole di cui il Washburne parla sono interessanti perché sviluppano certi aspetti del problema educativo; così per esempio la scuola «progressista» del Belgio si fonda sul principio che i bambini imparano venendo in contatto con il mondo e insegnando agli altri. La scuola Cousinet in Francia sviluppa l’abitudine allo sforzo collettivo, alla collaborazione. Quella di Glarisegg in Svizzera insiste in special modo nello sviluppare il senso della libertà e responsabilità morale di ciascun alunno ecc. (È utile seguire tutti questi tentativi che non sono altro che «eccezionali» forse più per vedere ciò che non occorre fare, che per altro).
Q9 §120 Letteratura popolare. Nel «Marzocco» del 13 settembre 1931, Aldo Sorani (che parecchie altre volte, in diverse riviste e giornali, si è occupato di questo argomento) scrive un articolo Romanzieri popolari contemporanei in cui commenta la serie di articoli dello Charensol sugli Illustri ignoti nella «Nouvelles Littéraires» (di cui è nota in altro quaderno). «Si tratta di scrittori popolarissimi di romanzi d’avventure e d’appendice, sconosciuti o quasi al pubblico letterario, ma idoleggiati e seguiti ciecamente da quel più grosso pubblico di lettori che decreta le tirature mastodontiche e di letteratura non s’intende affatto, ma vuol essere interessato e appassionato da intrecci sensazionali di vicende criminali od amorose. Per il popolo sono essi i veri scrittori ed il popolo sente per loro un’ammirazione ed una gratitudine che questi romanzieri tengon deste somministrando ad editori e lettori una mole di lavoro così continua ed imponente da parere incredibile e insostenibile da forze, non dico intellettuali, ma fisiche». Il Sorani osserva molto spregiudicatamente che questi scrittori «si sono asserviti ad un compito stremante e adempiono ad un servizio pubblico reale se infinite schiere di lettori e di lettrici non possono farne a meno e gli editori conseguono dalla loro inesauribile attività lauti guadagni».
Come si vede il Sorani impiega il termine di «servizio pubblico reale» ma ne dà una definizione ben meschina, e che non corrisponde a quella di cui si parla in queste . Il Sorani nota che questi scrittori, come appare dagli articoli dello Charensol, «hanno reso più severi i loro costumi e più morigerata, in genere, la loro vita, dal tempo ormai remoto in cui Ponson du Terrail o Xavier de Montépin esigevano una notorietà mondana e facevano di tutto per accaparrarsela …, pretendendo che, alla fine, essi non si distinguevano dai loro più accademici confratelli che per una diversità di stile. Essi scrivevano come si parla, mentre gli altri scrivevano come non si parla…!» (Tuttavia anche gli «illustri ignoti» fanno parte delle associazioni di letterati come il Montépin. Ricordate anche l’astio di Balzac contro Sue per i successi mondani e finanziari di questo).
Scrive ancora il Sorani: «Un lato non trascurabile della persistenza di questa letteratura popolare … è offerto dalla passione del pubblico. Specialmente il grosso pubblico francese, quel pubblico che taluno crede il più smaliziato, critico e blasé del mondo, è rimasto fedele al romanzo d’avventure e d’appendice. Il giornalismo francese di informazione e di grande tiratura è quello che non ha ancora saputo o potuto rinunziare al romanzo d’appendice. Proletariato e borghesia sono ancora in grandi masse così ingenui (?) da aver bisogno degli interminabili racconti emozionanti e sentimentali, raccapriccianti o larmoyants per nutrimento quotidiano della loro curiosità e della loro sentimentalità, hanno ancora bisogno di parteggiare tra gli eroi della delinquenza e quelli della giustizia o della vendetta». «A differenza del pubblico francese, quello inglese o americano s’è riversato sul romanzo d’avventure storiche (e i francesi no?) o su quello d’avventure poliziesche» ecc. (luoghi comuni sui caratteri nazionali).
«Quanto all’Italia, credo che ci si potrebbe domandare perché la letteratura popolare non sia popolare in Italia. (Non è esatto: perché non ci siano scrittori, non lettori, che sono una caterva). Dopo il Mastriani e l’Invernizio, mi pare che siano venuti a mancare tra noi i romanzieri capaci di conquistare la folla facendo inorridire e lacrimare un pubblico di lettori ingenui, fedeli e insaziabili. Perché questo genere di romanzieri non ha continuato (?) ad allignare tra noi? La nostra letteratura è stata anche nei suoi bassifondi troppo accademica e letterata? I nostri editori non hanno saputo coltivare una pianta ritenuta troppo spregevole? I nostri scrittori non hanno fantasia capace d’animare le appendici e le dispense? O noi, anche in questo campo, ci siamo contentati e ci contentiamo di importare quanto producono gli altri mercati? Certo non abbondiamo come la Francia di “illustri sconosciuti” e una qualche ragione per questa deficienza ci deve essere e varrebbe forse la pena di ricercarla». Finisce con luoghi comuni.
Q9 §121 Argomenti di cultura. I grandi genî nazionali. Ho accennato altrove all’importanza culturale che in ogni paese hanno avuto i grandi genî (come Shakespeare per l’Inghilterra, Dante per l’Italia, Goethe per la Germania). Di essi, che siano operanti anche oggi, o che abbiano operato fino all’avantiguerra, solo due: Shakespeare e Goethe, specialmente quest’ultimo, per la singolarità della sua figura. Si è affermato che l’ufficio di queste grandi figure è quello d’insegnare come filosofi quello che dobbiamo credere, come poeti quello che dobbiamo intuire (sentire), come uomini quello che dobbiamo fare. Ma quanti possono rientrare in questa definizione? Non Dante, per la sua lontananza nel tempo, e per il periodo che esprime, il passaggio del Medio Evo all’età moderna. Solo Goethe è sempre di una certa attualità, perché egli esprime in forma serena e classica ciò che nel Leopardi, per esempio, è ancora torbido romanticismo: la fiducia nell’attività creatrice dell’uomo, in una natura vista non come nemica e antagonista, ma come una forza da conoscere e dominare, con l’abbandono senza rimpianto e disperazione delle «favole antiche» di cui si conserva il profumo di poesia, che le rende ancor più morte come credenze e fedi. (È da vedere il libro di Emerson, Uomini rappresentativi e gli Eroi di Carlyle).
Q9 §122 Carattere cosmopolita della letteratura italiana. La poesia provenzale in Italia. È stata pubblicata la raccolta completa delle Poesie provenzali storiche relative all’Italia (Roma, 1931, nella serie delle Fonti dell’Istituto Storico Italiano) per cura di Vincenzo De Bartholomaeis e ne dà un annunzio Mario Pelaez nel «Marzocco» del 7 febbraio 1932. «Di circa 2600 poesie provenzali giunte fino a noi, 400 rientrano nella Storia d’Italia, o perché trattano di argomenti italiani, sebbene siano di poeti non mai venuti in Italia, o perché composte da poeti provenzali che vi dimorarono, o infine perché scritte da Italiani. Delle 400, la metà circa sono puramente amorose, le altre storiche, e qual più qual meno offrono testimonianze utili per la ricostruzione della vita e in generale della Storia italiana dalla fine del secolo XII alla metà del XIV. Duecento poesie di circa ottanta poeti». Questi trovatori, provenzali o italiani, vivevano nelle corti feudali dell’Italia settentrionale, all’ombra delle piccole Signorie e nei Comuni, partecipavano alla vita e alle lotte locali, sostenevano gli interessi di questo o quel Signore, di questo o quel Comune, con poesia di varia forma, di cui è ricca la lirica provenzale: serventesi politici, morali, satirici, di crociata, di compianto, di consiglio; canzoni, tenzoni, cobbole ecc. che apparendo via via e circolando negli ambienti interessati, compivano la funzione che ha oggi l’articolo di fondo del giornale. Il De Bartholomaeis ha cercato di datare queste poesie, cosa non difficile per le allusioni che contengono; le ha corredate di tutti i sussidi che ne agevolano la lettura, le ha tradotte. Di ogni trovatore è data una breve informazione biografica. Per la lettura del testo originale è dato un glossario delle voci meno facili a intendersi. Sulla poesia provenzale in Italia è da vedere il volume di Giulio Bertoni Trovatori d’Italia.
Q9 §123 Risorgimento. Il «mutuo insegnamento». Per l’importanza che ha avuto nel movimento liberale del Risorgimento il principio del «mutuo insegnamento» cfr Arturo Linacher su Enrico Mayer (due volumi). Il Mayer fu uno dei maggiori collaboratori dell’«Antologia» del Vieusseux e uno dei maggiori propagandisti del nuovo insegnamento.
Q9 §124 Critica letteraria. Che si possa parlare di lotta per una «nuova cultura» e non per una «nuova arte» mi pare evidente. Non si puo forse neanche dire, esattamente, che si lotta per un nuovo contenuto dell’arte, perché questo non può essere pensato astrattamente separato dalla forma. Lottare per una nuova arte significherebbe lottare per creare nuovi artisti individuali, ciò che è assurdo, poiché non si possono creare artificiosamente degli artisti. Si deve parlare di lotta per una nuova cultura, cioè per una nuova vita morale che non può non essere intimamente legata a una nuova concezione della vita, fino a che essa diventi un nuovo modo di sentire e di intuire la realtà e quindi mondo intimamente connaturato nell’artista e nelle sue opere. Che la creazione di artisti non possa essere prodotta artificiosamente non significa però che un nuovo mondo culturale, per la cui realizzazione si lotta, suscitando passioni e nuovo calore di umanità, non susciti anche «artisti nuovi»; non si può a priori dire che Tizio o Caio diventeranno artisti, ma non si può escludere anzi si può affermare che dal movimento nasceranno nuovi artisti. Un nuovo gruppo che entra nella vita storica egemonica, con una sicurezza di sé che prima non aveva, non può non suscitare dal suo interno personalità che prima non avrebbero trovato una forza sufficiente per esprimersi ecc.
Q9 §125 Passato e presente. Da Virgilio Brocchi, Il Volo Nuziale (cfr nel «Secolo Illustrato», 1° ottobre 1932): «Il governo pareva incerto, e negoziava la neutralità e la guerra: ma perché i negoziati fossero realmente proficui doveva dare al mondo e soprattutto agli alleati di ieri la sensazione o la prova che esso non poteva contenere oramai la volontà esasperata della nazione che scoppiava in mille incendi, dal più umile borgo alla capitale e divampava perfino dentro i ministeri. Sulle fiamme, ogni giornale – anche quelli che fino al giorno innanzi avevano esaltato la magnifica violenza degli imperi centrali – gettava olio e polvere esplosiva: contro tutti contrastava un solo giornale; ma chi lo dirigeva, se pur era uomo di indefettibile fede e di sicuro coraggio, mancava di virtù simpatiche e di sufficiente accorgimento, così che parve difendere, più che un supremo ideale umano, e l’istinto della civiltà minacciata, il pavido egoismo di proletari per cui la patria è solo la patria dei signori e la guerra una speculazione infame di banchieri».
Q9 §126 Risorgimento. Significato della Vita Militare del De Amicis: da porre accanto ad alcune pubblicazioni di G. C. Abba, nonostante il contrasto intimo e il diverso atteggiamento, Abba, più «educativo» e più «nazionale‑popolare», più «democratico», perché politicamente più robusto e austero. Nella Vita Militare è da vedere il capitolo «L’Esercito italiano durante il colera del 1867» perché ritrae l’atteggiamento del popolo siciliano verso il governo e gli «italiani» dopo la sommossa del settembre 1866. Guerra del 66, sommossa di Palermo, colera: i tre fatti non possono essere staccati. Sarà da vedere l’altra letteratura sul colera in tutto il Mezzogiorno nel 1866‑67. Non si può giudicare il livello di vita popolare senza trattare questo argomento. Esistono pubblicazioni ufficiali sui delitti commessi contro le autorità (soldati, ufficiali, ecc.) durante il colera?
Q9 §127 Risorgimento. Il moto nazionale che condusse all’unificazione dello Stato italiano deve necessariamente sboccare nel nazionalismo e nell’imperialismo nazionalistico e militare? Questo sbocco è anacronistico e antistorico; esso è realmente contro tutte le tradizioni italiane, romane prima, cattoliche poi. Le tradizioni sono cosmopolitiche. Che il moto nazionale dovesse reagire contro le tradizioni e dare luogo a un nazionalismo da intellettuali può essere spiegato, ma non è una reazione organico‑popolare. Del resto, anche nel Risorgimento, Mazzini‑Gioberti cercano di innestare il moto nazionale nella tradizione cosmopolita, di creare il mito di una missione dell’Italia rinata in una nuova Cosmopoli europea e mondiale, ma è un mito puramente verbale e cartaceo, retorico, fondato sul passato e non sulle condizioni del presente, già esistenti o in processo di sviluppo. Perché un fatto si è prodotto nel passato non significa che si produca nel presente e nell’avvenire; le condizioni di una espansione italiana nel presente e per l’avvenire non esistono e non appare che siano in processo di formazione. L’espansione moderna è di origine capitalistico-finanziaria. L’elemento «uomo», nel presente italiano, o è uomo‑capitale o è uomo‑lavoro. L’espansione italiana è dell’uomo‑lavoro non dell’uomo‑capitale e l’intellettuale che rappresenta l’uomo‑lavoro non è quello tradizionale, gonfio di retorica e di ricordi meccanici del passato. Il cosmopolitismo italiano non può non diventare internazionalismo. Non il cittadino del mondo, in quanto civis romanus o cattolico, ma in quanto lavoratore e produttore di civiltà. Perciò si può sostenere che la tradizione italiana dialetticamente si continua nel popolo lavoratore e nei suoi intellettuali, non nel cittadino tradizionale e nell’intellettuale tradizionale. E popolo italiano è quello che «nazionalmente» è più interessato all’internazionalismo. Non solo l’operaio ma il contadino e specialmente il contadino meridionale. Collaborare a ricostruire il mondo economicamente in modo unitario è nella tradizione della storia italiana e del popolo italiano, non per dominarlo e appropriarsi i frutti del lavoro altrui, ma per esistere o svilupparsi.
Il nazionalismo è una escrescenza anacronistica nella storia italiana, di gente che ha la testa volta all’indietro come i dannati di Dante. La missione di civiltà del popolo italiano è nella ripresa del cosmopolitismo romano e medioevale, ma nella sua forma più moderna e avanzata. Sia pure nazione proletaria; proletaria come nazione perché è stata l’esercito di riserva di capitalismi stranieri, perché ha dato maestranze a tutto il mondo, insieme coi popoli slavi. Appunto perciò deve innestarsi nel fronte moderno di lotta per riorganizzare il mondo anche non italiano, che ha contribuito a creare con il suo lavoro.
Q9 §128 Cattolicismo. Il medico cattolico e l’ammalato (moribondo) acattolico. Cfr «Civiltà Cattolica» del 19 novembre 1932, p. 381 (recensione al libro di Luigi Scremin, Appunti di morale professionale per i medici, Roma, Editrice «Studium», 1932, in 120, pp. 8 L. 5): «… così a p. 95, pur citando il Prümmer, è detto male che “per un acattolico che desideri ed esiga un ministro della sua religione, è lecito al medico, in mancanza di altri, far conoscere al ministro stesso il desiderio dell’infermo, ed è anche tenuto (sic) a farlo solo quando giudichi dannoso per l’infermo non soddisfare questo desiderio”. La sentenza del moralista è ben altra; ed infatti il Prümmer (I, 526) ci dice che non si deve chiamare un ministro acattolico, il quale non ha alcuna potestà di amministrare i sacramenti; ma piuttosto aiutare l’infermo a fare un atto di contrizione. Che se l’infermo esige assolutamente che si chiami il ministro acattolico e dal rifiuto nascerebbero gravi danni si può (non già si deve) far conoscere a detto ministro il desiderio dell’infermo. E si dovrebbe distinguere ancora, quando l’infermo fosse in buona fede, ed appartenesse ad un rito acattolico, in cui i ministri fossero insigniti di vero ordine sacro, come tra i Greci separati». Il brano è di grande significazione.
Q9 §129 Risorgimento. Il nodo storico 1848‑49. Per i movimenti popolari di sinistra del 48‑49 è da vedere Nicola Valdimiro Testa, Gli Irpini nei moti politici e nella reazione del 1848‑49, Napoli, R. Contessa e Fratelli, 1932, in 8°, pp. 320, L. 15.
Q9 §130 Passato e presente. Ottimismo e pessimismo. È da osservare che l’ottimismo non è altro, molto spesso, che un modo di difendere la propria pigrizia, le proprie irresponsabilità, la volontà di non far nulla. È anche una forma di fatalismo e di meccanicismo. Si conta sui fattori estranei alla propria volontà ed operosità, li si esalta, pare che si bruci di un sacro entusiasmo. E l’entusiasmo non è che esteriore adorazione di feticci. Reazione necessaria, che deve avere per punto di partenza l’intelligenza. Il solo entusiasmo giustificabile è quello che accompagna la volontà intelligente, l’operosità intelligente, la ricchezza inventiva in iniziative concrete che modificano la realtà esistente.
Q9 §131 Passato e presente. L’attuale generazione ha una strana forma di autocoscienza ed esercita su di sé una strana forma di autocritica. Ha la coscienza di essere una generazione di transizione, o meglio ancora, crede di sé di essere qualcosa come una donna incinta: crede di stare per partorire e aspetta che nasca un grande figliolo. Si legge spesso che «si è in attesa di un Cristoforo Colombo che scoprirà una nuova America dell’arte, della civiltà, del costume». Si è letto anche che noi viviamo in un’epoca pre‑dantesca: si aspetta il Dante novello che sintetizzi potentemente il vecchio e il nuovo e dia al nuovo lo slancio vitale. Questo modo di pensare, ricorrendo a immagini mitiche prese dallo sviluppo storico passato è dei più curiosi e interessanti per comprendere il presente, la sua vuotezza, la sua disoccupazione intellettuale e morale. Si tratta di una forma di «senno del poi» delle più strabilianti. In realtà, con tutte le professioni di fede spiritualistiche e volontaristiche, storicistiche e dialettiche ecc., il pensiero che domina è quello evoluzionistico volgare, fatalistico, positivistico. Si potrebbe porre così la quistione: ogni «ghianda» può pensare di diventar quercia. Se le ghiande avessero una ideologia, questa sarebbe appunto di sentirsi «gravide» di querce. Ma, nella realtà, il 999 per mille delle ghiande servono di pasto ai maiali e, al più, contribuiscono a crear salsicciotti e mortadella.
Q9 §132 Argomenti di cultura. 1°) È ancora possibile, nel mondo moderno, l’egemonia culturale di una nazione sulle altre? Oppure il mondo è già talmente unificato nella sua struttura economico‑sociale, che un paese, se può avere «cronologicamente» l’iniziativa di una innovazione, non ne può però conservare il «monopolio politico» e quindi servirsi di questo monopolio per farsene una base di egemonia? Quale significato quindi può avere oggi il nazionalismo? Non è esso possibile solo come «imperialismo» economico‑finanziario, ma non più come «primato civile» o egemonia politico‑intellettuale?
2°) Forme di «neolalismo». Il neolalismo come manifestazione patologica individuale. Ma non si può impiegare il termine in senso metaforico, per indicare tutta una serie di manifestazioni culturali, artistiche, intellettuali? Cosa sono tutte le scuole e scolette artistiche e letterarie, se non manifestazioni di neolalismo culturale? Nei periodi di crisi si hanno le manifestazioni più estese e molteplici di neolalismo.
La lingua e le lingue. Ogni espressione ha una «lingua» storicamente determinata, ogni attività intellettuale e morale: questa lingua è ciò che si chiama anche «tecnica» e anche struttura. Se un letterato si mettesse a scrivere in un linguaggio personalmente arbitrario (cioè diventasse un «neolalico» nel senso patologico della parola) e fosse imitato da altri, si parlerebbe di «Babele» delle lingue. La stessa impressione non si prova per il linguaggio (tecnica) musicale, pittorico, plastico ecc. Questo punto è da esaminate e da meditare.
Dal punto di vista della storia della cultura, e quindi anche della «creazione» culturale (da non confondersi con la «creazione artistica», ma da avvicinare invece alle attività «politiche» – e infatti in questo senso si può parlare di una «politica culturale») tra l’arte letteraria e le altre arti (figurative e musicali o orchestriche) esiste una differenza che bisognerebbe definire e precisare in modo teoricamente giustificato e comprensibile. L’espressione «verbale» ha un carattere strettamente nazionale‑popolare‑culturale; una poesia di Goethe, nell’originale, può essere capita e rivissuta solo da un tedesco; Dante può essere capito e rivissuto solo da un italiano colto ecc. Una statua di Michelangelo, un brano musicale di Verdi, un balletto russo, un quadro di Raffaello ecc. può essere capito quasi immediatamente da qualsiasi cittadino del mondo, anche non cosmopolita, anche se non ha superato l’angusta cerchia di una provincia del suo paese. Tuttavia questo è così solo in apparenza, superficialmente. L’emozione artistica che un giapponese o un lappone prova dinanzi a un quadro di Raffaello o ascoltando un brano di Verdi è una emozione artistica; lo stesso giapponese o lappone non potrebbe non restare insensibile e sordo se ascoltasse recitare una poesia di Dante, di Goethe, di Shelley; c’è quindi una profonda differenza tra l’espressione «verbale» e quelle delle arti figurative, della musica ecc.
Tuttavia, l’emozione artistica del giapponese o del lappone dinanzi a un quadro di Raffaello o ad un brano musicale di Verdi non sarà della stessa intensità e calore dell’emozione artistica di un italiano medio e tanto meno di un italiano colto. Cioè accanto o meglio al di sotto dell’espressione di carattere «cosmopolita» del linguaggio musicale, pittorico ecc., «internazionale», c’è una più profonda sostanza culturale più ristretta, più «nazionale‑popolare».
Non basta: i gradi di questo «linguaggio» sono diversi: c’è un grado «nazionale‑popolare» (e spesso prima di questo un grado provinciale‑dialettale‑folcloristico), poi un grado di una determinata «civiltà», che può determinarsi dalla religione (per esempio cristiana, ma divisa in cattolica e protestante e ortodossa ecc.), e anche, nel mondo moderno, di una determinata «corrente culturale-politica». Durante la guerra, per esempio, un oratore inglese, francese, russo, poteva parlare a un pubblico italiano nella sua lingua incompresa delle devastazioni tedesche nel Belgio: se il pubblico simpatizzava con l’oratore, se cioè il suo modo di pensare coincideva all’ingrosso con quello dell’oratore, il pubblico ascoltava attentamente e «seguiva» l’oratore, si può dire lo «comprendesse». È vero che nell’oratoria non è solo elemento la «parola»: c’è il gesto, il tono della voce, ecc., cioè un elemento musicale che comunica il leit motiv del sentimento predominante, della passione principale e l’elemento «orchestrico», il gesto in senso largo, che scandisce e articola l’onda sentimentale e passionale.
Per una politica di cultura queste osservazioni sono indispensabili, per una politica di cultura delle masse popolari sono fondamentali. Ecco la ragione del «successo» internazionale del cinematografo modernamente e, prima, del «melodramma» in particolare e della musica in generale.
Q9 §133 Machiavelli. Il cesarismo. Cesare, Napoleone I, Napoleone III, Cromwell, ecc. Fare un catalogo degli eventi storici che hanno culminato in una grande personalità «eroica». Si può dire che il cesarismo o bonapartismo esprime una situazione in cui le forze in lotta si equilibrano in modo catastrofico, cioè si equilibrano in modo che la continuazione della lottanon può concludersi che con la distruzione reciproca. Quando la forza progressiva A lotta con la forza regressiva B, può avvenire non solo che A vinca B o B vinca A, può avvenire anche che non vinca né A né B ma si svenino reciprocamte e una terza forza C intervenga dall’esterno assoggettando ciò che resta di A e di B. Nell’Italia dopo la morte di Lorenzo il Magnifico è appunto successo questo, come era successo nel mondo antico con le invasioni barbariche. Ma il cesarismo, se esprime sempre la soluzione «arbitrale», affidata a una grande personalità, di una situazione storico‑politica di un equilibrio delle forze a tendenza catastrofica, non ha sempre lo stesso significato storico. Ci può essere un cesarismo progressivo e un cesarismo regressivo, e il significato esatto di ogni forma di cesarismo, in ultima analisi, può essere ricostruito dalla storia concreta e non da uno schema sociologico. È progressivo il cesarismo quando il suo intervento aiuta la forza progressiva a trionfare sia pure con certi compromessi limitativi della vittoria; è regressivo quando il suo intervento aiuta a trionfare la forza regressiva, anche in questo caso con certi compromessi e limitazioni, che però hanno un valore, una portata e un significato diversi che non nel caso precedente. Cesare e Napoleone I sono esempi di cesarismo progressivo. Napoleone III (e anche Bismarck) di cesarismo regressivo. Si tratta di vedere se nella dialettica «rivoluzione‑restaurazione» è l’elemento rivoluzione o quello restaurazione che prevale, poiché è certo che nel movimento storico non si torna mai indietro e non esistono restaurazioni «in toto».
Del resto, il fenomeno «cesarista» è una formula più polemico-ideologica che non storico‑politica. Si può avere «soluzione cesarista» anche senza un cesare, senza una grande personalità «eroica» e rappresentativa. Il sistema parlamentare ha dato il meccanismo per tali soluzioni di compromesso, I governi «laburisti» di Mac Donald erano soluzioni di tale specie in un certo grado; il grado di cesarismo si intensificò quando si ebbe il governo con Mac Donald presidente e la maggioranza conservatrice. Così in Italia nell’ottobre 1922, fino al distacco dei popolari e poi gradatamente fino al 3 gennaio 1925 e ancora fino all’8 novembre 1926, si ebbe un moto politico‑storico in cui diverse gradazioni di cesarismo si succedettero fino a una forma più pura e permanente, sebbene anch’essa non immobile e statica. Ogni governo di coalizione è un grado iniziale di cesarismo, che può o non può svilupparsi fino ai gradi più significativi.
Nel mondo moderno, con le sue grandi coalizioni di carattere economico‑sindacale e politico, di partito, il meccanismo del fenomeno cesarista è diverso da quello che fu fino a Napoleone III; nel periodo fino a Napoleone III le forze militari regolari o di linea erano un elemento decisivo del cesarismo e questo si verificava con colpi di Stato ben precisi, con azioni militari ecc. Nel mondo moderno le forze sindacali e politiche, coi mezzi finanziari incalcolabili di cui possono disporre piccoli gruppi di cittadini, complicano il fenomeno; i funzionari dei partiti e dei sindacati economici possono essere corrotti o terrorizzati, senza bisogno di azione militare in grande stile, tipo Cesare o 18 brumaio. Si riproduce in questo campo la stessa situazione studiata a proposito della formula giacobino‑quarantottesca della così detta «rivoluzione permanente». Il «tecnicismo» politico moderno è completamente mutato dopo il 48, dopo l’espansione del parlamentarismo, del regime associativo sindacale e di partito, del formarsi di vaste burocrazie statali e «private» (politico‑private, di partito e sindacali) e le trasformazioni avvenute nell’organizzazione della polizia in senso largo, cioè non solo del servizio statale destinato alla repressione della delinquenza, ma dell’insieme di forze organizzate dallo Stato e dai privati per tutelare il dominio politico ed economico della classe dirigente. In questo senso, interi partiti «politici» e altre organizzazioni economiche o di altro genere devono essere considerati organismi di polizia politica di carattere «repressivo» e «investigativo».
Q9 §134 Letteratura italiana. Pirandello. Altrove ho notato come in un giudizio critico‑storico su Pirandello, l’elemento «storia della cultura» debba essere superiore all’elemento «storia dell’arte», cioè che nell’attività letteraria pirandelliana prevale il valore culturale al valore estetico. Nel quadro generale della letteratura contemporanea, l’efficacia del Pirandello è stata più grande come «innovatore» del clima intellettuale che come creatore di opere artistiche: egli ha contribuito molto più dei futuristi a «sprovincializzare» l’«uomo italiano», a suscitare un atteggiamento «critico» moderno in opposizione all’atteggiamento «melodrammatico» tradizionale e ottocentista.
La quistione è però ancor più complessa di quanto appaia da questi cenni. E si pone così: i valori poetici del teatro pirandelliano (e il teatro è il terreno più proprio del Pirandello, l’espressione più compiuta della sua personalità poetico‑culturale) non solo devono essere isolati dalla sua attività prevalentemente di cultura, intellettuale‑morale, ma devono subire una ulteriore limitazione: la personalità artistica del Pirandello è molteplice e complessa. Quando il Pirandello scrive un dramma, egli non esprime «letterariamente», cioè con la parola, che un aspetto parziale della sua personalità artistica. Egli «deve» integrare la «stesura letteraria» con la sua opera di capocomico e di regista. Il dramma del Pirandello acquista tutta la sua espressività solo in quanto la «recitazione» sarà diretta dal Pirandello capo‑comico, cioè in quanto Pirandello avrà suscitato negli attori dati una determinata espressione teatrale e in quanto Pirandello regista avrà creato un determinato rapporto estetico tra il complesso umano che reciterà e l’apparato materiale della scena (luce, colori, messinscena in senso largo). Cioè il teatro pirandelliano è strettamente legato alla personalità fisica dello scrittore e non solo ai valori artistico‑letterari «scritti». Morto Pirandello (cioè, se Pirandello oltre che come scrittore, non opera come capo‑comico e come regista) cosa rimarrà del teatro di Pirandello? Un «canovaccio» generico, che in un certo senso può avvicinarsi agli scenari del tealtro pregoldoniano: dei «pretesti» teatrali, non della «poesia» eterna. Si dirà che ciò avviene per tutte le opere di teatro e in un certo senso ciò è vero. Ma solo in un certo senso. È vero che una tragedia di Shakespeare può avere diverse interpretazioni teatrali a seconda dei capocomici e dei registi, cioè è vero che ogni tragedia di Shakespeare può diventare «pretesto» per spettacoli teatrali diversamente originali: ma rimane che la tragedia «stampata» in libro, e letta individualmente, ha una sua vita artistica indipendente, che può astrarre dalla recitazione teatrale: è poesia e arte anche fuori del teatro e dello spettacolo. Ciò non avviene per Pirandello: il suo teatro vive esteticamente in maggior parte solo se «rappresentato» teatralmente, e se rappresentato teatralmente avendo il Pirandello come capocomico e regista. (Tutto ciò sia inteso con molto sale).
Q9 §135 Letteratura nazionale‑popolare. Gli «umili». Questa espressione «gli umili» è caratteristica per comprendere l’atteggiamento tradizionale degli intellettuali italiani verso il popolo e quindi il significato della letteratura per gli «umili». Non si tratta del rapporto contenuto nell’espressione dostoievschiana di «umiliati e offesi». In Dostoievskij c’è potente il sentimento nazionale‑popolare, cioè la coscienza di una «missione degli intellettuali» verso il popolo che magari è «oggettivamente» costituito di «umili», ma deve essere liberato da questa «umiltà», trasformato, rigenerato. Nell’intellettuale italiano l’espressione di «umili» indica un rapporto di protezione paterna e padreternale, il sentimento «sufficiente» di una propria indiscussa superiorità, il rapporto come tra due razze, una ritenuta superiore e l’altra inferiore, il rapporto come tra adulti e bambini nella vecchia pedagogia e peggio ancora, un rapporto da «società protettrice degli animali», o da esercito della Salute anglosassone verso i cannibali della Guinea.
Q9 §136 Machiavelli. Il cesarismo. Lo schema generico delle forze A e B in lotta con prospettiva catastrofica, cioè con la prospettiva che non vinca né A né B per l’esistenza di un equilibrio organico, da cui nasce (può nascere) il cesarismo, è appunto un’ipotesi generica, uno schema sociologico (di scienza politica) a tipo matematico. L’ipotesi può ancora essere resa più concreta, portata a un grado maggiore di approssimazione alla realtà concreta storica. Ciò può ottenersi precisando meglio alcuni elementi fondamentali. Così, parlando di A e B, si è solo detto che esse sono una forza genericamente progressiva e una forza genericamente regressiva: si può precisare di quale tipo di forza regressiva e progressiva si tratta e ottenere così maggiore approssimazione. Nel caso di Cesare e di Napoleone I si può dire che A e B, pur essendo distinte e contrastanti, non erano però tali da non poter venire «assolutamente» ad una fusione ed assimilazione reciproca dopo un processo molecolare, ciò che infatti avvenne, in una certa misura almeno (sufficiente tuttavia ai fini storico‑politici della cessazione della lotta organica fondamentale e quindi del superamento della fase catastrofica). Questo è un elemento di maggiore approssimazione.
Un altro elemento è il seguente: la fase catastrofica può annodarsi per deficienza politica momentanea della forza dominante tradizionale, e non già per una sua deficienza organica insuperabile necessariamente. Ciò appunto si è verificato nel caso di Napoleone III. La forza dominante in Francia dal 1815 al 1848, si era scissa politicamente in quattro frazioni: quella legittimista, quella orleanista, quella bonapartista, quella repubblicano‑giacobina. Le lotte interne di frazione erano tali da rendere possibile l’avanzata della forza antagonista B (progressista) in forma «precoce»; tuttavia la forma sociale esistente non aveva ancora esaurito le sue possibilità di sviluppo, come infatti la storia successiva mostrò abbondantemente. Napoleone III rappresentò (a suo modo, cioè secondo la statura dell’uomo che non era grande) queste possibilità latenti o immanenti; il suo cesarismo dunque è ancora di un tipo particolare. È obbiettivamente progressivo, sebbene non come quello di Cesare e di Napoleone I.
Il cesarismo di Cesare e di Napoleone I è stato, per così dire, di carattere quantitativo‑qualitativo, ha cioè rappresentato la fase storica di passaggio da un tipo di Stato a un altro tipo, un passaggio in cui le innovazioni furono tante quantitativamente e tali, da rappresentare un completo rivolgimento qualitativo. Il cesarismo di Napoleone III fu solo e limitatamente quantitativo; non ci fu passaggio da un tipo di Stato ad un altro tipo, ma solo «evoluzione» dello stesso tipo, secondo una linea ininterrotta.
Nel mondo moderno i fenomeni di cesarismo sono del tutto diversi, sia da quelli del tipo progressivo Cesare‑Napoleone I, come anche da quelli del tipo Napoleone III, sebbene si avvicinino a questo ultimo. Nel mondo moderno l’equilibrio a prospettive catastrofiche non si verifica tra forze contrastanti che in ultima analisi potrebbero fondersi e unificarsi, sia pure dopo un processo faticoso e sanguinoso, ma tra forze il cui contrasto è insanabile storicamente e si approfondisce anzi specialmente coll’avvento di forme cesaree. Il cesarismo ha tuttavia un margine, più o meno grande, a seconda dei paesi e del loro significato nella struttura mondiale, perché una forma sociale ha «sempre» possibilità marginali di ulteriore sviluppo e sistemazione organizzativa e specialmente può contare sulla debolezza relativa della forza antagonista e progressiva, per la natura e il modo di vita peculiare di essa. Il cesarismo moderno più che militare è poliziesco.
Q9 §137 Argomenti di cultura. Sullo sviluppo della tecnica militare. Il tratto più caratteristico e significativo dello stadio attuale della tecnica militare e quindi anche dell’indirizzo nelle ricerche scientifiche in quanto sono collegate con lo sviluppo della tecnica militare (o tendono a questo fine) mi pare sia da ricercare in ciò, che la tecnica militare in alcuni suoi aspetti tende a rendersi indipendente dal complesso della tecnica generale e a diventate un’attività a parte, autonoma. Fino alla guerra mondiale la tecnica militare era una semplice applicazione «specializzata» della tecnica generale e pertanto la potenza militare di uno Stato o di un gruppo di Stati (alleati per integrarsi a vicenda) poteva essere calcolata con esattezza quasi matematica sulla base della potenza economica (industriale, agricola, finanziaria, tecnico‑culturale). Dalla guerra mondiale in poi questo calcolo non è più possibile, almeno con pari esattezza; ciò costituisce la piùformidabile incognita della situazione politico‑militare attuale. Come punto di riferimento basta accennare a pochi elementi: il sottomarino, l’aeroplano di bombardamento, il gas e i mezzi chimici e batteriologici applicati alla guerra. Ponendo la quistione nei suoi termini-limite, per assurdo, si può dire che Andorra può produrre mezzi bellici in gas e batteri da distruggere l’intera Francia.
Questa situazione del tecnicismo militare è uno degli elementi più «silenziosaniente» operanti di quella trasformazione dell’arte politica che ha portato al passaggio, anche in politica, dalla «guerra di movimento» alla «guerra di posizione o di assedio».
Q9 §138 Passato e presente. Aneddoto di Giustino Fortunato. Pare sia del 1925 o 1926. Raccontato da Lisa. Pare che si parlasse col Fortunato della lotta politica in Italia. Egli avrebbe detto che, secondo lui, c’erano in Italia due uomini veramente pericolosi, uno dei quali era il Miglioli. Sarebbe stato presente, oltre il Lisa, un certo avv. Giordano Bruno, di cui non ho mai sentito parlare nonostante il suo tragico nome. Il Bruno avrebbe detto: «Ma, senatore, sono due uomini di grande ingegno!» ingenuamente, perché di solito «pericoloso» ha un significato strettamente «poliziesco». E il Fortunato, ridendo: «Appunto perché sono intelligenti sono pericolosi». Non so se l’aneddoto sia vero, e dato che sia vero, il Lisa l’abbia vissuto o solamente «sentito dire». Ma è verosimile e si inquadra perfettamente nel modo di pensare del Fortunato.
Ricordare la lettera del Fortunato riportata da Prezzolini
nella prima edizione del suo volume La Cultura italiana, e ricordare il necrologio
di Piero Gobetti scritto dall’Einaudi (e mi pare anche che il
Fortunato abbia scritto qualcosa nello stesso numero unico del
«Baretti»); in ogni modo il Fortunato si teneva in rapporti col
Gobetti e cercava di immunizzarlo dall’influsso della gente
«pericolosa».
Q9 §139 Gli intellettuali. Sulla funzione che hanno avuto gli
intellettuali in Ispagna prima della caduta della monarchia è da
vedere il libro di S. de Madariaga, Spagna. Saggio di storia contemporanea, a cura
di Alessandro Schiavi, Laterza, Bari, 1932. Sull’argomento deve
esistere una larga letteratura in Ispagna, attualmente, poiché
la repubblica si presenta come una repubblica di intellettuali.
Il fenomeno spagnolo ha caratteri propri, peculiari, determinati
dalla speciale situazione delle masse contadine in Ispagna. Pure
è da riavvicinare alla funzione dell’«intellighenzia» russa,
alla funzione degli intellettuali italiani nel Risorgimento,
degli intellettuali tedeschi sotto il dominio francese e agli
enciclopedisti del Settecento. Ma in Ispagna la funzione degli
intellettuali nella politica ha un suo carattere inconfondibile
e può valere la pena di essere studiata.
Q9 §140 Sulla civiltà inglese. Le pubblicazioni sulla letteratura inglese di J. J. Jusserand (Storia letteraria del popolo inglese, Histoire littéraire, ecc.). L’opera di Jusserand è fondamentale anche per gli studiosi inglesi. Jusserand fu diplomatico francese a Londra; era stato allievo di Gaston Paris e di Ippolito Taine. Al momento della sua morte (verso il settembre 1932) dell’opera principale dello Jusserand, Histoire littéraire du Peuple Anglais erano usciti due volumi; un terzo e conclusivo doveva seguire. Altri lavori sulla letteratura inglese e sulla storia della cultura inglese dello stesso autore.
Q9 §141 Passato e presente. Caratteri del popolo italiano. Come si spiega la relativa popolarità «politica» di G. D’Annunzio? È innegabile che in D’Annunzio sono sempre esistiti alcuni elementi di «popolarismo»: dai suoi discorsi come candidato al Parlamento, dal suo gesto nel Parlamento, nella tragedia La Gloria, nel Fuoco (discorso su Venezia e l’artigianato), nel Canto di calendimaggio e giù giù fino alle manifestazioni (alcune almeno) politiche fiumane. Ma non mi pare che siano «concretamente» questi elementi di reale significato politico (vaghi, ma reali) a spiegare questa relativa popolarità. Altri elementi hanno concorso: 1°) l’apoliticità fondamentale del popolo italiano (specialmente della piccola borghesia e dei piccoli intellettuali), apoliticità irrequieta, riottosa, che permetteva ogni avventura, che dava a ogni avventuriero la possibilità di avere un seguito di qualche decina di migliaia di uomini, specialmente se la polizia lasciava fare o si opponeva solo debolmente e senza metodo; 2°) il fatto che non era incarnata nel popolo italiano nessuna tradizione di partito politico di massa, che non esistevano cioè «direttive» storico‑politiche di massa orientatrici delle passioni popolari, tradizionalmente forti e dominanti; 3°) la situazione del dopoguerra, in cui tali elementi si presentavano moltiplicati, perché, dopo quattro anni di guerra, decine di migliaia di uomini erano diventati moralmente e socialmente «vagabondi», disancorati, avidi di sensazioni non più imposte dalla disciplina statale, ma liberamente, volontariamente scelte a se stessi; 4°) quistioni sessuali, che dopo quattro anni di guerra si capisce essersi riscaldate enormemente: le donne di Fiume attiravano molti (e su questo elemento insiste stranamente anche Nino Daniele nel suo volumetto su D’Annunzio). Questi elementi sembrano inetti solo se non si pensa che i ventimila giovani raccoltisi a Fiume non rappresentavano una massa socialmente e territorialmente omogenea, ma erano «selezionati» da tutta Italia, ed erano delle origini più diverse e disparate; molti erano giovanissimi e non avevano fatto la guerra, ma avevano letto la letteratura di guerra e i romanzi di avventura.
Tuttavia al di sotto di queste motivazioni momentanee e d’occasione pare si debba anche porre un motivo più profondo e permanente, legato a un carattere permanente del popolo italiano: l’ammirazione ingenua e fanatica per l’intelligenza come tale, per l’uomo intelligente come tale, che corrisponde al nazionalismo culturale degli italiani, forse unica forma di sciovinismo popolare in Italia. Per apprezzare questo nazionalismo bisogna pensare alla Scoperta dell’America di Pascarella: il Pascarella è l’«aedo» di questo nazionalismo e il suo tono canzonatorio è il più degno di tale epopea. Questo sentimento è diversamente forte nelle varie parti d’Italia (è più forte in Sicilia e nel Mezzogiorno), ma è diffuso da per tutto in una certa dose, anche a Milano e a Torino (a Torino certo meno che a Milano e altrove): è più o meno ingenuo, più o meno fanatico, anche più o meno «nazionale» (si ha l’impressione, per esempio, che a Firenze sia più regionale che altrove, e così a Napoli, dove è anche di carattere più spontaneo e popolare in quanto i napoletani credono di essere più intelligenti di tutti come massa e singoli individui; a Torino poche «glorie» letterarie e più tradizione politico‑nazionale, per la tradizione ininterrotta di indipendenza e libertà nazionale). D’Annunzio si presentava come la sintesi popolare di tali sentimenti: «apoliticità» fondamentale, nel senso che da lui ci si poteva aspettare tutti i fini immaginabili, dal più sinistro al più destro, e l’essere D’Annunzio ritenuto popolarmente l’uomo più intelligente d’Italia.
Q9 §142 Machiavelli. Volontarismo e «massa sociale». In tutta una serie di quistioni, di ricostruzione storica del passato e di analisi storico‑politica per l’azione da compiere, non si tiene conto di questo elemento: che occorre distinguere e valutare diversamente le imprese e le organizzazioni di volontari, dalle imprese e dalle organizzazioni di «blocchi omogenei sociali». Ciò ha grande importanza specialmente in Italia: 1°) per l’apoliticismo e la passività tradizionale delle grandi masse popolari che ha come reazione naturale una relativa facilità al «reclutamento di volontari»; 2°) per la costituzione sociale italiana, uno dei cui elementi è la morbosa quantità di borghesi rurali o di tipo rurale, medi e piccoli, che sono l’elemento che dà molti intellettuali irrequieti e quindi «volontari» per ogni iniziativa anche la più bizzarra che sia vagamente sovversiva (a destra o a sinistra). Nell’analisi dei partiti politici italiani si può vedere che essi sono stati sempre di «volontari», in un certo senso di declassés, e mai o quasi di «blocchi omogenei sociali». Un’eccezione è stata la «destra storica» cavourriana e quindi la sua superiorità organica e permanente sul Partito d’Azione mazziniano e garibaldino, che è stato il prototipo di tutti i partiti italiani di «massa», che non erano in realtà tali (cioè non contenevano blocchi omogenei sociali) ma attendamenti zingareschi e nomadi della politica. Si può trovare una sola analisi di tal genere (ma imprecisa e gelatinosa, da un punto di vista solo «statistico-sociologico») in Roberto Michels nel volume Borghesia e proletariato. La posizione di Gottlieb [Amadeo Bordiga ndc] era appunto quella del Partito d'Azione mazziniano, anch’essa zingaresca e nomade: l’interesse sindacale era solo pelle pelle e di origine polemica, non organico, non sistematico, non di ricerca di omogeneità sociale, ma «paternalistico», formalistico, meccanicistico.
QUADERNO 10
LA FILOSOFIA DI BENEDETTO CROCE
Alcuni criteri generali metodici per la critica della filosofia del Croce. Conviene, in un primo momento, studiare la filosofia del Croce secondo alcuni criteri affermati dallo stesso Croce criteri, che a loro volta, fanno parte della concezione generale stessa:
1) Non cercare nel Croce un «problema filosofico generale», ma vedere nella sua filosofia, quel problema o quella serie di problemi che più interessano nel momento dato, che, cioè, sono più aderenti alla vita attuale e ne sono come il riflesso: questo problema o serie di problemi mi pare sia quello della storiografia da una parte e quello della filosofia della pratica, della scienza politica, dell’etica, dall’altra.
2) Occorre studiare attentamente gli scritti «minori» del Croce, cioè oltre le opere sistematiche e organiche, le raccolte di articoli, di postille, di piccole memorie, che hanno un maggiore e più evidente legame con la vita, col movimento storico concreto.
3) Occorre stabilire una «biografia filosofica» del Croce, cioè identificare le diverse espressioni assunte dal pensiero del Croce, la diversa impostazione e risoluzione di certi problemi, i nuovi problemi sorti dal suo lavorio e impostisi alla sua attenzione, e per questa ricerca appunto è utile lo studio dei suoi scritti minori, nella collezione della «Critica» e nelle altre pubblicazioni che li contengono; la base di questa ricerca può essere data dal Contributo alla critica di me stesso e dagli scritti, certamente autorizzati, di Francesco Flora e di Giovanni Castellano.
4) Critici del Croce: positivisti, neoscolastici, idealisti attuali. Obbiezioni di questi critici.
Q10 §1 Come si può impostare per la filosofia del Croce il problema di «rimettere l’uomo sulle proprie gambe», di farlo camminare coi piedi e non con la testa? È il problema dei residui di «trascendenza, di metafisica, di teologia» nel Croce, è il problema della qualità del suo «storicismo». Il Croce afferma spesso e volentieri di aver fatto ogni sforzo per espungere dal suo pensiero ogni traccia residua di trascendenza, di teologia, di metafisica, fino a rifiutare in filosofia ogni idea di «sistema» e di «problema fondamentale». Ma è però esatto che ci sia riuscito?
Il Croce si afferma «dialettico» (sebbene introduca nella dialettica una «dialettica dei distinti», oltre alla dialettica degli opposti, che non è riuscito a dimostrare cosa sia dialettica o cosa sia esattamente) ma il punto da chiarire è questo: nel divenire vede egli il divenire stesso o il «concetto» di divenire? Questo mi pare il punto da cui occorre partire per approfondire: 1) lo storicismo del Croce, e in ultima analisi, la sua concezione della realtà, del mondo, della vita, cioè la sua filosofia «tout court»; 2) il suo dissenso dal Gentile e dall’idealismo attuale; 3) la sua incomprensione del materialismo storico, accompagnata dall’ossessione del materialismo storico stesso. Che il Croce sia stato sempre ossessionato dal materialismo storico e lo sia tuttora in forma anche più acuta che nel passato non è difficile dimostrare. Che una tale ossessione sia diventata spasmodica in questi ultimi anni è dimostrato: dagli accenni contenuti negli Elementi di politica, dal suo intervento a proposito dell’estetica del materialismo storico nel Congresso di Oxford (cfr notizia pubblicata nella «Nuova Italia»), dalla recensione delle opere complete di Marx Engels pubblicata nella «Critica» del 1930, dall’accenno contenuto nei Capitoli introduttivi di una Storia dell’Europa nel secolo XIX, dalle lettere al Barbagallo pubblicate nella «Nuova Rivista Storica» del 1928‑29 e specialmente dall’importanza data al libro del Fülöp‑Miller, come appare da alcune pubblicate nella «Critica» nel 1925 (mi pare).
Se è necessario, nel perenne fluire degli avvenimenti, fissare dei concetti, senza i quali la realtà non potrebbe essere compresa, occorre anche, ed è anzi imprescindibile, fissare e ricordare che realtà in movimento e concetto della realtà, se logicamente possono essere distinti, storicamente devono essere concepiti come unità inseparabile. Altrimenti avviene ciò che avviene al Croce, che la storia diventa una storia formale, una storia di concetti, e in ultima analisi una storia degli intellettuali, anzi una storia autobiografica del pensiero del Croce, una storia di mosche cocchiere. Il Croce sta cadendo in una nuova e strana forma di sociologismo «idealistico», non meno buffo e inconcludente del sociologismo positivistico.
Q10 §2 Identità di storia e filosofia. L’identità di storia e filosofia è immanente nel materialismo storico (ma, in un certo senso, come previsione storica di una fase avvenire). Ha preso il Croce l’abbrivo dalla filosofia della praxis di Antonio Labriola? In ogni modo questa identità è diventata, nella concezione del Croce, ben altra cosa da quella che è immanente nel materialismo storico: esempio gli ultimi scritti di storia etico‑politica del Croce stesso. La proposizione che il proletariato tedesco è l’erede della filosofia classica tedesca contiene appunto l’identità tra storia e filosofia; così la proposizione che i filosofi hanno finora solo spiegato il mondo e che ormai si tratta di trasformarlo.
Questa proposizione del Croce della identità di storia e di filosofia è la più ricca di conseguenze critiche: 1) essa è mutila se non giunge anche alla identità di storia e di politica (e dovrà intendersi politica quella che si realizza e non solo i tentativi diversi e ripetuti di realizzazione alcuni dei quali falliscono presi in sé) e, 2) quindi anche alla identità di politica e di filosofia. Ma se è necessario ammettere questa identità, come è più possibile distinguere le ideologie (uguali, secondo Croce, a strumenti di azione politica) dalla filosofia? Cioè la distinzione sarà possibile, ma solo per gradi (quantitativa) e non qualitativamente. Le ideologie, anzi, saranno la «vera» filosofia, perché esse risulteranno essere quelle «volgarizzazioni» filosofiche che portano le masse all’azione concreta, alla trasformazione della realtà. Esse, cioè, saranno l’aspetto di massa di ogni concezione filosofica, che nel «filosofo» acquista caratteri di universalità astratta, fuori del tempo e dello spazio, caratteri peculiari di origine letteraria e antistorica.
La critica del concetto di storia nel Croce è essenziale: non ha essa un’origine puramente libresca e erudita? Solo l’identificazione di storia e politica toglie alla storia questo suo carattere. Se il politico è uno storico (non solo nel senso che fa la storia, ma nel senso che operando nel presente interpreta il passato), lo storico è un politico e in questo senso (che del resto appare anche nel Croce) la storia è sempre storia contemporanea, cioè politica: ma il Croce non può giungere fino a questa conclusione necessaria, appunto perché essa porta all’identificazione di storia e politica e quindi di ideologia e filosofia.
Q10 §3 Croce e Bernstein [Trotzky ndc]. Nella lettera di Sorel a Croce del 9 settembre 1899 (confrontare tutta la lettera nella «Critica») è scritto: «Bernstein vient de m’écrire qu’il a indiqué dans la “Neue Zeit” n° 46, qu’il avait été inspiré, en une certaine mesure, par vos travaux. Cela est intéressant parce que les Allemands ne sont pas faits pour indiquer des sources étrangères à leurs idées».
Q10 §4 Croce e Hegel. Dall’articolo di Guido Calogero, Il neohegelismo nel pensiero italiano contemporaneo, Nuova Antologia, 16 agosto 1930 (si tratta della relazione letta in tedesco dal Calogero al l° Congresso internazionale hegeliano, tenutosi all’Aja dal 21 al 24 aprile 1930): «Per il Croce ... il pregio della dottrina hegeliana è anzitutto quello della sua “logica della filosofia” e cioè della sua teoria della dialettica, come unica forma del pensiero mediante cui esso possa realmente superare, unificandoli, tutti quei dualismi che sul piano della classica logica intellettualistica esso non può che constatare, smarrendo con ciò il senso dell’unità del reale. La conquista immortale di Hegel è l’affermazione dell’unità degli opposti, concepita non nel senso di una statica e mistica coincidentia oppositorum ma in quello di una dinamica concordia discors: la quale è assolutamente necessaria alla realtà perché essa possa esser pensata come vita, svolgimento, valore, in cui ogni positività sia costretta a realizzarsi insieme affermando ed eternamente superando la sua negatività. Nello stesso tempo, la conciliazione dialettica dei dualismi essenziali del reale (bene e male, vero e falso, finito e infinito ecc.) porta all’esclusione categorica di tutte quelle altre forme di dualismo, che si basano sulla fondamentale antitesi di un mondo della realtà e di un mondo dell’apparenza, di una sfera della trascendenza o del noumeno e di una sfera dell’immanenza o del fenomeno: antitesi che tutte si eliminano per la rigorosa dissoluzione del loro elemento trascendente o noumenico, che rappresenta la mera esigenza, per tal via insoddisfabile e ora altrimenti soddisfatta, di salire dal mondo delle antinomie e delle contraddizioni a quello della immota e pacifica realtà. Hegel è così il vero instauratore dell’immanentismo: nella dottrina dell’identità del razionale e del reale è consacrato il concetto del valore unitario del mondo nel suo concreto sviluppo, come nella critica dell’astratto sollen si esprime tipicamente l’antitesi ad ogni negazione di quell’unità e ad ogni ipostatizzazione dell’ideale in una sfera trascendente a quella della sua realizzazione effettiva. E da questo punto di vista, per la prima volta, il valore della realtà s’identifica assolutamente con quello della sua storia: nell’immanenza hegeliana è insieme, così, la fondazione capitale di tutto lo storicismo moderno.
Dialettica, immanentismo, storicismo: questi, si potrebbe riassumere, i meriti essenziali del hegelismo dal punto di vista del pensiero crociano, che sotto questo rispetto può realmente sentirsene seguace e continuatore».
Q10 §5 Scienza della politica. Cosa significa l’accusa di «materialismo» che spesso il Croce fa a determinate tendenze politiche? Si tratta di un giudizio di ordine teorico, scientifico, o di una manifestazione di polemica politica in atto? Materialismo, in queste polemiche, pare significhi «forza materiale», «coercizione», «fatto economico» ecc. Ma forse che la «forza materiale», la «coercizione», il «fatto economico» sono «materialistici»? Cosa significherebbe «materialismo» in questo caso? Cfr Etica e Politica, p. 341: «Vi sono tempi nei quali ecc.».
Q10 §6 Introduzione allo studio della filosofia.
I. Il termine di «catarsi». Si può impiegare il termine di «catarsi» per indicare il passaggio dal momento meramente economico (o egoistico‑passionale) al momento etico-politico, cioè l’elaborazione superiore della struttura in superstruttura nella coscienza degli uomini. Ciò significa anche il passaggio dall’«oggettivo al soggettivo» e dalla «necessità alla libertà». La struttura da forza esteriore che schiaccia l’uomo, lo assimila a sé, lo rende passivo, si trasforma in mezzo di libertà, in strumento per creare una nuova forma etico‑politica, in origine di nuove iniziative. La fissazione del momento «catartico» diventa così, mi pare, il punto di partenza per tutta la filosofia della praxis; il processo catartico coincide con la catena di sintesi che sono risultato dello svolgimento dialettico. (Ricordare i due punti tra cui oscilla questo processo: – che nessuna società si pone compiti per la cui soluzione non esistano già o siano in via di apparizione le condizioni necessarie e sufficienti – e che nessuna società perisce prima di aver espresso tutto il suo contenuto potenziale).
II. Concezione soggettiva della realtà e filosofia della praxis. La filosofia della praxis «assorbe» la concezione soggettiva della realtà (l’idealismo) nella teoria delle superstrutture, l’assorbe e lo spiega storicamente, cioè lo «supera», lo riduce a un suo «momento». La teoria delle superstrutture è la traduzione in termini di storicismo realistico della concezione soggettiva della realtà.
III. Realtà del mondo esterno. Oltre all’esempio di Tolstoi ricordare la forma faceta in cui un giornalista rappresentava il filosofo «professionale o tradizionale» (rappresentato dal Croce nel cap. «Il “Filosofo”») che da anni e anni sta seduto al suo tavolino, rimirando il calamaio e domandandosi: – Questo calamaio è dentro di me o è fuori di me?
IV. Traducibilità dei linguaggi scientifici. Le scritte in questa rubrica devono essere raccolte appunto nella rubrica generale sui rapporti delle filosofie speculative e la filosofia della praxis e della loro riduzione a questa come momento politico che la filosofia della praxis spiega «politicamente». Riduzione a «politica» di tutte le filosofie speculative, a momento della vita storico‑politica; la filosofia della praxis concepisce la realtà dei rapporti umani di conoscenza come elemento di «egemonia» politica.
Q10 §7 Identificazione di individuo e Stato. Per mostrare il verbalismo delle nuove enunciazioni di «economia speculativa» del gruppo Spirito e C. basta ricordare che l’identificazione di individuo e Stato è anche l’identificazione di Stato e individuo; un’identità non muta se un termine è primo o secondo nell’ordine grafico e fonico, evidentemente. Perciò dire che occorre identificare individuo e Stato è meno che nulla, è puro vaniloquio, se le cose stessero in questi termini. Se individuo significa «egoismo» in senso gretto, «sordidamente ebraico», la identificazione non sarebbe che un modo metaforico di accentuare l’elemento «sociale» dell’individuo, ossia di affermare che «egoismo» in senso economico significa qualcosa di diverso da «grettamente egoista». Mi pare che anche in questo caso si tratta della assenza di una chiara enunciazione del concetto di Stato, e della distinzione in esso tra società civile e società politica, tra dittatura ed egemonia, ecc.
Q10 §8 Libertà e «automatismo» o razionalità. Sono in contrasto la libertà e il così detto automatismo? L’automatismo è in contrasto con l’arbitrio, non con la libertà. L’automatismo è una libertà di gruppo, in opposizione all’arbitrio individualistico. Quando Ricardo diceva «poste queste condizioni» si avranno queste conseguenze in economia, non rendeva «deterministica» l’economia stessa, né la sua concezione era «naturalistica». Osservava che posta l’attività solidale e coordinata di un gruppo sociale, che operi secondo certi principii accolti per convinzione (liberamente) in vista di certi fini, si ha uno sviluppo che si può chiamare automatico e si può assumere come sviluppo di certe leggi riconoscibili e isolabili col metodo delle scienze esatte. In ogni momento c’è una scelta libera, che avviene secondo certe linee direttrici identiche per una gran massa di individui o volontà singole, in quanto queste sono diventate omogenee in un determinato clima etico‑politico. Né è da dire che tutti operano in modo uguale: gli arbitrî individuali sono anzi molteplici, ma la parte omogenea predomina e «detta legge». Che se l’arbitrio si generalizza, non è più arbitrio ma spostamento della base dell’«automatismo», nuova razionalità. Automatismo è niente altro che razionalità, ma nella parola «automatismo» è il tentativo di dare un concetto spoglio di ogni alone speculativo: è possibile che la parola razionalità finisca coll’attribuirsi all’automatismo nelle operazioni umane, mentre quella «automatismo» tornerà a indicare il movimento delle macchine, che diventano «automatiche» dopo l’intervento dell’uomo e il cui automatismo è solo una metafora verbale, come lo è detto delle operazioni umane.
Q10 §9 Introduzione allo studio della filosofia. Immanenza speculativa e immanenza storicistica o realistica. Si afferma che la filosofia della praxis è nata sul terreno del massimo sviluppo della cultura della prima metà del secolo XIX, cultura rappresentata dalla filosofia classica tedesca, dall’economia classica inglese, e dalla letteratura e pratica politica francese. All’origine della filosofia della praxis sono questi tre momenti culturali. Ma in che senso occorre intendere questa affermazione? Che ognuno di questi movimenti ha contribuito a elaborare rispettivamente la filosofia, l’economia, la politica della filosofia della praxis? Oppure che la filosofia della praxis ha elaborato sinteticamente i tre movimenti, cioè l’intera cultura dell’epoca, e che nella sintesi nuova, in qualsiasi momento la si esamini, momento teorico, economico, politico, si ritrova come «momento» preparatorio ognuno dei tre movimenti? Così appunto a me pare. E il momento sintetico unitario mi pare da identificare nel nuovo concetto di immanenza, che dalla sua forma speculativa, offerta dalla filosofia classica tedesca, è stato tradotto in forma storicistica coll’aiuto della politica francese e dell’economia classica inglese. Per ciò che riguarda i rapporti di identità sostanziale tra il linguaggio filosofico tedesco e il linguaggio politico francese cfr le contenute sparsamente nei diversi quaderni. Ma una ricerca delle più interessanti e feconde mi pare debba essere fatta a proposito dei rapporti tra filosofia tedesca, politica francese e economia classica inglese.
In un certo senso mi pare si possa dire che la filosofia della praxis è uguale a Hegel + Davide Ricardo. Il problema è da presentare inizialmente così: i nuovi canoni metodologici introdotti dal Ricardo nella scienza economica sono da considerarsi come valori meramente strumentali (per intendersi, come un nuovo capitolo della logica formale) o hanno avuto un significato di innovazione filosofica? La scoperta del principio logico formale della «legge di tendenza», che porta a definire scientificamente i concetti fondamentali nell’economia di «homo oeconomicus» e di «mercato determinato» non è stata una scoperta di valore anche gnoseologico? Non implica appunto una nuova «immanenza», una nuova concezione della «necessità» e della libertà ecc.? Questa traduzione mi pare appunto abbia fatto la filosofia della praxis che ha universalizzato le scoperte di Ricardo estendendole adeguatamente a tutta la storia, quindi ricavandone originalmente una nuova concezione del mondo. Sarà da studiare tutta una serie di quistioni: 1) riassumere i principî scientifici‑formali del Ricardo nella loro forma di canoni empirici; 2) ricercare l’origine storica di questi principî ricardiani che sono connessi al sorgere della scienza economica stessa, cioè allo sviluppo della borghesia come classe «concretamente mondiale» e al formarsi quindi di un mercato mondiale già abbastanza «denso» di movimenti complessi perché se ne possano isolare e studiare delle leggi di regolarità necessarie, cioè delle leggi di tendenza, che sono leggi non in senso naturalistico o del determinismo speculativo, ma in senso «storicistico» in quanto cioè si verifica il «mercato determinato», ossia un ambiente organicamente vivo e connesso nei suoi movimenti di sviluppo. (L’economia studia queste leggi di tendenza in quanto espressioni quantitative dei fenomeni; nel passaggio dall’economia alla storia generale il concetto di quantità è integrato da quello di qualità e dalla dialettica quantità che diventa qualità quantità = necessità; qualità = libertà. La dialettica quantità‑qualità è identica a quella necessità‑libertà); 3) porre in connessione Ricardo con Hegel e con Robespierre; 4) come la filosofia della praxis è giunta dalla sintesi di queste tre correnti vive alla nuova concezione dell’immanenza, depurata da ogni traccia di trascendenza e di teologia.
Q10 §10 Introduzione allo studio della filosofia. 1) Una serie di concetti da approfondire è anche quella di: empirismo ‑ realismo storicistico ‑ speculazione filosofica.
2) Accanto alla ricerca accennata nel paragrafo precedente e riguardante la quistione dell’apporto ricardiano alla filosofia della praxis, è da porre quella accennata a p. 49 di questo stesso quaderno e riguardante l’atteggiamento della filosofia della praxis verso l’attuale continuazione della filosofia classica tedesca rappresentata dalla moderna filosofia idealistica italiana di Croce e Gentile. Come occorre intendere la proposizione di Engels sull’eredità della filosofia classica tedesca?. Occorre intenderla come un circolo storico ormai chiuso, in cui l’assorbimento della parte vitale dell’hegelismo è già definitivamente compiuto, una volta per tutte, o si può intendere come un processo storico ancora in movimento, per cui si riproduce una necessità nuova di sintesi culturale filosofica? A me pare giusta questa seconda risposta: in realtà si riproduce ancora la posizione reciprocamente unilaterale criticata nella prima tesi su Feuerbach tra materialismo e idealismo e come allora, sebbene in un momento superiore, è necessaria la sintesi in un momento di superiore sviluppo della filosofia della praxis.
Q10 §11 Punti di riferimento per un saggio su B. Croce. Per comprendere l’atteggiamento del Croce nel secondo dopoguerra è utile ricordare la risposta inviata da Mario Missiroli a una inchiesta promossa dalla rivista il «Saggiatore» e pubblicata nel 1932 (sarebbe interessante conoscere tutte le risposte all’inchiesta). Il Missiroli ha scritto (cfr «Critica Fascista» del 15 maggio 1932): «Non vedo ancora nulla di bene delineato, ma solo degli stati d’animo, delle tendenze soprattutto morali. Difficile prevedere quale potrà essere l’orientamento della coltura; ma non esito a formulare l’ipotesi che si vada verso un positivismo assoluto, che rimetta in onore la scienza e il razionalismo nel senso antico della parola. La ricerca sperimentale potrà essere il vanto di questa nuova generazione, che ignora e vuole ignorare i verbalismi delle recentissime filosofie. Non mi pare temerario prevedere una ripresa dell’anticlericalismo, che, personalmente, sono lungi dall’augurare».
Cosa potrà significare «positivismo assoluto»? La «previsione» del Missiroli coincide con l’affermazione fatta varie volte in queste che tutta l’attività teorica più recente del Croce si spiega con la previsione di una ripresa in grande stile e con caratteri tendenzialmente egemonici della filosofia della praxis, che può riconciliare la cultura popolare e la scienza sperimentale con una visione del mondo che non sia il grossolano positivismo né l’alambiccato attualismo né il libresco neotomismo.
Q10 §12 Introduzione allo studio della filosofia. La proposizione contenuta nell’introduzione alla Critica dell’economia politica che gli uomini prendono coscienza dei conflitti di struttura nel terreno delle ideologie deve essere considerata come un’affermazione di valore gnoseologico e non puramente psicologico e morale. Da ciò consegue che il principio teorico‑pratico dell’egemonia ha anche esso una portata gnoseologica e pertanto in questo campo è da ricercare l’apporto teorico massimo di Ilici [Lenin ndc] alla filosofia della praxis. Ilici avrebbe fatto progredire effettivamente la filosofia come filosofia in quanto fece progredire la dottrina e la pratica politica. La realizzazione di un apparato egemonico, in quanto crea un nuovo terreno ideologico, determina una riforma delle coscienze e dei metodi di conoscenza, è un fatto di conoscenza, un fatto filosofico. Con linguaggio crociano: quando si riesce a introdurre una nuova morale conforme a una nuova concezione del mondo, si finisce con l’introdurre anche tale concezione, cioè si determina una intera riforma filosofica.
Q10 §13 Introduzione allo studio della filosofia. Nel brano sul «materialismo francese nel secolo XVIII» (Sacra Famiglia) è abbastanza bene e chiaramente accennata la genesi della filosofia della praxis: essa è il «materialismo» perfezionato dal lavoro della stessa filosofia speculativa e fusosi con l’umanismo. È vero che con questi perfezionamenti del vecchio materialismo rimane solo il realismo filosofico.
Altro punto da meditare è questo: se la concezione di «spirito» della filosofia speculativa non sia una trasformazione aggiornata del vecchio concetto di «natura umana» proprio sia della trascendenza che del materialismo volgare, se cioè nella concezione dello «spirito» non ci sia altro che il vecchio «Spirito santo» speculativizzato. Si potrebbe allora dire che l’idealismo è intrinsecamente teologico.
Q10 §14 Punti di riferimento per un saggio su B. Croce. La posizione relativa del Croce nella gerarchia intellettuale della classe dominante è mutata dopo il Concordato e l’avvenuta fusione in una unità morale dei due tronconi di questa stessa classe. Occorre una doppia opera di educazione da parte dei responsabili: educazione del nuovo personale dirigente da «trasformare» e assimilare e educazione della parte cattolica, che per lo meno dovrà essere subordinata (anche subordinare è educare, in certe condizioni). L’entrata in massa dei cattolici nella vita statale dopo il Concordato (e sono entrati questa volta come e in quanto cattolici e anzi con privilegi culturali) ha reso molto più difficile l’opera di «trasformismo» delle forze nuove d’origine democratica. Che il Gentile non abbia capito il problema e l’abbia capito il Croce, mostra la diversa sensibilità nazionale tra i due filosofi: che il Gentile, per lo meno, se ha capito il problema, si sia messo nelle condizioni di non poter far nulla, all’infuori del lavoro da Università popolare degli Istituti di Cultura (i rabbiosi scritti dei suoi discepoli nei «Nuovi Studi» contro il cattolicismo, hanno ben poca eco) mostra la sua riduzione a una condizione ben misera di subalternità intellettuale. Non si tratta infatti di una educazione «analitica», cioè di una «istruzione», di un immagazzinamento di nozioni, ma di una educazione «sintetica», della diffusione di una concezione del mondo divenuta norma di vita, di una «religione» nel senso crociano. Che il Concordato avesse posto il problema, moltiplicandolo e complicandolo, era stato compreso dal Croce, come appare dal suo discorso al Senato. D’altronde è appunto il Concordato, con la sua introduzione nella vita statale di una grande massa di cattolici come tali, e come tali privilegiati, che ha posto il problema dell’educazione della classe dirigente non nei termini di «Stato etico», ma nei termini di «società civile» educatrice, cioè di una educazione per iniziativa «privata», che entra in concorrenza con quella cattolica, che nella società civile occupa ora tanta parte e in condizioni speciali.
Per comprendere quanto possa essere apprezzata l’attività del Croce in tutta la sua perseverante inflessibilità, dalla parte più responsabile, chiaroveggente (e conservatrice) della classe dominante, oltre alla citata «previsione» del Missiroli (e occorre capire cosa può significare di implicito senso critico il termine di «previsione» in questo caso), sarà utile ricordare una serie di articoli pubblicati da Camillo Pellizzi nel «Selvaggio» di Mino Maccari (che esce ora a Roma in forma di rivista mensile e che sarebbe interessante analizzare in tutta la collezione e nelle varie fasi). Dall’«Italia Letteraria» del 29 maggio 1932 ricopio testualmente un pezzo della Rassegna della Stampa compilata da Corrado Pavolini che commenta un brano di uno di questi articoli del Pellizzi: «Credere in poche cose, ma crederci! Ed è massima bellissima, leggibile nell’ultimo numero del “Selvaggio” (1° maggio). Mi dispiace per Camillo Pellizzi, fascista dei primi, galantuomo di tre cotte e acutissimo ingegno: ma lo stile ingarbugliato della sua ultima lettera aperta a Maccari: Il Fascismo come libertà mi fa venire il dubbio che i concetti dei quali parla non siano ben chiari nella sua mente; o, se chiari, pensati troppo in astratto per poter ricevere pratica applicazione: “Il fascismo è nato come il supremo sforzo di un popolo civile (anzi, del popolo più intimamente civile fra tutti) per attuare una forma di comunismo civile. Ossia risolvere il problema del comunismo dentro il maggior problema della civiltà; ma poiché non è civiltà senza la spontanea manifestazione di quei valori individuali antichi sempre rinnovantisi, di cui si è detto, noi concludiamo che il fascismo è, nella sua intima ed universale significazione, un comunismo libero; nel quale, per intendersi, comunistico o collettivistico è il mezzo, l’organismo empirico, lo strumento d’azione rispondente al problema di un determinato momento della storia, mentre il fine reale, la destinazione ultima, è la civiltà, ossia, nel senso ormai detto e ripetuto, la libertà”. È linguaggio indigesto di filosofo. “Credere a poche cose...” Per esempio, semplicisticamente credere che il fascismo non è comunismo, mai, in nessun senso, né concreto né traslato, può riuscir più “utile” che non affaticarsi alla ricerca di definizioni troppo ingegnose per non essere, in ultima analisi, equivoche e nocive. (C’è poi la relazione Spirito al Convegno corporativo di Ferrara...)».
Appare abbastanza chiaramente che la serie di scritti del Pellizzi pubblicati dal «Selvaggio» è stata suggerita dal libro ultimo del Croce ed è un tentativo di assorbire la posizione del Croce in una nuova posizione che il Pellizzi ritiene superiore e tale da risolvere tutte le antinomie. In realtà il Pellizzi si muove tra concetti da Controriforma e le sue elucubrazioni intellettualmente possono dar luogo a una nuova «Città del Sole», praticamente a una costruzione come quella dei gesuiti nel Paraguay. Ma questo importa poco, perché non si tratta di possibilità pratiche vicine o remote, né per il Pellizzi, né per lo Spirito; si tratta del fatto che tali svolgimenti astratti di pensiero mantengono fermenti ideologici pericolosi, impediscono che si formi una unità etico-politica nella classe dirigente, minacciano di rimandare all’infinito la soluzione del problema di «autorità», cioè del ristabilimento per consenso della direzione politica da parte dei gruppi conservatori. L’atteggiamento del Pellizzi mostra che la posizione dello Spirito a Ferrara non era un «monstrum» culturale; ciò è dimostrato anche da alcune pubblicazioni in «Critica Fascista» più o meno impacciate ed equivoche.
Q10 §15 relle di economia. La discussione intorno al concetto di «homo oeconomicus» è diventata una delle tante discussioni sulla così detta «natura umana». Ognuno dei disputanti ha una sua «fede», e la sostiene con argomenti di carattere prevalentemente moralistico. L’«homo oeconomicus» è l’astrazione dell’attività economica di una determinata forma di società, cioè di una determinata struttura economica. Ogni forma sociale ha il suo «homo oeconomicus», cioè una sua attività economica. Sostenere che il concetto di homo oeconomicus scientificamente non ha valore non è che un modo di sostenere che la struttura economica e la sua attività conforme è radicalmente mutata, oppure che la struttura economica è talmente mutata che necessariamente deve mutare il modo di operare economico, perché diventi conforme alla nuova struttura. Ma appunto in ciò è dissenso, e non tanto dissenso scientifico obbiettivo, ma politico. Cosa significherebbe del resto un riconoscimento scientifico che la struttura economica è mutata radicalmente e che deve mutare l’operare economico per conformarsi alla nuova struttura? Avrebbe un significato di stimolo politico, nulla più. Tra la struttura economica e lo Stato con la sua legislazione e la sua coercizione sta la società civile, e questa deve essere radicalmente trasformata in concreto e non solo sulla carta della legge e dei libri degli scienziati; lo Stato è lo strumento per adeguare la società civile alla struttura economica, ma occorre che lo Stato «voglia» far ciò, che cioè a guidare lo Stato siano i rappresentanti del mutamento avvenuto nella struttura economica. Aspettare che, per via di propaganda e di persuasione, la società civile si adegui alla nuova struttura, che il vecchio «homo oeconomicus» sparisca senza essere seppellito con tutti gli onori che merita, è una nuova forma di retorica economica una nuova forma di moralismo economico vacuo e inconcludente.
Q10 §16 Punti di riferimento per un saggio su B. Croce. Possono avere avuto importanza per il Croce gli amichevoli avvertimenti di L. Einaudi a proposito del suo atteggiamento di critico «disinteressato» della filosofia della praxis? È la stessa quistione presentata in altra forma: quanto sia l’elemento pratico immediato che spinge il Croce alla sua posizione attuale «liquidazionista». Si può osservare infatti come il Croce non intenda per nulla entrare in polemica coi filosofi della praxis, e come questa polemica lo interessi così poco da non spingerlo neppure a ricercare informazioni un po’ più abbondanti ed esatte di quelle di cui evidentemente dispone. Si può dire che il Croce non tanto si interessi di combattere la filosofia della praxis quanto l’economismo storico, cioè l’elemento di filosofia della praxis che è penetrato nella concezione del mondo tradizionale, disgregandola e perciò rendendola meno resistente «politicamente»; non tanto si interessi di «convertire» gli avversari, quanto di rafforzare il suo campo; cioè il Croce presenta come «offensiva» una attività che è meramente «difensiva». Se così non fosse il Croce dovrebbe (avrebbe dovuto) rivedere «sistematicamente» la sua opera specializzata sulla filosofia della praxis, confessare di essersi sbagliato completamente allora, dimostrare questi errori passati in contrasto con le convinzioni attuali ecc. In un uomo così accurato e scrupoloso come il Croce, il nessun interesse verso l’obbiettiva esigenza di giustificare logicamente quest’ultimo passaggio dei suoi modi di pensare, è per lo meno strano e non può essere spiegato altrimenti che con interessi pratici immediati.
Q10 §17 Introduzione allo studio della filosofia. Principi e preliminari. (Cfr quad. I, p. 63 bis). Cosa occorra intendere per filosofia, per filosofia di un’epoca storica, e quale sia l’importanza e il significato delle filosofie dei filosofi in ognuna di tali epoche storiche. Assunta la definizione che B. Croce dà della religione, cioè di una concezione del mondo che sia diventata norma di vita, poiché norma di vita non si intende in senso libresco ma attuata nella vita pratica, la maggior parte degli uomini sono filosofi in quanto operano praticamente e nel loro pratico operare (nelle linee direttive della loro condotta) è contenuta implicitamente una concezione del mondo, una filosofia. La storia della filosofia come si intende comunemente, cioè la storia delle filosofie dei filosofi, è la storia dei tentativi e delle iniziative ideologiche di una determinata classe di persone per mutare, correggere, perfezionare le concezioni del mondo esistenti in ogni determinata epoca e per mutare quindi le conformi e relative norme di condotta, ossia per mutare la attività pratica nel suo complesso. Dal punto di vista che a noi interessa, lo studio della storia e della logica delle diverse filosofie dei filosofi non è sufficiente. Almeno come indirizzo metodico, occorre attirare l’attenzione sulle altre parti della storia della filosofia: cioè sulle concezioni del mondo delle grandi masse, su quelle dei più ristretti gruppi dirigenti (o intellettuali) e infine sui legami tra questi vari complessi culturali e la filosofia dei filosofi.
La filosofia di un’epoca non è la filosofia di uno o altro filosofo, di uno o altro gruppo di intellettuali, di una o altra grande partizione delle masse popolari: è una combinazione di tutti questi elementi che culmina in una determinata direzione, in cui il suo culminare diventa norma d’azione collettiva, cioè diventa «storia» concreta e completa (integrale). La filosofia di un’epoca storica non è dunque altro che la «storia» di quella stessa epoca, non è altro che la massa di variazioni che il gruppo dirigente è riuscito a determinare nella realtà precedente: storia e filosofia sono inscindibili in questo senso, formano «blocco». Possono però essere «distinti» gli elementi filosofici propriamente detti, e in tutti i loro diversi gradi: come filosofia dei filosofi, come concezione dei gruppi dirigenti (cultura filosofica) e come religioni delle grandi masse, e vedere come in ognuno di questi gradi si abbia a che fare con forme diverse di «combinazione» ideologica.
Q10 §18 Punti di riferimento per un saggio su B. Croce. A proposito della nota precedente di questa rubrica sui rapporti tra il Croce e l’Einaudi, in una nota si potrebbe osservare come l’Einaudi non sia sempre un lettore molto attento e accurato del Croce. A p. 277 dell’annata 1929 della «Riforma Sociale» l’Einaudi scrive: «Una teoria non va attribuita a chi la intuì, o per incidente la enunciò o espose un principio da cui poteva essere dedotta o raccontò slegatamente le diverse nozioni, le quali aspiravano ad essere ricomposte in unità». La parte positiva della proposizione è accennata in seguito così: «in quale altro libro fu assunta come oggetto “voluto” di “particolare” trattato la seguente proposizione, ecc.»?
Il Croce, nel Materialismo storico, IV, p. 26, aveva scritto: «Altro è metter fuori un’osservazione incidentale, che si lascia poi cadere senza svolgerla, ed altro stabilire un principio di cui si sono scorte le feconde conseguenze; altro enunciare un pensiero generico ed astratto ed altro pensarlo realmente e in concreto; altro finalmente, inventare, ed altro ripetere di seconda o di terza mano». L’enunciazione dell’Einaudi è derivata dal Croce con in più le curiose improprietà linguistiche e l’impaccio teoretico. Perché l’Einaudi non ha citato addirittura il Croce? Forse perché il brano del Croce è contenuto in uno scritto contro il prof. Loria. Un altro esempio di superficialità dell’Einaudi si può trovare in un numero successivo della «Riforma Sociale», nella lunga recensione dell’Autobiografia di R. Rigola.
Q10 §19 Bizantinismo francese. La tradizione culturale francese, che presenta i concetti sotto forma di azione politica, in cui speculazione e pratica si sviluppano in un solo nodo storico comprensivo, parrebbe esemplare. Ma questa cultura è rapidamente degenerata dopo gli avvenimenti della grande rivoluzione, è diventata una nuova Bisanzio culturale. Gli elementi di tale degenerazione, d’altronde, erano già presenti e attivi anche durante lo svolgersi del grande dramma rivoluzionario, negli stessi giacobini che lo impersonarono con maggiore energia e compiutezza. La cultura francese non è «panpolitica» come noi oggi intendiamo, ma giuridica. La forma francese non è quella attiva e sintetica dell’uomo o lottatore politico, ma quella del giurista sistematico di astrazioni formali; la politica francese è specialmente elaborazione di forme giuridiche. Il francese non ha una mentalità dialettica e concretamente rivoluzionaria neanche quando opera come rivoluzionario: la sua intenzione è «conservatrice» sempre, perché la sua intenzione è di dare una forma perfetta e stabile alle innovazioni che attua. Nell’innovare pensa già a conservare, a imbalsamare l’innovazione in un codice.
Q10 §20 Punti per lo studio dell’economia. Polemica Einaudi ‑ Spirito sullo Stato. È da connettere con la polemica Einaudi‑Benini (Cfr Riforma Sociale di settembre-ottobre 1931). Ma nella polemica Einaudi‑Spirito hanno torto ambedue i litiganti: essi si riferiscono a cose diverse e usano linguaggi diversi. La polemica Benini‑Einaudi illumina la precedente polemica. In ambedue queste polemiche l’Einaudi assume la stessa posizione di quando cerca di limitare, in polemica col Croce, ogni funzione scientifica della filosofia della praxis. La coerenza della posizione dell’Einaudi è mirabile «intellettualmente»: egli comprende che ogni concessione teorica all’avversario, sia pure solo intellettuale, può far franare tutto il proprio edificio.
Nella concezione dello Stato: Einaudi pensa all’intervento governativo nei fatti economici, sia come regolatore «giuridico» del mercato, cioè come la forza che dà al mercato determinato la forma legale, in cui tutti gli agenti economici si muovano a «parità di condizioni giuridiche», sia all’intervento governativo come creatore di privilegi economici, come perturbatore della concorrenza a favore di determinati gruppi. Lo Spirito invece si riferisce alla sua concezione speculativa dello Stato, per cui l’individuo si identifica con lo Stato. Ma c’è un terzo aspetto della quistione che è sottintesa nell’uno e nell’altro scrittore, ed è quello per cui, identificandosi lo Stato con un gruppo sociale, l’intervento statale non solo avviene nel modo accennato dall’Einaudi, o nel modo voluto dallo Spirito, ma è una condizione preliminare di ogni attività economica collettiva, è un elemento del mercato determinato, se non è addirittura lo stesso mercato determinato, poiché è la stessa espressione politico‑giuridica del fatto per cui una determinata merce (il lavoro) è preliminarmente deprezzata, è messa in condizioni di inferiorità competitiva, paga per tutto il sistema determinato. Questo punto è messo in luce dal Benini, e non si tratta certo di una scoperta; ma è interessante che il Benini vi sia giunto e in che modo vi è giunto. Poiché il Benini vi è giunto partendo da principi dell’economia classica, ciò che appunto irrita l’Einaudi.
Tuttavia l’Einaudi aveva, nella lettera pubblicata dai «Nuovi Studi», accennato alla «meravigliosa capacità» di Giovanni Vailati, di presentare un teorema economico (o anche filosofico) e la sua soluzione, nei diversi linguaggi scientifici sorti dal processo storico di sviluppo delle scienze, cioè aveva implicitamente ammesso la traducibilità reciproca di questi linguaggi: il Benini ha proprio fatto questo, ha presentato in linguaggio dell’economia liberale un fatto economico già presentato nel linguaggio della filosofia della praxis, pur con tutte le limitazioni e cautele del caso (l’episodio Benini è da avvicinare all’episodio Spirito al Convegno di Ferrara). Ricordare a questo proposito l’affermazione di Engels a proposito della possibilità di giungere, anche partendo dalla concezione marginalista del valore, alle stesse conseguenze (se pure in forma volgare) di quelle a cui giunse l’economia critica. L’affermazione di Engels va analizzata in tutte le sue conseguenze: una di esse mi pare questa, che se si vuole difendere la concezione critica dell’economia, bisogna sistematicamente insistere sul fatto che l’economia ortodossa tratta gli stessi problemi, in altro linguaggio, dimostrando tale identità di problemi trattati e dimostrando che la soluzione critica è superiore: insomma occorre che i testi siano sempre «bilingui», il testo autentico, e la traduzione «volgare» o dell’economia liberale, a lato, o interlineata.
Q10 §21 Introduzione allo studio della filosofia. Filosofia «scientifica» e filosofia intesa nel senso volgare di insieme di idee e opinioni. Ma possono essere disgiunte? – Si dice «prender le cose con filosofia», «avere della filosofia», «prenderla filosoficamente», ecc. (Si potrebbero raggruppare i modi di dire popolari e le espressioni degli scrittori di carattere popolare – prendendole dai grandi vocabolari – in cui entrano le espressioni filosofia e filosoficamente, che hanno un significato molto preciso, di un superamento delle passioni elementari e bestiali in una concezione delle cose «ragionata», per cui, rendendosi conto della loro razionalità e necessità, non ci si abbandona ad escandescenze e ad atti impulsivi e irrazionali, ma si dà al proprio operare una direzione consapevole).
Q10 §22 Punti di riferimento per un saggio su Croce. Perché occorre scrivere nel senso in cui è stato redatto il primo paragrafo a p. 42. Occorre dare il senso dell’importanza culturale che ha il Croce non solo in Italia, ma in Europa, e quindi del significato che ha la rapida e grande diffusione dei suoi più recenti libri quali sono le Storie d’Italia e d’Europa. Che il Croce si proponga l’educazione delle classi dirigenti non mi par dubbio. Ma come effettivamente viene accolta la sua opera educativa, a quali «leghe» ideologiche dà luogo? Quali sentimenti positivi fa nascere? È un luogo comune pensare che l’Italia ha attraversato tutte le esperienze politiche dello sviluppo storico moderno e che pertanto ideologie e istituzioni conformi a queste ideologie sarebbero per il popolo italiano cavoli rifatti, repugnanti al palato. Intanto non è vero che si tratti di cavoli riscaldati: il «cavolo» è stato mangiato solo «metaforicamente» dagli intellettuali, e sarebbe riscaldato solo per questi. Non è «riscaldato» e quindi disgustoso per il popolo (a parte il fatto che il popolo, quando ha fame, mangia cavoli riscaldati anche due o tre volte). Il Croce ha un bel corazzarsi di sarcasmo per l’eguaglianza, la fratellanza, ed esaltare la libertà – sia pure speculativa –. Essa sarà compresa come eguaglianza e fratellanza e i suoi libri appariranno come l’espressione e la giustificazione implicita di un costituentismo che trapela da tutti i pori di quell’Italia «qu’on ne voit pas» e che solo da dieci anni sta facendo il suo apprendissaggio politico.
Cercare nei libri del Croce i suoi accenni alla funzione del capo dello Stato. (Un cenno può trovarsi nella Seconda Serie delle Conversazioni critiche a p. 176, nella recensione del libro di Ernesto Masi: Asti e gli Alfieri nei ricordi della villa di S. Martino: «Anche la vita moderna può avere la sua alta moralità e il suo semplice eroismo, quantunque sopra diverse fondamenta. E queste diverse fondamenta le ha poste la storia, che non consente l’antica semplicistica fede nel re, nel dio dei padri, nelle idee tradizionali, ed impedisce il rinserrarsi durevole, come una volta accadeva, nella breve cerchia della vita familiare e di classe», Mi pare di ricordare che il D’Andrea, nella recensione della Storia d’Europa pubblicata in «Critica Fascista», rimproveri al Croce un’altra di queste espressioni che il D’Andrea ritiene deleteria). (Il libro del Masi è del 1903 e quindi è probabile che la recensione del Croce sia stata pubblicata nella «Critica» poco dopo, nello stesso 1903 o nel 1904). Si può supporre che il Croce, accanto alla parte polemica, abbia una parte ricostruttiva nel suo pensiero? E che tra l’una e l’altra possa esserci un «salto»? Dagli scritti non mi pare che appaia. Ma appunto questa incertezza, penso sia uno dei motivi per cui anche molti che pensano come il Croce, si mostrino freddi o almeno preoccupati. Il Croce dirà: alla parte ricostruttiva pensino i pratici, i politici e nel suo sistema di distinzioni teoriche, la risposta è formalmente congruente. Ma solo «formalmente» e in ciò ha buon gioco il Gentile nelle sue aggressioni più o meno filosofiche, che mi paiono tanto più esasperate, in quanto non può e non vuole porre tutto il problema (posizione del Vaticano verso il libro Una storia e un’idea), non può e non vuole parlare chiaramente al Croce, fargli vedere dove può condurre la sua posizione polemica ideologica e di principio. Ma bisognerebbe vedere se proprio questo il Croce non si proponga, per ottenere un’attività riformistica dall’alto, che attenui le antitesi e le concilii in una nuova legalità ottenuta «trasformisticamente». Ma non ci può essere un neomalthusianismo voluto nel Croce, la volontà di non «impegnarsi» a fondo, che è il modo di badare solo al proprio «particulare» del moderno guicciardinismo proprio di molti intellettuali per i quali pare che basti il «dire»: «Dixi, et salvavi animam meam», ma l’anima non si salva per solo dire. Ci vogliono le opere, e come!
Q10 §23 Punti di meditazione per lo studio dell’economia. Dove batte specialmente l’accento nelle ricerche scientifiche dell’economia classica e dove invece in quelle dell’economia critica, e per quali ragioni, cioè in vista di quali fini pratici da raggiungere, o in vista di quali determinati problemi teorici e pratici da risolvere? Per l’economia critica, pare basti fissare il concetto di «lavoro socialmente necessario» per giungere al concetto di valore, perché si vuol partire dal lavoro di tutti i lavoratori per giungere a fissare la loro funzione nella produzione economica e giungere a fissare il concetto astratto e scientifico di valore e plusvalore e la funzione di tutti i capitalisti come insieme. Per l’economia classica invece ha importanza non il concetto astratto e scientifico di valore (al quale cerca di giungere per altra via, ma solo per fini formali, di sistema armonico logicamente‑verbalmente, e vi giunge, o crede di giungervi, attraverso ricerche psicologiche, con l’utilità marginale), ma quello concreto e più immediato di profitto individuale o d’azienda; ha perciò importanza lo studio della dinamica del «lavoro socialmente necessario», che assume varie impostazioni teoriche, – di teoria dei costi comparati, di equilibrio economico statico e dinamico. Per l’economia critica il problema interessante comincia dopo che il «lavoro socialmente necessario» è stato già stabilito in una formula matematica; per l’economia classica invece tutto l’interesse è nella fase dinamica della formazione del «lavoro socialmente necessario» locale, nazionale, internazionale, e nei problemi che le differenze dei «lavori analitici» pongono nelle varie fasi di tali lavori. È il costo comparato, cioè la comparazione del lavoro «particolare» cristallizzato nelle varie merci, che interessa l’economia classica.
Ma non interessa questa ricerca anche l’economia critica? Ed è «scientifico» che in un lavoro come il Précis non siano trattati anche questi nessi di problemi? L’economia critica ha diverse fasi storiche e in ognuna di esse è naturale che l’accento cada sul nesso teorico e pratico storicamente prevalente. Quando gestore dell’economia è la proprietà, l’accento cade sull’«insieme» del lavoro socialmente necessario, come sintesi scientifica e matematica, perché praticamente si vuole che il lavoro diventi consapevole del suo insieme, del fatto che è specialmente un «insieme» e che come «insieme» determina il processo fondamentale del movimento economico (invece alla proprietà interessa ben poco il lavoro socialmente necessario, anche ai fini della propria costruzione scientifica; importa il lavoro particolare, nelle condizioni determinate da un dato apparato tecnico e da un dato mercato di viveri immediato, e da un dato ambiente immediato ideologico e politico, per cui, dovendosi fondare un’azienda si ricercherà di identificare queste condizioni più conformi al fine del massimo profitto «particolare» e non si ragionerà per «medie» socialmente necessarie). Ma quando il lavoro è diventato esso stesso gestore dell’economia, anch’esso dovrà, per il suo essere cambiato fondamentalmente di posizione, preoccuparsi delle utilità particolari e delle comparazioni fra queste utilità per trarne iniziative di movimento progressivo. Cosa sono poi le «gare», se non un modo di preoccuparsi di questo nesso di problemi e di comprendere che il movimento progressivo avviene per «spinte» particolari, cioè un modo di «comparare» i costi e di insistere per ridurli continuamente, identificando e anche suscitando le condizioni oggettive e soggettive in cui ciò è possibile?
Q10 §24 Introduzione allo studio della filosofia. Nell’impostazione dei problemi storico‑critici, non bisogna concepire la discussione scientifica come un processo giudiziario, in cui c’è un imputato e c’è un procuratore che, per obbligo d’ufficio, deve dimostrare che l’imputato è colpevole e degno di essere tolto dalla circolazione. Nella discussione scientifica, poiché si suppone che l’interesse sia la ricerca della verità e il progresso della scienza, si dimostra più «avanzato» chi si pone dal punto di vista che l’avversario può esprimere un’esigenza che deve essere incorporata, sia pure come momento subordinato, nella propria costruzione. Comprendere e valutare realisticamente la posizione e le ragioni dell’avversario (e talvolta è avversario tutto il pensiero passato) significa appunto essersi liberato dalla prigione delle ideologie (nel senso deteriore, di cieco fanatismo ideologico), cioè porsi da un punto di vista «critico», l’unico fecondo nella ricerca scientifica.
Q10 §25 Punti di meditazione per lo studio dell’economia. Quando si può parlare di un inizio della scienza economica? (cfr Luigi Einaudi, Di un quesito intorno alla nascita della scienza economica, nella Riforma Sociale, marzo‑aprile 1932, a proposito di alcune pubblicazioni di Mario De Bernardi su Giovanni Botero). Se ne può parlare da quando si fece la scoperta che la ricchezza non consiste nell’oro (e quindi tanto meno nel possesso dell’oro) ma consiste nel lavoro. William Petty (A treatise of taxes and contributions, 1662, e Verbum Sapientis, 1666) intravvide e Cantillon (1730) esplicitamente affermò che la ricchezza non consiste nell’oro: «... la Richesse en elle‑même n’est autre chose que la nourriture, les commodités et les agréments de la vie... le travail de l’homme donne la forme de richesse à tout cela». Il Botero si era avvicinato a una affermazione molto somigliante, in un brano del suo lavoro Delle cause della grandezza della città stampato nel 1588 (ristampato ora dal De Bernardi di su questa edizione‑principe, nei Testi inediti e rari pubblicati sotto la direzione dell’Istituto giuridico della R. Università di Torino, Torino, 1930, in 8°, pp. XII‑84, L. 10): «E perché l’arte gareggia con la natura, m’adimanderà alcuno quale delle due cose importi più per ringrandire e per rendere popoloso un luogo, la fecondità del terreno o l’industria dell’huomo? L’industria senza dubbio.
Prima perché le cose prodotte dall’artificiosa mano dell’huomo sono molto più e di molto maggior prezzo che le cose generate dalla natura, conciosia che la natura dà la materia e ’l soggetto, ma la sottigliezza e l’arte dell’huomo dà l’inennarrabile varietà delle forme, ecc.». Secondo l’Einaudi però non si può rivendicare al Botero né la teoria della ricchezza‑lavoro né la paternità della scienza economica, di contro al Cantillon, per il quale «non si tratta più solo di un paragone atto a farci sapere quale di due fattori: la natura o il lavoro, dia il maggior prezzo alle cose, come ricerca il Botero; ma della ricerca teorica intorno a che cosa sia la ricchezza».
Se questo è il punto di partenza della scienza economica e se in tal modo è stato fissato il concetto fondamentale dell’economia, ogni ulteriore ricerca non potrà che approfondire teoricamente il concetto di «lavoro», che intanto non potrà essere annegato nel concetto più generico di industria e di attività, ma dovrà invece essere fissato in quella attività umana che in ogni forma sociale è ugualmente necessaria. Questo approfondimento è stato compiuto dall’economia critica.
Sarà da vedere La Storia
delle dottrine economiche (Das Mehrwert); del Cannan, A
Review of economic Theory.
Q10 §26 Punti di riferimento per un saggio sul Croce. Giudizi
del Croce sul libro del De Man Il superamento mostrano che nell’atteggiamento
del Croce, nel periodo attuale, l’elemento «pratico» immediato
soverchia la preoccupazione e gli interessi teorici e
scientifici. Il De Man è infatti una derivazione della corrente
psicanalitica e tutta la presunta originalità delle sue ricerche
è data dall’impiego di una terminologia psicanalitica esteriore
e appiccicata. La stessa osservazione si può fare per il De
Ruggiero che ha recensito non solo il Superamento ma anche La gioia del lavoro e ha
poi scritto una stroncatura un po’ affrettata e superficiale di
Freud e della psicanalisi, senza però aver rilevato che il De
Man ne dipende strettamente.
Q10 §27 Punti di meditazione per lo studio dell’economia. A proposito del così detto homo oeconomicus, cioè dell’astrazione dei bisogni dell’uomo, si può dire che una tale astrazione non è per nulla fuori della storia, e quantunque si presenti sotto l’aspetto delle formulazioni matematiche, non è per nulla della stessa natura delle astrazioni matematiche. L’homo oeconomicus è l’astrazione dei bisogni e delle operazioni economiche di una determinata forma di società, così come l’insieme delle ipotesi poste dagli economisti nelle loro elaborazioni scientifiche non è altro che l’insieme delle premesse che sono alla base di una determinata forma di società. Si potrebbe fare un lavoro utile raccogliendo sistematicamente le «ipotesi» di qualche grande economista «puro», per esempio di M. Pantaleoni, e coordinandole in modo da mostrare che esse appunto sono la «descrizione» di una determinata forma di società.
Q10 §28 Introduzione allo studio della filosofia. 1) Cfr Pietro Lippert, S. J., Visione Cattolica del Mondo (Die Weltanschauung des Katholizismus), traduzione di Ernesto Peternolli. Prefazione di M. Bendiscioli («Il pensiero cattolico moderno», n° 4), Brescia, «Morcelliana», 1931, pp. 190, L. 10. È da leggere, sia per il testo del padre Lippert, che è uno dei più noti scrittori gesuiti tedeschi, sia per la prefazione del Bendiscioli. Il libro è apparso nella collezione «Metaphysik und Weltanschauung» diretta dal Driesch e dallo Schingnitz. Il Lippert, come i gesuiti tedeschi, si preoccupa di dare una soddisfazione alle esigenze che erano alla base del modernismo, ma senza cadere nelle deviazioni dall’ortodossia che furono caratteristiche del modernismo perché in questa impostazione del problema cattolico non vi è traccia di immanentismo; il Lippert e i gesuiti tedeschi non si allontanano dai dogmi sistemati dalla Chiesa coi sussidi logici e metafisici della filosofia aristotelico‑tomistica e neppure li interpretano in modo nuovo, ma intendono tradurli per l’uomo moderno nella terminologia della filosofia moderna, «rivestire realtà eterne di forme mutevoli» dice letteralmente il Lippert.
2) È da osservare che l’attuale discussione tra «storia e antistoria» non è altro che la ripetizione nei termini della cultura filosofica moderna della discussione, avvenuta alla fine del secolo scorso, nei termini del naturalismo e positivismo, se la natura e la storia procedano per «salti» o solo per evoluzione graduale e progressiva. La stessa discussione si ritrova svolta anche dalle generazioni precedenti, sia nel campo delle scienze naturali (dottrine del Cuvier) sia nel campo filosofico (e si trova la discussione nello Hegel) Si dovrebbe fare la storia di questo problema in tutte le sue manifestazioni concrete e significative e si troverebbe che esso è sempre stato attuale, perché in ogni tempo ci sono stati conservatori e giacobini, progressisti e retrivi. Ma il significato «teorico» di questa discussione mi pare consistere in ciò: essa indica il punto di passaggio «logico» di ogni concezione del mondo alla morale che le è conforme, di ogni «contemplazione» all’«azione», di ogni filosofia all’azione politica che ne dipende. È il punto cioè in cui la concezione del mondo, la contemplazione, la filosofia diventano «reali» perché tendono a modificare il mondo, a rovesciare la prassi. Si può dire perciò che questo è il nesso centrale della filosofia della prassi, il punto in cui essa si attualizza, vive storicamente, cioè socialmente e non più solo nei cervelli individuali, cessa dall’essere «arbitraria» e diventa necessaria‑razionale‑reale. Il problema è da vedere storicamente, appunto. Che i tanti mascherotti nietzschiani rivoltati verbalmente contro tutto l’esistente, contro i convenzionalismi ecc. abbiano finito con lo stomacare e col togliere serietà a certi atteggiamenti, può essere ammesso, ma non bisogna, nei propri giudizi, lasciarsi guidare dai mascherotti. Contro il titanismo di maniera, il velleitarismo, l’astrattismo occorre avvertire la necessità di essere «sobri» nelle parole e negli atteggiamenti esteriori, appunto perché ci sia più forza nel carattere e nella volontà concreta. Ma questa è quistione di stile, non «teoretica».
La forma classica di questi passaggi dalla concezione del mondo alla norma pratica di condotta, mi pare quella per cui dalla predestinazione calvinistica sorge uno dei maggiori impulsi all’iniziativa pratica che si sia avuto nella storia mondiale. Così ogni altra forma di determinismo a un certo punto si è sviluppata in spirito di iniziativa e in tensione estrema di volontà collettiva.
Q10 §29 Punti di riferimento per un saggio sul Croce.
I. Premesso che le due ultime storie, quella d’Italia e quella d’Europa, sono state pensate all’inizio della guerra mondiale, per concludere un processo di meditazioni e di riflessioni sulle cause di quegli avvenimenti del 1914 e 1915, si può domandare quale preciso scopo «educativo» esse abbiano. Preciso, specialmente preciso. E si conclude che non l’hanno, che anche esse rientrano in quella letteratura sul «Risorgimento» di carattere spiccatamente letterario e ideologico, che nella realtà non riuscì a interessare che ristretti gruppi intellettuali: tipico esempio il libro di Oriani sulla Lotta politica. Sono stati notati gli interessi attuali del Croce e quindi gli scopi pratici che ne scaturiscono: si nota appunto che essi sono «generici», di educazione astratta e «metodologica», per così dire, «predicatorii» in una parola. L’unico punto preciso la quistione «religiosa», ma anche esso si può dire «preciso»? La posizione anche nel problema della religione rimane da intellettuale e sebbene non si possa negare che anche tale posizione sia importante, occorre dire che essa è insufficiente.
II. Il saggio potrebbe avere come nucleo centrale l’esame del concetto di storiografia etico‑politica, che realmente corona tutto il lavoro filosofico del Croce. Si potrebbe quindi esaminare l’operosità del Croce come tutta conducente a questo sbocco, nei suoi vari atteggiamenti verso la filosofia della prassi, e giungere alla conclusione appunto che lo stesso lavorio del Croce era stato compiuto parallelamente dai migliori teorici della filosofia della prassi, sicché l’affermazione di «definitivo superamento» è semplicemente una millanteria critica, ciò insieme alla dimostrazione analitica che ciò che vi è di «sano» e di progressivo nel pensiero del Croce non è altro che filosofia della praxis presentata in linguaggio speculativo.
Q10 §30 Punti di meditazione per lo studio dell’economia. Osservazioni sui Principî di economia pura di M. Pantaleoni (nuova edizione 1931, Treves‑Treccani-Tumminelli).
1) A rileggere il libro del Pantaleoni si comprendono meglio i motivi delle abbondanti scritture di Ugo Spirito.
2) La parte prima del libro, dove si tratta del postulato edonistico, potrebbe più acconciamente servire come introduzione a un raffinato manuale di arte culinaria o ad un ancor più raffinato manuale sulle posizioni degli amanti. È un peccato che gli scrittori di arte culinaria non studino l’economia pura, perché coi sussidi di gabinetti di psicologia sperimentale e del metodo statistico potrebbero giungere a trattazioni ben più complete e sistematiche di quelle volgarmente diffuse: lo stesso si dica della più clandestina ed esoterica attività scientifica che si affatica ad elaborare l’arte dei godimenti sessuali.
3) La filosofia del Pantaleoni è il sensismo del secolo XVIII, sviluppato nel positivismo del secolo XIX: il suo «uomo» è l’uomo in generale, nelle premesse astratte, cioè l’uomo della biologia, un insieme di sensazioni dolorose e piacevoli, che però diventa l’uomo di una determinata forma sociale ogni qualvolta dall’astratto si passa al concreto, cioè ogni qualvolta si parla di economia e non di scienza naturale in genere. Il libro del Pantaleoni è quello che si può chiamare un’«opera materialistica» in senso «ortodosso» e scientifico!
4) Questi economisti «puri» pongono l’origine della scienza economica nella scoperta fatta da Cantillon che la ricchezza è il lavoro, è l’industria umana. Quando però cercano di fare scienza essi stessi, dimenticano le origini e affogano nell’ideologia che prima sviluppò, secondo i suoi metodi, la scoperta iniziale. Delle origini essi sviluppano non il nucleo positivo, ma l’alone filosofico legato al mondo culturale del tempo, quantunque questo mondo sia stato criticato e superato dalla cultura successiva.
5) Cosa dovrebbe sostituirsi al così detto «postulato edonistico» dell’economia «pura» in un’economia critica e storicistica? La descrizione del «mercato determinato», cioè la descrizione della forma sociale determinata, del tutto in confronto della parte, del tutto che determina, in quella determinata misura, quell’automatismo e insieme di uniformità e regolarità che la scienza economica cerca di descrivere col massimo di esattezza e precisione e completezza. Si può dimostrare che una tale impostazione della scienza economica è superiore a quella dell’economia «pura»? Si può dire che il postulato edonistico non è astratto, ma generico: infatti esso può essere premesso non alla sola economia, ma a tutta una serie di operazioni umane, che possono chiamarsi «economiche» solo allargando e genericizzando enormemente la nozione di economia fino a renderla empiricamente vuota di significato o a farla coincidere con una categoria filosofica, come infatti ha cercato di fare il Croce.
Q10 §31 Punti di riferimento per un saggio sul Croce. I. Nesso tra filosofia, religione, ideologia (nel senso crociano). Se per religione si ha da intendere una concezione del mondo (una filosofia) con una norma di condotta conforme, quale differenza può esistere tra religione e ideologia (o strumento d’azione) e in ultima analisi, tra ideologia e filosofia? Esiste o può esistere filosofia senza una volontà morale conforme? I due aspetti della religiosità, la filosofia e la norma di condotta, possono concepirsi come staccate e come possono essere state concepite come staccate? E se la filosofia e la morale sono sempre unitarie, perché la filosofia deve essere logicamente precedente alla pratica e non viceversa? O non è un assurdo una tale impostazione e non deve concludersi che «storicità» della filosofia significa niente altro che sua «praticità»? Si può forse dire che il Croce ha sfiorato il problema in Conversazioni critiche, I, pp. 298‑99‑300, dove analizzando alcune delle Glosse al Feuerbach giunge alla conclusione che in esse «dinanzi alla filosofia preesistente» prendono la parola «non già altri filosofi, come si aspetterebbe, ma i rivoluzionari pratici», che il Marx «non tanto capovolgeva la filosofia hegeliana, quanto la filosofia in genere, ogni sorta di filosofia; e il filosofare soppiantava con l’attività pratica». Ma non si tratta io, invece della rivendicazione, di fronte alla filosofia «scolastica», puramente teorica o contemplativa, di una filosofia che produca una morale conforme, una volontà attualizzatrice e in essa si identifichi in ultima analisi? La tesi XI: «I filosofi hanno soltanto variamente interpretato il mondo; si tratta ora di cangiarlo», non può essere interpretata come un gesto di ripudio di ogni sorta di filosofia, ma solo di fastidio per i filosofi e il loro psittacismo e l’energica affermazione di una unità tra teoria e pratica. Che una tale soluzione da parte del Croce sia criticamente inefficiente si può osservare anche da ciò che, anche ammesso per ipotesi assurda che Marx¹ volesse «soppiantare» la filosofia in genere con l’attività pratica, sarebbe da «sfoderare» l’argomento perentorio che non si può negare la filosofia se non filosofando, cioè riaffermando ciò che si era voluto negare, e lo stesso Croce, in una nota del volume Materialismo storico ed economia marxistica riconosce (aveva riconosciuto) esplicitamente come giustificata l’esigenza di costruire una filosofia della praxis posta da Antonio Labriola.
Questa interpretazione delle Glosse al Feuerbach come rivendicazione di unità tra teoria e pratica, e quindi come identificazione della filosofia con ciò che il Croce chiama ora religione (concezione del mondo con una norma di condotta conforme) – ciò che poi non è che l’affermazione della storicità della filosofia fatta nei termini di un’immanenza assoluta, di una «terrestrità assoluta» – si può ancora giustificare con la famosa proposizione che «il movimento operaio tedesco è l’erede della filosofia classica tedesca», la quale non significa già, come scrive il Croce: «erede che non continuerebbe già l’opera del predecessore, ma ne imprenderebbe un’altra, di natura diversa e contraria» ma significherebbe proprio che l’«erede» continua il predecessore, ma lo continua «praticamente» poiché ha dedotto una volontà attiva, trasformatrice del mondo, dalla mera contemplazione e in questa attività pratica è contenuta anche la «conoscenza» che solo anzi nell’attività pratica è «reale conoscenza» e non «scolasticismo». Se ne deduce anche che il carattere della filosofia della praxis è specialmente quello di essere una concezione di massa, una cultura di massa e di massa che opera unitariamente, cioè che ha norme di condotta non solo universali in idea, ma «generalizzate» nella realtà sociale. E l’attività del filosofo «individuale» non può essere pertanto concepita che in funzione di tale unità sociale, cioè anch’essa come politica, come funzione di direzione politica.
Anche da questo punto appare come il Croce abbia saputo mettere bene a profitto il suo studio della filosofia della praxis. Cosa è infatti la tesi crociana dell’identità di filosofia e di storia se non un modo, il modo crociano, di presentare lo stesso problema posto dalle glosse al Feuerbach e confermato dall’Engels nel suo opuscolo su Feuerbach? Per Engels «storia» è pratica (l’esperimento, l’industria) per Croce Storia è ancora un concetto speculativo; cioè Croce ha rifatto a rovescio il cammino – dalla filosofia speculativa si era giunti a una filosofia «concreta e storica», la filosofia della praxis; il Croce ha ritradotto in linguaggio speculativo le acquisizioni progressive della filosofia della praxis e in questa ritraduzione è il meglio del suo pensiero.
Si può vedere con maggiore esattezza e precisione il significato che la filosofia della praxis ha dato alla tesi hegeliana che la filosofia si converte nella storia della filosofia, cioè della storicità della filosofia. Ciò porta alla conseguenza che occorre negare la «filosofia assoluta» astratta o speculativa, cioè la filosofia che nasce dalla precedente filosofia e ne eredita i «problemi supremi», così detti, o anche solo il «problema filosofico», che diventa pertanto un problema di storia, di come nascono e si sviluppano i determinati problemi della filosofia. La precedenza passa alla pratica, alla storia reale dei mutamenti dei rapporti sociali, dai quali quindi (e quindi, in ultima analisi, dall’economia) sorgono (o sono presentati) i problemi che il filosofo si propone ed elabora.
Per il concetto più largo di storicità della filosofia, che cioè una filosofia è «storica» in quanto si diffonde, in quanto diventa concezione della realtà di una massa sociale (con un’etica conforme), si capisce che la filosofia della praxis, nonostante la «sorpresa» e lo «scandalo» del Croce, studi «nei filosofi proprio (!) ciò che non è filosofico: le tendenze pratiche, e gli affetti sociali e di classe, che quelli rappresentano. Onde nel materialismo del secolo decimottavo essi scorgevano la vita francese di allora, volta tutta all’immediato presente, al comodo e all’utile; nello Hegel, lo Stato prussiano; nel Feuerbach, gli ideali della vita moderna, ai quali la società germanica non si era ancora innalzata; nello Stirner, l’anima dei merciai; nello Schopenhauer, quella dei piccoli borghesi; e via discorrendo».
Ma non era ciò appunto uno «storicizzare» le rispettive filosofie, un ricercare il nesso storico tra i filosofi e la realtà storica da cui erano stati mossi? Si potrà dire e si dice infatti: ma la «filosofia» non è invece proprio ciò che «residua» dopo questa analisi per la quale si identifica ciò che è «sociale» nell’opera del filosofo? Intanto occorre porre questa rivendicazione e giustificarla mentalmente. Dopo aver distinto ciò che è sociale o «storico» in una determinata filosofia, ciò che corrisponde a una esigenza della vita pratica, a una esigenza che non sia arbitraria e cervellotica (e certo non è sempre facile una tale identificazione, specialmente se tentata immediatamente, senza cioè una sufficiente prospettiva) sarà da valutare questo «residuo», che poi non sarà così grande come apparirebbe a prima vista, se il problema fosse posto partendo dal pregiudizio crociano che esso sia una futilità o uno scandalo. Che una esigenza storica sia concepita da un filosofo «individuo» in modo individuale e personale e che la particolare personalità del filosofo incida profondamente sulla concreta forma espressiva della sua filosofia, è evidente senz’altro. Che questi caratteri individuali abbiano importanza, è anche senz’altro da concedere. Ma che significato avrà questa importanza? Non sarà puramente strumentale e funzionale, dato che se è vero che la filosofia non si sviluppa da altra filosofia ma è una continua soluzione di problemi che lo sviluppo storico propone, è anche vero che ogni filosofo non può trascurare i filosofi che l’hanno preceduto e anzi di solito opera proprio come se la sua filosofia fosse una polemica o uno svolgimento delle filosofie precedenti, delle concrete opere individuali dei filosofi precedenti. Talvolta anzi «giova» proporre una propria scoperta di verità come se fosse svolgimento di una tesi precedente di altro filosofo, perché è una forza innestarsi nel particolare processo di svolgimento della particolare scienza cui si collabora.
In ogni modo appare quale sia stato il nesso teorico per cui la filosofia della praxis, pur continuando l’hegelismo, lo «capovolge», senza perciò, come crede il Croce, voler «soppiantare» ogni sorta di filosofia. Se la filosofia è storia della filosofia, se la filosofia è «storia», se la filosofia si sviluppa perché si sviluppa la storia generale del mondo (e cioè i rapporti sociali in cui gli uomini vivono) e non già perché a un grande filosofo succede un più grande filosofo e così via, è chiaro che lavorando praticamente a fare storia, si fa anche filosofia «implicita», che sarà «esplicita» in quanto dei filosofi la elaboreranno coerentemente, si suscitano dei problemi di conoscenza che oltre alla forma «pratica» di soluzione troveranno, prima o poi, la forma teorica per opera degli specialisti, dopo aver immediatamente trovato la forma ingenua del senso comune popolare cioè degli agenti pratici delle trasformazioni storiche. Si vede come i crociani non capiscano questo modo di porre la quistione dalla loro maraviglia (cfr recensione del De Ruggiero del libro di Arthur Feiler nella «Critica» del 20 marzo 1932) di fronte a certi avvenimenti: «... si presenta il fatto paradossale di un’ideologia grettamente, aridamente materialistica, che dà luogo, in pratica, a una passione dell’ideale, a una foga di rinnovamento, a cui non si può negare una certa (!) sincerità», e la spiegazione astratta cui ricorrono: «Tutto ciò è vero in linea di massima (!) ed è anche provvidenziale, perché mostra che l’umanità ha grandi risorse interiori, che entrano in gioco nel momento stesso che una ragione superficiale pretenderebbe negarle», coi giochetti di dialettica formale d’uso: «La religione del materialismo, per il fatto stesso che è religione, non è più materia (!?); l’interesse economico, quando è elevato ad etica, non è più mera economia». Questo arzigogolo del De Ruggiero o è una futilità oppure è da riallacciarsi a una proposizione del Croce che ogni filosofia in quanto tale non è che idealismo: ma posta questa tesi, perché allora tanta battaglia di parole? Sarà solo per una quistione di terminologia?
Il Masaryk nel suo libro di memorie (La Résurrection d’un Etat. Souvenirs et reflexions. 1914‑1918. Parigi, Plon) riconosce l’apporto positivo del materialismo storico, attraverso l’opera del gruppo che l’incarna, nel determinare un nuovo atteggiamento verso la vita, attivo, di intraprendenza e di iniziativa, cioè nel campo in cui precedentemente egli aveva teorizzato la necessità di una riforma religiosa.
All’accenno del De Ruggiero si possono fare altre notazioni critiche che non sono fuori posto in questi appunti sul Croce (si potrebbe questo brano ridurlo a una nota): 1) che questi filosofi speculativi quando non sanno spiegarsi un fatto, ricorrono subito alla solita astuzia della provvidenza che naturalmente spiega tutto; 2) che di superficiale c’è solo l’informazione «filologica» del De Ruggiero, il quale si vergognerebbe di non conoscere tutti i documenti su un minuscolo fatto di storia della filosofia, ma trascura di informarsi con maggiore sostanziosità su avvenimenti giganteschi come quelli sfiorati nella sua recensione. La posizione di cui parla il De Ruggiero per cui un’ideologia «grettamente ecc.» dà luogo in pratica a una passione dell’ideale ecc. non è poi nuova nella storia: basta accennare alla teoria della predestinazione e della grazia propria del calvinismo e al suo dar luogo a una vasta espansione dello spirito d’iniziativa. In termini di religione è lo stesso fatto cui accenna il De Ruggiero, che il De Ruggiero non riesce a penetrare forse per la sua mentalità ancora fondamentalmente cattolica e antidialettica (cfr come il cattolico Jemolo, nella sua storia del giansenismo in Italia non riesca a comprendere questa conversione attivistica della teoria della grazia, ignori la letteratura in proposito e si domandi donde l’Anzilotti abbia attinto una tale corbelleria).
II. La critica crociana della filosofia della praxis può prendere le mosse dalle sue affermazioni perentorie in proposito nella Storia d’Italia e nella Storia d’Europa, in cui il Croce dà come definitive e ormai comunemente accettate le sue conclusioni, ma sarà esposta in forma sistematica. Intanto occorre notare che le affermazioni del Croce sono state molto meno assiomatiche e formalmente decise di quanto egli voglia oggi fare apparire. La teoria del valore è tutt’altro che intrinsecamente negata nel suo saggio principale: egli afferma che sola «teoria del valore» scientifica è quella del grado finale d’utilità, e che la teoria del valore marxista è «un’altra cosa», ma come «altra cosa» ne riconosce la saldezza e l’efficacia e domanda agli economisti di ribatterla con ben altri argomenti da quelli che di solito impiegano il Böhm‑Bawerk e C. La sua tesi sussidiaria, poi, che si tratti di un paragone ellittico, oltre che non giustificata, è di fatto inficiata subito dall’osservazione che si tratta di una continuazione logica della teoria ricardiana del valore e che il Ricardo non faceva certo «paragoni ellittici». La riduzione della filosofia della praxis a canone empirico di interpretazione è solamente affermata con metodo indiretto di esclusione, cioè ancora non dall’intrinseco. Per il Croce si tratta certamente di «qualche cosa» di importante, ma siccome non può essere né questo né quello ecc. sarà un canone d’interpretazione. Non pare che la dimostrazione sia conclusiva. La stessa prudenza formale appare nello scritto sulla caduta del saggio di profitto: cosa avrà voluto dire l’autore della teoria? Se ha voluto dir questo, non è esatto. Ma ha voluto dir questo? Dunque occorre ancora pensarci su, ecc. È anzi da porre in rilievo come questo atteggiamento prudente sia completamente mutato in questi anni e tutto sia diventato perentorio e definitivo nello stesso momento in cui è maggiormente acritico e ingiustificato.
Q10 §32 Punti di meditazione per lo studio dell’economia. Intorno ai Principî di Economia Pura del Pantaleoni.
I. È da fissare con esattezza il punto in cui si distingue tra «astrazione» e «generizzazione». Gli agenti economici non possono essere sottoposti a un processo di astrazione per cui l’ipotesi di omogeneità diventa l’uomo biologico; questa non è astrazione ma generizzazione o «indeterminazione». Astrazione sarà sempre astrazione di una categoria storica determinata, vista appunto in quanto categoria e non in quanto molteplice individualità. L’homo oeconomicus è anch’esso storicamente determinato pur essendo insiememente indeterminato: è un’astrazione determinata. Questo processo nell’economia critica avviene ponendo come valore il valore di scambio e non quello d’uso e riducendo quindi il valore d’uso al valore di scambio, potenzialmente, nel senso che una economia di scambio modifica anche le abitudini fisiologiche e la scala psicologica dei gusti e dei gradi finali d’utilità, che appaiono così come «superstrutture» e non dati economici primari, oggetto della scienza economica.
II. Occorre fissare il concetto di mercato determinato. Come viene assunto nell’economia «pura» e come nell’economia critica. Mercato determinato nell’economia pura è una astrazione arbitraria, che ha un valore puramente convenzionale ai fini di un’analisi pedantesca e scolastica. Mercato determinato per l’economia critica sarà invece l’insieme delle attività economiche concrete di una forma sociale determinata, assunte nelle loro leggi di uniformità, cioè «astratte», ma senza che l’astrazione cessi di essere storicamente determinata. Si astrae la molteplicità individuale degli agenti economici della società moderna quando si parla di capitalisti, ma appunto l’astrazione è nell’ambito storico di una economia capitalistica e non di una generica attività economica che astragga nelle sue categorie tutti gli agenti economici apparsi nella storia mondiale riducendoli genericamente e indeterminatamente all’uomo biologico.
III. Si può domandare se l’economia pura sia una scienza oppure se essa sia «un qualche cosa d’altro» che però si muove con un metodo che in quanto metodo ha un suo rigore scientifico. Che esistano attività di questo genere è mostrato dalla teologia. Anche la teologia parte da una certa serie di ipotesi e quindi costruisce su di esse tutto un massiccio edifizio dottrinale saldamente coerente e rigorosamente dedotto. Ma la teologia è perciò una scienza? L’Einaudi (cfr Ancora intorno al modo di scrivere la storia del dogma economico in «Riforma Sociale» del maggio‑giugno 1932) scrive che l’economia è «una dottrina avente la medesima indole delle scienze matematiche e fisiche (affermazione questa, si osservi, la quale non ha alcun necessario legame con l’altra che sia necessario od utile nel suo studio l’impiego dello strumento matematico)», ma sarebbe difficile dimostrare coerentemente e rigorosamente questa affermazione. Lo stesso concetto è stato espresso dal Croce («Critica», fascicolo del gennaio 1931) con le parole: «L’Economia non cangia natura quali che siano gli ordinamenti sociali, capitalistici o comunistici, quale che sia il corso della storia, al modo stesso che non cangia natura l’aritmetica pel variare delle cose da numerare». Intanto mi pare non sia da confondere la matematica e la fisica. La matematica si può chiamare una scienza puramente «strumentale», complementare di tutta una serie di scienze naturali «quantitative», mentre la fisica è una scienza immediatamente «naturale». Alla matematica può essere paragonata la logica formale con la quale del resto la matematica superiore si è unificata sotto molti aspetti. Può dirsi lo stesso della economia pura? La discussione è ancora vivace e non pare stia per finire. Del resto già nei cosiddetti economisti puri non c’è grande compattezza. Per alcuni è economia pura solo quella ipotetica, che imposta le sue dimostrazioni con un «supposto che», cioè è economia pura anche quella che rende astratti ossia generalizza tutti i problemi economici storicamente posti. Per altri invece è economia pura solo quella che si può dedurre dal principio economico o postulato edonistico, che cioè astrae completamente da ogni storicità e presuppone solo una generica «natura umana» uguale nel tempo e nello spazio. Ma se si tiene conto della lettera aperta dell’Einaudi a Rodolfo Benini, pubblicata nei «Nuovi Studi» qualche tempo fa, si vede che la posizione degli economisti puri è tentennante e mal sicura.
Q10 §33 Punti di riferimento per un saggio su Croce. Nello scritto sulla caduta tendenziale del saggio del profitto è da notare un errore fondamentale del Croce. Questo problema è già impostato nel I volume della Critica dell’economia politica, là dove si parla del plusvalore relativo e del progresso tecnico come causa appunto di plusvalore relativo; nello stesso punto si osserva come in questo processo si manifesti una contraddizione, cioè mentre da un lato il progresso tecnico permette una dilatazione del plusvalore, dall’altro determina, per il cangiamento che introduce nella composizione del capitale, la caduta tendenziale del saggio del profitto e ciò è dimostrato nel III volume della Critica dell’Economia Politica. Il Croce presenta come obbiezione alla teoria esposta nel III volume quella parte di trattazione che è contenuta nel I volume, cioè espone come obbiezione alla legge tendenziale della caduta del saggio del profitto la dimostrazione dell’esistenza di un plusvalore relativo dovuto al progresso tecnico, senza però mai accennare una sola volta al I volume, come se l’obbiezione fosse scaturita dal suo cervello, o addirittura fosse un portato del buon senso. (Tuttavia occorrerà rivedere i testi della Critica dell’Economia politica prima di presentare questa critica all’obbiezione del Croce, cautela che d’altronde si intende necessaria per tutte queste , che sono state scritte in grandissima parte fondandosi sulla memoria).
In ogni caso è da fissare che la quistione della legge tendenziale del saggio del profitto non può essere studiata solamente sull’esposizione data dal III volume; questa trattazione è l’aspetto contraddittorio della trattazione esposta nel I volume, da cui non può essere staccata. Inoltre occorrerà forse meglio determinare il significato di legge «tendenziale»: poiché ogni legge in Economia politica non può non essere tendenziale, dato che si ottiene isolando un certo numero di elementi e trascurando quindi le forze controperanti, sarà forse da distinguere un grado maggiore o minore di tendenzialità e mentre di solito l’aggettivo «tendenziale» si sottintende come ovvio, si insiste invece su di esso quando la tendenzialità diventa un carattere organicamente rilevante come in questo caso in cui la caduta del saggio del profitto è presentata come l’aspetto contraddittorio di un’altra legge, quella della produzione del plusvalore relativo, in cui una tende ad elidere l’altra con la previsione che la caduta del saggio del profitto sarà la prevalente.
Quando si può immaginare che la contraddizione giungerà a un nodo di Gordio, insolubile normalmente, ma domandante l’intervento di una spada di Alessandro? Quando tutta l’economia mondiale sarà diventata capitalistica e di un certo grado di sviluppo: quando cioè la «frontiera mobile» del mondo economico capitalistico avrà raggiunto le sue colonne d’Ercole. Le forze controperanti della legge tendenziale e che si riassumono nella produzione di sempre maggiore plusvalore relativo hanno dei limiti, che sono dati, per esempio, tecnicamente dall’estensione della resistenza elastica della materia e socialmente dalla misura sopportabile di disoccupazione in una determinata società. Cioè la contraddizione economica diventa contraddizione politica e si risolve politicamente in un rovesciamento della praxis.
Sull’argomento della caduta tendenziale del saggio del profitto ricordare un lavoro recensito nella prima annata di «Nuovi Studi» e dovuto a un economista tedesco, scolaro dissidente di Franz Oppenheimer, e un più recente volume del Grossmann recensito nella rivista «Economia» di Trieste e nella «Critique Sociale» da Lucien Laurat.
Q10 §34 Punti di riferimento per un saggio sul Croce. Quanto grande sia il mutamento avvenuto nella posizione critica del Croce verso la filosofia della praxis si può vedere confrontando questo brano dello scritto Il libro del prof. Stammler: «Ma, per lui (Stammler), nell’opera del Marx non si tratta di simili “piccole considerazioni”: che la cosidetta vita economica eserciti un’efficacia sulle idee, sulle scienze, sulle arti, e simili: roba vecchia, di poca conseguenza. Come il materialismo filosofico non consiste nell’affermare che i fatti corporali abbiano efficacia sugli spirituali, ma nel far di questi una mera apparenza, irreale, di quelli; così il materialismo storico deve consistere nell’affermare che l’economia è la vera realtà e il diritto è l’ingannevole apparenza» – con i capitoli finali della Storia della storiografia italiana nel secolo XIX: in questi il Croce assume proprio questa posizione dello Stammler senza neanche cercare di giustificarla con un principio o un accenno di dimostrazione. Ciò che nel 1898 era semplicemente una sforzatura arbitraria dello Stammler nel 1915 diventa verità ovvia che neanche vale la pena di svolgere.
Q10 §35 Introduzione allo studio della filosofia. Si può osservare il parallelo svolgersi della democrazia moderna e di determinate forme di materialismo metafisico e di idealismo. L’uguaglianza è ricercata dal materialismo francese del secolo XVIII nella riduzione dell’uomo a categoria della storia naturale, individuo di una specie biologica, distinto non per qualificazioni sociali e storiche, ma per doti naturali; in ogni caso essenzialmente uguale ai suoi simili. Questa concezione è passata nel senso comune, che ha come affermazione popolare che «siamo nati tutti nudi» (se pure l’affermazione di senso comune non è precedente alla discussione ideologica degli intellettuali). Nell’idealismo si ha l’affermazione che la filosofia è la scienza democratica per eccellenza in quanto si riferisce alla facoltà di ragionare comune a tutti gli uomini, cosa per cui si spiega l’odio degli aristocratici per la filosofia e le proibizioni legali contro l’insegnamento e la cultura da parte delle classi del vecchio regime.
Q10 §36 Punti di riferimento per un saggio su Croce. Dopo aver notato che nel suo scritto sulla caduta del saggio del profitto il Croce non fa che presentare come obbiezione l’altro aspetto contraddittorio del processo legato al progresso tecnico cioè la teoria del plusvalore relativo, già studiato nel I volume della Critica dell’economia politica, occorre notare che il Croce dimentica nella sua analisi un elemento fondamentale nella formazione del valore e del profitto cioè il «lavoro socialmente necessario», la cui formazione non può essere studiata e rilevata in una sola fabbrica o impresa. Il progresso tecnico dà appunto alla singola impresa la chance molecolare di aumentare la produttività del lavoro al di sopra della media sociale e quindi di realizzare profitti eccezionali (come è stato studiato nel I volume), ma appena il progresso dato si socializza, questa posizione iniziale viene perduta gradatamente e funziona la legge della media sociale del lavoro che attraverso la concorrenza abbassa prezzi e profitti: in quel punto si ha una caduta del saggio del profitto, perché la composizione organica del capitale si manifesta sfavorevole. Gli impresari tendono a prolungare per quanto è possibile la chance iniziale anche per mezzo dell’intervento legislativo: difesa dei brevetti, dei segreti industriali ecc., che però non può che essere limitato ad alcuni aspetti del progresso tecnico, forse secondari, ma che in ogni modo hanno il loro peso non certo irrilevante. Il mezzo più efficace degli impresari singoli per sfuggire alla legge della caduta è quello di introdurre incessantemente nuove modificazioni progressive in tutti i campi del lavoro e della produzione, senza trascurare gli apporti minimi di progresso che nelle grandissime aziende, moltiplicati per una grande scala, danno risultati molto apprezzabili.
Tutta l’attività industriale di Henry Ford si può studiare da questo punto di vista: una lotta continua, incessante per sfuggire alla legge della caduta del saggio del profitto, mantenendo una posizione di superiorità sui concorrenti. Il Ford è dovuto uscire dal campo strettamente industriale della produzione per organizzare anche i trasporti e la distribuzione della sua merce, determinando così una distribuzione della massa del plusvalore più favorevole all’industriale produttore.
L’errore del Croce è di varia natura: parte dal presupposto che ogni progresso tecnico determini immediatamente, come tale, una caduta del saggio del profitto, ciò che è erroneo perché la Critica dell’economia politica afferma solo che il progresso tecnico determina un processo di sviluppo contradditorio, uno dei cui aspetti è la caduta tendenziale. Afferma di tener conto di tutte le premesse teoriche dell’economia critica e dimentica la legge del lavoro socialmente necessario. Dimentica del tutto la parte della quistione trattata nel I volume, ciò che gli avrebbe risparmiato tutta questa serie di errori, dimenticanza tanto più grave in quanto egli stesso riconosce che nel III volume la sezione dedicata alla legge della caduta tendenziale è incompiuta, solo abbozzata, ecc.; una ragione perentoria per studiare tutto ciò che altrove lo stesso autore aveva scritto sull’argomento. (La quistione del testo del III volume può essere ristudiata ora che si ha a disposizione, come credo, l’edizione diplomatica dell’insieme di appunti e di che avrebbero dovuto servire alla sua stesura definitiva. Non è da escludere che nell’edizione tradizionale siano stati trascurati dei passi che, dopo le polemiche avvenute, potrebbero avere un’importanza ben maggiore di quella che il primo riordinatore del materiale frammentario potesse immaginare).
Un tecnico dell’economia dovrebbe poi riprendere la formula generale della legge della caduta tendenziale, che fissa il momento in cui la legge stessa si verifica e criticamente stabilire tutta la serie di passaggi che tendenzialmente ad essa conducono come conclusione logica.
È da svolgere l’accenno sul significato che «tendenziale» deve avere, riferito alla legge della caduta del profitto. È evidente che in questo caso la tendenzialità non può riferirsi solo alle forze controperanti nella realtà ogni volta che da essa si astraggono alcuni elementi isolati per costruire un’ipotesi logica. Poiché la legge è l’aspetto contraddittorio di un’altra legge, quella del plusvalore relativo che determina l’espansione molecolare del sistema di fabbrica e cioè lo sviluppo stesso del modo di produzione capitalistico, non può trattarsi di tali forze controperanti come quelle delle ipotesi economiche comuni. In questo caso la forza controperante è essa stessa studiata organicamente e dà luogo a una legge altrettanto organica che quella della caduta. Il significato di «tendenziale» pare dover essere pertanto di carattere «storico» reale e non metodologico: il termine appunto serve a indicare questo processo dialettico per cui la spinta molecolare progressiva porta a un risultato tendenzialmente catastrofico nell’insieme sociale, risultato da cui partono altre spinte singole progressive in un processo di continuo superamento che però non può prevedersi infinito, anche se si disgrega in un numero molto grande di fasi intermedie di diversa misura e importanza.
Per la stessa ragione non è completamente esatto dire come fa il Croce nella prefazione alla seconda edizione del suo libro che la legge circa la caduta del saggio del profitto, se fosse esattamente stabilita, come credeva il suo autore, «importerebbe né più né meno che la fine automatica e imminente della società capitalistica». Niente di automatico e tanto meno di imminente. Questa illazione del Croce è dovuta appunto all’errore di aver esaminato la legge della caduta del saggio del profitto isolandola dal processo in cui è stata concepita e isolandola non ai fini scientifici di una migliore esposizione, ma come se essa fosse valida «assolutamente» e non invece come termine dialettico di un più vasto processo organico. Che in molti la legge sia stata interpretata nello stesso modo del Croce, non esonera questo da una certa responsabilità scientifica. Molte affermazioni dell’economia critica sono state così «mitizzate» e non è detto che una tale formazione di miti non abbia avuto la sua importanza pratica immediata e non possa ancora averla. Ma si tratta di un altro aspetto della quistione, che non ha che poco da vedere con l’impostazione scientifica del problema e con la deduzione logica: potrà essere esaminata in sede di critica dei metodi politici e dei metodi di politica culturale. È probabile che in questa sede sia da dimostrare inetto in ultima analisi e produttivo di maggior danno che utile in definitiva il metodo politico di forzare arbitrariamente una tesi scientifica per trarne un mito popolare energetico e propulsivo: il metodo potrebbe paragonarsi all’uso degli stupefacenti che creano un istante di esaltazione delle forze fisiche e psichiche ma debilitano permanentemente l’organismo.
Q10 §37 Punti di meditazione per lo studio dell’economia.
I Nell’esame della quistione del metodo di ricerca economica e del concetto di astrazione, è da vedere se l’appunto critico che il Croce fa all’economia critica di procedere attraverso «una continua mescolanza di deduzione teorica e di descrizione storica, di nessi logici e di nessi di fatto» (MSEM 4a, p. 160) non sia invece uno dei tratti caratteristici della superiorità dell’economia critica sull’economia pura e una delle forze che la rendono più feconda per il progresso scientifico. Del resto sono da notare le manifestazioni dell’insoddisfazione e del fastidio da parte dello stesso Croce per i procedimenti più comuni dell’economia pura, coi suoi bizantinismi e la sua mania scolastica di rivestire di un pomposo mantello scientifico le più triviali banalità di senso comune e le più vuote generalità. L’economia critica ha cercato un giusto contemperamento tra il metodo deduttivo e il metodo induttivo, cioè di costruire ipotesi astratte non sulla base indeterminata di un uomo in generale, storicamente indeterminato e che da nessun punto di vista può essere riconosciuto astrazione di una realtà concreta, ma sulla realtà effettuale, «descrizione storica», che dà la premessa reale per costruire ipotesi scientifiche, cioè per astrarre l’elemento economico o quelli tra gli aspetti dell’elemento economico su cui si vuole attrarre l’attenzione ed esercitare l’esame scientifico. In tal modo non può esistere l’homo oeconomicus generico, ma può astrarsi il tipo di ognuno degli agenti o protagonisti dell’attività economica che si sono successi nella storia; il capitalista, il lavoratore, lo schiavo, il padrone di schiavi, il barone feudale, il servo della gleba. Non per nulla la scienza economica è nata nell’età moderna, quando il diffondersi del sistema capitalistico ha diffuso un tipo relativamente omogeneo di uomo economico, cioè ha creato le condizioni reali per cui un’astrazione scientifica diveniva relativamente meno arbitraria e genericamente vacua di quanto fosse prima possibile.
II. È da riflettere su questo punto: come potrebbe e dovrebbe essere compilato modernamente un sommario di scienza critica economica che riproducesse il tipo rappresentato nel passato e per le passate generazioni dai compendi del Cafiero, del Deville, del Kautsky, dell’Aveling, del Fabietti, più modernamente dal compendio del Borchardt e, in una serie distinta, dalla letteratura economica di divulgazione scolastica che nelle lingue occidentali è rappresentata dal Precis d’Économie politique di Lapidus e Ostrovitianov, ma che nella lingua originale deve essere rappresentato ormai da una quantità ragguardevole di compendi di diverso tipo e di mole molto variabile a seconda del pubblico cui i compendi stessi sono dedicati.
Si osserva: 1) che oggi dopo l’avvenuta pubblicazione
dell’edizione critica delle diverse opere di economia critica,
il problema del rifacimento di tali compendi è divenuto di
soluzione necessaria, scientificamente doverosa; 2) che il
compendio del Borchardt, in quanto non è compilato sul solo I
volume della Critica
dell’Economia politica ma su i tre volumi, è superiore
evidentemente a quelli del Deville, del Kautsky ecc. (lasciando
da parte, per il momento, il valore intrinseco delle diverse
trattazioni); 3) che il tipo del compendio moderno dovrebbe
ancora essere più esteso di quello del Borchardt, in quanto
dovrebbe tener conto di tutta la trattazione economica dovuta
allo stesso autore e presentarsi come un compendio e una
esposizione di tutto il corpo dottrinale dell’Economia critica e
non solo come un sunto di determinate opere sia pure
fondamentali; 4) che il metodo dell’esposizione non dovrebbe
essere determinato dalle fonti letterarie date, ma dovrebbe
nascere ed essere dettato dalle esigenze critiche e culturali di
attualità cui si vuole dare una soluzione scientifica e
organica; 5) che pertanto, sono da escludere senz’altro i sunti
pedissequi e materiali, ma tutto il materiale deve essere rifuso
e riorganizzato in modo «originale», preferibilmente
sistematico, secondo uno schema che faciliti «didatticamente» lo
studio e l’apprendimento; 6) che tutto il corredo di esempi e di
fatti concreti deve essere aggiornato e quelli contenuti nei
testi originari devono e possono essere riferiti solo nella
misura in cui la storia economica e la legislazione del paese
per cui il compendio è fatto, non ne offrano di corrispondenti
per un diverso sviluppo del processo storico o non così
rilevanti ed espressivi; 7) che l’esposizione deve essere
critica e polemica, nel senso che deve rispondere, sia pure
implicitamente e per sottinteso, all’impostazione che dei
problemi economici è data, nel paese determinato, dalla cultura
economica più diffusa e dagli economisti ufficiali e in auge. Il
manuale del Lapidus e Ostrovitianov da questo punto di vista è
«dogmatico», presenta le sue affermazioni e i suoi svolgimenti
come se essi non fossero «contestati» e rigettati radicalmente
da nessuno, ma fossero l’espressione di una scienza che dal
periodo di lotta e di polemica per affermarsi e trionfare è già
entrata nel periodo classico della sua espansione organica.
Evidentemente questo non è il caso, invece. Il compendio deve
essere appunto energicamente polemico ed aggressivo e non
lasciare senza risposta (implicita e sottintesa nella propria
autonoma impostazione, se così forse è meglio) ogni quistione
essenziale o che come essenziale è presentata dall’economia
volgare, in modo da cacciare questa qui da tutti i suoi ripari e
le sue difese e squalificarla al cospetto delle giovani
generazioni di studiosi; 8) il compendio di scienza economica
non può andare disgiunto da un corso di storia delle dottrine
economiche. Il così detto IV volume della Critica dell’Economia
politica è appunto una storia delle dottrine economiche e con
questo titolo appunto è stato tradotto in francese. Tutta la
concezione dell’economia critica è storicistica (ciò che non
vuol dire che essa debba confondersi con la così detta scuola
storica dell’economia) e la sua trattazione teorica non può
scompagnarsi da una storia della scienza economica, il cui
nucleo centrale oltre che nel detto IV volume può ricostruirsi
in parte almeno da accenni contenuti dispersamente in tutta
l’opera degli scrittori originari; 9) così non si può fare a
meno di una sia pur breve introduzione generale che sulla
traccia della prefazione alla 2a edizione del I volume dia
un’esposizione riassuntiva della filosofia della prassi e dei
principi metodologici più importanti ed essenziali, estraendoli
dall’insieme delle opere economiche, dove sono incorporati nella
trattazione o dispersi e accennati quando se ne presenta
l’opportunità concreta.
Q10 §38 Punti di riferimento per un saggio su Croce.
I. Che la teoria del valore nella economia critica non sia una teoria del valore, ma «qualcosa d’altro» fondato su un paragone ellittico, cioè con riferimento a una ipotetica società avvenire ecc. Ma la dimostrazione non è riuscita e la confutazione di essa è contenuta implicitamente nello stesso Croce (cfr il primo capitolo del saggio Per la interpretazione e la critica ecc.). Occorre dire che la trovata del paragone ellittico è puramente letteraria; infatti la teoria del valore‑lavoro ha tutta una storia che culmina nelle dottrine di Ricardo e i rappresentanti storici di tale dottrina non intendevano fare certo dei paragoni ellittici. (Questa obbiezione è stata enunziata dal prof. Graziadei nel volumetto Capitale e salari; sarebbe da vedere se fu presentata prima e da chi. Essa è così ovvia che dovrebbe venire subito sulla punta del pennino). È da vedere anche se il Croce conoscesse il volume Das Mehrwert, in cui l’esposizione dello svolgimento storico della teoria del valore‑lavoro è contenuta. (Confronti cronologici tra la pubblicazione del Mehrwert, avvenuta postuma e dopo i volumi 2 e 3 della Critica dell’Economia politica, e il saggio del Croce). La quistione quindi è questa: il tipo di ipotesi scientifica propria dell’Economia critica che astrae non principii economici dell’uomo in generale, di tutti i tempi e luoghi, ma delle leggi di un determinato tipo di società, è arbitrario o invece più concreto del tipo di ipotesi dell’economia pura? E posto che un tipo di società si presenta pieno di contraddizioni, è corretto astrarre solo uno dei termini di questa contraddizione? D’altronde ogni teoria è un paragone ellittico, poiché c’è sempre un paragone tra i fatti reali e l’«ipotesi» depurata di questi fatti. Quando il Croce dice che la teoria del valore non è la «teoria del valore» ma qualcosa d’altro, in realtà non distrugge la teoria stessa ma pone una quistione formale di nomenclatura: ecco perché gli economisti ortodossi non furono contenti del suo saggio (cfr nel libro MSEM l’articolo in polemica col prof. Racca). Così non è valida l’osservazione a proposito del termine «plusvalore», il quale invece esprime con molta chiarezza ciò che si vuol dire appunto per le ragioni per cui il Croce lo critica; si tratta della scoperta di un fatto nuovo, il quale viene espresso con un termine la cui novità consiste nella formazione, appunto contradditoria in confronto della scienza tradizionale; che non possano esistere «plusvalori» alla lettera può esser giusto, ma il neologismo ha un significato metaforico, non letterale, cioè è una nuova parola che non si risolve nel valore letterale delle originarie forme etimologiche.
II. Forse sarebbe opportuno, secondo l’ampiezza del Saggio, dare uno schizzo della tradizione intellettuale del Mezzogiorno (specialmente nel pensiero politico e filosofico) in contrapposizione col resto d’Italia, specialmente la Toscana, così come si riflette fino alla generazione del Croce (e Giustino Fortunato). Il libro di Luigi Russo sul De Sanctis e l’Università napoletana può essere molto utile, anche per vedere come la tradizione meridionale abbia col De Sanctis raggiunto un grado di sviluppo teorico‑pratico di fronte al quale l’atteggiamento del Croce rappresenta un arretramento, senza che l’atteggiamento del Gentile, che tuttavia più del Croce si è impegnato nell’azione pratica, possa giudicarsi una continuazione dell’attività desanctisiana per altre ragioni. A proposito del contrasto culturale tra la Toscana e il Mezzogiorno si può ricordare (a titolo di curiosità) l’epigramma di Ardengo Soffici (credo nel Giornale di Bordo) sul «carciofo». Il carciofo toscano, scrive su per giù il Soffici, non si presenta a prima vista così vistoso e allettante come il carciofo napoletano; è ispido, duro, tutto spine, irsuto. Ma sfogliatelo; dopo le prime foglie legnose e immangiabili, da buttar via, sempre più aumenta la parte commestibile e saporita, finché, nel mezzo, si trova il nucleo compatto, polposo, saporitissimo. Prendete il carciofo napoletano; subito dalle prime foglie c’è qualcosa da mangiare, ma quale acquosità e banalità di sapore; sfogliate sempre, il sapore non migliora e nel centro trovate nulla, un vuoto pieno di pagliosità disgustevole. Opposizione tra la cultura scientifica e sperimentale dei toscani e la cultura speculativa dei napoletani. Solo che la Toscana oggi non ha una particolare funzione nella cultura nazionale e si nutre della boria dei ricordi passati.
Q10 §39 Punti di riferimento per un saggio sul Croce. Nota su Luigi Einaudi. Non pare che Einaudi abbia studiato direttamente le opere di Economia critica e di filosofia della praxis; si può anzi dire che egli ne parla, specialmente della filosofia della praxis, da orecchiante, per sentito dire, spesso di terza o quarta mano. Le nozioni principali le ha prese dal Croce (MSEM) ma in modo superficiale e spesso sgangherato (confronta un paragrafo precedente). Ciò che più interessa è il fatto che della «Riforma Sociale» è sempre stato scrittore apprezzato (e per qualche tempo, credo, anche membro della redazione) Achille Loria cioè il divulgatore di una derivazione deteriore della filosofia della praxis. Si può dire anzi che in Italia ciò che passa sotto la bandiera di filosofia della praxis non è altro che contrabbando di paccotiglia scientifica loriana. Recentemente, proprio nella Riforma Sociale, il Loria ha pubblicato un suo zibaldone di schede caoticamente disposte, intitolandolo: Nuove conferme dell’economismo storico. Nella «Riforma Sociale» di novembre‑dicembre 1930 l’Einaudi ha pubblicato una nota: Il mito (!) dello strumento tecnico a proposito dell’autobiografia di Rinaldo Rigola che rinforza l’opinione accennata più su. Appunto il Croce aveva mostrato nel suo saggio sul Loria (nel MSEM) che il «mito (!) dello strumento tecnico» è stata una particolare invenzione del Loria, ciò di cui Einaudi non fa cenno, persuaso come è che si tratti invece di una dottrina della filosofia della praxis. L’Einaudi inoltre commette tutta una serie di errori per ignoranza dell’argomento: 1) confonde lo sviluppo dello strumento tecnico con lo sviluppo delle forze economiche; per lui parlare di sviluppo delle forze di produzione significa solo parlare dello sviluppo dello strumento tecnico; 2) ritiene che le forze di produzione per l’economia critica siano solo le cose materiali e non anche le forze e i rapporti sociali, cioè umani, che sono incorporati nelle cose materiali e di cui il diritto di proprietà è l’espressione giuridica; 3) risalta anche in questo scritto il solito «cretinismo» economistico che è proprio dell’Einaudi e di molti suoi amici liberoscambisti i quali come propagandisti sono dei veri illuminati. Sarebbe interessante rivedere la raccolta degli scritti di propaganda giornalistica dell’Einaudi; da essi apparirebbe che i capitalisti non hanno mai capito i loro veri interessi e si sono sempre comportati antieconomicamente.
Data la innegabile influenza intellettuale dell’Einaudi su un largo strato di intellettuali, varrebbe la pena di fare una ricerca di tutte le in cui egli accenna alla filosofia della praxis. È inoltre da ricordare l’articolo necrologico su Piero Gobetti pubblicato dall’Einaudi nel «Baretti», che spiega l’attenzione con cui l’Einaudi rimbecca ogni scrittura dovuta a liberali in cui si riconoscono alla filosofia della praxis l’importanza e l’influsso avuti nello svolgimento della cultura moderna. È anche da ricordarle a questo proposito il brano sul Gobetti nel Piemonte di Giuseppe Prato.
Q10 §40 Introduzione allo studio della filosofia. Il «noumeno» kantiano. Se la realtà è come noi la conosciamo e la nostra conoscenza muta continuamente, se cioè nessuna filosofia è definitiva ma è storicamente determinata, è difficile immaginare che la realtà oggettivamente muti col nostro mutare ed è difficile ammetterlo non solo per il senso comune ma anche per il pensiero scientifico. Nella Sacra Famiglia si dice che la realtà si esaurisce tutta nei fenomeni e che al di là dei fenomeni non c’è nulla, e così è certamente. Ma la dimostrazione non è agevole. Cosa sono i fenomeni? Sono qualcosa di oggettivo, che esistono in sé e per sé, o sono qualità che l’uomo ha distinto in conseguenza dei suoi interessi pratici (la costruzione della sua vita economica) e dei suoi interessi scientifici, cioè della necessità di trovare un ordine nel mondo e di descrivere e classificare le cose (necessità che è anch’essa legata a interessi pratici mediati e futuri)? Posta l’affermazione che ciò che noi conosciamo nelle cose è niente altro che noi stessi, i nostri bisogni e i nostri interessi, cioè che le nostre conoscenze sono soprastrutture (o filosofie non definitive) è difficile evitare che si pensi a qualcosa di reale al di là di queste conoscenze, non nel senso metafisico di un «noumeno», di un «dio ignoto» o di «un inconoscibile», ma nel senso concreto di una «relativa ignoranza» della realtà, di qualcosa di ancora «sconosciuto» che però potrà essere un giorno conosciuto quando gli strumenti «fisici» e intellettuali degli uomini saranno più perfetti, cioè quando saranno mutate, in senso progressivo le condizioni sociali e tecniche della umanità. Si fa quindi una previsione storica che consiste semplicemente nell’atto del pensiero che proietta nell’avvenire un processo di sviluppo come quello che si è verificato dal passato ad oggi. In ogni modo occorre studiare Kant e rivedere i suoi concetti esattamente.
Q10 §41 Punti di riferimento per un saggio sul Croce.
I. Discorso del Croce alla sezione di Estetica del Congresso filosofico di Oxford (riassunto nella «Nuova Italia» del 20 ottobre 1930): svolge in forma estrema le tesi sulla filosofia della praxis esposte nella Storia della Storiografia italiana nel secolo XIX. Questo più recente punto di vista critico del Croce sulla filosofia della praxis (che innova completamente quello sostenuto nel suo volume MSEM) come può essere giudicato criticamente? Si dovrà giudicare non come un giudizio da filosofo, ma come un atto politico di portata pratica immediata. È certo che della filosofia della praxis si è formata una corrente deteriore, che può essere considerata in rapporto alla concezione dei fondatori della dottrina come il cattolicismo popolare in rapporto a quello teologico o degli intellettuali: come il cattolicismo popolare può essere tradotto nei termini del paganesimo, o di religioni inferiori al cattolicismo per le superstizioni e le stregonerie da cui erano o sono dominate, così la filosofia della praxis deteriore può essere tradotta in termini «teologici» o trascendentali, cioè delle filosofie prekantiane e precartesiane. Il Croce si comporta come gli anticlericali massonici e razionalisti volgari che appunto combattono il cattolicismo con questi confronti e con queste traduzioni del cattolicismo volgare in linguaggio «feticista». Il Croce cade nella stessa posizione intellettualistica che il Sorel rimproverava al Clemenceau, di giudicare un movimento storico dalla sua letteratura di propaganda e di non capire che anche dei banali opuscoletti possono essere l’espressione di movimenti estremamente importanti e vitali.
Per una filosofia è una forza o una debolezza di avere oltrepassato i soliti limiti dei ristretti ceti intellettuali e di diffondersi nelle grandi masse sia pure adattandosi alla mentalità di queste e perdendo poco o molto del suo nerbo? E che significato ha il fatto di una concezione del mondo che in tal modo si diffonde e si radica e continuamente ha dei momenti di ripresa e di nuovo splendore intellettuale? È una ubbia da intellettuali fossilizzati credere che una concezione del mondo possa essere distrutta da critiche di carattere razionale: quante volte non si è parlato di «crisi» della filosofia della praxis? e che cosa significa questa crisi permanente? non significa forse la vita stessa che procede per negazioni di negazioni? Ora, chi ha conservato la forza delle successive riprese teoriche se non la fedeltà delle masse popolari che si erano appropriate la concezione, sia pure in forme superstiziose e primitive? Si parla spesso che in certi paesi il non esserci stata la riforma religiosa è causa di regresso in tutti i campi della vita civile e non si osserva che appunto la diffusione della filosofia della praxis è la grande riforma dei tempi moderni, è una riforma intellettuale e morale che compie su scala nazionale ciò che il liberalismo non è riuscito a compiere che per ristretti ceti della popolazione. Appunto l’analisi che il Croce ha fatto nella Storia dell’Europa delle religioni e il concetto che il Croce ha elaborato di religione servono a comprendere meglio il significato storico della filosofia della praxis e le ragioni della sua resistenza a tutti gli attacchi e a tutte le diserzioni.
La posizione del Croce è quella dell’uomo del Rinascimento verso la Riforma protestante con la differenza che il Croce rivive una posizione che storicamente si è dimostrata falsa e reazionaria e che egli stesso (e i suoi scolari: cfr il volume del De Ruggiero su Rinascimento e Riforma) ha contribuito a dimostrare falsa e reazionaria. Che Erasmo potesse dire di Lutero: «dove appare Lutero, muore la cultura» si può capire. Che oggi il Croce riproduca la posizione di Erasmo non si capisce, poiché il Croce ha visto come dalla primitiva rozzezza intellettuale dell’uomo della Riforma è tuttavia scaturita la filosofia classica tedesca e il vasto movimento culturale da cui è nato il mondo moderno. Ancora: tutta la trattazione che il Croce fa nella sua Storia d’Europa del concetto di religione è una critica implicita delle ideologie piccolo borghesi (Oriani, Missiroli, Gobetti, Dorso ecc.) che spiegano le debolezze dell’organismo nazionale e statale italiano con l’assenza di una Riforma religiosa, intesa in senso angustamente confessionale. Allargando e precisando il concetto di religione, il Croce mostra la meccanicità e lo schematismo astratto di queste ideologie, che erano niente altro che costruzioni di letterati. Ma appunto per ciò, più grave appunto gli si deve fare di non aver capito che appunto la filosofia della praxis, col suo vasto movimento di massa, ha rappresentato e rappresenta un processo storico simile alla Riforma, in contrasto col liberalismo, che riproduce un Rinascimento angustamente ristretto a pochi gruppi intellettuali e che a un certo punto ha capitolato di fronte al cattolicesimo, fino al punto che il solo partito liberale efficiente era il partito popolare, cioè una nuova forma di cattolicismo liberale.
Croce rimprovera alla filosofia della praxis il suo «scientismo», la sua superstizione «materialistica», un suo presunto ritorno al «medioevo intellettuale». Sono i rimproveri che Erasmo, nel linguaggio del tempo, muoveva al luteranismo. L’uomo del Rinascimento e l’uomo creato dallo sviluppo della Riforma si sono fusi nell’intellettuale moderno del tipo Croce, ma se questo tipo sarebbe incomprensibile senza la Riforma, esso non riesce più a comprendere il processo storico per cui dal «medioevale» Lutero si è necessariamente giunti allo Hegel e perciò di fronte alla grande riforma intellettuale e morale rappresentata dal diffondersi della filosofia della praxis riproduce meccanicamente l’atteggiamento di Erasmo. Questa posizione del Croce si può studiare con molta precisione nel suo atteggiamento pratico verso la religione confessionale.
Croce è essenzialmente anticonfessionale (non possiamo dire antireligioso data la sua definizione del fatto religioso), e per un largo gruppo di intellettuali italiani ed europei la sua filosofia, specialmente nelle sue manifestazioni meno sistematiche (come le recensioni, le postille ecc. raccolte nei volumi come Cultura e vita morale, Conversazioni critiche, Frammenti di Etica ecc.) è stata una vera e propria riforma intellettuale e morale di tipo «Rinascimento». «Vivere senza religione» (e s’intende senza confessione religiosa) è stato il succo che il Sorel ha tratto dalla lettura del Croce (cfr Lettere di G. Sorel a B. Croce pubblicate nella «Critica» del 1927 e sgg.). Ma il Croce non è «andato al popolo», non è voluto diventare un elemento «nazionale» (come non lo sono stati gli uomini del Rinascimento, a differenza dei luterani e calvinisti), non ha voluto creare una schiera di discepoli che, in sua sostituzione (dato che egli personalmente volesse serbare la sua energia per la creazione di un’alta coltura) potessero popolarizzare la sua filosofia, tentando di farla diventare un elemento educativo fin dalle scuole elementari (e quindi educativo per il semplice operaio e contadino, cioè per il semplice uomo del popolo). Forse ciò era impossibile, ma valeva la pena che fosse tentato e il non averlo tentato ha pure un significato.
Croce in qualche libro ha scritto qualcosa di questo genere: «Non si può togliere la religione all’uomo del popolo, senza subito sostituirla con qualcosa che soddisfi le stesse esigenze per cui la religione è nata e ancora permane». C’è del vero in questa affermazione, ma non contiene questa una confessione dell’impotenza della filosofia idealista a diventare una integrale (e nazionale) concezione del mondo? E infatti come si potrebbe distruggere la religione nella coscienza dell’uomo del popolo senza nello stesso tempo sostituirla? È possibile in questo caso solo distruggere senza creare? È impossibile. Lo stesso anticlericalismo volgare‑massonico, sostituisce una nuova concezione alla religione che distrugge (in quanto realmente distrugge) e se questa nuova concezione è rozza e bassa, significa che la religione sostituita era realmente ancor più rozza e bassa. L’affermazione del Croce pertanto non può essere che un modo ipocrita di ripresentare il vecchio principio che la religione è necessaria per il popolo. Il Gentile, meno ipocritamente, e più conseguentemente, ha rimesso l’insegnamento della religione nelle scuole elementari (si è andati ancora più oltre di ciò che intendeva fare il Gentile e si è allargato l’insegnamento religioso alle scuole medie) e ha giustificato il suo atto con la concezione hegeliana della religione come filosofia dell’infanzia dell’umanità (è da vedere il programma scolastico del Croce, caduto per le vicende parlamentari del governo Giolitti 1920‑21, ma che per rispetto alla religione non era molto diverso da quello che fu il programma Gentile, se ben ricordo), che è diventato un puro sofisma applicato ai tempi attuali, e un modo di rendere servizio al clericalismo.
È da ricordare il «frammento di Etica» sulla religione; perché non è stato svolto? Forse ciò era impossibile. La concezione dualistica e della «obbiettività del mondo esterno» quale è stata radicata nel popolo dalle religioni e dalle filosofie tradizionali diventate «senso comune» non può essere sradicata e sostituita che da una nuova concezione che si presenti intimamente fusa con un programma politico e una concezione della storia che il popolo riconosca come espressione delle sue necessità vitali. Non è possibile pensare alla vita e alla diffusione di una filosofia che non sia insieme politica attuale, strettamente legata all’attività preponderante nella vita delle classi popolari, il lavoro, e non si presenti pertanto, entro certi limiti, come connessa necessariamente alla scienza. Essa concezione nuova magari assumerà inizialmente forme superstiziose e primitive come quelle della religione mitologica, ma troverà in se stessa e nelle forze intellettuali che il popolo esprimerà dal suo seno gli elementi per superare questa fase primitiva. Questa concezione connette l’uomo alla natura per mezzo della tecnica, mantenendo la superiorità dell’uomo ed esaltandola nel lavoro creativo, quindi esalta lo spirito e la storia. (È da vedere l’articolo di M. Missiroli sulla scienza pubblicato dall’«Ordine Nuovo»).
A proposito dei rapporti tra l’idealismo e il popolo è interessante questo brano del Missiroli (cfr «L’Italia Letteraria», 23 marzo 1930, Calendario: Religione e filosofia): «È probabile che qualche volta, di fronte alla logica del professore di filosofia, specie se questo sarà un seguace dell’idealismo assoluto, il senso comune degli scolari e il buon senso degli insegnanti delle altre materie, siano tratti a dar ragione al teologo piuttosto che al filosofo. Non vorrei, in un eventuale contraddittorio, davanti ad un pubblico non iniziato, trovarmi a dover perorare le ragioni della filosofia moderna. L’umanità è ancora tutta quanta aristotelica e la comune opinione segue ancora quel dualismo, che è proprio del realismo greco‑cristiano. Che il conoscere sia un “vedere” anziché un “fare”, che la verità sia fuori di noi, esistente in sé e per sé, e non una nostra creazione, che la “natura” e il “mondo” siano delle intangibili realtà, nessuno dubita e si rischia di passare per pazzi quando si afferma il contrario. I difensori dell’oggettività del sapere, i difensori più rigidi della scienza positiva, della scienza e del metodo di Galileo contro la gnoseologia dell’idealismo assoluto, oggi si trovano fra i cattolici. Quelli che Croce chiama pseudoconcetti e quello che Gentile definisce come pensiero astratto, sono le ultime rocche dell’oggettivismo. Donde la tendenza, sempre più visibile, della coltura cattolica a valorizzare la scienza positiva e l’esperienza contro la nuova metafisica dell’assoluto. Non è da escludere che il pensiero cattolico possa ringiovanirsi rifugiandosi nella cittadella della scienza sperimentale. Da trent’anni i gesuiti lavorano per eliminare i contrasti – in realtà basati su equivoci – fra la religione e la scienza e non a caso Giorgio Sorel in uno scritto oggi rarissimo osservava che, fra tutti gli scienziati, i matematici sono i soli per i quali il miracolo non ha nulla di miracoloso».
Questo modo di vedere i rapporti tra scienza sperimentale e cattolicismo non è molto costante nel Missiroli e d’altronde la sua ipotesi non è molto fondata sui fatti reali. Nel volume Date a Cesare il quadro che Missiroli fa della cultura dei religiosi in Italia non è molto brillante e promettente di un qualsiasi sviluppo pericoloso per la cultura laica. In una recente risposta a un referendum del «Saggiatore» il Missiroli prevede nell’avvenire italiano un diffondersi generale delle scienze naturali a danno del pensiero speculativo e nello stesso tempo un’ondata di anticlericalismo, cioè prevede che lo sviluppo delle scienze sperimentali sarà in contrasto con le correnti religiose. Che i gesuiti da trent’anni lavorino per riconciliare scienza e religione non pare molto esatto, almeno in Italia. In Italia la filosofia neoscolastica, che si era assunta questa missione, è rappresentata piuttosto dai francescani (che nell’Università del Sacro Cuore si sono circondati di molti laici) che dai gesuiti, tra i quali pare abbondino soprattutto gli studiosi di psicologia sperimentale e di metodo erudito (scienza biblica ecc.). Anzi si ha l’impressione che i gesuiti (quelli della «Civiltà Cattolica» almeno) guardino con un certo sospetto gli studi scientifici e anche l’Università del Sacro Cuore per il fatto che i professori di essa civettano un po’ troppo con le idee moderne (la «Civiltà Cattolica» non cessa mai di censurare ogni adesione troppo spinta al darwinismo ecc. Del resto i neoscolastici del gruppo Gemelli hanno civettato non poco col Croce e col Gentile e ne hanno accolto particolari teorie: il libro di monsignor Olgiati su Carlo Marx – del 1920 – è tutto costruito con materiali critici crociani e il padre Chiocchetti che ha scritto un libro sul Croce accetta di questi la dottrina dell’origine pratica dell’errore che non si vede come possa essere isolata da tutto il sistema crociano).
L’atteggiamento del Croce verso il cattolicismo si è andato precisando dopo il 1925 e ha avuto la sua nuova manifestazione più cospicua con la Storia d’Europa nel secolo XIX, che è stata messa all’indice. Il Croce qualche anno fa si maravigliava perché i suoi libri non erano mai stati posti all’indice: ma perché ciò avrebbe dovuto avvenire? La Congregazione dell’Indice (che è poi il Santo Ufficio dell’Inquisizione) ha una sua politica accorta e prudente. Mette all’Indice librucciacci di poco conto, ma evita quanto può di indicare all’attenzione pubblica come contrarie alla fede le opere di grandi intellettuali. Si trincera dietro la scusa molto comoda che sono devono essere intesi come automaticamente all’Indice tutti i libri che sono contrari a certi principii elencati nelle introduzioni delle diverse edizioni degli Indici. Così per D’Annunzio si è decisa la messa all’Indice solo quando il governo decise di fare l’edizione nazionale delle opere e per il Croce per la Storia d’Europa. In realtà la Storia d’Europa è il primo libro del Croce in cui le opinioni antireligiose dello scrittore assumevano un significato di politica attiva e avevano una diffusione inaudita.
Il recente atteggiamento del Croce verso la filosofia della praxis (la cui manifestazione più cospicua è stata finora il discorso alla sezione di Estetica del Congresso di Oxford) non è solo un rinnegamento (anzi un capovolgimento) della prima posizione assunta dal Croce prima del 1900 (quando scriveva che il nome di «materialismo» era solo un modo di dire e polemizzava col Plekhanov dando ragione al Lange di non aver parlato della filosofia della praxis nella sua Storia del Materialismo), capovolgimento non giustificato logicamente, ma è anche un rinnegamento, anch’esso non giustificato, della sua propria filosofia passata (almeno di una parte cospicua di essa) in quanto il Croce era un filosofo della praxis «senza saperlo» (sarà da vedere il saggio di Gentile in proposito contenuto nel volume Saggi Critici, Serie seconda, ediz. Vallecchi, Firenze).
Alcune quistioni poste dal Croce sono puramente verbali. Quando egli scrive che le superstrutture sono concepite come apparenze, non pensa che ciò può significare semplicemente qualcosa di simile alla sua affermazione della non «definitività» ossia della «storicità» di ogni filosofia? Quando per ragioni «politiche», pratiche, per rendere indipendente un gruppo sociale dall’egemonia di un altro gruppo, si parla di «illusione», come si può confondere in buona fede un linguaggio polemico con un principio gnoseologico? E come spiega il Croce la non definitività delle filosofie? Da una parte egli fa questa affermazione gratuitamente, senza giustificarla altro che con il principio generale del «divenire», dall’altra riafferma il principio (già da altri affermato) che la filosofia non è una cosa astratta ma è la risoluzione dei problemi che la realtà nel suo svolgimento incessantemente presenta. La filosofia della praxis intende invece giustificare non con principi generici, ma con la storia concreta, la storicità delle filosofie, storicità che è dialettica perché dà luogo a lotte di sistemi, a lotte tra modi di vedere la realtà, e sarebbe strano che chi è convinto della propria filosofia, ritenesse concrete e non illusorie le credenze avversarie (e di questo si tratta, poiché altrimenti i filosofi della praxis dovrebbero ritenere illusorie le loro proprie concezioni o essere degli scettici e degli agnostici). Ma il più interessante è questo: che la dottrina dell’origine pratica dell’errore del Croce non è altro che la filosofia della praxis ridotta a una dottrina particolare. In questo caso l’errore del Croce è l’illusione dei filosofi della praxis.
Solo che errore e illusione deve significare nel caso di questa filosofia niente altro che «categoria storica» transeunte per i cambiamenti della pratica, cioè l’affermazione della storicità delle filosofie non solo, ma anche una spiegazione realistica di tutte le concezioni soggettivistiche della realtà. La teoria delle superstrutture non è che la soluzione filosofica e storica dell’idealismo soggettivistico. Accanto alla dottrina dell’origine pratica dell’errore è da porre la teoria delle ideologie politiche spiegate dal Croce nel loro significato di strumenti pratici d’azione: ma dove trovare il limite tra ciò che deve essere inteso come ideologia nel senso stretto crociano e l’ideologia nel senso della filosofia della praxis cioè tutto l’insieme delle soprastrutture? Anche in questo caso la filosofia della praxis ha servito al Croce per costruire una dottrina particolare. D’altronde sia l’«errore» che l’«ideologia come strumento pratico d’azione» anche per il Croce possono essere rappresentati da interi sistemi filosofici che sono tutti un errore perché originati da bisogni pratici e da necessità sociali. Sebbene non l’abbia finora esplicitamente scritto, non sarebbe maraviglioso se il Croce sostenesse l’origine pratica delle religioni mitologiche e quindi così spiegasse la loro erroneità da una parte e il loro resistere tenace alle critiche delle filosofie laiche, dall’altra, perché qualche accenno in questo senso si potrebbe trovare nei suoi scritti (il Machiavelli, con la sua concezione della religione come strumento di dominio, potrebbe avere già enunziato la tesi dell’origine pratica delle religioni).
L’affermazione del Croce che la filosofia della praxis «stacca» la struttura dalle superstrutture, rimettendo così in vigore il dualismo teologico e ponendo un «dio ignoto‑struttura» non è esatta e non è neanche molto profonda invenzione. L’accusa di dualismo teologico e di disgregazione del processo del reale è vacua e superficiale. È strano che una tale accusa sia venuta dal Croce, che ha introdotto il concetto di dialettica dei distinti e che per ciò è continuamente accusato dai gentiliani di aver appunto disgregato il processo del reale. Ma, a parte ciò, non è vero che la filosofia della praxis «stacchi» la struttura dalle superstrutture quando invece concepisce il loro sviluppo come intimamente connesso e necessariamente interrelativo e reciproco. Né la struttura è neanche per metafora paragonabile a un «dio ignoto»: essa è concepita in modo ultrarealistico, tale da poter essere studiata coi metodi delle scienze naturali ed esatte e anzi appunto per questa sua «consistenza» oggettivamente controllabile la concezione della storia è stata ritenuta «scientifica». Forse che la struttura è concepita come qualcosa di immobile ed assoluto o non invece come la realtà stessa in movimento e l’affermazione delle Tesi su Feuerbach dell’«educatore che deve essere educato» non pone un rapporto necessario di reazione attiva dell’uomo sulla struttura, affermando l’unità del processo del reale? Il concetto di «blocco storico» costruito dal Sorel coglieva appunto in pieno questa unità sostenuta dalla filosofia della praxis. È da notare quanto fosse cauto e prudente il Croce nei primi saggi raccolti in MSEM e quante riserve avanzasse nell’enunziare le sue critiche e le sue interpretazioni (sarà interessante registrare queste riserve cautelose) e come invece diverso sia il suo metodo in questi recenti scritti, che d’altronde, se colpissero nel segno, dimostrerebbero come egli abbia perduto il suo tempo nel primo periodo e sia stato di straordinaria semplicità e superficialità. Solo che allora il Croce tentava almeno di giustificare logicamente le sue caute affermazioni mentre oggi è diventato perentorio e non crede necessaria nessuna giustificazione. Si potrebbe trovare l’origine pratica del suo attuale errore ricordando il fatto che prima del 900 egli si riteneva onorato di passare anche politicamente per un seguace della filosofia della praxis, poiché allora la situazione storica faceva di questo movimento un alleato del liberalismo, mentre oggi le cose sono molto cambiate e certi scherzetti sarebbero pericolosi.
Q10 §41 II È da ricordare il giudizio del Croce su Giovanni Botero nel volume Storia dell’età barocca in Italia. Il Croce riconosce che i moralisti del 600, per quanto piccoli di statura al paragone del Machiavelli «rappresentavano, nella filosofia politica, uno stadio ulteriore e superiore». Questo giudizio è da avvicinarsi a quello del Sorel sul Clemenceau che non riusciva a vedere, anche «attraverso» una letteratura mediocre, le esigenze che tale letteratura rappresentava e che esse non erano mediocri. Un pregiudizio da intellettuali è quello di misurare i movimenti storici e politici col metro dell’intellettualismo, dell’originalità, della «genialità», cioè della compiuta espressione letteraria e delle grandi personalità brillanti e non invece della necessità storica e della scienza politica, cioè della capacità concreta e attuale di conformare il mezzo al fine. Questo pregiudizio è anche popolare, in certi stadi della organizzazione politica (stadio degli uomini carismatici) e si confonde spesso col pregiudizio dell’«oratore»: l’uomo politico deve essere grande oratore o grande intellettuale, deve avere il «crisma» del genio ecc. ecc. Si arriva poi allo stadio inferiore di certe regioni contadine o dei negri in cui per essere seguiti occorre avere la barba.
Q10 §41 III L’avvicinamento dei due termini etica e politica per indicare la più recente storiografia crociana è l’espressione delle esigenze in cui si muove il pensiero storico crociano: l’etica si riferisce all’attività della società civile, all’egemonia; la politica si riferisce all’iniziativa e alla coercizione statale‑governativa. Quando c’è contrasto tra etica e politica, tra esigenze della libertà ed esigenze della forza, tra società civile e Stato‑governo c’è crisi e il Croce giunge ad affermare che il vero «Stato», cioè la forza direttiva dell’impulso storico, occorre talvolta cercarlo non là dove si crederebbe, nello Stato giuridicamente inteso, ma nelle forze «private» e anche nei così detti rivoluzionari. Questa proposizione del Croce è molto importante per intendere appieno la sua concezione della storia e della politica. Sarebbe utile analizzare in concreto queste tesi nei libri di storia del Croce in quanto vi sono incorporate concretamente.
Q10 §41 IV Si potrebbe dire che il Croce è l’ultimo del Rinascimento e che esprime esigenze e rapporti internazionali e cosmopoliti. Ciò non vuol dire che egli non sia un «elemento nazionale», anche nel significato moderno del termine, vuol dire che anche dei rapporti ed esigenze nazionali egli esprime specialmente quelli che sono più generali e coincidono con nessi di civiltà più vasti dell’area nazionale: l’Europa, quella che suole chiamarsi civiltà occidentale ecc. Il Croce è riuscito a ricreare nella sua personalità e nella sua posizione di leader mondiale della cultura quella funzione di intellettuale cosmopolita che è stata svolta quasi collegialmente dagli intellettuali italiani dal Medio Evo fino alla fine del 600. D’altronde, se nel Croce sono vive le preoccupazioni di leader mondiale, che lo inducono ad assumere sempre atteggiamenti equilibrati, olimpici, senza impegni troppo compromettenti di carattere temporaneo ed episodico, è anche vero che egli stesso ha inculcato il principio che in Italia, se si vuole sprovincializzare la cultura e il costume (e il provincialismo ancora permane come residuo del passato di disgregazione politica e morale) occorre elevare il tono della vita intellettuale attraverso il contatto e lo scambio di idee col mondo internazionale (era questo il programma rinnovatore del gruppo fiorentino della «Voce»), quindi nel suo atteggiamento e nella sua funzione è immanente un principio essenzialmente nazionale.
La funzione del Croce si potrebbe paragonare a quella del papa cattolico e bisogna dire che il Croce, nell’ambito del suo influsso, talvolta ha saputo condursi più abilmente del papa: nel suo concetto di intellettuale, del resto, c’è qualcosa di «cattolico e clericale», come può vedersi dalle sue pubblicazioni del tempo di guerra e come risulta anche oggi da recensioni e postille; in forma più organica e stringata la sua concezione dell’intellettuale può avvicinarsi a quella espressa da Julien Benda nel libro La trahison des clercs.
Dal punto di vista della sua funzione culturale non bisogna tanto considerare il Croce come filosofo sistematico quanto alcuni aspetti della sua attività: 1) il Croce come teorico dell’estetica e della critica letteraria ed artistica (l’ultima edizione dell’Enciclopedia Britannica ha affidato al Croce la voce «Estetica», trattazione pubblicata in Italia fuori commercio col titolo Aestethica in nuce; il Breviario d’Estetica è stato compilato per gli Americani. In Germania sono molti i seguaci dell’Estetica crociana); 2) il Croce come critico della filosofia della praxis e come teorico della storiografia; 3) specialmente il Croce come moralista e maestro di vita, costruttore di principii di condotta che astraggono da ogni confessione religiosa, anzi mostrano come si può «vivere senza religione».
Quello del Croce è un ateismo da signori, un anticlericalismo che aborre la rozzezza e la grossolanità plebea degli anticlericali sbracati, ma si tratta sempre di ateismo e di anticlericalismo; si domanda perciò perché il Croce non si sia messo a capo, se non attivamente, almeno dando il suo nome e il suo patrocinio, a un movimento italiano di Kulturkampf, che avrebbe avuto un’enorme importanza storica (per l’atteggiamento ipocrita dei crociani verso il clericalismo è da vedere l’articolo di G. Prezzolini La paura del prete nel volume Mi pare... stampato dalla casa editrice Delta di Fiume). Né si può dire che egli non si sia impegnato nella lotta per considerazioni di carattere filisteo, per considerazioni personali ecc., perché egli ha dimostrato di non curarsi di queste vanità mondane convivendo liberamente con una donna molto intelligente, che manteneva vivacità al suo salotto napoletano frequentato da scienziati italiani e stranieri e sapeva destare l’ammirazione di questi frequentatori; questa unione libera impedì al Croce di entrare nel Senato prima del 1912, quando la signora era morta e il Croce era ridiventato per Giolitti una persona «rispettabile». È anche da notare, a proposito di religione, l’atteggiamento equivoco del Croce verso il modernismo: che il Croce dovesse essere antimodernista poteva intendersi, in quanto anticattolico, ma l’impostazione della lotta ideologica non fu questa.
Obbiettivamente il Croce fu un alleato prezioso dei gesuiti contro il modernismo (nel Date a Cesare il Missiroli esalta dinanzi ai cattolici l’atteggiamento del Croce e del Gentile contro il modernismo in questo senso) e la ragione di questa lotta, che tra religione trascendentale e filosofia immanentistica non può esistere un tertium quid ancipite ed equivoco, pare tutto un pretesto. Anche in questo caso appare l’uomo del Rinascimento, il tipo di Erasmo, con la stessa mancanza di carattere e di coraggio civile. I modernisti, dato il carattere di massa che era dato loro dalla contemporanea nascita di una democrazia rurale cattolica (legata alla rivoluzione tecnica che avveniva nella valle padana con la scomparsa della figura dell’obbligato o schiavandaro e l’espandersi del bracciante e di forme meno servili di mezzadria) erano dei riformatori religiosi, apparsi non secondo schemi intellettuali prestabiliti, cari allo hegelismo, ma secondo le condizioni reali e storiche della vita religiosa italiana. Era una seconda ondata di cattolicismo liberale, molto più esteso e di carattere più popolare che non fosse stato quello del neoguelfismo prima del 48 e del più schietto liberalismo cattolico posteriore al 48. L’atteggiamento del Croce e del Gentile (col chierichetto Prezzolini) isolò i modernisti nel mondo della cultura e rese più facile il loro schiacciamento da parte dei gesuiti, anzi parve una vittoria del papato contro tutta la filosofia moderna: l’enciclica antimodernista è in realtà contro l’immanenza e la scienza moderna e in questo senso fu commentata nei seminari e nei circoli religiosi (è curioso che oggi l’atteggiamento dei crociani verso i modernisti, o almeno i maggiori di essi – non però contro il Buonajuti – è cambiato di molto come può vedersi dalla elaborata recensione di Adolfo Omodeo, nella «Critica» del 20 luglio 1932, dei Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre temps di Alfredo Loisy). Perché del modernismo il Croce non diede la stessa spiegazione logica che nella Storia d’Europa ha dato del cattolicismo liberale, come di una vittoria della «religione della libertà», che riusciva a penetrare anche nella cittadella del suo più acerrimo antagonista e nemico ecc.? (È da rivedere nella Storia d’Italia ciò che si dice del modernismo: ma ho l’impressione che il Croce sorvoli, mentre esalta la vittoria del liberalismo sul socialismo divenuto riformismo per l’attività scientifica del Croce stesso).
La stessa osservazione può farsi al Missiroli, anch’egli antimodernista e antipopolare: se il popolo non può giungere alla concezione della libertà politica e all’idea nazionale se non dopo aver attraversato una riforma religiosa, cioè dopo aver conquistato la nozione di libertà nella religione, non si capisce perché Missiroli e i liberali del «Resto del Carlino» siano stati così ferocemente antimodernisti: o si capisce anche troppo; perché modernismo significava politicamente democrazia cristiana, questa era particolarmente forte nell’Emilia‑Romagna e in tutta la valle padana e il Missiroli coi suoi liberali lottavano per l’Agraria.
Si pone il problema di chi rappresenti più adeguatamente la società contemporanea italiana dal punto di vista teorico e morale: il papa, Croce, Gentile; cioè: 1) chi abbia più importanza dal punto di vista dell’egemonia, come ordinatore dell’ideologia che dà il cemento più intimo alla società civile e quindi allo Stato; 2) chi all’estero rappresenti meglio l’influsso italiano nel quadro della cultura mondiale. Il problema non è di facile risoluzione, perché ognuno dei tre domina ambienti e forze sociali diverse. Il papa come capo e guida della maggioranza dei contadini italiani e delle donne, e perché la sua autorità e influsso operano con tutta una organizzazione accentrata e bene articolata, è una grande, la più grande forza politica del paese dopo il governo; ma è la sua una autorità diventata passiva e accettata per inerzia, che anche prima del Concordato era, di fatto, un riflesso dell’autorità statale. Per questa ragione è difficile fare un paragone tra l’influsso del papa e quello di un privato nella vita culturale. Un paragone più razionale può farsi tra il Croce e il Gentile, ed è subito evidente che l’influsso del Croce, nonostante tutte le apparenze, è di molto superiore a quello del Gentile. Intanto l’autorità del Gentile è tutt’altro che ammessa nella sua stessa parte politica (ricordare l’attacco di Paolo Orano in Parlamento contro la filosofia del Gentile e l’attacco personale contro il Gentile e i gentiliani nel settimanale «Roma» da parte di G. A. Fanelli). Mi pare che la filosofia del Gentile, l’attualismo, sia più nazionale solo nel senso che è strettamente legata a una fase primitiva dello Stato, allo stadio economico‑corporativo, quando tutti i gatti son bigi. Per questa stessa ragione si può credere alla maggiore importanza e influsso di questa filosofia, così come molti credono che in Parlamento un industriale sia più di un avvocato rappresentante degli interessi industriali (o di un professore o magari di un leader dei sindacati operai), senza pensare che, se l’intera maggioranza parlamentare fosse di industriali, il Parlamento perderebbe immediatamente la sua funzione di mediazione politica e ogni prestigio (per il corporativismo ed economismo del Gentile è da confrontare il suo discorso tenuto a Roma e pubblicato nel volume Cultura e Fascismo). L’influsso del Croce è meno rumoroso di quello del Gentile ma più profondo e radicato;
Croce è realmente una specie di papa laico, ma la morale del Croce è troppo da intellettuali, troppo del tipo Rinascimento, non può diventare popolare, mentre il papa e la sua dottrina influenzano masse sterminate di popolo con massime di condotta che si riferiscono anche alle cose più elementari. È vero che il Croce afferma che ormai questi modi di vita non sono più specificatamente cristiani e religiosi, perché «dopo Cristo siamo tutti cristiani», cioè il cristianesimo in ciò che è reale esigenza di vita e non mitologia è stato assorbito dalla civiltà moderna (questo aforisma di Croce ha certo molto di verità: il senatore Mariano D’Amelio, primo presidente di Cassazione, combatte l’obbiezione che i codici occidentali non possono introdursi in paesi non cristiani come il Giappone, la Turchia, ecc., appunto perché sono stati costruiti con molti elementi introdotti dal cristianesimo, ricordando questa «semplice verità» del Croce. Ora realmente i codici occidentali vengono introdotti nei paesi «pagani» come espressione della civiltà europea e non del cristianesimo come tale e i buoni mussulmani non credono di essere diventati cristiani e di aver abiurato l’islamismo).
Q10 §41 V Deve essere criticata l’impostazione che il Croce fa della scienza politica. La politica, secondo il Croce, è l’espressione della «passione». A proposito del Sorel il Croce ha scritto (Cultura e vita morale, 2a ed., p. 158): «Il “sentimento di scissione” non l’aveva garantito (il sindacalismo) abbastanza, forse anche perché una scissione teorizzata è una scissione sorpassata; né il “mito” lo scaldava abbastanza, forse perché il Sorel, nell’atto stesso di crearlo, lo aveva dissipato, dandone la spiegazione dottrinale». Ma il Croce non si è accorto che le osservazioni fatte al Sorel si possono ritorcere contro il Croce stesso: la passione teorizzata non è anch’essa sorpassata? La passione di cui si dà una spiegazione dottrinale, non è anch’essa «dissipata»? Né si dica che la «passione» del Croce sia cosa diversa dal «mito» soreliano, che la passione significhi la categoria, il momento spirituale della pratica, mentre il mito sia una determinata passione che come storicamente determinata può essere sorpassata e dissipata senza che perciò si annichili la categoria che è un momento perenne dello spirito; l’obbiezione è vera nel solo senso che Croce non è Sorel, cosa ovvia e banale. Intanto è da osservare come l’impostazione del Croce sia intellettualistica e illuministica. Poiché neanche il mito concretamente studiato dal Sorel era una cosa di carta, una costruzione arbitraria dell’intelletto soreliano, esso non poteva essere dissipato da qualche paginetta dottrinale, conosciuta da ristretti gruppi di intellettuali, che poi diffondevano la teoria come prova scientifica della verità scientifica del mito quale ingenuamente appassionava le grandi masse popolari.
Se la teoria del Croce fosse reale, la scienza politica dovrebbe essere niente altro che una nuova «Medicina» delle passioni e non è da negare che una gran parte degli articoli politici del Croce sia proprio una intellettualistica e illuministica Medicina delle passioni, così come finisce con l’essere comica la sicurezza del Croce d’aver ammazzato vasti movimenti storici nella realtà perché crede d’averli «sorpassati e dissolti» in idea. Ma in realtà non è neanche vero che il Sorel abbia solo teorizzato e spiegato dottrinalmente un determinato mito: la teoria dei miti è per il Sorel il principio scientifico della scienza politica, è la «passione» del Croce studiata in modo più concreto, è ciò che il Croce chiama «religione» cioè una concezione del mondo con un’etica conforme, è un tentativo di ridurre a linguaggio scientifico la concezione delle ideologie della filosofia della praxis vista attraverso appunto il revisionismo crociano. In questo studio del mito come sostanza dell’azione politica, il Sorel ha anche studiato diffusamente il mito determinato che era alla base di una certa realtà sociale e ne era la molla di progresso. La sua trattazione ha perciò due aspetti: uno propriamente teorico, di scienza politica e un aspetto politico immediato, programmatico. È possibile, sebbene sia molto discutibile, che l’aspetto politico e programmatico del sorelismo sia stato sorpassato e dissipato; oggi si può dire che esso è stato superato nel senso che è stato integrato e depurato di tutti gli elementi intellettualistici e letterari, ma anche oggi occorre riconoscere che il Sorel aveva lavorato sulla realtà effettuale e che tale realtà non è stata sorpassata e dissipata.
Che il Croce non sia uscito da queste contraddizioni e che in parte ne abbia coscienza, si capisce dal suo atteggiamento verso i «partiti politici» quale appare dal capitolo «Il partito come giudizio e come pregiudizio» del volume Cultura e vita morale e da ciò che dei partiti si dice negli Elementi di politica, quest’ultimo ancor più significativo. Il Croce riduce l’atto politico all’attività dei singoli «capipartito» che per soddisfare la loro passione si costruiscono, nei partiti, gli strumenti adatti al trionfo (sicché la medicina delle passioni basterebbe propinarla a pochi individui). Ma anche ciò spiega nulla. Si tratta di questo: i partiti sono sempre esistiti, permanentemente, anche se con altre forme ed altri nomi, ed una passione permanente è un controsenso (solo per metafora si parla di pazzi ragionanti ecc.), ed ancor di più è sempre esistita una organizzazione permanentemente militare, la quale educa a compiere a sangue freddo, senza passione l’atto pratico più estremo, l’uccisione di altri uomini che non sono singolarmente odiati dai singoli ecc. D’altronde l’esercito è l’attore politico per eccellenza anche in tempo di pace: come mettere d’accordo la passione con la permanenza, con l’ordine e la disciplina sistematica ecc.? La volontà politica deve avere qualche altra molla oltre la passione, una molla di carattere anch’essa permanente, ordinata, disciplinata ecc. Non è detto che la lotta politica, come la lotta militare, si risolvano sempre sanguinosamente, con sacrifizi personali che giungono fino al sacrifizio supremo della vita. La diplomazia è appunto quella forma di lotta politica internazionale (e non è detto che non esista una diplomazia anche per le lotte nazionali fra partiti) che influisce per ottenere vittorie (che non sono sempre di poco momento) senza spargimento di sangue, senza guerra. Il solo paragone «astratto» fra le forze militari e politiche (alleanze ecc.) di due Stati rivali, convince il più debole a fare delle concessioni. Ecco un caso di «passione» ammaestrata e ragionevole. Nel caso dei capi e dei gregari, avviene che i capi e i gruppi dirigenti suscitano le passioni delle folle artatamente e le conducono alla lotta e alla guerra, ma in questo caso non la passione è causa e sostanza della politica ma la condotta dei capi che si mantengono freddamente ragionatori. L’ultima guerra ha poi mostrato che non la passione manteneva le masse militari in trincea, ma o il terrore dei tribunali militari o un senso del dovere freddamente ragionato e riflessivo.
Q10 §41 VI La teoria del valore come paragone ellittico. Oltre all’obbiezione che la teoria del valore ha la sua origine nel Ricardo, che certamente non intendeva fare un paragone ellittico nel senso che pensa il Croce, è da aggiungere qualche altra serie di ragionamenti. Era arbitraria la teoria del Ricardo ed è arbitraria la soluzione più precisa dell’economia critica? E in che punto del ragionamento starebbe l’arbitrio o il sofisma? Bisognerebbe studiare bene la teoria di Ricardo e specialmente la teoria di Ricardo sullo Stato come agente economico, come la forza che tutela il diritto di proprietà, cioè il monopolio dei mezzi di produzione. È certo che lo Stato ut sic non produce la situazione economica ma è l’espressione della situazione economica, tuttavia si può parlare dello Stato come agente economico in quanto appunto lo Stato è sinonimo di tale situazione. Se si studia infatti l’ipotesi economica pura, come Ricardo intendeva fare, non occorre prescindere da questa situazione di forza rappresentata dagli Stati e dal monopolio legale della proprietà? Che la quistione non sia oziosa è dimostrato dai cambiamenti apportati nella situazione di forza esistente nella società civile dalla nascita delle Trade‑Unions, quantunque lo Stato non abbia mutato di natura. Non si trattava dunque per nulla di un paragone ellittico, fatto in vista di una futura forma sociale diversa da quella studiata, ma di una teoria risultante dalla riduzione della società economica alla pura «economicità» cioè al massimo di determinazione del «libero gioco delle forze economiche», in cui essendo l’ipotesi quella dell’homo oeconomicus, non poteva non prescindersi dalla forza data dall’insieme di una classe organizzata nello Stato, di una classe che aveva nel Parlamento la sua Trade‑Union, mentre i salariati non potevano coalizzarsi e far valere la forza data dalla collettività a ogni singolo individuo. Ricardo, come del resto gli altri economisti classici, erano estremamente spregiudicati e la teoria ricardiana del valore‑lavoro non sollevò nessuno scandalo quando fu espressa (cfr la Storia delle dottrine economiche di Gide e Rist) perché allora non rappresentava nessun pericolo, appariva solo, come era, una constatazione puramente oggettiva e scientifica. Il valore polemico e di educazione morale e politica, pur senza perdere la sua oggettività, doveva acquistarla solo con la Economia critica. Il problema è poi legato al problema fondamentale della scienza economica «pura», cioè alla identificazione di quello che deve essere il concetto e il fatto storicamente determinato, indipendente dagli altri concetti e fatti pertinenti alle altre scienze: il fatto determinato della scienza economica moderna non può essere che quello di merce, di produzione e distribuzione di merci e non un concetto filosofico come vorrebbe il Croce per il quale anche l’amore è un fatto economico e tutta la «natura» è ridotta al concetto di economia.
Sarebbe ancora da notare che, se si vuole, tutto il linguaggio è una serie di paragoni ellittici, che la storia è un paragone implicito tra il passato e il presente (l’attualità storica) o tra due momenti distinti dello svolgimento storico. E perché l’ellissi è illecita se il paragone avviene con un’ipotesi avvenire, mentre sarebbe lecita se il paragone è fatto con un fatto passato (il quale in tal caso è assunto proprio come ipotesi, come punto di riferimento utile per meglio comprendere il presente)? Lo stesso Croce, parlando delle previsioni, sostiene che la previsione non è altro che uno speciale giudizio sull’attualità che sola si conosce, poiché non si può conoscere l’avvenire per definizione poiché esso non esiste e non è esistito e non si può conoscere l’inesistente (cfr Conversazioni Critiche, Serie prima, pp. 150‑153). Si ha l’impressione che il ragionamento del Croce sia piuttosto da letterato e da costruttore di frasi ad effetto.
Q10 §41 VII Sulla caduta tendenziale del saggio del profitto. Questa legge dovrebbe essere studiata sulla base del taylorismo e del fordismo. Non sono questi due metodi di produzione e di lavoro dei tentativi progressivi di superare la legge tendenziale, eludendola col moltiplicare le variabili nelle condizioni dell’aumento progressivo del capitale costante? Le variabili sono queste (tra le più importanti, ma dai libri del Ford si potrebbe costruire un registro completo e molto interessante): 1) le macchine continuamente introdotte sono più perfette e raffinate; 2) i metalli più resistenti e di durata maggiore; 3) si crea un tipo nuovo di operaio monopolizzato con gli alti salari; 4) diminuzione dello scarto nel materiale di fabbricazione; 5) utilizzazione sempre più vasta di sempre più numerosi sottoprodotti, cioè risparmio di scarti che prima erano necessari e che è stato reso possibile dalla grande ampiezza delle imprese; 6) utilizzazione dello scarto di energie caloriche: per esempio il calore degli alti forni che prima si disperdeva nell’atmosfera viene immesso in tubatura e riscalda gli ambienti d’abitazione, ecc. (La selezione di un nuovo tipo di operaio rende possibile, attraverso la razionalizzazione taylorizzata dei movimenti, una produzione relativa e assoluta più grande di quella precedente con la stessa forza di lavoro). Con ognuna di queste innovazioni l’industriale passa da un periodo di costi crescenti (cioè di caduta del saggio del profitto) a un periodo di costi decrescenti, in quanto viene a godere di un monopolio di iniziativa che può durare abbastanza a lungo (relativamente). Il monopolio dura a lungo anche a causa degli alti salari che tali industrie progressive «devono» dare, se vogliono formare una maestranza selezionata e se vogliono contendere ai concorrenti gli operai più predisposti, dal punto di vista psicotecnico, alle nuove forme di produzione e di lavoro (ricordare il fatto simile del senatore Agnelli che, per assorbire nella Fiat le altre imprese automobilistiche, bloccò tutti gli operai battilastra della piazza con gli alti salari; le fabbriche, private così dei loro reparti specializzati per la produzione dei parafanghi, cercarono di resistere tentando di fabbricare parafanghi di legno compensato, ma l’innovazione fallì e dovettero capitolare). L’estensione dei nuovi metodi determina una serie di crisi, ognuna delle quali ripropone gli stessi problemi dei costi crescenti e il cui ciclo si può immaginare ricorrente finché: 1) non si sia raggiunto il limite estremo di resistenza del materiale; 2) non si sia raggiunto il limite nell’introduzione di nuove macchine automatiche, cioè il rapporto ultimo tra uomini e macchine; 3) non si sia raggiunto il limite di saturazione di industrializzazione mondiale, tenendo conto del saggio di aumento della popolazione (che d’altronde declina con l’estendersi dell’industrialismo) e della produzione per rinnovare la merce d’uso e i beni strumentali. La legge tendenziale della caduta del profitto sarebbe quindi alla base dell’americanismo, cioè sarebbe la causa del ritmo accelerato nel progresso dei metodi di lavoro e di produzione e di modificazione del tipo tradizionale dell’operaio.
Q10 §41 VIII Il punto più importante in cui il Croce riassume le critiche, secondo lui decisive e che avrebbero rappresentato un’epoca storica, è la Storia d’Italia dal 1871 al 1915 nel capitolo in cui accenna alla fortuna della filosofia della praxis e dell’economia critica. Nella prefazione alla seconda edizione del volume MSEM egli fissa in quattro le tesi principali del suo revisionismo: la prima che la filosofia della praxis debba valere come semplice canone di interpretazione, e la seconda che la teoria del valore‑lavoro sia niente altro che il risultato di un paragone ellittico tra due tipi di società, egli afferma essere «state generalmente accolte», «sono divenute usuali, e si odono ormai ripetere quasi senza che si ricordi chi le ha messe pel primo in circolazione». La terza tesi, critica della legge circa la caduta del saggio del profitto («legge che, se fosse esattamente stabilita, ... importerebbe né più né meno che la fine automatica e imminente (!?) della società capitalistica») «è forse più dura ad accettare»; ma il Croce si allieta dell’adesione dell’«economista e filosofo» Ch. Andler (nelle s critiques de science sociale, Parigi, anno I, n. 5, 10 marzo 1900, p. 77). La quarta tesi, quella di un’economia filosofica, «è offerta più propriamente alla meditazione dei filosofi» e il Croce rimanda al suo futuro volume sulla pratica. Per i rapporti tra filosofia della praxis e lo hegelismo rimanda al suo saggio sullo Hegel.
Nella «Conclusione» al suo saggio Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti (MSEM, pp. 55‑113, la conclusione è a pp. 110‑113) il Croce riassume in quattro punti i risultati positivi della sua indagine: 1) Sotto il rispetto della scienza economica, la giustificazione dell’economia critica, intesa non in quanto scienza economica generale, ma in quanto economia sociologica comparativa, che tratta delle condizioni del lavoro nelle società; 2) Sotto il rispetto della scienza della storia, la liberazione della filosofia della praxis da ogni concetto aprioristico (sia esso eredità hegeliana o contagio di volgare evoluzionismo), e l’intendimento della dottrina come fecondo bensì, ma semplice canone d’interpretazione storica; 3) Sotto il rispetto pratico l’impossibilità di dedurre il programma sociale del movimento (come anche ogni altro programma sociale) da proposizioni di pura scienza, dovendosi portare il giudizio dei programmi sociali nel campo dell’osservazione empirica e delle pratiche persuasioni; 4) Sotto il rispetto etico, la negazione della intrinseca amoralità o dell’intrinseca antieticità della filosofia della praxis. (Sarà utile ricavare altri punti di discussione e di critica da tutti gli scritti del Croce sull’argomento, riassumendoli attentamente con tutti i richiami bibliografici del caso, pur mantenendo un posto speciale a questi punti che dal Croce stesso sono indicati come quelli che maggiormente hanno attratto il suo interesse e la sua riflessione più metodica e sistematica).
Q10 §41 IX Per comprendere meglio la teoria crociana esposta nella relazione al Congresso di Oxford su «Storia e Antistoria» (e che in altro punto è stata riavvicinata alla discussione svolta dalla generazione passata sul punto della possibilità dei «salti» nella storia e nella natura) occorre studiare lo studio del Croce Interpretazione storica delle proposizioni filosofiche nel quale oltre l’argomento da cui deriva il titolo, di per sé molto interessante e che non è dal Croce osservato nella sua polemica ultima contro la filosofia della praxis, è contenuta una interpretazione restrittiva e capziosa della proposizione hegeliana: «ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale», appunto nel senso dell’antistoria.
Q10 §41 X L’importanza che hanno avuto il machiavellismo e l’antimachiavellismo in Italia per lo sviluppo della scienza politica e il significato che in questo svolgimento hanno avuto recentemente la proposizione del Croce sull’autonomia del momento politico‑economico e le pagine dedicate al Machiavelli. Si può dire che il Croce non sarebbe giunto a questo risultato senza l’apporto culturale della filosofia della praxis? È da ricordare in proposito che il Croce ha scritto di non poter capire come mai nessuno abbia pensato di svolgere il concetto che il fondatore della filosofia della praxis ha compiuto, per un gruppo sociale moderno, la stessa opera compiuta dal Machiavelli al suo tempo. Da questo paragone del Croce si potrebbe dedurre tutta l’ingiustizia dell’attuale suo atteggiamento culturale, anche perché il fondatore della filosofia della praxis ha avuto interessi molto più vasti del Machiavelli e dello stesso Botero (che per il Croce integra Machiavelli nello svolgimento della scienza politica, sebbene ciò non sia molto esatto, se del Machiavelli non si considera solo il Principe ma anche i Discorsi) non solo, ma in lui è contenuto in nuce anche l’aspetto etico‑politico della politica o la teoria dell’egemonia e del consenso, oltre all’aspetto della forza e dell’economia.
La quistione è questa: dato il principio crociano della dialettica dei distinti (che è da criticare come soluzione puramente verbale di una reale esigenza metodologica, in quanto è vero che non esistono solo gli opposti, ma anche i distinti) quale rapporto che non sia quello di «implicazione nell’unità dello spirito» esisterà tra il momento economico‑politico e le altre attività storiche? È possibile una soluzione speculativa di questi problemi, o solo una soluzione storica, data dal concetto di «blocco storico» presupposto dal Sorel? Intanto si può dire che mentre l’ossessione politico‑economica (pratica, didascalica) distrugge l’arte, la morale, la filosofia, invece queste attività sono anche «politica». Cioè la passione economico‑politica è distruttiva quando è esteriore imposta con la forza, secondo un piano prestabilito (e anche che sia così può essere necessario politicamente e si hanno periodi in cui l’arte, la filosofia ecc. s’addormentano, mentre l’attività pratica è sempre vivace) ma può diventare implicita nell’arte ecc. quando il processo è normale, non violento, quando tra struttura e superstrutture c’è omogeneità e lo Stato ha superato la sua fase economico‑corporativa. Lo stesso Croce (nel volume Etica e politica) accenna a queste diverse fasi, una di violenza, di miseria, di lotta accanita, di cui non si può fare storia etico-politica (nel suo senso ristretto) e una di espansione culturale che sarebbe la «vera» storia.
Nei suoi due recenti libri: Storia d’Italia e Storia d’Europa sono precisamente omessi i momenti della forza, della lotta, della miseria e la storia comincia in una dopo il 1870 e nell’altra dal 1815. Secondo questi criteri schematici si può dire che lo stesso Croce riconosce implicitamente la priorità del fatto economico, cioè della struttura come punto di riferimento e di impulso dialettico per le superstrutture, ossia i «momenti distinti dello spirito». Il punto della filosofia crociana su cui occorre insistere pare appunto debba essere la così detta dialettica dei distinti.
C’è una esigenza reale nel distinguere gli opposti dai distinti, ma c’è anche una contraddizione in termini, perché dialettica si ha solo degli opposti. Vedere le obbiezioni non verbalistiche presentate dai gentiliani a questa teoria crociana e risalire allo Hegel? È da vedere se il movimento da Hegel a Croce‑Gentile non sia stato un passo indietro, una riforma «reazionaria». Non hanno essi reso più astratto Hegel? Non ne hanno tagliato via la parte più realistica, più storicistica? e non è invece proprio di questa parte che solo la filosofia della praxis, in certi limiti, è una riforma e un superamento? E non è stato proprio l’insieme della filosofia della praxis a far deviare in questo senso il Croce e il Gentile, sebbene essi di questa filosofia si siano serviti per dottrine particolari? (cioè per ragioni implicitamente politiche?) Tra Croce‑Gentile ed Hegel si è formato un anello tradizione Vico‑Spaventa‑(Gioberti). Ma ciò non significò un passo indietro rispetto ad Hegel?
Hegel non può essere pensato senza la Rivoluzione francese e Napoleone con le sue guerre, senza cioè le esperienze vitali e immediate di un periodo storico intensissimo di lotte, di miserie, quando il mondo esterno schiaccia l’individuo e gli fa toccare la terra, lo appiattisce contro la terra, quando tutte le filosofie passate furono criticate dalla realtà in modo così perentorio? Cosa di simile potevano dare Vico e Spaventa? (Anche Spaventa che partecipò a fatti storici di portata regionale e provinciale, in confronto a quelli dall’89 al 1815 che sconvolsero tutto il mondo civile d’allora e costrinsero a pensare «mondialmente»? Che misero in movimento la «totalità» sociale, tutto il genere umano concepibile, tutto lo «spirito»? Ecco perché Napoleone può apparire ad Hegel lo «spirito del mondo» a cavallo!) A quale movimento storico di grande portata partecipa il Vico? Quantunque la sua genialità consista appunto nell’aver concepito un vasto mondo da un angoletto morto della «storia» aiutato dalla concezione unitaria e cosmopolita del cattolicismo... In ciò la differenza essenziale tra Vico ed Hegel, tra dio e la provvidenza e Napoleone ‑ spirito del mondo, tra una astrazione remota e la storia della filosofia concepita come sola filosofia, che porterà all’identificazione sia pure speculativa tra storia e filosofia, del fare e del pensare, fino al proletariato tedesco come solo erede della filosofia classica tedesca.
Q10 §41 XI La biografia politico‑intellettuale del Croce non è raccolta tutta nel Contributo alla critica di me stesso. Per ciò che riguarda i suoi rapporti con la filosofia della praxis, molti elementi e spunti essenziali sono disseminati in tutte le opere. Nel volume Cultura e vita morale (2a ed., p. 45, ma anche in altre pagine, come quelle in cui si spiega l’origine delle sue simpatie per il Sorel) egli afferma che, nonostante le sue tendenze naturaliter democratiche (poiché il filosofo non può non essere democratico), il suo stomaco si rifiutò di digerire la democrazia, finché essa non prese qualche condimento di filosofia della praxis, la quale, «cosa notissima, è imbevuta di filosofia classica tedesca». Durante la guerra egli afferma che questa è proprio la guerra della filosofia della praxis (cfr l’intervista col Croce del De Ruggiero riportata nella «Révue de métaphysique et de morale», le Pagine di guerra, e l’introduzione del 1917 al MSEM.
Q10 §41 XII Uno dei punti che più interessa di esaminare ed approfondire è la dottrina crociana delle ideologie politiche. Non basta perciò leggere gli Elementi di politica con l’appendice, ma occorre ricercare le recensioni pubblicate nella «Critica» (tra le altre quella all’opuscolo del Malagodi sulle Ideologie politiche di cui un capitolo era dedicato al Croce; questi scritti sparsi forse saranno raccolti nel 3° e 4° volume delle Conversazioni Critiche).
Il Croce dopo aver sostenuto nel MSEM che la filosofia della praxis non era che un modo di dire e che bene aveva fatto il Lange a non parlarne nella sua storia del materialismo (sui rapporti tra il Lange e la filosofia della praxis, che furono molto oscillanti e incerti è da vedere il saggio di R. D’Ambrosio La dialettica nella natura nella «Nuova Rivista Storica», volume del 1932, pp. 223‑52) a un certo punto ha mutato idea radicalmente e ha fatto perno della sua nuova revisione proprio la definizione costruita dal prof. Stammler sul Lange e che il Croce stesso nel MSEM (IV ed., p. 118) così riferisce: «Come il materialismo filosofico non consiste nell’affermare che i fatti corporali abbiano efficacia sugli spirituali, ma nel far di questi una mera apparenza, irreale, di quelli; così la “filosofia della praxis” deve consistere nell’affermare che l’economia è la vera realtà e il diritto è l’ingannevole apparenza».
Adesso anche per il Croce le superstrutture sono mere apparenze e illusioni, ma è poi ragionata questa mutazione del Croce e specialmente corrisponde alla sua attività di filosofo? La dottrina del Croce sulle ideologie politiche è di evidentissima derivazione dalla filosofia della praxis: esse sono costruzioni pratiche, strumenti di direzione politica, cioè si potrebbe dire, le ideologie sono per i governati delle mere illusioni, un inganno subito, mentre sono per i governanti un inganno voluto e consapevole. Per la filosofia della praxis le ideologie sono tutt’altro che arbitrarie; esse sono fatti storici reali, che occorre combattere e svelare nella loro natura di strumenti di dominio non per ragioni di moralità ecc. ma proprio per ragioni di lotta politica: per rendere intellettualmente indipendenti i governati dai governanti, per distruggere un’egemonia e crearne un’altra, come momento necessario del rovesciamento della praxis. Pare che all’interpretazione materialistica volgare si avvicini più il Croce che la filosofia della praxis.
Per la filosofia della praxis le superstrutture sono una realtà (o lo diventano, quando non sono pure elucubrazioni individuali) oggettiva ed operante; essa afferma esplicitamente che gli uomini prendono conoscenza della loro posizione sociale e quindi dei loro compiti sul terreno delle ideologie, ciò che non è piccola affermazione di realtà; la stessa filosofia della praxis è una superstruttura, è il terreno in cui determinati gruppi sociali prendono coscienza del proprio essere sociale, della propria forza, dei propri compiti, del proprio divenire. In questo senso è giusta l’affermazione dello stesso Croce (MSEM, IV ed., p. 118) che la filosofia della praxis «è storia fatta o in fieri». C’è però una differenza fondamentale tra la filosofia della praxis e le altre filosofie: le altre ideologie sono creazioni inorganiche perché contraddittorie, perché dirette a conciliare interessi opposti e contraddittori; la loro «storicità» sarà breve perché la contraddizione affiora dopo ogni avvenimento di cui sono state strumento. La filosofia della praxis invece non tende a risolvere pacificamente le contraddizioni esistenti nella storia e nella società, anzi è la stessa teoria di tali contraddizioni; non è lo strumento di governo di gruppi dominanti per avere il consenso ed esercitare l’egemonia su classi subalterne; è l’espressione di queste classi subalterne che vogliono educare se stesse all’arte di governo e che hanno interesse a conoscere tutte le verità, anche le sgradevoli e ad evitare gli inganni (impossibili) della classe superiore e tanto più di se stesse. La critica delle ideologie, nella filosofia della praxis, investe il complesso delle superstrutture e afferma la loro caducità rapida in quanto tendono a nascondere la realtà, cioè la lotta e la contraddizione, anche quando sono «formalmente» dialettiche (come il crocismo) cioè spiegano una dialettica speculativa e concettuale e non vedono la dialettica nello stesso divenire storico.
Si veda un aspetto della posizione del Croce che nella prefazione del 1917 al MSEM scrive che al fondatore della filosofia della praxis «serberemo ... altresì la nostra gratitudine per aver conferito a renderci insensibili alle alcinesche seduzioni ... della Dea Giustizia e della Dea Umanità»: e perché no della Dea Libertà? Anzi la Libertà è stata dal Croce deificata ed egli è diventato il pontefice di una religione della Libertà. È da notare che il significato di ideologia non è lo stesso in Croce e nella filosofia della praxis. In Croce il significato è ristretto in modo un po’ indefinibile, sebbene per il suo concetto di «storicità» anche la filosofia acquisti il valore di una ideologia. Si può dire che per il Croce ci siano tre gradi di libertà: il liberismo economico e il liberalismo politico che non sono né la scienza economica né la scienza politica (sebbene per il liberalismo politico il Croce sia meno esplicito) ma appunto «ideologie politiche» immediate; la religione della libertà; l’idealismo. Anche la religione della libertà essendo, come ogni concezione del mondo necessariamente connessa con un’etica conforme, non dovrebbe essere scienza ma ideologia. Scienza pura sarebbe solo l’idealismo, poiché il Croce afferma che tutti i filosofi, in quanto tali, non possono non essere idealisti, nolenti o volenti.
Il concetto del valore concreto (storico) delle superstrutture nella filosofia della praxis deve essere approfondito accostandolo al soreliano concetto di «blocco storico». Se gli uomini acquistano coscienza della loro posizione sociale e dei loro compiti nel terreno delle superstrutture, ciò significa che tra struttura e superstruttura esiste un nesso necessario e vitale. Bisognerebbe studiare contro quali correnti storiografiche la filosofia della praxis ha reagito nel momento della sua fondazione e quali erano le opinioni più diffuse in quel tempo anche riguardo alle altre scienze. Le stesse immagini e metafore cui ricorrono spesso i fondatori della filosofia della praxis danno indizi in proposito: l’affermazione che l’economia è per la società ciò che l’anatomia nelle scienze biologiche; ed è da ricordare la lotta che nelle scienze naturali è avvenuta per scacciare dal terreno scientifico principi di classificazione basati su elementi esteriori e labili. Se gli animali fossero classificati dal colore della pelle, o del pelo o delle piume, tutti oggi protesterebbero. Nel corpo umano non si può certo dire che la pelle (e anche il tipo di bellezza fisica storicamente prevalente) siano mere illusioni e che lo scheletro e l’anatomia siano la sola realtà, tuttavia per molto tempo si è detto qualcosa di simile. Mettendo in valore l’anatomia e la funzione dello scheletro nessuno ha voluto affermare che l’uomo (e tanto meno la donna) possano vivere senza di essa. Continuando nella metafora si può dire che non è lo scheletro (in senso stretto) che fa innamorare di una donna, ma che tuttavia si comprende quanto lo scheletro contribuisca alla grazia dei movimenti ecc. ecc.
Un altro elemento contenuto nella prefazione del Zur Kritik è certo da connettere con la riforma della legislazione processuale e penale. È detto nella prefazione che come non si giudica un individuo da ciò che esso pensa di se stesso, così non si può giudicare una società dalle ideologie. Si può forse dire che questa affermazione è connessa con la riforma per cui nei giudizi penali le prove testimoniali e materiali hanno finito col sostituire le affermazioni dell’imputato con relativa tortura ecc.
Accennando alle così dette leggi naturali e al concetto di natura (diritto di natura, stato di natura ecc.) «che sorto nella filosofia del secolo decimosettimo, fu dominante nel decimottavo» il Croce (p. 93 del MSEM) accenna che «simile concezione è colpita in verità solo di sbieco dalla critica del Marx, il quale, analizzando il concetto di natura, mostrava com’esso fosse il complemento ideologico dello svolgimento storico della borghesia, un’arma potentissima di cui questa si valse contro i privilegi e le oppressioni, che mirava ad abbattere». L’accenno serve al Croce per l’affermazione metodica seguente: «Quel concetto potrebbe essere sorto come strumento per un fine pratico e occasionale ed essere nondimeno intrinsecamente vero. “Leggi naturali” equivale, in quel caso, a “leggi razionali”; e la razionalità e l’eccellenza di esse leggi occorre negare. Ora appunto per essere di origine metafisica, quel concetto si può rigettare radicalmente, ma non si può confutare in particolare. Esso tramonta con la metafisica di cui faceva parte; e pare ormai che sia tramontato davvero. Sia pace alla “gran bontà” delle leggi naturali». Il brano non è molto chiaro e perspicuo nel suo complesso. È da riflettere sul fatto che in generale (cioè talvolta) un concetto può sorgere come strumento per un fine pratico e occasionale ed essere nondimeno intrinsecamente vero. Ma non credo che siano molti a sostenere che mutatasi una struttura, tutti gli elementi della corrispondente soprastruttura debbano necessariamente cadere. Avviene anzi che di una ideologia sorta per guidare le masse popolari e che pertanto non può non tener conto di alcuni loro interessi, sopravvivano più elementi: lo stesso diritto di natura, se è tramontato per le classi colte, è conservato dalla religione cattolica ed è vivace nel popolo, più di quanto si creda. D’altronde nella critica del fondatore della filosofia della praxis si affermava la storicità del concetto, la sua caducità, e il suo valore intrinseco era limitato a tale storicità ma non negato.
Nota I. I fenomeni della moderna decomposizione del parlamentarismo possono offrire molti esempi sulla funzione e il valore concreto delle ideologie. Come questa decomposizione viene presentata per nascondere le tendenze reazionarie di certi gruppi sociali è del più alto interesse. Su questi argomenti sono state scritte molte sparse in vari quaderni (per es. sulla quistione della crisi del principio d’autorità ecc.) che raccolte insieme sono da rimandare a queste sul Croce.
Q10 §41 XIII In un articolo su Clemenceau pubblicato nella «Nuova Antologia» del 16 dicembre 1929 e in un altro pubblicato nell’«Italia Letteraria» il 15 dicembre (il primo firmato «Spectator», il secondo col nome e cognome), Mario Missiroli riproduce due importanti brani di lettere inviategli dal Sorel e riguardanti Clemenceau (nella Nuova Antologia i due brani sono stampati come un tutto organico; nell’«Italia Letteraria» invece come distinti e tra il primo e il secondo il Missiroli intercala un «altrove», ciò che fa meglio comprendere stilisticamente il contesto): 1) «Egli (Clemenceau) giudica la filosofia di Marx, che costituisce l’ossatura del socialismo contemporaneo, come una dottrina oscura, buona per i barbari di Germania, come sempre è apparsa alle intelligenze pronte e brillanti, abituate alle facili letture. Spiriti leggeri come il suo non riescono a capire ciò che Renan capiva così bene, che, cioè, valori storici di grande importanza possono apparire congiunti con una produzione letteraria di evidente mediocrità, quale è appunto la letteratura socialista offerta al popolo». 2) «Io credo che se Clemenceau ha fatto per lungo tempo poco conto del socialismo, meno ancora dovette farne quando vide Jaurès diventare l’idolo dei partiti socialisti. La faconda oratoria di Jaurès lo inaspriva. Nella sua “estrema leggerezza” – la definizione è di Giuseppe Reinach – giudicò che il socialismo non potesse contenere nulla di serio, dal momento che un professore di università, riconosciuto capo della nuova dottrina, non riusciva a ricavarne che vento.
Non si curava di sapere se le masse, una volta scosse dalle vacue declamazioni dei capi, non avrebbero saputo trovare nel loro seno dei direttori capaci di condurle verso delle regioni che i capi della democrazia non potevano neppure sospettare. Clemenceau non crede all’esistenza di una classe che si travaglia a formarsi la coscienza di una grande missione storica da compiere, missione che ha per iscopo il rinnovamento totale della nostra civiltà. Crede che il dovere delle democrazie sia quello di venire in soccorso dei diseredati che assicurano la produzione delle ricchezze materiali, delle quali nessuno può fare a meno. Nei momenti difficili un potere intelligente deve fare delle leggi per imporre ai ricchi dei sacrifici, destinati a salvare la solidarietà nazionale. Un’evoluzione bene ordinata, che conduca ad una vita relativamente dolce, ecco quanto il popolo reclamerebbe in nome della scienza, se avesse dei buoni consiglieri. Ai suoi occhi i socialisti sono dei cattivi pastori quando introducono, nella politica di un paese democratico, la nozione della rivoluzione. Come tutti gli uomini della sua generazione, Clemenceau ha conservato un vivo ricordo della Comune. Credo fermamente che egli non abbia ancora perdonato al popolo di Parigi la brutalità con la quale le guardie nazionali insorte lo cacciarono dal palazzo del Comune di Montmartre».
Q10 §41 XIV Le origini «nazionali» dello storicismo crociano. È da ricercare cosa significa esattamente e come è giustificata in Edgar Quinet la formula dell’equivalenza di rivoluzione‑restaurazione nella storia italiana. Secondo Daniele Mattalia (Gioberti in Carducci nella «Nuova Italia» del 20 novembre 1931) la formula del Quinet sarebbe stata adottata dal Carducci attraverso il concetto giobertiano di «classicità nazionale» (Rinnovamento, ediz. Laterza, III, 88; Primato, ed. Utet, 1, 5, 6, 7,-…). È da vedere se la formula del Quinet può essere avvicinata a quella di «rivoluzione passiva» del Cuoco; esse forse esprimono il fatto storico dell’assenza di una iniziativa popolare unitaria nello svolgimento della storia italiana e l’altro fatto che lo svolgimento si è verificato come reazione delle classi dominanti al sovversivismo sporadico, elementare, disorganico delle masse popolari con «restaurazioni» che hanno accolto una qualche parte delle esigenze dal basso, quindi «restaurazioni progressive» o «rivoluzioni‑restaurazioni» o anche «rivoluzioni passive». Si potrebbe dire che si è sempre trattato di rivoluzioni dell’«uomo del Guicciardini» (nel senso desanctisiano), in cui i dirigenti hanno sempre salvato il loro «particulare»: il Cavour avrebbe appunto «diplomatizzato» la rivoluzione dell’uomo del Guicciardini ed egli stesso si avvicinava come tipo al Guicciardini.
Lo storicismo del Croce sarebbe quindi niente altro che una forma di moderatismo politico, che pone come solo metodo d’azione politica quello in cui il progresso, lo svolgimento storico, risulta dalla dialettica di conservazione e innovazione. Nel linguaggio moderno questa concezione si chiama riformismo. Il contemperamento di conservazione e di innovazione costituisce appunto il «classicismo nazionale» del Gioberti, così come costituisce il classicismo letterario e artistico dell’ultima estetica crociana. Ma questo storicismo da moderati e da riformisti non è per nulla una teoria scientifica, il «vero» storicismo; è solo il riflesso di una tendenza pratico‑politica, una ideologia nel senso deteriore. Infatti perché la «conservazione» deve essere proprio quella data «conservazione», quel dato elemento del passato? E perché si deve essere «irrazionalisti» e «antistoricisti» se non si conserva proprio quel determinato elemento?
In realtà, se è vero che il progresso è dialettica di conservazione e innovazione e l’innovazione conserva il passato superandolo, è anche vero che il passato è cosa complessa, un complesso di vivo e di morto, in cui la scelta non può essere fatta arbitrariamente, a priori, da un individuo o da una corrente politica. Se la scelta è stata fatta in tal modo (sulla carta) non può trattarsi di storicismo ma di un atto di volontà arbitrario, del manifestarsi di una tendenza pratico‑politica, unilaterale, che non può dare fondamento a una scienza, ma solo a una ideologia politica immediata. Ciò che del passato verrà conservato nel processo dialettico non può essere determinato a priori, ma risulterà dal processo stesso, avrà un carattere di necessità storica e non di scelta arbitraria da parte dei così detti scienziati e filosofi. E intanto è da osservare che la forza innovatrice, in quanto essa stessa non è un fatto arbitrario, non può non essere già immanente nel passato, non può non essere in un certo senso essa stessa il passato, un elemento del passato, ciò che del passato è vivo e in isviluppo, è essa stessa conservazione‑innovazione, contiene in sé l’intero passato, degno di svolgersi e perpetuarsi. Per questa specie di storicisti moderati (e si intende moderati in senso politico, di classe, cioè di quelle classi che operarono nella restaurazione dopo il 1815 e il 1848) irrazionale era il giacobinismo, antistoria era uguale a giacobinismo. Ma chi potrà mai provare storicamente che i giacobini siano stati guidati solo dall’arbitrio? E non è ormai una proposizione storica banale che né Napoleone né la Restaurazione hanno distrutto i «fatti compiuti» dai giacobini? O forse l’antistoricismo dei giacobini sarà consistito in ciò che delle loro iniziative non si è «conservato» il 100%, ma solo una certa percentuale? Non pare che ciò sia plausibile da sostenersi, perché la storia non si ricostruisce con calcoli matematici e d’altronde nessuna forza innovatrice si realizza immediatamente, ma appunto è sempre razionalità e irrazionalità, arbitrio e necessità, è «vita», cioè, con tutte le debolezze e le forze della vita, con le sue contraddizioni e le sue antitesi.
Fissare bene questo rapporto dello storicismo del Croce con la tradizione moderata del Risorgimento e col pensiero reazionario della Restaurazione. Osservare come la sua concezione della «dialettica» hegeliana abbia privato questa di ogni vigore e di ogni grandezza, rendendola una quistione scolastica di parole. Il Croce ripete oggi la funzione del Gioberti e a questi si applica la critica contenuta nella Miseria della filosofia sul modo di non comprendere l’hegelismo. E tuttavia questo dello «storicismo» è uno dei punti e dei motivi permanenti in tutta l’attività intellettuale e filosofica del Croce e una delle ragioni della fortuna e dell’influsso esercitato dalla sua attività da trent’anni. In realtà il Croce si inserisce nella tradizione culturale del nuovo Stato italiano e riporta la cultura nazionale alle origini sprovincializzandola e depurandola di tutte le scorie magniloquenti e bizzarre del Risorgimento. Stabilire con esattezza il significato storico e politico dello storicismo crociano significa appunto ridurlo alla sua reale portata di ideologia politica immediata, spogliandolo della grandezza brillante che gli viene attribuita come di manifestazione di una scienza obbiettiva, di un pensiero sereno e imparziale che si colloca al di sopra di tutte le miserie e le contingenze della lotta quotidiana, di una disinteressata contemplazione dell’eterno divenire della storia umana.
Q10 §41 XV Esaminare, ancora, il principio crociano (o accettato e svolto dal Croce) del «carattere volitivo dell’affermazione teoretica» (a questo proposito cfr il capitolo «La libertà di coscienza e di scienza» nel volume Cultura e Vita morale, 2a ediz., pp. 95 sgg.).
Q10 §41 XVI È da vedere se, a suo modo, lo storicismo crociano non sia una forma, abilmente mascherata, di storia a disegno, come tutte le concezioni liberali riformistiche. Se si può affermare, genericamente, che la sintesi conserva ciò che è vitale ancora della tesi, superata dall’antitesi, non si può affermare, senza arbitrio, ciò che sarà conservato, ciò che a priori si ritiene vitale, senza cadere nell’ideologismo, senza cadere nella concezione di una storia a disegno. Che cosa il Croce ritiene che della tesi sia da conservare, perché vitale? Non essendo che raramente un politico pratico, il Croce si guarda bene da ogni enumerazione di istituti pratici e di concezioni programmatiche, da affermare «intangibili», ma tuttavia essi possono essere dedotti dall’insieme della sua opera. Ma se anche ciò non fosse fattibile, rimarrebbe sempre l’affermazione che è «vitale» e intangibile la forma liberale dello Stato, la forma cioè che garantisce a ogni forza politica di muoversi e di lottare liberamente.
Ma come può confondersi questo fatto empirico col concetto di libertà, cioè di storia? Come domandare che le forze in lotta «moderino» la lotta entro certi limiti (i limiti della conservazione dello Stato liberale) senza cadere in arbitrio e nel disegno preconcetto? Nella lotta «i colpi non si danno a patti» e ogni antitesi deve necessariamente porsi come radicale antagonista della tesi, fino a proporsi di distruggerla completamente e completamente sostituirla. Concepire lo svolgimento storico come un gioco sportivo col suo arbitro e le sue norme prestabilite da rispettare lealmente, è una forma di storia a disegno, in cui l’ideologia non si fonda sul «contenuto» politico ma sulla forma e sul metodo della lotta.
È un’ideologia che tende a snervare l’antitesi, a spezzettarla in una lunga serie di momenti, cioè a ridurre la dialettica a un processo di evoluzione riformistica «rivoluzione-restaurazione», in cui solo il secondo termine è valido, poiché si tratta di rabberciare continuamente dall’esterno un organismo che non possiede internamente la propria ragion di salute. Del resto si potrebbe dire che un simile atteggiamento riformistico è un’«astuzia della Provvidenza» per determinare una maturazione più rapida delle forze interne tenute imbrigliate dalla pratica riformistica.
Q10 §42 Appendice. La conoscenza filosofica come atto pratico, di volontà. Si può studiare questo problema specialmente nel Croce, ma in generale nei filosofi idealisti, perché essi insistono specialmente sulla vita intima dell’individuo‑uomo, sui fatti e sull’attività spirituale. Nel Croce per la grande importanza che nel suo sistema ha la teoria dell’arte, l’estetica. Nell’attività spirituale, e per chiarezza d’esempio, nella teoria dell’arte (ma anche nella scienza economica, per cui il punto di partenza per l’impostazione di questo problema può essere il saggio Le due scienze mondane: l’Estetica e l’Economica pubblicato dal Croce nella «Critica» del 20 novembre 1931) le teorie dei filosofi scoprono verità fin allora ignorate, o «inventano», «creano» schemi mentali, nessi logici che mutano la realtà spirituale fin allora esistente, storicamente concreta come cultura diffusa in un gruppo di intellettuali, in una classe, in una civiltà? È questo uno dei tanti modi di porre la quistione della così detta «realtà del mondo esterno» e della realtà senza altro. Esiste una «realtà» esterna al singolo pensatore (il punto di vista del solipsismo può essere utile didascalicamente, le robinsonate filosofiche possono essere altrettanto utili praticamente, se impiegate con discrezione e con garbo, delle robinsonate economiche) sconosciuta (cioè non ancora conosciuta, ma non perciò «inconoscibile», noumenica) in senso storico, e che viene «scoperta» (nel senso etimologico), oppure nel mondo spirituale non si «scopre» niente (cioè non si rivela nulla) ma si «inventa» e si «impone» al mondo della cultura?
Q10 §43 Introduzione allo studio della filosofia. È da vedere, a questo proposito, l’opera di Vincenzo Gioberti, intitolata appunto: Introduzione allo studio della Filosofia, seconda edizione, riveduta e corretta dall’autore, Bruxelles, dalle stampe di Meline, Caus e compagnia, 1844, 4 voll., in‑8°. Non si tratta di un lavoro tecnicamente rivolto a «introdurre» didascalicamente allo studio della filosofia, ma di un lavoro enciclopedico che si propone di «rivoluzionare» un mondo culturale, in tutta la sua complessità, trattando tutti gli argomenti che possono interessare una «cultura» nazionale, una concezione del mondo nazionale. L’opera del Gioberti sarà da studiare proprio da questo punto di vista. Dati i tempi e le circostanze storiche e data la personalità del Gioberti, l’attività filosofica dell’uomo non poteva essere rinchiusa in ischemi da intellettuale professionale: il filosofo e pensatore non poteva essere staccato dall’uomo politico e di partito. Per questo riguardo la personalità storica del Gioberti può essere avvicinata a quella del Mazzini, con le differenze determinate dai diversi fini e dalle diverse forze sociali che rappresentavano i due, che appunto determinavano i fini. Mi pare che il prototipo possa ritrovarsi nel Fichte e nei suoi Discorsi alla nazione tedesca.
Q10 §44 Introduzione allo studio della filosofia. Il linguaggio, le lingue, il senso comune. Posta la filosofia come concezione del mondo e l’operosità filosofica non concepita più solamente come elaborazione «individuale» di concetti sistematicamente coerenti ma inoltre e specialmente come lotta culturale per trasformare la «mentalità» popolare e diffondere le innovazioni filosofiche che si dimostreranno «storicamente vere» nella misura in cui diventeranno concretamente cioè storicamente e socialmente universali, la quistione del linguaggio e delle lingue «tecnicamente» deve essere posta in primo piano. Saranno da rivedere le pubblicazioni in proposito dei pragmatisti. Cfr gli Scritti di G. Vailati (Firenze, 1911), tra i quali lo studio Il linguaggio come ostacolo alla eliminazione di contrasti illusori.
Nel caso dei pragmatisti, come in generale nei confronti di qualsiasi altro tentativo di sistemazione organica della filosofia, non è detto che il riferimento sia alla totalità del sistema o al nucleo essenziale di esso. Mi pare di poter dire che la concezione del linguaggio del Vailati e di altri pragmatisti non sia accettabile: tuttavia pare che essi abbiano sentito delle esigenze reali e le abbiano «descritte» con esattezza approssimativa, anche se non sono riusciti a impostare i problemi e a darne la soluzione. Pare si possa dire che «linguaggio» è essenzialmente un nome collettivo, che non presuppone una cosa «unica» né nel tempo né nello spazio. Linguaggio significa anche cultura e filosofia (sia pure nel grado di senso comune) e pertanto il fatto «linguaggio» è in realtà una molteplicità di fatti più o meno organicamente coerenti e coordinati: al limite si può dire che ogni essere parlante ha un proprio linguaggio personale, cioè un proprio modo di pensare e di sentire. La cultura, nei suoi vari gradi, unifica una maggiore o minore quantità di individui in strati numerosi, più o meno a contatto espressivo, che si capiscono tra loro in gradi diversi ecc. Sono queste differenze e distinzioni storico‑sociali che si riflettono nel linguaggio comune e producono quegli «ostacoli» e quelle «cause di errore» di cui i pragmatisti hanno trattato.
Da questo si deduce l’importanza che ha il «momento culturale» anche nell’attività pratica (collettiva): ogni atto storico non può non essere compiuto dall’«uomo collettivo», cioè presuppone il raggiungimento di una unità «culturale‑sociale» per cui una molteplicità di voleri disgregati, con eterogeneità di fini, si saldano insieme per uno stesso fine, sulla base di una (uguale) e comune concezione del mondo (generale e particolare, transitoriamente operante – per via emozionale – o permanente, per cui la base intellettuale è così radicata, assimilata, vissuta, che può diventare passione). Poiché così avviene, appare l’importanza della quistione linguistica generale, cioè del raggiungimento collettivo di uno stesso «clima» culturale.
Questo problema può e deve essere avvicinato all’impostazione moderna della dottrina e della pratica pedagogica, secondo cui il rapporto tra maestro e scolaro è un rapporto attivo, di relazioni reciproche e pertanto ogni maestro è sempre scolaro e ogni scolaro maestro. Ma il rapporto pedagogico non può essere limitato ai rapporti specificatamente «scolastici», per i quali le nuove generazioni entrano in contatto con le anziane e ne assorbono le esperienze e i valori storicamente necessari «maturando» e sviluppando una propria personalità storicamente e culturalmente superiore. Questo rapporto esiste in tutta la società nel suo complesso e per ogni individuo rispetto ad altri individui, tra ceti intellettuali e non intellettuali, tra governanti e governati, tra élites e seguaci, tra dirigenti e diretti, tra avanguardie e corpi di esercito. Ogni rapporto di «egemonia» è necessariamente un rapporto pedagogico e si verifica non solo nell’interno di una nazione, tra le diverse forze che la compongono, ma nell’intero campo internazionale e mondiale, tra complessi di civiltà nazionali e continentali.
Perciò si può dire che la personalità storica di un filosofo individuale è data anche dal rapporto attivo tra lui e l’ambiente culturale che egli vuole modificare, ambiente che reagisce sul filosofo e, costringendolo a una continua autocritica, funziona da «maestro». Così si è avuto che una delle maggiori rivendicazioni dei moderni ceti intellettuali nel campo politico è stata quella delle così dette «libertà di pensiero e di espressione del pensiero (stampa e associazione)» perché solo dove esiste questa condizione politica si realizza il rapporto di maestro‑discepolo nei sensi più generali su ricordati e in realtà si realizza «storicamente» un nuovo tipo di filosofo che si può chiamare «filosofo democratico», cioè del filosofo convinto che la sua personalità non si limita al proprio individuo fisico, ma è un rapporto sociale attivo di modificazione dell’ambiente culturale. Quando il «pensatore» si accontenta del pensiero proprio, «soggettivamente» libero, cioè astrattamente libero, dà oggi luogo alla beffa: l’unità di scienza e vita è appunto una unità attiva, in cui solo si realizza la libertà di pensiero, è un rapporto maestro-scolaro, filosofo‑ambiente culturale in cui operare, da cui trarre i problemi necessari da impostare e risolvere, cioè è il rapporto filosofia‑storia.
Q10 §45 Punti per un saggio sul Croce. È da confrontare a proposito della Storia d’Europa il saggio di Arrigo Cajumi Dall’Ottocento ad oggi (nella «Cultura» di aprile‑giugno 1932, pp. 323‑50). Il Cajumi si occupa del Croce specificamente nel I paragrafo dei VII che compongono lo studio, ma accenni al Croce (utili) sono contenuti qua e là anche negli altri sei paragrafi che riferiscono di altre pubblicazioni recenti di carattere storico‑politico. Il punto di vista del Cajumi nelle sue critiche e osservazioni è difficile da riassumere in breve: è quello dei principali scrittori della «Cultura», i quali rappresentano un gruppo di intellettuali ben definito nella vita culturale italiana e degni di studio nell’attuale fase della vita nazionale. Si riallacciano al De Lollis, loro maestro, e quindi a certe tendenze della cultura francese più seria e criticamente sostanziosa, ma ciò significa poco, perché il De Lollis non elaborò un metodo critico fecondo di sviluppi e di universalizzazioni. In realtà si tratta di una forma di «erudizione», ma non nel senso più comune e tradizionale del termine. Una erudizione «umanistica», che sviluppa il «buon gusto» e la «ghiottoneria» raffinata; nei collaboratori della «Cultura» ricorrono spesso gli aggettivi «ghiotto», «gustoso».
Il Caiumi, fra i redattori della «Cultura» è quello meno «universitario», nel senso, non che non ci tenga alla «tenuta» universitaria dei suoi scritti e delle sue ricerche, ma nel senso che la sua attività è stata spesso impegnata in imprese «pratiche» e politiche, dal giornalismo militante ad operazioni forse anche più pratiche (come la direzione dell’«Ambrosiano» datagli dal finanziere Gualino non certo solo per «mecenatismo»). Sul Cajumi sono scritte alcune pro memoria in altri quaderni. Su Riccardo Gualino il Cajumi ha scritto una nota molto vivace e pungente nella «Cultura» di gennaio‑marzo 1932 (Confessioni di un figlio del secolo, pp. 193‑95, a proposito del libro del Gualino Frammenti di vita), insistendo appunto sul fatto che il Gualino si serviva del suo «mecenatismo» e delle imprese di cultura per meglio infinocchiare i risparmiatori italiani. Ma anche il cav. Enrico Cajumi (così il Cajumi firmava la gerenza dell’«Ambrosiano») ha raccolto qualche briciola del mecenatismo gualinesco!
Q10 §46 Introduzione allo studio della filosofia. La quistione della «oggettività esterna del reale» in quanto è connessa col concetto della «cosa in sé» e del «noumeno» kantiano. Pare difficile escludere che la «cosa in sé» sia una derivazione dell’«oggettività esterna del reale» e del così detto realismo greco‑cristiano (Aristotele ‑ S. Tomaso) e ciò si vede anche dal fatto che tutta una tendenza del materialismo volgare e del positivismo ha dato luogo alla scuola neokantiana o neo‑critica. Cfr a proposito della kantiana «cosa in sé» ciò che è scritto nella Sacra Famiglia.
Q10 §47 Punti per un saggio su B. Croce. Croce e J. Benda. Si può fare un paragone tra le idee e la posizione assunta da B. Croce e il diluvio di scritti di J. Benda sul problema degli intellettuali (oltre al libro sul Tradimento degli intellettuali del Benda bisognerebbe esaminare gli articoli pubblicati nelle «Nouvelles Littéraires» e forse in altre riviste). In realtà tra il Croce e il Benda, nonostante certe apparenze, l’accordo è solo superficiale o per qualche particolare aspetto della quistione. Nel Croce esiste una costruzione organica di pensiero, una dottrina sullo Stato, sulla religione e sulla funzione degli intellettuali nella vita statale, che non esiste nel Benda, che è più che altro un «giornalista». Bisogna anche dire che la posizione degli intellettuali in Francia e in Italia è molto diversa, organicamente e immediatamente; le preoccupazioni politico‑ideologiche del Croce non sono quelle del Benda anche per questa ragione. Ambedue sono «liberali», ma con tradizioni nazionali e culturali ben diverse.
Croce e il modernismo. È da confrontare, nell’intervista sulla massoneria (Cultura e Vita Morale, II ed.) ciò che il Croce dice del modernismo con quanto scrive A. Omodeo nella «Critica» del 20 luglio 1932 recensendo i tre volumi di Alfred Loisy (Mémoires pour servir à l’histoire religieuse): a p. 291 per es.: «Ai facili alleati acattolici di Pio X, della stessa repubblica anticlericale (e in Italia, il Croce), il Loisy rinfaccia l’ignoranza di ciò che sia il cattolicesimo assolutistico e del pericolo rappresentato da questo impero internazionale in mano al papa; rinfaccia il danno (già rilevato ai suoi tempi dal Quinet) di lasciare ridurre tanta parte dell’umanità a stupido gregge vuoto di pensiero e di vita morale e solo animato da una passiva acquiescenza. Indubbiamente in queste osservazioni v’è molta parte di verità».
Q10 §48 Introduzione allo studio della filosofia.
I. Il senso comune o buon senso. In che consiste esattamente il pregio di quello che suol chiamarsi «senso comune» o «buon senso»? Non solamente nel fatto che, sia pure implicitamente, il senso comune impiega il principio di causalità, ma nel fatto molto più ristretto, che in una serie di giudizi il senso comune identifica la causa esatta, semplice e alla mano, e non si lascia deviare da arzigogolature e astruserie metafisiche, pseudo‑profonde, pseudo‑scientifiche ecc. Il «senso comune» non poteva non essere esaltato nei secoli XVII e XVIII, quando si reagì al principio di autorità rappresentato dalla Bibbia e da Aristotele: si scoprì infatti che nel «senso comune» c’era una certa dose di «sperimentalismo» e di osservazione diretta della realtà, sia pure empirica e limitata. Anche oggi, in rapporti simili, si ha lo stesso giudizio di pregio del senso comune, sebbene la situazione sia mutata e il «senso comune» odierno abbia molta più limitatezza nel suo pregio intrinseco.
II. Progresso e divenire. Si tratta di due cose diverse o di aspetti diversi di uno stesso concetto? Il progresso è una ideologia, il divenire è una concezione filosofica. Il «progresso» dipende da una determinata mentalità, a costituire la quale entrano certi elementi culturali storicamente determinati; il «divenire» è un concetto filosofico, da cui può essere assente il «progresso». Nell’idea di progresso è sottintesa la possibilità di una misurazione quantitativa e qualitativa: più e meglio. Si suppone quindi una misura «fissa» o fissabile, ma questa misura è data dal passato, da una certa fase del passato, o da certi aspetti misurabili ecc. (Non che si pensi a un sistema metrico del progresso). Come è nata l’idea del progresso? Rappresenta questa nascita un fatto culturale fondamentale, tale da fare epoca? Pare di sì.
La nascita e lo sviluppo dell’idea del progresso corrisponde alla coscienza diffusa che è stato raggiunto un certo rapporto tra la società e la natura (incluso nel concetto di natura quello di caso e di «irrazionalità») tale per cui gli uomini, nel loro complesso, sono più sicuri del loro avvenire, possono concepire «razionalmente» dei piani complessivi della loro vita. Per combattere l’idea di progresso il Leopardi deve ricorrere alle eruzioni vulcaniche, cioè a quei fenomeni naturali che sono ancora «irresistibili» e senza rimedio. Ma nel passato c’erano ben più numerose forze irresistibili: carestie, epidemie, ecc. che entro certi limiti sono state dominate. Che il progresso sia stata una ideologia democratica è indubbio; che abbia servito politicamente alla formazione dei moderni Stati costituzionali ecc. pure. Che oggi non sia più in auge, anche; ma in che senso? Non in quello che si sia perduto la fede nella possibilità di dominare razionalmente la natura e il caso, ma in senso «democratico»; cioè che i «portatori» ufficiali del progresso sono divenuti incapaci di questo dominio, perché hanno suscitato forze distruttive attuali altrettanto pericolose e angosciose di quelle del passato (ormai dimenticate «socialmente» se non da tutti gli elementi sociali, perché i contadini continuano a non comprendere il «progresso», cioè credono di essere, e sono ancora troppo in balia delle forze naturali e del caso, conservano quindi una mentalità «magica», medioevale, «religiosa») come le «crisi», la disoccupazione ecc. La crisi dell’idea di progresso non è quindi crisi dell’idea stessa, ma crisi dei portatori di essa idea, che sono diventati «natura» da dominare essi stessi. Gli assalti all’idea di progresso, in questa situazione, sono molto interessati e tendenziosi.
Può disgiungersi l’idea di progresso da quella di divenire? Non pare. Esse sono nate insieme, come politica (in Francia), come filosofia (in Germania, poi sviluppata in Italia). Nel «divenire» si è cercato di salvare ciò che di più concreto è nel «progresso», il movimento e anzi il movimento dialettico (quindi anche un approfondimento, perché il progresso è legato alla concezione volgare dell’evoluzione).
Da un articoluccio di Aldo Capasso nell’«Italia Letteraria» del 4 dicembre 1932 riporto alcuni brani che presentano i dubbi volgari su questi problemi: «Anche da noi è comune l’irrisione verso l’ottimismo umanitario e democratico di stile ottocentesco, e Leopardi non è un solitario quando parla delle “sorti progressive” con ironia; ma s’è escogitato quell’astuto travestimento del “Progresso” ch’è l’idealistico “Divenire”: idea che resterà nella storia, crediamo, più ancora come italiana che come tedesca. Ma che senso può avere un Divenire che si prosegue ad infinitum, un miglioramento che non sarà mai paragonabile ad un bene fisico? Mancando il criterio di un ultimo gradino stabile, manca, del “miglioramento”, l’unità di misura. E inoltre non si può arrivare nemmeno a pascersi della fiducia di essere, noi uomini reali e viventi, migliori, che so io, dei Romani o dei primi Cristiani, perché il “miglioramento” andando inteso in un senso tutto ideale, è perfettamente ammissibile che noi oggi siamo tutti “decadenti” mentre, allora, fossero quasi tutti uomini pieni o magari santi. Sicché, dal punto di vista etico, l’idea d’ascesa ad infinitum implicita nel concetto di Divenire resta alquanto ingiustificabile, dato che il “melioramento” etico è fatto individuale e che nel piano individuale è proprio possibile concludere, procedendo caso per caso, che tutta l’epoca ultima è deteriore... E allora il concetto del Divenire ottimistico si fa inafferrabile tanto sul piano ideale quanto nel piano reale (...). È noto come il Croce negasse il valore raziocinativo del Leopardi, asserendo che pessimismo e ottimismo sono atteggiamenti sentimentali, non filosofici. Ma il pessimista (...) potrebbe osservare che, per l’appunto, la concezione del Divenire idealistica, è un fatto d’ottimismo e di sentimento: perché il pessimista e l’ottimista (se non animati di fede nel Trascendente) concepiscono allo stesso modo la Storia: come lo scorrere di un fiume senza foce; e poi collocare l’accento sulla parola «fiume» o sulle parole «senza foce», secondo il loro stato sentimentale. Dicono gli uni: non c’è foce, ma, come in un fiume armonioso, c’è la continuità delle onde e la sopravvivenza, sviluppata, nell’oggi, dello ieri... E gli altri: c’è la continuità di un fiume, ma non c’è la foce... Insomma, non dimentichiamo che l’ottimismo è sentimento, non meno del pessimismo. Resta che ogni “filosofia” non può fare a meno di atteggiarsi sentimentalmente, come pessimismo o come ottimismo» ecc. ecc.
Non c’è molta coerenza nel pensiero del Capasso, ma il suo modo di pensare è espressivo di uno stato d’animo diffuso, molto snobistico e incerto, molto sconnesso e superficiale e talvolta anche senza molta onestà e lealtà intellettuale e senza la necessaria logicità formale.
La quistione è sempre la stessa: cos’è l’uomo? cos’è la natura umana? Se si definisce l’uomo come individuo, psicologicamente e speculativamente, questi problemi del progresso e del divenire sono insolubili o rimangono di mera parola. Ma se si concepisce l’uomo come l’insieme dei rapporti sociali, intanto appare che ogni paragone tra uomini nel tempo è impossibile, perché si tratta di cose diverse, se non eterogenee. D’altronde, poiché l’uomo è anche l’insieme delle sue condizioni di vita, si può misurare quantitativamente la differenza tra il passato e il presente, poiché si può misurare la misura in cui l’uomo domina la natura e il caso. La possibilità non è la realtà, ma è anch’essa una real‑tà: che l’uomo possa fare una cosa o non possa farla, ha la sua importanza per valutare ciò che realmente si fa. Possibilità vuol dire «libertà». La misura delle libertà entra nel concetto d’uomo. Che ci siano le possibilità obbiettive di non morire di fame, e che si muoia di fame ha la sua importanza, a quanto pare. Ma l’esistenza delle condizioni obbiettive, o possibilità o libertà non è ancora sufficiente: occorre «conoscerle» e sapersene servire. Volersene servire.
L’uomo, in questo senso, è volontà concreta, cioè applicazione effettuale dell’astratto volere o impulso vitale ai mezzi concreti che tale volontà realizzano. Si crea la propria personalità: 1) dando un indirizzo determinato e concreto («razionale») al proprio impulso vitale o volontà; 2) identificando i mezzi che rendono tale volontà concreta e determinata e non arbitraria; 3) contribuendo a modificare l’insieme delle condizioni concrete che realizzano questa volontà nella misura dei propri limiti di potenza e nella forma più fruttuosa.
L’uomo è da concepire come un blocco storico di elementi puramente individuali e soggettivi e di elementi di massa e oggettivi o materiali coi quali l’individuo è in rapporto attivo. Trasformare il mondo esterno, i rapporti generali, significa potenziare se stesso, sviluppare se stesso. Che il «miglioramento» etico sia puramente individuale è illusione ed errore: la sintesi degli elementi costitutivi dell’individualità è «individuale», ma essa non si realizza e sviluppa senza un’attività verso l’esterno, modificatrice dei rapporti esterni, da quelli verso la natura a quelli verso gli altri uomini in vari gradi, nelle diverse cerchie sociali in cui si vive, fino al rapporto massimo, che abbraccia tutto il genere umano. Perciò si può dire che l’uomo è essenzialmente «politico», poiché l’attività per trasformare e dirigere coscientemente gli altri uomini realizza la sua «umanità», la sua «natura umana».
Q10 §49 Punti per un saggio sul Croce. Dall’«Italia Letteraria» del 20 marzo 1932 riporto alcuni brani dell’articolo di Roberto Forges Davanzati sulla Storia d’Europa del Croce, pubblicato nella «Tribuna» del 10 marzo (La storia come azione e la storia come dispetto): «Croce è senza dubbio un uomo tipico, ma tipico appunto di quella mostruosità culturale, raziocinante, enciclopedica che ha accompagnato il liberalismo politico ed è in bancarotta, perché è l’antitesi della Poesia, della Fede, dell’Azione credente, e cioè della vita militante. Croce è statico, retrospettivo, analitico, anche quando sembra ricercare una sintesi. Il suo odio puerile per la gioventù guerriera, sportiva è anche l’odio fisico di un cervello che non sa uscire a contatto con l’infinito, con l’eterno, che il mondo ci mostra quando si viva nel mondo, e quando si abbia la ventura di vivere nella parte del mondo che si chiama Italia, ove il divino più manifestamente si rivela. Nessuna sorpresa pertanto se questo cervello passato dalla erudizione alla filosofia abbia mancato di spirito creatore e nella sua intelligenza dialettica non abbia brillato alcuna luce di fresca, ingenua o profonda intuizione; passato dalla filosofia alla critica letteraria abbia confessato di non aver quel tanto di propria poesia che è necessaria per intendere la Poesia; e finalmente entrato nella storia politica abbia mostrato e mostri di non capire la storia del tempo suo, e si ponga fuori e contro la Fede, ... massimamente contro la Fede rivelata e custodita da quella Chiesa che in Roma ha il suo centro millenario. Nessuna sorpresa se questo cervello è oggi condannato ad essere sequestrato fuori dell’Arte, della Patria vivente, della Fede cattolica, dello spirito e del governo degli uomini del suo tempo, e sia incapace di portare a conclusioni credute e animose la grave mora delle sue cognizioni, cui si può attingere senza credere e senza seguire».
Il Forges Davanzati è davvero un tipo, e un tipo da farsa intellettuale. Si potrebbe così delineare il suo carattere: egli è il «superuomo» rappresentato da un romanziere o drammaturgo minchione ed è nello stesso tempo questo romanziere o drammaturgo. La vita come opera d’arte, ma opera d’arte d’un minchione. È noto che molti giovanotti vogliono rappresentare il genio, ma per rappresentare il genio occorre essere genio e infatti la maggior parte di questi genii rappresentati sono dei solennissimi imbecilli: il Forges Davanzati rappresenta se stesso ecc.
Q10 §50 Introduzione allo studio della filosofia. I. È da vedere
il libretto di Paul Nizan Les
chiens de garde, Paris, Rieder, 1932; polemica contro
la filosofia moderna, pare in sostegno della filosofia della
prassi. Su questo volumetto cfr due articolucci in «Critica
Fascista» del 1° febbraio 1933, di Giorgio Granata e Agostino
Nasti. Poiché il Granata aveva scritto che la filosofia della
prassi «è derivata proprio essa dai sistemi idealistici e si
rivela astratta quant’altra mai», il Nasti ci tiene a far sapere
che: «Se con le parole “sistemi idealistici” il Granata intende
alludere a quella che si chiama filosofia idealistica, da Hegel
a Gentile, egli ripete un’affermazione che si fa da alcuni, in
questi tempi, con l’ingenuo scopo di gettare il discredito su
quella filosofia» ecc.; «Che Marx, lui, abbia creduto di
prendere le mosse da Hegel, può anche darsi; ma che noi gli si
debba riconoscere, oltre all’aver adottato come strumento utile
o conveniente alle sue concezioni il meccanismo (!) logico,
puramente formale (!), della dialettica di essere ‑ non essere ‑
divenire (!?), anche una filiazione o collegazione sostanziale
con la filosofia idealistica, questo ci parrebbe uno sproposito
assolutamente gratuito».
II. Quantità è qualità. Poiché non può esistere quantità senza qualità e qualità senza quantità (economia senza cultura, attività pratica senza intelligenza e viceversa) ogni contrapposizione dei due termini è un non senso razionalmente. E infatti, quando si contrappone la qualità alla quantità con tutte le variazioni melense alla Guglielmo Ferrero e Co., in realtà si contrappone una certa qualità ad altra qualità, una certa quantità ad altra quantità, cioè si fa una certa politica e non si fa un’affermazione filosofica. Se il nesso quantità‑qualità è inscindibile si pone la quistione: ove sia più utile applicare la propria forza di volere: a sviluppare la quantità o la qualità? quale dei due aspetti è più controllabile? quale più facilmente misurabile? su quale si possono fare previsioni, costruire piani di lavoro? La risposta non pare dubbia: sull’aspetto quantitativo. Affermare pertanto che si vuole lavorare sulla quantità, che si vuole sviluppare l’aspetto «corposo» del reale non significa che si voglia trascurare la «qualità», ma significa invece che si vuole porre il problema qualitativo nel modo più concreto e realistico, cioè si vuole sviluppare la qualità nel solo modo in cui tale sviluppo è controllabile e misurabile.
La quistione è connessa all’altra espressa nel proverbio: «Primum vivere, deinde philosophari». In realtà non è possibile staccare il vivere dal filosofare; tuttavia il proverbio ha un significato pratico: vivere significa occuparsi specialmente dell’attività pratica economica, filosofare occuparsi di attività intellettuali, di otium litteratum. Tuttavia c’è chi «vive» solamente, chi è costretto a un lavoro servile, estenuante ecc., senza di cui alcuni non potrebbero avere la possibilità di essere esonerati dall’attività economica per filosofare.
Sostenere la «qualità» contro la quantità significa proprio solo questo: mantenere intatte determinate condizioni di vita sociale in cui alcuni sono pura quantità, altri qualità. E come è piacevole ritenersi rappresentanti patentati della qualità, della bellezza, del pensiero ecc. Non c’è signora del bel mondo che non creda di adempiere a tale funzione di conservare sulla terra la qualità e la bellezza!
Q10 §51 Punti per un saggio sul Croce. Sul concetto di «libertà». Dimostrare che eccettuati i «cattolici», tutte le altre correnti filosofiche e pratiche si svolgono sul terreno della filosofia della libertà e dell’attuazione della libertà. Questa dimostrazione è necessaria, perché è vero che si è formata una mentalità sportiva che ha fatto della libertà un pallone con cui giocare al football. Ogni «villan che parteggiando viene» immagina se stesso dittatore e il mestiere del dittatore sembra facile: dare ordini imperiosi, firmare carte ecc. poiché si immagina che «per grazia di dio» tutti ubbidiranno e gli ordini verbali e scritti diverranno azione: il verbo si farà carne. Se non si farà, vuol dire che occorrerà attendere ancora finché la «grazia» (ossia le cosiddette «condizioni obbiettive») lo renderanno possibile.
Q10 §52 Introduzione allo studio della filosofia. Posto il principio che tutti gli uomini sono «filosofi», che cioè tra i filosofi professionali o «tecnici» e gli altri uomini non c’è differenza «qualitativa» ma solo «quantitativa» (e in questo caso «quantità» ha un significato suo particolare, che non può essere confuso con somma aritmetica, poiché indica maggiore o minore «omogeneità», «coerenza», «logicità» ecc., cioè quantità di elementi qualitativi), è tuttavia da vedere in che consista propriamente la differenza. Così non sarà esatto chiamare «filosofia» ogni tendenza di pensiero, ogni orientamento generale ecc. e neppure ogni «concezione del mondo e della vita». Il filosofo si potrà chiamare «un operaio qualificato» in confronto ai manovali, ma neanche questo è esatto, perché nell’industria, oltre al manovale e all’operaio qualificato c’è l’ingegnere, il quale non solo conosce il mestiere praticamente, ma lo conosce teoricamente e storicamente.
Il filosofo professionale o tecnico non solo «pensa» con maggior rigore logico, con maggiore coerenza, con maggiore spirito di sistema degli altri uomini, ma conosce tutta la storia del pensiero, cioè sa rendersi ragione dello sviluppo che il pensiero ha avuto fino a lui ed è in grado di riprendere i problemi dal punto in cui essi si trovano dopo aver subito il massimo di tentativo di soluzione ecc. Hanno nel campo del pensiero la stessa funzione che nei diversi campi scientifici hanno gli specialisti. Tuttavia c’è una differenza tra il filosofo specialista e gli altri specialisti: che il filosofo specialista si avvicina più agli altri uomini di ciò che avvenga per gli altri specialisti. L’avere fatto del filosofo specialista una figura simile, nella scienza, agli altri specialisti, è appunto ciò che ha determinato la caricatura del filosofo. Infatti si può immaginare un entomologo specialista, senza che tutti gli altri uomini siano «entomologhi» empirici, uno specialista della trigonometria, senza che la maggior parte degli altri uomini si occupino di trigonometria ecc. (si possono trovare scienze raffinatissime, specializzatissime, necessarie, ma non perciò «comuni»), ma non si può pensare nessun uomo che non sia anche filosofo, che non pensi, appunto perché il pensare è proprio dell’uomo come tale (a meno che non sia patologicamente idiota).
Q10 §53 Punti di meditazione sull’economia. Distribuzione delle forze umane di lavoro e di consumo. Si può osservare come vadano sempre più crescendo le forze di consumo in confronto a quelle di produzione. La popolazione economicamente passiva e parassitaria. Ma il concetto di «parassitario» deve essere ben precisato. Può avvenire che una funzione parassitaria intrinsecamente si dimostri necessaria date le condizioni esistenti: ciò rende ancor più grave tale parassitismo. Appunto quando un parassitismo è «necessario», il sistema che crea tali necessità è condannato in se stesso. Ma non solo i puri consumatori aumentano di numero, aumenta anche il loro tenore di vita, cioè aumenta la quota di beni che da essi è consumata (o distrutta). Se si osserva bene si deve giungere alla conclusione che l’ideale di ogni elemento della classe dirigente è quello di creare le condizioni in cui i suoi eredi possano vivere senza lavorare, di rendita: come è possibile che una società sia sana quando si lavora per essere in grado di non lavorare più? Poiché questo ideale è impossibile e malsano, significa che tutto l’organismo è viziato e malato. Una società che dice di lavorare per creare dei parassiti, per vivere sul così detto lavoro passato (che è metafora per indicare il presente lavoro degli altri) in realtà distrugge se stessa.
Q10 §54 Introduzione allo studio della filosofia. Che cosa è l’uomo? È questa la domanda prima e principale della filosofia. Come si può rispondere. La definizione si può trovare nell’uomo stesso; e cioè in ogni singolo uomo. Ma è giusta? In ogni singolo uomo si può trovare che cosa è ogni «singolo uomo». Ma a noi non interessa che cosa è ogni singolo uomo, che poi significa che cosa è ogni singolo uomo in ogni singolo momento. Se ci pensiamo, vediamo che ponendoci la domanda che cosa è l’uomo vogliamo dire: che cosa l’uomo può diventare, se cioè l’uomo può dominare il proprio destino, può «farsi», può crearsi una vita. Diciamo dunque che l’uomo è un processo e precisamente è il processo dei suoi atti.
Se ci pensiamo, la stessa domanda: cosa è l’uomo? non è una domanda astratta, o «obbiettiva». Essa è nata da ciò che abbiamo riflettuto su noi stessi e sugli altri e vogliamo sapere, in rapporto a ciò che abbiamo riflettuto e visto, cosa siamo e cosa possiamo diventare, se realmente ed entro quali limiti, siamo «fabbri di noi stessi», della nostra vita, del nostro destino. E ciò vogliamo saperlo «oggi», nelle condizioni date oggi, della vita «odierna» e non di una qualsiasi vita e di un qualsiasi uomo. La domanda è nata, riceve il suo contenuto da speciali, cioè determinati modi di considerare la vita e l’uomo: il più importante di questi modi è la «religione» ed una determinata religione, il cattolicismo. In realtà, domandandoci: «cos’è l’uomo», quale importanza ha la sua volontà e la sua concreta attività nel creare se stesso e la vita che vive, vogliamo dire: «è il cattolicismo una concezione esatta dell’uomo e della vita? essendo cattolici, cioè facendo del cattolicismo una norma di vita, sbagliamo o siamo nel vero?» Tutti hanno la vaga intuizione che facendo del cattolicismo una norma di vita sbagliano, tanto vero che nessuno si attiene al cattolicismo come norma di vita, pur dichiarandosi cattolico. Un cattolico integrale, che cioè applicasse in ogni atto della vita le norme cattoliche, sembrerebbe un mostro, ciò che è, a pensarci, la critica più rigorosa del cattolicismo stesso e la più perentoria. I cattolici diranno che nessuna altra concezione è seguita puntualmente, ed hanno ragione, ma ciò dimostra solo che non esiste di fatto, storicamente, un modo di concepire ed operare uguale per tutti gli uomini e niente altro; non ha nessuna ragione favorevole al cattolicismo, sebbene questo modo di pensare ed operare da secoli sia organizzato a questo scopo, ciò che ancora non è avvenuto per nessun’altra religione con gli stessi mezzi, con lo stesso spirito di sistema, con la stessa continuità e centralizzazione.
Dal punto di vista «filosofico» ciò che non soddisfa nel cattolicismo è il fatto che esso, nonostante tutto, pone la causa del male nell’uomo stesso individuo, cioè concepisce l’uomo come individuo ben definito e limitato. Tutte le filosofie finora esistite può dirsi che riproducono questa posizione del cattolicismo, cioè concepiscono l’uomo come individuo limitato alla sua individualità e lo spirito come tale individualità. È su questo punto che occorre riformare il concetto dell’uomo.
Cioè occorre concepire l’uomo come una serie di rapporti attivi (un processo) in cui se l’individualità ha la massima importanza, non è però il solo elemento da considerare. L’umanità che si riflette in ogni individualità è composta di diversi elementi: 1) l’individuo; 2) gli altri uomini; 3) la natura. Ma il 2° e il 3° elemento non sono così semplici come potrebbe apparire. L’individuo non entra in rapporti con gli altri uomini per giustapposizione, ma organicamente, cioè in quanto entra a far parte di organismi dai più semplici ai più complessi. Così l’uomo non entra in rapporto con la natura semplicemente, per il fatto di essere egli stesso natura, ma attivamente, per mezzo del lavoro e della tecnica. Ancora. Questi rapporti non sono meccanici. Sono attivi e coscienti, cioè corrispondono a un grado maggiore o minore d’intelligenza che di essi ha il singolo uomo. Perciò si può dire che ognuno cambia se stesso, si modifica, nella misura in cui cambia e modifica tutto il complesso di rapporti di cui egli è il centro di annodamento. In questo senso il filosofo reale è e non può non essere altri che il politico, cioè l’uomo attivo che modifica l’ambiente, inteso per ambiente l’insieme dei rapporti di cui ogni singolo entra a far parte.
Se la propria individualità è l’insieme di questi rapporti, farsi una personalità significa acquistare coscienza di tali rapporti, modificare la propria personalità significa modificare l’insieme di questi rapporti. Ma questi rapporti, come si è detto, non sono semplici. Intanto, alcuni di essi sono necessari, altri volontari. Inoltre averne coscienza più o meno profonda (cioè conoscere più o meno il modo con cui si possono modificare) già li modifica. Gli stessi rapporti necessari in quanto sono conosciuti nella loro necessità, cambiano d’aspetto e d’importanza. La conoscenza è potere, in questo senso. Ma il problema è complesso anche per un altro aspetto: che non basta conoscere l’insieme dei rapporti in quanto esistono in un momento dato come un dato sistema, ma importa conoscerli geneticamente, nel loro moto di formazione, poiché ogni individuo non solo è la sintesi dei rapporti esistenti ma anche della storia di questi rapporti, cioè è il riassunto di tutto il passato. Si dirà che ciò che ogni singolo può cambiare è ben poco, in rapporto alle sue forze. Ciò che è vero fino a un certo punto. Poiché il singolo può associarsi con tutti quelli che vogliono lo stesso cambiamento e, se questo cambiamento è razionale, il singolo può moltiplicarsi per un numero imponente di volte e ottenere un cambiamento ben più radicale di quello che a prima vista può sembrare possibile.
Società alle quali un singolo può partecipare: sono molto numerose, più di quanto può sembrare. È attraverso queste «società» che il singolo fa parte del genere umano. Così sono molteplici i modi con cui il singolo entra in rapporto colla natura, poiché per tecnica, deve intendersi non solo quell’insieme di nozioni scientifiche applicate industrialmente che di solito s’intende, ma anche gli strumenti «mentali», la conoscenza filosofica.
Che l’uomo non possa concepirsi altro che vivente in società è luogo comune, tuttavia non se ne traggono tutte le conseguenze necessarie anche individuali: che una determinata società umana presupponga una determinata società delle cose e che la società umana sia possibile solo in quanto esiste una determinata società delle cose è anche luogo comune. È vero che finora a questi organismi oltre individuali è stato dato un significato meccanicistico e deterministico (sia la societas hominum che la societas rerum): quindi la reazione. Bisogna elaborare una dottrina in cui tutti questi rapporti sono attivi e in movimento, fissando ben chiaro che sede di questa attività è la coscienza dell’uomo singolo che conosce, vuole, ammira, crea, in quanto già conosce, vuole, ammira, crea ecc. e si concepisce non isolato ma ricco di possibilità offertegli dagli altri uomini e dalla società delle cose, di cui non può non avere una certa conoscenza. (Come ogni uomo è filosofo, ogni uomo è scienziato ecc.).
Q10 §55 Punti di meditazione sull’economia. Le idee di Agnelli. (Cfr Riforma Sociale, gennaio‑febbraio 1933). Alcune osservazioni preliminari sul modo di porre il problema tanto da parte di Agnelli che di Einaudi: 1) Intanto il progresso tecnico non avviene «evolutivamente», un tanto per volta, per cui si possano fare delle previsioni oltre certi limiti: il progresso avviene per spinte determinate, in certi campi. Se fosse così come ragiona specialmente Einaudi, si giungerebbe all’ipotesi del paese di Cuccagna, in cui le merci si ottengono senza lavoro alcuno. 2) La quistione poi più importante è quella della produzione di alimenti: non si pensa che «finora», data la molteplicità di livelli di lavoro tecnicamente più o meno progrediti, il salario è stato «elastico» solo perché è stata permessa, entro certi limiti, una ridistribuzione degli alimenti e specialmente di alcuni di essi (di quelli che danno il tono alla vita) (con gli alimenti occorre porre l’abbigliamento e l’abitazione). Ora, nella produzione degli alimenti i limiti alla produttività del lavoro sono più segnati che nella produzione dei beni manufatti (e si intende «quantità globale» degli alimenti, non loro modificazioni merceologiche, che non ne aumentano la quantità). Le possibilità di «ozio» (nel senso dell’Einaudi) oltre certi limiti, sono date dalla possibilità della moltiplicazione degli alimenti come quantità, e non dalla produttività del lavoro e la «superficie della terra» con il regime delle stagioni ecc. pongono limiti ferrei quantunque sia da ammettere che prima di raggiungere tali limiti ci sia ancora molto viaggio.
Le polemiche tipo Agnelli‑Einaudi fanno pensare al fenomeno psicologico che durante la fame si pensa di più all’abbondanza di cibo: sono ironiche, per dire il meno. Intanto la discussione è sbagliata psicologicamente, perché tende a far credere che l’attuale disoccupazione sia «tecnica», mentre ciò è falso. La disoccupazione «tecnica» è poca cosa in confronto della disoccupazione generale. Inoltre. Il ragionamento è fatto come se la società fosse costituita di «lavoratori» e di «industriali» (datori di lavoro in senso stretto, tecnico), ciò che è falso e porta a ragionamenti illusori. Se così fosse, dato che l’industriale ha bisogni limitati, la quistione sarebbe semplice realmente: la quistione di ricompensare l’industriale con plus salari o premi di capacità sarebbe cosa da nulla e che nessun uomo sensato rifiuterebbe di prendere in considerazione: il fanatismo dell’eguaglianza non nasce dai «premi» che vengono dati agli industriali valenti. Il fatto è questo: che, date le condizioni generali, il maggior profitto creato dai progressi tecnici del lavoro, crea nuovi parassiti, cioè gente che consuma senza produrre, che non «scambia» lavoro con lavoro, ma lavoro altrui con «ozio» proprio (e ozio nel senso deteriore). Dato il rapporto prima notato sul progresso tecnico nella produzione degli alimenti, avviene una selezione dei consumatori di alimenti, in cui i «parassiti» entrano nel conto prima dei lavoratori effettivi e specialmente prima dei lavoratori potenziali (cioè attualmente disoccupati). È da questa situazione che nasce il «fanatismo dell’eguaglianza» e rimarrà «fanatismo» cioè tendenza estrema e irrazionale, finché tale situazione durerà. Si vede che esso scompare già dove si vede che per lo meno si lavora a far scomparire o attenuare tale situazione generale.
Il fatto che la «società industriale» non è costituita solo di «lavoratori» e di «imprenditori», ma di «azionisti» vaganti (speculatori) turba tutto il ragionamento di Agnelli: avviene che se il progresso tecnico permette un più ampio margine di profitto, questo non sarà distribuito razionalmente ma «sempre» irrazionalmente agli azionisti e affini. Né oggi si può dire che esistano «imprese sane». Tutte le imprese sono divenute malsane, e ciò non si dice per prevenzione moralistica o polemica, ma oggettivamente. È la stessa «grandezza» del mercato azionario che ha creato la malsania: la massa dei portatori di azioni è così grande che essa ormai ubbidisce alle leggi di «folla» (panico, ecc. che ha i suoi termini tecnici speciali nel «boom», nel «run» ecc.) e la speculazione è diventata una necessità tecnica, più importante del lavoro degli ingegneri e degli operai.
L’osservazione sulla crisi americana del 1929 appunto questo ha messo in luce: l’esistenza di fenomeni irrefrenabili di speculazione, da cui sono travolte anche le aziende «sane» per cui si può dire che «aziende sane» non ne esistono più: si può pertanto usare la parola «sana» accompagnandola da un riferimento storico: «nel senso di una volta», cioè quando esistevano certe condizioni generali che permettevano certi fenomeni generali non solo in senso relativo, ma anche in senso assoluto. (Su molte di questo paragrafo è da vedere il libro di Sir Artur Salter: Ricostruzione: come finirà la crisi, Milano, Bompiani, 1932, pp. 398, L. 12).
Q10 §56 Punti per un saggio su B. Croce. Passione e politica. Che il Croce abbia identificato la politica con la passione può spiegarsi col fatto che egli si è avvicinato seriamente alla politica, interessandosi all’azione politica delle classi subalterne, che «essendo costrette», «sulla difensiva», trovandosi in caso di forza maggiore, cercando di liberarsi da un male presente (sia pure presunto ecc.) o come altrimenti si vuol dire, realmente confondono politica con passione (anche nel senso etimologico). Ma la scienza politica non solo (secondo il Croce) deve spiegare una parte, l’azione di una parte, ma anche l’altra parte, l’azione dell’altra parte. Ciò che si deve spiegare è l’iniziativa politica, sia essa «difensiva», quindi «appassionata», ma anche «offensiva» cioè non diretta ad evitare un male presente (sia pure presunto, poiché anche il male presunto fa soffrire e in quanto fa soffrire è un male reale). Se si esamina bene questo concetto crociano di «passione» escogitato per giustificare teoricamente la politica, si vede che esso a sua volta non può essere giustificato che dal concetto di lotta permanente, per cui l’«iniziativa» è sempre «appassionata» perché la lotta è incerta e si attacca continuamente per evitare di essere sconfitto non solo, ma per tenere in soggezione l’avversario che «potrebbe vincere» se non fosse continuamente persuaso di essere il più debole, cioè continuamente sconfitto. Insomma non può esserci «passione» senza antagonismo ed antagonismo tra gruppi d’uomini, perché nella lotta tra l’uomo e la natura la passione si chiama «scienza» e non «politica». Si può dire pertanto che nel Croce il termine di «passione» è uno pseudonimo per lotta sociale.
Q10 §57 Punti di meditazione sull’economia. Impostare il problema se può esistere una scienza economica e in che senso. Può darsi che la scienza economica sia una scienza sui generis, anzi unica nel suo genere. Si può vedere in quanti sensi è impiegata la parola scienza, dalle varie correnti filosofiche, e se qualcuno di questi sensi si possa applicare alle ricerche economiche. A me pare che la scienza economica stia a sé, cioè sia una scienza unica, poiché non si può negare che sia scienza e non solo nel senso «metodologico», cioè non solo nel senso che i suoi procedimenti sono scientifici e rigorosi. Mi pare anche che non possa avvicinarsi l’economia alla matematica, sebbene tra le varie scienze la matematica forse si avvicini più di tutte all’economia. In ogni modo l’economia non può essere ritenuta una scienza naturale (qualunque sia il modo di concepire la natura o il mondo esterno, soggettivistico od oggettivistico) né una scienza «storica» nel senso comune della parola, ecc.
Uno dei pregiudizi contro i quali bisogna forse ancora lottare è che per essere «scienza» una ricerca debba aggrupparsi con altre ricerche in un tipo e che tale «tipo» sia la «scienza». Può invece avvenire che l’aggruppamento sia impossibile non solo, ma che una ricerca sia «scienza» in un certo periodo storico e non in un altro: infatti altro pregiudizio è che se una ricerca è «scienza» avrebbe potuto esserlo sempre e sempre lo sarà. (Non lo fu perché mancarono gli «scienziati», non la materia della scienza). Per l’economia appunto questi elementi critici sono da esaminare: c’è stato un periodo in cui non poteva esserci «scienza» non solo perché mancavano gli scienziati, ma perché mancavano certe premesse che creavano quella certa «regolarità» o quel certo «automatismo», il cui studio dà origine appunto alla ricerca scientifica. Ma la regolarità o l’automatismo possono essere di tipi diversi nei diversi tempi e ciò creerà diversi tipi di «scienze». Non è da credere che essendo sempre esistita una «vita economica» debba sempre essere esistita la possibilità di una «scienza economica», così come essendo sempre esistito un movimento degli astri è sempre esistita la «possibilità» di un’astronomia, anche se gli astronomi si chiamavano astrologi ecc. Nell’economia l’elemento «perturbatore» è la volontà umana, volontà collettiva, diversamente atteggiata a seconda delle condizioni generali in cui gli uomini vivevano, cioè diversamente «cospirante» o organizzata.
Q10 §58 Punti per un saggio su B. Croce. Passione e politica. Può nascere passione dalla preoccupazione del prezzo che può assumere la sugna di porco? Una vecchia signora che ha venti servitori può sentir passione dal pensiero di doverli ridurre a diciannove? Passione può essere un sinonimo di economia, nel senso non di produzione economica o di ricerca dell’ofelimità, ma nel senso di continuo studio perché un determinato rapporto non muti sfavorevolmente, anche se lo sfavore sia «utilità generale», libertà generale; ma allora «passione» ed «economia» significano «personalità umana» determinata storicamente in una certa società «gerarchica». Cos’è il «punto d’onore» della malavita se non un patto economico? Ma non è anche una forma di manifestarsi (polemica, di lotta) della personalità? Essere «deprezzato» (spregiato), è il timore morboso di tutti gli uomini nelle forme di società in cui la gerarchia si manifesta in modi «raffinati» (capillari), in minuzie ecc. Nella malavita la gerarchia si fonda sulla forza fisica e sulla furberia: essere «presi in giro», essere fatti apparire sciocchi, lasciare che un oltraggio sia impunito ecc. degrada. Perciò tutto un protocollo e un cerimoniale di convenzione, ricco di sfumature e di sottintesi nelle relazioni reciproche dei soci; venir meno al protocollo è un’ingiuria. Ma ciò non avviene solo nella malavita: le quistioni di rango si verificano in ogni forma di rapporto: da quello tra gli Stati a quello tra famigliari. Chi deve fare un servizio per un certo tempo e non viene sostituito all’ora esatta, s’infuria e reagisce anche con atti di violenza estrema (perfino criminosa); ciò anche se dopo il servizio non ha niente che fare o non acquista la piena libertà di movimento (per es.: un soldato che deve fare la sentinella e dopo il suo turno deve tuttavia rimanere in caserma). Che in questi episodi sia una manifestazione di «personalità» vuol dire solo che la personalità di molti uomini è meschina, angusta: essa è sempre personalità. Ed è innegabile che esistono delle forze che tendono a mantenerla tale e anche ad immeschinirla di più: per troppi essere «qualcosa» significa solo che altri uomini sono ancora «meno cosa» (qualcosa di meno). Che però anche queste piccole cose, queste inezie siano «tutto» o «gran cosa» per certuni risulta da ciò che tali episodi determinano appunto reazioni in cui si arrischia la vita e la libertà personale.
Q10 §59 per un saggio su B. Croce. I. Il Croce come uomo di partito. Distinzione del concetto di partito: 1) Il partito come organizzazione pratica (o tendenza pratica), cioè come strumento per la soluzione di un problema o di un gruppo di problemi della vita nazionale e internazionale. In questo senso il Croce non appartenne mai esplicitamente a nessuno dei gruppi liberali, anzi esplicitamente combatté l’idea stessa e il fatto dei partiti permanentemente organizzati (Il Partito come giudizio e pregiudizio, in Cultura e Vita Morale, saggio pubblicato in uno dei primi numeri della «Unità» fiorentina) e si pronunziò a favore dei movimenti politici che non si pongono un «programma» definito, «dogmatico», permanente, organico, ma tendono volta per volta a risolvere problemi politici immediati. D’altronde tra le varie tendenze liberali il Croce manifestò la sua simpatia per quella conservatrice, rappresentata dal «Giornale d’Italia». Il «Giornale d’Italia» non solo per lungo tempo pubblicò articoli della «Critica» prima che i fascicoli della rivista fossero divulgati, ma ebbe il «monopolio» delle lettere che il Croce scriveva di tanto in tanto per esprimere le sue opinioni su argomenti di politica e di politica culturale che lo interessavano e intorno ai quali riteneva necessario pronunciarsi. Nel dopoguerra anche la «Stampa» pubblicò le primizie della «Critica» (o di scritti del Croce pubblicati in Atti accademici), ma non ebbe le lettere che continuarono ad essere pubblicate dal «Giornale» d’Italia» per il primo e furono riprodotte dalla «Stampa» e da altri giornali. 2) Il partito come, ideologia generale, superiore ai vari aggruppamenti più immediati. In realtà il modo di essere del partito liberale in Italia dopo il 1876 fu quello di presentarsi al paese come un «ordine sparso» di frazioni e di gruppi nazionali e regionali. Erano frazioni del liberalismo politico tanto il cattolicismo liberale dei popolari, come il nazionalismo (il Croce collaborò a «Politica» di A. Rocco e F. Coppola), tanto le unioni monarchiche come il partito repubblicano e gran parte del socialismo, tanto i radicali democratici come i conservatori, tanto Sonnino‑Salandra, come Giolitti, Orlando, Nitti e Co. Il Croce fu il teorico di ciò che tutti questi gruppi e gruppetti, camarille e mafie avevano di comune, il capo di un ufficio centrale di propaganda di cui tutti questi gruppi beneficiavano e si servivano, il leader nazionale dei movimenti di cultura che nascevano per rinnovare le vecchie forme politiche.
Come è stato osservato altrove il Croce divise con Giustino Fortunato questo ufficio di leader nazionale della cultura liberale democratica. Dal 1900 al 1914 e anche dopo (ma come risoluzione) Croce e Fortunato apparivano sempre come ispiratori (come fermenti) di ogni nuovo movimento giovanile serio che si proponesse di rinnovare il «costume» politico e la vita dei partiti borghesi: così per la «Voce», l’«Unità», l’«Azione Liberale», la «Patria» (di Bologna) ecc. Con la «Rivoluzione Liberale» di Piero Gobetti avviene una innovazione fondamentale: il termine «liberalismo» viene interpretato nel senso più «filosofico» o più astratto e dal concetto di libertà nei termini tradizionali della personalità individuale si passa al concetto di libertà nei termini di personalità collettiva dei grandi gruppi sociali e della gara non più tra individui ma tra gruppi. Di questo ufficio di leader nazionale del liberalismo occorre tener conto per comprendere come il Croce abbia ampliato il cerchio della sua influenza direttrice oltre l’Italia, sulla base di un elemento della sua «propaganda»: quella revisionistica.
Q10 §59 II Come occorre intendere l’espressione «condizioni materiali» e l’«insieme» di queste condizioni? Come il «passato», la «tradizione», concretamente intesi, obbiettivamente constatabili e «misurabili» con metodi di accertamento «universalmente» soggettivi, cioè appunto «oggettivi». Il presente operoso non può non continuare, sviluppandolo, il passato, non può non innestarsi nella «tradizione». Ma come riconoscere la «vera» tradizione, il «vero» passato ecc.? Cioè la storia reale, effettiva e non la velleità di fare nuova storia che cerca nel passato una sua giustificazione tendenziosa, di «superstruttura»? È passato reale la struttura appunto, perché essa è la testimonianza, il «documento» incontrovertibile di ciò che è stato fatto e continua a sussistere come condizione del presente e dell’avvenire. Si potrà osservare che nell’esame della «struttura» i singoli critici possono sbagliare, affermando vitale ciò che è morto, o non è germe di nuova vita da sviluppare, ma il metodo stesso non può essere confutato perentoriamente. Che esista possibilità di errore è ammissibile senz’altro, ma sarà errore dei singoli critici (uomini politici, statisti) non errore di metodo. Ogni gruppo sociale ha una «tradizione», un «passato» e pone questo come il solo e totale passato. Quel gruppo che comprendendo e giustificando tutti questi «passati», saprà identificare la linea di sviluppo reale, perciò contraddittoria, ma nella contraddizione passibile di superamento, commetterà «meno errori», identificherà più elementi «positivi» su cui far leva per creare nuova storia.
Q10 §59 III Vedere se il principio di «distinzione», cioè quella che il Croce chiama «dialettica dei distinti» non sia stato determinato dalla riflessione sul concetto astratto di «homo oeconomicus» proprio dell’economia classica. Posto che tale astrazione ha una portata e un valore puramente «metodologici» o addirittura di tecnica della scienza (cioè immediato ed empirico), è da vedere come il Croce abbia elaborato tutto il sistema dei «distinti». In ogni modo tale elaborazione, come del resto molte altre parti del sistema crociano, avrebbe avuto origine dallo studio dell’economia politica e più precisamente dallo studio della filosofia della prassi, ciò che però non può non significare che il sistema crociano abbia avuto un’origine e una determinazione immediata «economica». La stessa difficoltà che molti filosofi attualisti incontrano nel comprendere il concetto di «homo oeconomicus», trovano nel comprendere il significato e la portata della «dialettica dei distinti». La ricerca ha due aspetti: uno di carattere logico e l’altro di carattere storico. La prima «distinzione» posta dal Croce mi pare sia stata «storicamente» proprio quella del «momento dell’economia o dell’utilità», che non coincide e non può coincidere con quella degli economisti nel senso stretto, poiché nel momento dell’utilità o economico il Croce fa rientrare una serie di attività umane che ai fini della scienza economica sono irrilevanti (per es. l’amore).
Q10 §59 IV L’idealismo attuale fa coincidere verbalmente ideologia e filosofia (ciò che, in ultima analisi, non è altro che uno degli aspetti dell’unità superficiale postulata da esso fra reale e ideale, fra teoria e pratica ecc.) ciò che rappresenta una degradazione della filosofia tradizionale rispetto all’altezza cui l’aveva portata il Croce con la cosiddetta dialettica dei «distinti». Tale degradazione è visibilissima negli sviluppi (o involuzioni) che l’idealismo attuale mostra nei discepoli del Gentile: i «Nuovi Studi» di Ugo Spirito e A. Volpicelli sono il documento più vistoso di questo fenomeno. L’unità di ideologia e filosofia, quando è affermata in questa forma, crea una nuova forma di sociologismo, né storia né filosofia, cioè, ma un insieme di schemi verbali astratti, sorretti da una fraseologia tediosa e pappagallesca. La resistenza del Croce a questa tendenza è veramente «eroica»: il Croce ha viva la consapevolezza che tutti i movimenti del pensiero moderno conducono a una rivalutazione trionfale della filosofia della prassi, cioè al capovolgimento della posizione tradizionale dei problemi filosofici e alla dissoluzione della filosofia intesa nel modo tradizionale. Il Croce resiste con tutte le sue forze alla pressione della realtà storica, con una intelligenza eccezionale dei pericoli e dei mezzi idonei per ovviarli. Perciò lo studio dei suoi scritti dal 19 ad oggi ha un grandissimo significato. La preoccupazione del Croce nasce con la guerra mondiale che egli stesso affermò essere la «guerra del materialismo storico». La sua posizione «au dessus», in un certo senso, è già indice di questa preoccupazione ed è una posizione di allarme (durante la guerra, filosofia e ideologia entrarono in frenetico connubio). Anche l’atteggiamento del Croce verso libri come quello del De Man, dello Zibordi ecc., non possono spiegarsi altrimenti perché in stridente contraddizione con le sue posizioni ideologiche e pratiche di prima della guerra.
Questo spostamento del Croce dalla posizione «critica» a una posizione tendenzialmente pratica e di preparazione all’azione politica effettiva (nei limiti consentiti dalle circostanze e dalla posizione sociale del Croce) è molto significativo. Che importanza può aver avuto il suo libro sulla Storia d’Italia? Qualcosa può dedursi dal libro del Bonomi su Bissolati, da quello dello Zibordi su citato, dalla prefazione di Schiavi al libro del De Man. Il De Man serve anch’esso di ponte di passaggio.
È da ricordare tuttavia la lettera di Orazio Raimondo riportata da G. Castellano nella sua Introduzione allo studio delle opere di Benedetto Croce. La lettera dimostra l’influsso che il Croce esercitava in certi ambienti, penetrando per meati che rimanevano incontrollati. E si tratta del Raimondo, massone, realmente imbevuto dell’ideologia massonica fino alle midolla e «francesamente» democratico, come appare in molte sue orazioni ma specialmente in quella di difesa della Tiepolo (o della dama che assassinò l’attendente Polidori) dove appare il teismo massonico in tutta la sua spiegatezza ed evidenza.
Q10 §60 La proposizione che occorre rimettere «l’uomo sui suoi piedi». Nell’esame dell’influsso esercitato dall’hegelismo sul fondatore della filosofia della prassi occorre ricordare (tenuto conto specialmente del carattere eminentemente pratico‑critico del Marx che il Marx¹ partecipò alla vita universitaria tedesca poco dopo la morte dello Hegel, quando doveva essere ancora vivissimo il ricordo dell’insegnamento orale dello Hegel e delle discussioni appassionate, con riferimento alla storia effettuale recente, che tale insegnamento aveva suscitato, discussioni nelle quali la concretezza storica del pensiero hegeliano doveva risultare molto più evidente di quanto risulti dagli scritti sistematici. Alcune proposizioni della filosofia della prassi pare siano da ritenere specialmente legate a questa vivacità conversativa: per esempio, l’affermazione che lo Hegel fa camminare gli uomini sulla testa. Hegel impiega questa espressione parlando della Rivoluzione francese, quando dice che in un certo momento pareva che il mondo camminasse sulla testa (da verificare con esattezza). Il Croce si domanda (verificare dove e come) da dove Marxa abbia preso questa immagine, come se essa non fosse stata impiegata dallo Hegel nei suoi scritti. L’immagine è cosi poco «libresca», che dà l’impressione di essere scaturita da una conversazione.
Antonio Labriola nello scritto Da un secolo all’altro scrive: «Gli è proprio quel codino di Hegel che disse come quegli uomini (della Convenzione) avessero pei primi, dopo Anassagora, tentato di capovolgere la nozione del mondo, poggiando questo sulla ragione» (ed. Dal Pane, p. 45).
Questa proposizione, sia nell’impiego fattone da Hegel, sia in quello fattone dalla filosofia della prassi, è da confrontare col parallelo, fatto dallo stesso Hegel e che ha uno spunto nella Sacra Famiglia, tra il pensiero pratico‑giuridico francese e quello speculativo tedesco (a questo proposito è da vedere il quaderno su «Introduzione allo studio della filosofia» p. 59).
Q10 §61 Punti per un saggio critico sulle due Storie del Croce: d’Italia e d’Europa. Rapporto storico tra lo Stato moderno francese nato dalla Rivoluzione e gli altri Stati moderni dell’Europa continentale. Il confronto è di importanza vitale, purché non sia fatto in base ad astratti schemi sociologici. Esso può risultare dall’esame di questi elementi: 1) esplosione rivoluzionaria in Francia con radicale e violenta mutazione dei rapporti sociali e politici; 2) opposizione europea alla Rivoluzione francese e alla sua diffusione per i «meati» di classe; 3) guerra della Francia, con la Repubblica e con Napoleone, contro l’Europa, prima per non essere soffocata, poi per costituire una egemonia permanente francese con la tendenza a formare un impero universale; 4) riscosse nazionali contro l’egemonia francese e nascita degli Stati moderni europei per piccole ondate riformistiche successive, ma non per esplosioni rivoluzionarie come quella originaria francese. Le «ondate successive» sono costituite da una combinazione di lotte sociali, di interventi dall’alto di tipo monarchia illuminata e di guerre nazionali, con prevalenza di questi ultimi due fenomeni. Il periodo della «Restaurazione» è il più ricco di sviluppi da questo punto di vista: la restaurazione diventa la forma politica in cui le lotte sociali trovano quadri abbastanza elastici da permettere alla borghesia di giungere al potere senza rotture clamorose, senza l’apparato terroristico francese. Le vecchie classi feudali sono degradate da dominanti a «governative», ma non eliminate, né si tenta di liquidarle come insieme organico: da classi diventano «caste» con determinati caratteri culturali e psicologici, non più con funzioni economiche prevalenti.
Questo «modello» della formazione degli Stati moderni può ripetersi in altre condizioni? È ciò da escludere in senso assoluto, oppure può dirsi che almeno in parte si possono avere sviluppi simili, sotto forma di avvento di economie programmatiche? Può escludersi per tutti gli Stati o solo per i grandi? La quistione è di somma importanza, perché il modello Francia‑Europa ha creato una mentalità, che per essere «vergognosa di sé» oppure per essere uno «strumento di governo» non è perciò meno significativa.
Una quistione importante connessa alla precedente è quella dell’ufficio che hanno creduto di avere gli intellettuali in questo lungo processo di fermentazione politico‑sociale covata dalla Restaurazione. La filosofia classica tedesca è la filosofia di questo periodo, essa vivifica i movimenti liberali nazionali dal 48 al 70. A questo proposito è anche da richiamare il parallelo hegeliano (e della filosofia della prassi) tra la pratica francese e la speculazione tedesca. In realtà il parallelo può essere esteso: ciò che è «pratica» per la classe fondamentale diventa «razionalità» e speculazione per i suoi intellettuali (su questa base di rapporti storici è da spiegare tutto l’idealismo filosofico moderno).
Quistione più vasta: se è possibile pensare la storia come solo «storia nazionale» in qualunque momento dello svolgimento storico, – se il modo di scrivere la storia (e di pensare) non sia sempre stato «convenzionale». Il concetto hegeliano sullo «spirito del mondo» che si impersona in questo o quel paese è un modo «metaforico» o immaginoso di attirare l’attenzione su questo problema metodologico, alla cui compiuta spiegazione si oppongono limitazioni di origine diversa: la «boria» delle nazioni, cioè limitazioni di carattere politico‑pratico nazionale (che non sono sempre deteriori); limitazioni intellettuali (non comprensione del problema storico nella sua totalità) e intellettuali‑pratiche (assenza di informazioni, sia perché mancano i documenti, sia perché è difficile averli a disposizione e interpretarli). (Come per es. fare una storia integrale del cristianesimo se in essa si vuole comprendere il cristianesimo popolare e non solo quello degli intellettuali? In questo caso solo il successivo svolgimento storico è documento del precedente svolgimento, ma documento parziale).
La concezione dello Stato secondo la funzione produttiva delle classi sociali non può essere applicata meccanicamente all’interpretazione della storia italiana ed europea dalla Rivoluzione francese fino a tutto il secolo XIX. Sebbene sia certo che per le classi fondamentali produttive (borghesia capitalistica e proletariato moderno) lo Stato non sia concepibile che come forma concreta di un determinato mondo economico, di un determinato sistema di produzione, non è detto che il rapporto di mezzo e fine sia facilmente determinabile e assuma l’aspetto di uno schema semplice e ovvio a prima evidenza. È vero che conquista del potere e affermazione di un nuovo mondo produttivo sono inscindibili, che la propaganda per l’una cosa è anche propaganda per l’altra e che in realtà solo in questa coincidenza risiede l’unità della classe dominante che è insieme economica e politica; ma si presenta il problema complesso dei rapporti delle forze interne del paese dato, del rapporto delle forze internazionali, della posizione geopolitica del paese dato. In realtà la spinta al rinnovamento rivoluzionario può essere originata dalle necessità impellenti di un paese dato, in circostanze date, e si ha l’esplosione rivoluzionaria della Francia, vittoriosa anche internazionalmente; ma la spinta al rinnovamento può essere data dalla combinazione di forze progressive scarse e insufficienti di per sé (tuttavia ad altissimo potenziale perché rappresentano l’avvenire del loro paese) con una situazione internazionale favorevole alla loro espansione e vittoria.
Il libro di Raffaele Ciasca sulle Origini del programma nazionale, mentre dà la prova che esistevano in Italia gli stessi problemi impellenti che nella Francia dell’antico regime e una forza sociale che interpretava e rappresentava tali problemi nello stesso senso francese, dà anche la prova che tali forze erano scarse e i problemi si mantenevano al livello della «piccola politica». In ogni caso si vede come, quando la spinta del progresso non è strettamente legata a un vasto sviluppo economico locale che viene artificiosamente limitato e represso, ma è il riflesso dello sviluppo internazionale che manda alla periferia le sue correnti ideologiche, nate sulla base dello sviluppo produttivo dei paesi più progrediti, allora il gruppo portatore delle nuove idee non è il gruppo economico, ma il ceto degli intellettuali e la concezione dello Stato di cui si fa la propaganda, muta d’aspetto: esso è concepito come una cosa a sé, come un assoluto razionale. La quistione può essere impostata così: essendo lo Stato la forma concreta di un mondo produttivo ed essendo gli intellettuali l’elemento sociale da cui si trae il personale governativo, è proprio dell’intellettuale non ancorato fortemente a un forte gruppo economico, di presentare lo Stato come un assoluto: così è concepita come assoluta e preminente la stessa funzione degli intellettuali, è razionalizzata astrattamente la loro esistenza e la loro dignità storica. Questo motivo è basilare per comprendere storicamente l’idealismo filosofico moderno ed è connesso al modo di formazione degli Stati moderni nell’Europa continentale come «reazione‑superamento nazionale» della Rivoluzione francese che con Napoleone tendeva a stabilire una egemonia permanente (motivo essenziale per comprendere il concetto di «rivoluzione passiva», di «restaurazione‑rivoluzione» e per capire l’importanza del confronto hegeliano tra i principii dei giacobini e la filosofia classica tedesca).
A questo proposito si può osservare che alcuni criteri tradizionali di valutazione storica e culturale del periodo del Risorgimento devono essere modificati e talvolta capovolti: 1) le correnti italiane che vengono «bollate» di razionalismo francese e di illuminismo astratto sono invece forse le più aderenti alla realtà italiana, in quanto, in realtà, concepiscono lo Stato come forma concreta di uno sviluppo economico italiano in divenire: a ugual contenuto conviene uguale forma politica; 2) sono invece proprio «giacobine» (nel senso deteriore che il termine ha assunto per certe correnti storiografiche) le correnti che appaiono più autoctone, in quanto pare sviluppino una tradizione italiana. Ma in realtà questa corrente è «italiana» solo perché la «cultura» per molti secoli è stata la sola manifestazione «nazionale» italiana. Si tratta di una illusione verbale. Dove era la base di questa cultura italiana? Essa non era in Italia: questa cultura «italiana» è la continuazione del cosmopolitismo medioevale legato alla tradizione dell’Impero e alla Chiesa, concepiti universali con sede «geografica» in Italia. Gli intellettuali italiani erano funzionalmente una concentrazione culturale cosmopolita, essi accoglievano ed elaboravano teoricamente i riflessi della più soda e autoctona vita del mondo non italiano. Anche nel Machiavelli si vede questa funzione, sebbene il Machiavelli cerchi di volgerla a fini nazionali (senza fortuna e senza seguito apprezzabile): il Principe infatti è una elaborazione degli avvenimenti spagnoli, francesi, inglesi nel travaglio dell’unificazione nazionale, che in Italia non ha forze sufficienti e neppure interessa molto. Poiché i rappresentanti della corrente tradizionale realmente vogliono applicare all’Italia schemi intellettuali e razionali, elaborati sì in Italia, ma su esperienze anacronistiche, e non sui bisogni immediati nazionali, essi sono i giacobini nel senso deteriore.
La quistione è complessa, irta di contraddizioni e perciò deve essere approfondita. In ogni modo, gli intellettuali meridionali nel Risorgimento appaiono con chiarezza essere questi studiosi del «puro» Stato, dello Stato in sé. E ogni volta che gli intellettuali dirigono la vita politica, alla concezione dello Stato in sé segue tutto il corteo reazionario che ne è la compagnia d’obbligo.
QUADERNO 10b
PUNTI DI RIFERIMENTO PER UN SAGGIO SU B. CROCE
Introduzione. generali: 1) Appunti metodici (cfr 1a nota); 2) L’uomo di partito: il partito come risoluzione pratica di problemi particolari, come programma organico politico (collaborazione a «Giornale d’Italia» conservatore, «Stampa» ecc., «Politica»); il partito come tendenza generale ideologica, come forma culturale (p. 37 bis); 3) Croce e G. Fortunato come «fermenti» (più che guide) dei movimenti italiani culturali dal 900 al 914 («Voce», «Unità» ecc. fino a «Rivoluzione Liberale»).
1°. L’atteggiamento del Croce durante la guerra mondiale come punto di orientamento per comprendere i motivi della sua attività posteriore di filosofo e di leader della cultura europea.
2°. Croce come leader intellettuale delle tendenze revisionistiche degli anni 90: Bernstein in Germania, Sorel in Francia, la scuola economico‑giuridica in Italia.
3°. Croce dal 1912 al 1932 (elaborazione della teoria della storia etico‑politica) tende a rimanere il leader delle tendenze revisioniste per condurle fino a una critica radicale ed alla liquidazione (politico‑ideologica) anche del materialismo storico attenuato e della teoria economico‑giuridica cfr nota in margine nella pagina seguente.
4°. Elementi della relativa popolarità del Croce: a) elemento stilistico‑letterario mancanza di pedanteria e di astruseria, b) elemento filosofico‑metodico (unità di filosofia e senso comune), c) elemento etico (serenità olimpica).
5°. Croce e la religione: a) il concetto crociano di religione lo spunto per il saggio Religione e serenità è preso dal saggio del De Sanctis La Nerina del Leopardi del 1877 («Nuova Antologia», gennaio 1877), b) Croce e il cristianesimo, c) fortune e sfortune del crocismo tra i cattolici italiani (neoscolastici italiani e vari stadi delle loro manifestazioni filosofiche, filopositiviste, filoidealiste, e ora per un ritorno al tomismo «puro»; carattere eminentemente «pratico» dell’attività del padre Gemelli e suo agnosticismo filosofico), d) articoli del Papini e del Ferrabino nella «Nuova Antologia», come manifestazioni eminenti del pensiero del laicismo cattolico quattro articoli della «Civiltà Cattolica» (del 1932 e 1933), tutti dedicati solo all’introduzione della Storia d’Europa; dopo il 3° articolo il libro è posto all’Indice, e) è Croce un riformatore «religioso»? cfr alcuni brevi saggi pubblicati nella «Critica» in cui si traducono in linguaggio «speculativo» alcuni punti della teologia cattolica (la grazia ecc.) e nel saggio sul «Caracciolo» della teologia calvinista ecc. «Traduzioni» e interpretazioni simili sono contenute incidentalmente in numerosi scritti del Croce.
6°. Croce e la tradizione italiana o una corrente determinata della tradizione italiana: teorie storiche della Restaurazione; scuola dei moderati; la rivoluzione passiva del Cuoco divenuta formula d’«azione» da «avvertimento» di energetica etico‑nazionale; dialettica «speculativa» della storia, meccanicismo arbitrario di essa (cfr la posizione del Proudhon criticata nella Miseria della filosofia); dialettica degli «intellettuali» che concepiscono se stessi come impersonanti la tesi e l’antitesi e quindi elaboranti la sintesi; questo non «impegnarsi» interamente nell’atto storico non è poi una forma di scetticismo? o di poltroneria? almeno non è esso stesso un «atto» politico?
7°. Significato reale della formula «storia etico‑politica». È una ipostasi arbitraria e meccanica dei momento dell’«egemonia». La filosofia della praxis non esclude la storia etico‑politica. L’opposizione tra le dottrine storiche crociane e la filosofia della praxis è nel carattere speculativo della concezione del Croce. Concezione dello Stato in Croce.
8°. Trascendenza‑teologia‑speculazione. storicismo speculativo e storicismo realistico. Soggettivismo idealistico e concezione delle superstrutture nella filosofia della praxis. Gherminella polemica del Croce che «oggi» dà un significato metafisico, trascendente speculativo ai termini della filosofia della praxis, quindi l’«identificazione» della «struttura» con un «dio ascoso». Dalle diverse edizioni dei libri e saggi del Croce estrarre i giudizi successivi, sempre mutati, senza una giustificazione specifica, sull’importanza e la statura filosofica dei fondatori della filosofia della prassi.
9°. La storia d’Europa vista come «rivoluzione passiva». Può farsi una storia d’Europa del secolo XIX senza trattare organicamente della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche? E può farsi una storia d’Italia nel tempo moderno senza le lotte del Risorgimento? In un caso e nell’altro il Croce, per ragioni estrinseche e tendenziose, prescinde dal momento della lotta, in cui la struttura viene elaborata e modificata, e placidamente assume come storia il momento dell’espansione culturale o etico‑politico. Ha un significato «attuale» la concezione della «rivoluzione passiva»? Siamo in un periodo di «restaurazione‑rivoluzione» da assestare permanentemente, da organizzare ideologicamente, da esaltare liricamente? L’Italia avrebbe nei confronti con l’urss la stessa relazione che la Germania e l’Europa di Kant‑Hegel con la Francia di Robespierre‑Napoleone?
10°. La «libertà» come identità di storia e di spirito e la «libertà» come ideologia immediatamente circostanziata, come «superstizione», come strumento pratico di governo. Se si dice che la «natura dell’uomo è lo spirito» si dice che essa è la «storia», cioè l’insieme dei rapporti sociali in processo di sviluppo, cioè ancora l’insieme della natura e della storia, delle forze materiali e di quelle spirituali o culturali ecc..
11°. Tuttavia, si può dire che nella concezione del Croce, anche dopo l’elaborazione subita in questi ultimi anni, non ci sia traccia di filosofia della praxis? Il suo storicismo non risente di nessun influsso della sua esperienza intellettuale degli anni dal 90 al 900? La posizione del Croce a questo proposito risulta dalla prefazione del 1917 alla nuova edizione del Materialismo storico: il Croce vorrebbe far credere che il valore di questa esperienza sia stato essenzialmente negativo, nel senso che avrebbe contribuito a distruggere pregiudizi ecc. Ma lo stesso accanimento del Croce in questi ultimi tempi contro ogni elemento di filosofia della praxis è sospetto (specialmente la presentazione del libro del De Man, mediocrissimo): impressione che Croce combatta troppo per non avere una richiesta di conti. Le tracce di una filosofia della praxis si trovano nella soluzione di problemi particolari è da vedere se l’insieme di questi problemi particolari non contenga implicitamente una elaborazione totale della filosofia della prassi, cioè tutta la metodologia o filosofia del Croce, cioè se i problemi non direttamente collegabili con quelli corrispondenti della filosofia della prassi, non lo siano però con gli altri direttamente collegabili: la dottrina dell’errore mi pare la più tipica. In generale si può dire che la polemica contro la filosofia dell’atto puro ha costretto il Croce a un maggior realismo e a sentire un certo fastidio almeno per le esagerazioni nel linguaggio speculativo degli attualisti.
Sui «residui» o sopravvivenze (ma in realtà sono elaborazioni che hanno una loro peculiare organicità) nella filosofia del Croce della dottrina della filosofia della prassi si sta costituendo una certa letteratura: cfr per esempio il saggio di Enzo Tagliacozzo In memoria di Antonio Labriola («Nuova Italia», 20 dicembre 1934 ‑ 20 gennaio 1935, specialmente nella seconda puntata), e il saggio di Edmondo Cione La logica dello storicismo, Napoli 1933 (forse estratto dagli atti dell’Accademia Reale di scienze morali e politiche). (Da una recensione che di questo saggio pubblica la «Nuova Rivista Storica» gennaio‑febbraio 1935, pp. 132-134, pare che per il Cione solo con la Storia d’Europa il Croce si liberi completamente delle sopravvivenze della filosofia della praxis. Questo e altri saggi del Cione sono da vedere). Nota: In una recensione di alcune pubblicazioni di Guido Calogero («Critica», maggio 1935) il Croce accenna al fatto che il Calogero chiama «filosofia della praxis» una propria interpretazione dell’attualismo gentiliano. Quistioni di terminologia (ma forse non solo di terminologia) che occorre chiarire.
12°. La concezione della storia come storia etico‑politica sarebbe dunque una futilità? Occorre fissare che il pensiero storiografico del Croce, anche nella sua fase più recente, deve essere studiato e meditato con attenzione. Esso rappresenta essenzialmente una reazione all’«economismo» e al meccanicismo fatalistico, sebbene si presenti come superamento della filosofia della praxis. Anche per il Croce vale il criterio che il suo pensiero deve essere criticato e valutato non per quello che pretende di essere, ma per ciò che è realmente e che si manifesta nelle opere storiche concrete. Per la filosofia della praxis lo stesso metodo speculativo non è futilità ma è stato fecondo di valori «strumentali» del pensiero, che la filosofia della praxis si è incorporata (la dialettica, per es.). Il pensiero del Croce deve essere dunque apprezzato come valore strumentale e così si può dire che esso ha energicamente attirato l’attenzione allo studio dei fatti di cultura e di pensiero come elementi di dominio politico, alla funzione dei grandi intellettuali nella vita degli Stati, al momento dell’egemonia e del consenso come forma necessaria del blocco storico concreto. La storia etico‑politica è dunque uno dei canoni di interpretazione storica da tener sempre presente nell’esame e nell’approfondimento dello svolgimento storico, se si vuol fare storia integrale e non storie parziali od estrinseche.
Q10b §1 Atteggiamento del Croce durante la guerra mondiale. Scritti di Croce in proposito raccolti nelle Pagine sulla guerra (Laterza, 2a ed. accresciuta, L. 25); sarebbe interessante però rivederli nella prima stesura, a mano a mano che furono pubblicati nella «Critica» o in altri periodici e tener conto delle altre quistioni di carattere culturale e morale che contemporaneamente interessavano il Croce e mostrano a quali altri svolgimenti connessi più o meno direttamente alla situazione bellica egli credeva necessario reagire. L’atteggiamento del Croce durante la neutralità e la guerra indica quali interessi intellettuali e morali (e quindi sociali) predominano anche oggi nella sua attività letteraria e filosofica. Il Croce reagisce contro l’impostazione popolare (con la conseguente propaganda) della guerra come guerra di civiltà e quindi a carattere religioso, ciò che teoricamente dovrebbe portare all’annientamento del nemico.
Il Croce vede nel momento della pace quello della guerra e nel momento della guerra quello della pace e lotta perché non siano mai distrutte le possibilità di mediazione tra i due momenti. La pace dovrà succedere alla guerra e la pace può costringere ad aggruppamenti ben diversi da quelli della guerra: ma come sarebbe possibile una collaborazione tra Stati dopo lo scatenamento di fanatismi religiosi della guerra? Ne risulta che nessuna necessità immediata di politica può e deve essere innalzata a criterio universale. Ma questi termini non comprendono esattamente l’atteggiamento del Croce. Non si può dire, infatti, che egli sia contro l’impostazione «religiosa» della guerra in quanto ciò è necessario politicamente perché le grandi masse popolari mobilitate siano disposte a sacrificarsi in trincea e a morire: è questo un problema di tecnica politica che spetta di risolvere ai tecnici della politica.
Ciò che importa al Croce è che gli intellettuali non si abbassino al livello della massa, ma capiscano che altro è l’ideologia, strumento pratico per governare, e altro la filosofia e la religione che non deve essere prostituita nella coscienza degli stessi sacerdoti. Gli intellettuali devono essere governanti e non governati, costruttori di ideologie per governare gli altri e non ciarlatani che si lasciano mordere e avvelenare dalle proprie vipere. Il Croce quindi rappresenta la grande politica contro la piccola politica, il machiavellismo di Machiavelli contro il machiavellismo di Stenterello. Egli pone se stesso molto in alto e certamente pensa che anche le critiche furibonde e gli attacchi personali i più selvaggi sono «politicamente» necessari e utili perché questa sua alta posizione sia possibile da mantenere. L’atteggiamento di Croce durante la guerra può essere paragonato solo a quello del Papa, che era il capo dei vescovi che benedicevano le armi dei tedeschi e degli austriaci e di quelli che benedicevano le armi degli italiani e dei francesi, senza che in ciò ci fosse contraddizione. Cfr Etica e Politica, p. 343: «Uomini di Chiesa, che qui bisogna intendere, come la Chiesa stessa ecc.».
Questo stesso atteggiamento, che non è privo di inconvenienti, lo si trova in Croce verso il modernismo. Di fatto, poiché non è possibile pensare un passaggio delle masse popolari dallo stadio religioso a quello «filosofico», e il modernismo praticamente erodeva la massiccia struttura pratico‑ideologica della Chiesa, l’atteggiamento del Croce servì a rinsaldare le posizioni della Chiesa. Così il suo atteggiamento «revisionistico» servì a rinsaldare le correnti reazionarie (al Labriola che glielo faceva notare il Croce rispondeva: «quanto alla politica e ai conati reazionari, caveant consules»). Così il suo avvicinarsi a «Politica» nel 1920 e i suoi veri e propri atteggiamenti pratici a Napoli (discorsi ecc., partecipazione al governo Giolitti ecc.). La posizione di «puro intellettuale» diventa o un vero e proprio «giacobinismo» deteriore (e in tal senso, mutate le stature intellettuali, Amadeo può essere avvicinato al Croce, come forse non pensava Jacques Mesnil) o un «ponziopilatismo» spregevole, o successivamente l’uno e l’altro o anche simultaneamente l’uno e l’altro.
Per la guerra si può riferite al Croce l’osservazione di Lyautey: in realtà il sentimento nazionale dei sedicenti nazionalisti è «temperato» da un cosmopolitismo talmente accentuato, di casta, di cultura ecc., che può essere ritenuto un vero e proprio strumento di governo e le sue «passioni» essere ritenute non immediate, ma subordinate al possesso del potere.
Q10b §2 Croce come leader intellettuale delle correnti revisionistiche della fine del secolo XIX. Nella lettera di Giorgio Sorel al Croce in data 9 settembre 1899 è scritto: «Bernstein vient de m’écrire qu’il a indiqué dans la “Neue Zeit” n. 46 qu’il avait été inspiré, en une certaine mesure, par vos travaux. Cela est intéressant, parce que les Allemands ne sont pas faits pour indiquer des sources étrangères à leurs idées». Dei rapporti intellettuali tra il Sorel e il Croce esiste oggi una documentazione molto importante nell’epistolario del Sorel al Croce pubblicato dalla «Critica» (1927 sgg.): appare che la dipendenza intellettuale del Sorel dal Croce è stata più grande di ciò che prima potesse pensarsi. I saggi del Croce revisionista sono pubblicati nel volume sul Materialismo storico, ma ad essi occorre aggiungere il cap. XI del primo volume delle Conversazioni critiche. Nel revisionismo crociano occorre fissare dei limiti, e di questa prima fase mi pare il limite sia da trovare nella intervista col prof. Castellano pubblicata nella «Voce» e riprodotta nel volume Cultura e Vita Morale. La riduzione del Croce del materialismo storico a canone di interpretazione della storia irrobustisce criticamente l’indirizzo «economico‑giuridico» nella scuola italiana.
Q10b §3 Elaborazione della teoria della storia etico‑politica. Croce «approfondisce» sistematicamente i suoi studi di teoria della storia e questa nuova fase è rappresentata dal volume Teoria e storia della Storiografia. Ma il più significativo della biografia scientifica del Croce è che egli continua a considerarsi il leader intellettuale dei revisionisti e la sua ulteriore elaborazione della teoria storiografica è condotta con questa preoccupazione: egli vuole giungere alla liquidazione del materialismo storico ma vuole che questo svolgimento avvenga in modo da identificarsi con un movimento culturale europeo. L’affermazione, fatta durante la guerra, che la guerra stessa può dirsi la «guerra del materialismo storico»; gli sviluppi storici e culturali nell’Europa orientale dal 1917 in poi: questi due elementi determinano il Croce a svolgere con maggior precisione la sua teoria storiografica che dovrebbe liquidare ogni forma, anche attenuata, di filosofia della praxis (già prima della guerra teorie «attivistiche», fondate su concezioni irrazionalistiche – sviluppo di esse nel dopoguerra – reazione del Croce: cfr Storia d’Italia e poi discorsi e scritti su «Storia e Antistoria»). Che le teorie storiografiche siano rivolte contro la filosofia della praxis dice il Croce esplicitamente in una breve polemica con Corrado Barbagallo pubblicata nella «Nuova Rivista Storica» del 1928‑29. (È da notare l’atteggiamento del prof. Luigi Einaudi verso alcune pubblicazioni del Croce che esprimono questa fase «liquidazionista». Secondo Einaudi, il Croce fa ancora troppe concessioni alla filosofia della praxis, col riconoscere a questo movimento di cultura determinate benemerenze scientifiche).
La documentazione del fatto che il Croce sente con forza di essere il leader di una corrente intellettuale europea, e giudica di grande momento la sua posizione con gli obblighi che ne derivano si può vedere specialmente nella Storia d’Italia, ma risulta anche da tutta una serie di scritti occasionali e recensioni pubblicati nella «Critica». Occorre ricordare anche certi riconoscimenti che di tale funzione dirigente sono documentati: il più curioso è quello del Bonomi nel suo libro sul Bissolati (sarebbe interessante vedere se il Bonomi si riferiva al Croce nelle sue Vie Nuove). Prefazione dello Schiavi al libro del De Man. Per il periodo 90-900 è interessante la lettera di Orazio Raimondo stampata dal prof. Castellano nel suo volume sulla fortuna delle idee crociane (Introduzione allo studio delle opere di B. Croce, Laterza, Bari).
Q10b §4 Elementi della relativa popolarità del pensiero del Croce, tanto più notevole in quanto nel Croce non c’è niente che possa colpire la fantasia e suscitare forti passioni o dar luogo a movimenti di carattere romantico (non si tien conto, in questo punto, della popolarità delle idee estetiche del Croce che hanno alimentato una letteratura giornalistica da dilettanti). Un elemento è quello stilistico‑letterario. Beniamin Crémieux ha scritto che Croce è il più grande prosatore italiano dopo il Manzoni, ma forse questo riferimento può suscitare preconcetti errati; mi pare più esatto collocare gli scritti del Croce nella linea della prosa scientifica italiana che ha avuto scrittori come il Galileo. Altro elemento è quello etico e cioè risiede nella fermezza di carattere di cui il Croce ha dato prova in parecchi momenti della vita nazionale ed europea, come l’atteggiamento mantenuto durante la guerra e in seguito, atteggiamento che si può chiamare goethiano; mentre tanti intellettuali perdevano la testa, e non sapevano orientarsi nel caos generale, rinnegavano il proprio passato, ondeggiavano lamentosamente nel dubbio di chi fosse per essere il più forte, il Croce è rimasto imperturbabile nella sua serenità e nell’affermazione della sua fede che «metafisicamente il male non può prevalere e che la storia è razionalità».
Ma occorre dire che l’elemento più importante della popolarità del Croce è intrinseco al suo stesso pensiero e al metodo del suo pensare ed è da ricercare nella maggiore adesione alla vita della filosofia del Croce che di qualsiasi altra filosofia speculativa. Da questo punto di vista è interessante lo scritto di Croce intitolato «Il filosofo» (ristampato in Eternità e storicità della filosofia, Rieti, 1930; e tutti gli scritti raccolti in questo volumetto) in cui, in forma brillante, sono fissate le principali caratteristiche che distinguono l’attività del Croce da quella dei «filosofi» tradizionali. Dissoluzione del concetto di «sistema» chiuso e definito e quindi pedantesco e astruso in filosofia: affermazione che la filosofia deve risolvere i problemi che il processo storico nel suo svolgimento presenta volta a volta. La sistematicità è ricercata non in una esterna struttura architettonica ma nell’intima coerenza e feconda comprensività di ogni soluzione particolare. Il pensiero filosofico non è concepito quindi come uno svolgimento – da pensiero altro pensiero – ma pensiero dalla realtà storica. Questa impostazione spiega la popolarità del Croce nei paesi anglosassoni, superiore a quella dei paesi germanici; gli anglosassoni hanno sempre preferito le concezioni del mondo che non si presentavano come grandi e farraginosi sistemi ma come espressione del senso comune, integrato dalla critica e dalla riflessione, come soluzione di problemi morali e pratici.
Il Croce ha scritto centinaia e centinaia di brevi saggi (recensioni, postille) nei quali il suo pensiero idealistico circola intimamente, senza pedanterie scolastiche; ogni soluzione sembra a sé stante, accettabile indipendentemente dalle altre soluzioni, in quanto è appunto presentata come espressione del comune buon senso. Ancora: l’attività del Croce si presenta essenzialmente come critica, incomincia col distruggere una serie di pregiudizi tradizionali, col mostrare falsi e inconcludenti una serie di problemi che erano il comico «dada» dei filosofi precedenti, ecc., identificandosi in ciò con l’atteggiamento che verso questo vecchiume aveva sempre mostrato il senso comune.
Q10b §5 Croce e la religione. La posizione del Croce verso la religione è uno dei punti più importanti da analizzare per comprendere il significato storico del crocismo nella storia della cultura italiana. Per il Croce la religione è una concezione della realtà con una morale conforme a questa concezione, presentata in forma mitologica. Pertanto è religione ogni filosofia, cioè ogni concezione del mondo, in quanto è diventata «fede», cioè considerata non come attività teoretica (di creazione di nuovo pensiero) ma come stimolo all’azione (attività etico‑politica concreta, di creazione di nuova storia). Il Croce tuttavia è molto cauto nei suoi rapporti con la religione tradizionale: lo scritto più «avanzato», è il capitolo iv dei «Frammenti di Etica» (p. 23 del volume Etica e politica), Religione e serenità, che fu pubblicato la prima volta durante la guerra, verso la fine del 1916 o ai primi del 1917. Sebbene il Croce non pare voglia fare nessuna concessione intellettuale alla religione (neppure del genere molto equivoco di quelle che fa il Gentile) e a ogni forma di misticismo, tuttavia il suo atteggiamento è tutt’altro che combattivo e militante. Questa posizione è anzi molto significativa e da mettere in rilievo. Una concezione del mondo non può rivelarsi valida a permeare tutta una società e a diventare «fede» se non quando dimostra di essere capace di sostituire le concezioni e fedi precedenti in tutti i gradi della vita statale. Ricorrere alla teoria hegeliana della religione mitologica come filosofia delle società primitive l’infanzia dell’umanità per giustificare l’insegnamento confessionale sia pure nelle sole scuole elementari, non significa altro se non ripresentare sofisticata la formula della «religione buona per il popolo» e in realtà abdicare e capitolare dinanzi all’organizzazione clericale. Non può non essere rilevato inoltre che una fede che non si riesce a tradurre in termini «popolari» mostra per ciò stesso di essere caratteristica di un determinato gruppo sociale.
Nonostante questa posizione verso la religione, la filosofia del Croce è stata molto studiata dai cattolici del gruppo neo‑scolastico e soluzioni di problemi particolari sono state accolte dall’Olgiati e dal Chiocchetti (il libro dell’Olgiati su Marx è costruito con materiali critici crociani; il Chiocchetti nel suo volume sulla Filosofia di B. Croce difende l’accoglimento di alcune dottrine crociane, come quella dell’origine pratica dell’errore). C’è stato un periodo in cui i neo-scolastici, che avevano rappresentato il tentativo di incorporare nel tomismo le moderne dottrine scientifiche e il positivismo del secolo XIX, di fronte al discredito che il positivismo godeva fra gli intellettuali e alle fortune del neoidealismo, tentarono di trovare un terreno d’accordo tra il tomismo e l’idealismo e quindi una certa fortuna, tra loro, delle filosofie del Croce e del Gentile. Da qualche tempo i neoscolastici stanno concentrandosi su un terreno più ristretto e più proprio, e combattono contro ogni infiltrazione idealistica nelle loro dottrine: certo essi credono di poter ereditare tutto ciò che può essere salvato del positivismo e di appropriarselo, diventando i soli oppositori teorici dell’idealismo.
Oggi l’opposizione dei cattolici al Croce si va intensificando, per ragioni specialmente pratiche (è molto diverso l’atteggiamento critico della «Civiltà Cattolica» verso il Croce e verso il Gentile); i cattolici capiscono molto bene che il significato e la funzione intellettuale del Croce non sono paragonabili a quelli dei filosofi tradizionali, ma sono quelli di un vero riformatore religioso, che per lo meno riesce a mantenere il distacco tra intellettuali e cattolicismo e quindi a rendere, in una certa misura, difficile anche una forte ripresa clericale nelle masse popolari. Per il Croce, «dopo Cristo siamo diventati tutti cristiani», cioè la parte vitale del cristianesimo è stata assorbita dalla civiltà moderna e si può vivere senza «religione mitologica».
La polemica anticrociana da parte di cattolici laici non è di molto momento: sono da ricordare l’articolo di Giovanni Papini Il Croce e la Croce nella «Nuova Antologia» del 1° marzo 1932 e quello di Aldo Ferrabino L’Europa in Utopia nella «Nuova Antologia» del 1° aprile 1932.
Nota 1a. L’osservazione di maggior rilievo fatta dal Papini alla Storia d’Europa, e che sia congruente, è quella riguardante gli ordini religiosi. Ma l’osservazione non è valida, poiché è verissimo che dopo il Concilio di Trento e la fondazione della Compagnia di Gesù, non sorse più nessun grande ordine religiosamente attivo e fecondo di nuove o rinnovate correnti di sentimento cristiano; sorsero nuovi ordini, è vero, ma essi ebbero un carattere, per così dire, prevalentemente amministrativo e corporativo. Il giansenismo e il modernismo, che furono i due grandi movimenti religiosi e rinnovatori che sorsero nel seno della Chiesa in questo periodo, non hanno suscitato ordini nuovi o rinnovato i vecchi.
Nota 2a. L’articolo del Ferrabino è più notevole per una certa rivendicazione di realismo storico contro le astrazioni speculative. Ma è astratto anch’esso e presenta un’improvvisazione interpretativa della storia del secolo XIX molto sconnessa e di carattere cattolico‑rettorico, con prevalenza della rettorica. Il rilievo a p. 348 riguardante Marx è anacronistico, poiché le teorie marxiste sullo Stato erano tutte elaborate prima della fondazione dell’Impero tedesco e anzi furono abbandonate dalla socialdemocrazia proprio nel periodo di espansione del principio imperiale, ciò che mostra, al contrario di quanto scrive il Ferrabino, come l’Impero ebbe la capacità di influenzare e assimilare tutte le forze sociali della Germania.
Q10b §6 Croce e la tradizione storiografica italiana. Si può dire che la storiografia del Croce è una rinascita della storiografia della Restaurazione adattata alle necessità e agli interessi del periodo attuale. Il Croce continua la storiografia della corrente neoguelfa di prima del 48 come fu irrobustita attraverso l’hegelismo dai moderati che dopo il 48 continuarono la corrente neoguelfa. Questa storiografia è un hegelismo degenerato e mutilato, perché la sua preoccupazione fondamentale è un timor panico dei movimenti giacobini, di ogni intervento attivo delle grandi masse popolari come fattore di progresso storico. È da vedere come la formula critica di Vincenzo Cuoco sulle «rivoluzioni passive», che quando fu emessa (dopo il tragico esperimento della Repubblica Partenopea del 1799) aveva un valore di avvertimento e avrebbe dovuto creare una morale nazionale di maggiore energia e di iniziativa rivoluzionaria popolare, si convertì, attraverso il cervello e il panico sociale dei neoguelfi‑moderati, in una concezione positiva, in un programma politico e in una morale che dietro i rutilanti orpelli retorici e nazionalistici di «primato», di «iniziativa italiana», di «l’Italia farà da sé», nascondeva l’inquietezza dell’«apprendista negromante» e l’intenzione di abdicare e capitolare alla prima minaccia seria di una rivoluzione italiana profondamente popolare, cioè radicalmente nazionale.
Un fenomeno culturale paragonabile a quello dei
neoguelfi‑moderati, sebbene in una posizione storico‑politica
più avanzata, è il sistema di ideologia del Proudhon in Francia.
Sebbene l’affermazione possa apparire paradossale, mi pare si
possa dire che il Proudhon è il Gioberti della situazione
francese poiché Proudhon ha verso il movimento operaio francese
la stessa posizione del Gioberti di fronte al movimento
liberale‑nazionale italiano. Si ha nel Proudhon una stessa
mutilazione dell’hegelismo e della dialettica che nei moderati
italiani e pertanto la critica a questa concezione
politico‑storiografica è la stessa, sempre viva e attuale,
contenuta nella Miseria della filosofia. Questa concezione fu
definita da Edgar Quinet di «rivoluzione‑restaurazione» che non
è se non la traduzione francese del concetto di «rivoluzione
passiva» interpretato «positivamente» dai moderati italiani.
L’errore filosofico (di origine pratica!) di tale concezione
consiste in ciò che nel processo dialettico si presuppone
«meccanicamente» che la tesi debba essere «conservata»
dall’antitesi per non distruggere il processo stesso, che
pertanto viene «preveduto», come una ripetizione all’infinito,
meccanica, arbitrariamente prefissata. In realtà si tratta di
uno dei tanti modi di «mettere le brache al mondo», di una delle
tante forme di razionalismo antistoricistico.
La concezione hegeliana, pur nella sua forma speculativa, non
consente tali addomesticamenti e costrizioni mutilatrici, pur
non dando luogo con ciò a forme di irrazionalismo e
arbitrarietà, come quelle contenute nella concezione
bergsoniana. Nella storia reale l’antitesi tende a distruggere
la tesi, la sintesi sarà un superamento, ma senza che si possa a
priori stabilire ciò che della tesi sarà «conservato» nella
sintesi, senza che si possa a priori «misurare» i colpi come in
un «ring» convenzionalmente regolato. Che questo poi avvenga di
fatto è quistione di «politica» immediata, perché nella storia
reale il processo dialettico si sminuzza in momenti parziali
innumerevoli; l’errore è di elevare a momento metodico ciò che è
pura immediatezza, elevando appunto l’ideologia a filosofia
(sarebbe come se si ritenesse elemento «matematico» ciò che
risulta da questo apologo: si domanda a un bambino: – tu hai una
mela, ne dai la metà a tuo fratello; quanta mela mangerai tu? –
Il bambino risponde: – una mela. – Ma come; non hai dato mezza
mela a tuo fratello? – Ma io non gliela ho data, ecc. Nel
sistema logico si introduce l’elemento passionale immediato e
poi si pretende che rimanga valido il valore strumentale del
sistema).
Che un tal modo di concepire la dialettica fosse errato e «politicamente» pericoloso, si accorsero gli stessi moderati hegeliani del Risorgimento come lo Spaventa: basta ricordare le sue osservazioni su quelli che vorrebbero, con la scusa che il momento dell’autorità è imprescindibile e necessario, conservare l’uomo sempre in «culla» e in schiavitù. Ma non potevano reagire oltre certi limiti, oltre i limiti del loro gruppo sociale che si trattava «concretamente» di far uscire di «culla»: la composizione fu trovata nella concezione «rivoluzione‑restaurazione» ossia in un conservatorismo riformistico temperato. Si può osservare che un tal modo di concepire la dialettica è proprio degli intellettuali, i quali concepiscono se stessi come gli arbitri e i mediatori delle lotte politiche reali, quelli che impersonano la «catarsi» dal momento economico al momento etico‑politico, cioè la sintesi del processo dialettico stesso, sintesi che essi «manipolano» speculativamente nel loro cervello dosandone gli elementi «arbitrariamente» (cioè passionalmente). Questa posizione giustifica il loro non «impegnarsi» interamente nell’atto storico reale ed è indubbiamente comoda: è la posizione di Erasmo nei confronti della Riforma.
Q10b §7 Definizione del concetto di storia etico‑politica. Si osserva che la storia etico‑politica è una ipostasi arbitraria e meccanica del momento dell’egemonia, della direzione politica, del consenso, nella vita e nello svolgimento dell’attività dello Stato e della società civile. Questa impostazione che il Croce ha fatto del problema storiografico riproduce la sua impostazione del problema estetico; il momento etico‑politico è nella storia ciò che il momento della «forma» è nell’arte; è la «liricità» della storia, la «catarsi» della storia. Ma le cose non sono così semplici nella storia come nell’arte. Nell’arte la produzione di «liricità» è individuata perfettamente in un mondo culturale personalizzato, nel quale si può ammettere l’identificazione di contenuto e forma e la così detta dialettica dei distinti nell’unità dello spirito (si tratta solo di tradurre in linguaggio storicistico il linguaggio speculativo, nel trovare cioè se questo linguaggio speculativo ha un valore strumentale concreto che sia superiore ai precedenti valori strumentali). Ma nella storia e nella produzione della storia la rappresentazione «individualizzata» degli Stati e delle Nazioni è una mera metafora.
Le «distinzioni» che in tali rappresentazioni occorre fare non sono e non possono essere presentate «speculativamente» sotto pena di cadere in una nuova forma di rettorica e in una nuova specie di «sociologia», che per essere «speculativa» non sarebbe meno un’astratta e meccanica sociologia: esse esistono come distinzioni di gruppi «verticali» e come stratificazioni «orizzontali», cioè come una coesistenza e giustapposizione di civiltà e culture diverse, connesse dalla coercizione statale e organizzate culturalmente in una «coscienza morale», contradditoria e nello stesso tempo «sincretistica». A questo punto occorre una critica della concezione crociana del momento politico come momento della «passione» (inconcepibilità di una «passione» permanente e sistematica), la sua negazione dei «partiti politici» (che sono appunto la manifestazione concreta della inconcepibile permanenza passionale, la prova della contraddizione intima del concetto «politica‑passione») e quindi l’inesplicabilità degli eserciti permanenti e dell’esistenza organizzata della burocrazia militare e civile, e la necessità per il Croce e per la filosofia crociana di essere la matrice dell’«attualismo» gentiliano. Infatti solo in una filosofia ultra speculativa come quella attualistica, queste contraddizioni e insufficienze della filosofia crociana trovano una composizione formale e verbale, ma nello stesso tempo l’attualismo mostra in modo più evidente il carattere poco concreto della filosofia, del Croce, così come il «solipsismo» documenta l’intima debolezza della concezione soggettiva‑speculativa della realtà.
Che la storia etico‑politica sia la storia del momento dell’egemonia si può vedere da tutta una serie di scritti teorici del Croce (e non solo da quelli contenuti nel volume Etica e politica); di questi scritti occorrerà fare un’analisi concreta. Si può vedere anche e specialmente da alcuni accenni sparsi sul concetto di Stato. Per esempio in qualche luogo il Croce ha affermato che non sempre occorre ricercare lo «Stato» là dove lo indicherebbero le istituzioni ufficiali, perché talvolta esso potrebbe trovarsi invece nei partiti rivoluzionari: l’affermazione non è paradossale secondo la concezione Stato ‑ egemonia ‑ coscienza morale, perché può infatti accadere che la direzione politica e morale del paese in un determinato frangente non sia esercitata dal governo legale ma da una organizzazione «privata» e anche da un partito rivoluzionario. Ma non è difficile mostrare quanto sia arbitraria la generalizzazione che fa il Croce di questa osservazione di senso comune.
Il problema più importante da discutere in questo paragrafo è questo: se la filosofia della praxis escluda la storia etico‑politica, cioè non riconosca la realtà di un momento dell’egemonia, non dia importanza alla direzione culturale e morale e giudichi realmente come «apparenze» i fatti di superstruttura. Si può dire che non solo la filosofia della praxis non esclude la storia etico‑politica, ma che anzi la fase più recente di sviluppo di essa consiste appunto nella rivendicazione del momento dell’egemonia come essenziale nella sua concezione statale e nella «valorizzazione» del fatto culturale, dell’attività culturale, di un fronte culturale come necessario accanto a quelli meramente economici e meramente politici. Il Croce ha il torto grave di non applicare alla critica della filosofia della praxis i criteri metodologici che applica allo studio di correnti filosofiche molto meno importanti e significative. Se questi criteri impiegasse potrebbe trovare che il giudizio contenuto nel termine «apparenze» per le superstrutture è niente altro che il giudizio della «storicità» di esse espresso in polemica con concezioni dogmatiche popolari e quindi con un linguaggio «metaforico» adatto al pubblico cui è destinato. La filosofia della praxis criticherà quindi come indebita e arbitraria la riduzione della storia a sola storia etico‑politica, ma non escluderà questa. L’opposizione tra il crocismo e la filosofia della praxis è da ricercare nel carattere speculativo del crocismo.
Rapporti delle teorie crociane sulla storia etico‑politica o storia «religiosa» con le teorie storiografiche di Fustel de Coulanges quali sono contenute nel libro sulla Città Antica. È da notare che la Città Antica è stata pubblicata dal Laterza proprio negli anni scorsi (forse nel 1928) più di 40 anni dopo che fu scritta (Fustel de Coulanges è morto nel 1889), e subito dopo che una traduzione ne era stata offerta dall’editore Vallecchi. È da pensare che l’attenzione del Croce sia stata attirata dal libro francese mentre elaborava le sue teorie e preparava i suoi libri. È da ricordare che nel Contributo alla critica di me stesso, nelle ultime righe (1915), il Croce annunzia di voler scrivere la Storia d’Europa. Sono le riflessioni sulla guerra che l’hanno orientato verso questi problemi storiografici e di scienza politica.
Q10b §8 Trascendenza – teologia – speculazione. Il Croce coglie ogni occasione per mettere in rilievo come egli, nella sua attività di pensatore, abbia studiosamente cercato di espungere dalla sua filosofia ogni traccia e residuo di trascendenza e di teologia e quindi di metafisica, intesa nel senso tradizionale. Così egli, in confronto del concetto di «sistema» ha messo in valore il concetto di problema filosofico, così egli ha negato che il pensiero produca altro pensiero, astrattamente, ed ha affermato che i problemi che il filosofo deve risolvere, non sono una filiazione astratta del precedente pensiero filosofico, ma sono proposti dallo svolgimento storico attuale, ecc. Il Croce è giunto fino ad affermare che la sua ulteriore e recente critica della filosofia della praxis è appunto connessa a questa sua preoccupazione antimetafisica e antiteologica, in quanto la filosofia della praxis sarebbe teologizzante e il concetto di «struttura» non sarebbe che la ripresentazione ingenua del concetto di un «dio ascoso».
Bisogna riconoscere gli sforzi del Croce per fare aderire alla vita la filosofia idealistica, e tra i suoi contributi positivi allo sviluppo della scienza sarà da annoverare la sua lotta contro la trascendenza e la teologia nelle loro forme peculiari al pensiero religioso‑confessionale. Ma che il Croce sia riuscito nel suo intento in modo conseguente non è possibile ammettere: la filosofia del Croce rimane una filosofia «speculativa» e in ciò non è solo una traccia di trascendenza e di teologia, ma è tutta la trascendenza e la teologia, appena liberate dalla più grossolana scorza mitologica. La stessa impossibilità in cui pare si trovi il Croce di comprendere l’assunto della filosofia della praxis (tanto da lasciare l’impressione che si tratti non di una grossolana ignorantia elenchi ma di una gherminella polemica meschina e avvocatesca) mostra come il pregiudizio speculativo lo acciechi e lo devii.
La filosofia della praxis deriva certamente dalla concezione immanentistica della realtà, ma da essa in quanto depurata da ogni aroma speculativo e ridotta a pura storia o storicità o a puro umanesimo. Se il concetto di struttura viene concepito «speculativamente», certo esso diventa un «dio ascoso»; ma appunto esso non deve essere concepito speculativamente, ma storicamente, come l’insieme dei rapporti sociali in cui gli uomini reali si muovono e operano, come un insieme di condizioni oggettive che possono e debbono essere studiate coi metodi della «filologia» e non della «speculazione». Come un «certo» che sarà anche «vero», ma che deve essere studiato prima di tutto nella sua «certezza» per essere studiato come «verità». Non solo la filosofia della praxis è connessa all’immanentismo, ma anche alla concezione soggettiva della realtà, in quanto appunto la capovolge, spiegandola come fatto storico, come «soggettività storica di un gruppo sociale», come fatto reale, che si presenta come fenomeno di «speculazione» filosofica ed è semplicemente un atto pratico, la forma di un contenuto concreto sociale e il modo di condurre l’insieme della società a foggiarsi una unità morale. L’affermazione che si tratti di «apparenza», non ha nessun significato trascendente e metafisico, ma è la semplice affermazione della sua «storicità», del suo essere «morte‑vita», del suo rendersi caduca perché una nuova coscienza sociale e morale si sta sviluppando, più comprensiva, superiore, che si pone come sola «vita», come sola «realtà» in confronto del passato morto e duro a morire nello stesso tempo. La filosofia della praxis è la concezione storicistica della realtà, che si è liberata da ogni residuo di trascendenza e di teologia anche nella loro ultima incarnazione speculativa; lo storicismo idealistico crociano rimane ancora nella fase teologico‑speculativa.
Q10b §9 Paradigmi di storia etico‑politica. La Storia dell’Europa nel secolo XIX pare sia il saggio di storia etico‑politica che deve diventare il paradigma della storiografia crociana offerto alla cultura europea. Ma occorre tener conto degli altri saggi: Storia del regno di Napoli, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, e anche La rivoluzione napoletana del 1799 e Storia dell’età barocca in Italia. I più tendenziosi e dimostrativi sono però la Storia d’Europa e la Storia d’Italia. Per questi due saggi si pongono subito le domande: è possibile scrivere (concepire) una storia d’Europa nel secolo XIX senza trattare organicamente della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche? e può farsi una storia d’Italia nell’età moderna senza trattare delle lotte del Risorgimento? Ossia: è a caso o per una ragione tendenziosa che il Croce inizia le sue narrazioni dal 1815 e dal 1871? cioè prescinde dal momento della lotta, dal momento in cui si elaborano e radunano e schierano le forze in contrasto? dal momento in cui un sistema etico‑politico si dissolve e un altro si elabora nel fuoco e col ferro? in cui un sistema di rapporti sociali si sconnette e decade e un altro sistema sorge e si afferma? e invece assume placidamente come storia il momento dell’espansione culturale o etico‑politico? Si può dire pertanto che il libro sulla Storia d’Europa non è altro che un frammento di storia, l’aspetto «passivo» della grande rivoluzione che si iniziò in Francia nel 1789, traboccò nel resto d’Europa con le armate repubblicane e napoleoniche, dando una potente spallata ai vecchi regimi, e determinandone non il crollo immediato come in Francia, ma la corrosione «riformistica» che durò fino al 1870.
Si pone il problema se questa elaborazione crociana, nella sua tendenziosità non abbia un riferimento attuale e immediato, non abbia il fine di creare un movimento ideologico corrispondente a quello del tempo trattato dal Croce, di restaurazione‑rivoluzione, in cui le esigenze che trovarono in Francia una espressione giacobino‑napoleonica furono soddisfatte a piccole dosi, legalmente, riformisticamente, e si riuscì così a salvare la posizione politica ed economica delle vecchie classi feudali, a evitare la riforma agraria e specialmente a evitare che le masse popolari attraversassero un periodo di esperienze politiche come quelle verificatesi in Francia negli anni del giacobinismo, nel 1831, nel 1848. Ma nelle condizioni attuali il movimento corrispondente a quello del liberalismo moderato e conservatore non sarebbe più precisamente il movimento fascista? Forse non è senza significato che nei primi anni del suo sviluppo il fascismo affermasse di riannodarsi alla tradizione della vecchia destra o destra storica. Potrebbe essere una delle tante manifestazioni paradossali della storia (un’astuzia della natura, per dirla vichianamente) questa per cui il Croce, mosso da preoccupazioni determinate, giungesse a contribuire a un rafforzamento del fascismo, fornendogli indirettamente una giustificazione mentale dopo aver contribuito a depurarlo di alcune caratteristiche secondare, di ordine superficialmente romantico ma non perciò meno irritanti per la compostezza classica del Goethe.
L’ipotesi ideologica potrebbe essere presentata in questi termini: si avrebbe una rivoluzione passiva nel fatto che per l’intervento legislativo dello Stato e attraverso l’organizzazione corporativa, nella struttura economica del paese verrebbero introdotte modificazioni più o meno profonde per accentuare l’elemento «piano di produzione», verrebbe accentuata cioè la socializzazione e cooperazione della produzione senza per ciò toccare (o limitandosi solo a regolare e controllare) l’appropriazione individuale e di gruppo del profitto. Nel quadro concreto dei rapporti sociali italiani questa potrebbe essere l’unica soluzione per sviluppare le forze produttive dell’industria sotto la direzione delle classi dirigenti tradizionali, in concorrenza con le più avanzate formazioni industriali di paesi che monopolizzano le materie prime e hanno accumulato capitali imponenti.
Che tale schema possa tradursi in pratica e in quale misura e in quali forme, ha un valore relativo: ciò che importa politicamente e ideologicamente è che esso può avere ed ha realmente la virtù di prestarsi a creare un periodo di attesa e di speranze, specialmente in certi gruppi sociali italiani, come la grande massa dei piccoli borghesi urbani e rurali, e quindi a mantenere il sistema egemonico e le forze di coercizione militare e civile a disposizione delle classi dirigenti tradizionali. Questa ideologia servirebbe come elemento di una «guerra di posizione» nel campo economico (la libera concorrenza e il libero scambio corrisponderebbero alla guerra di movimento) internazionale, così come la «rivoluzione passiva» lo è nel campo politico. Nell’Europa dal 1789 al 1870 si è avuta una guerra di movimento (politica) nella rivoluzione francese e una lunga guerra di posizione dal 1815 al 1870; nell’epoca attuale, la guerra di movimento si è avuta politicamente dal marzo 1917 al marzo 1921 ed è seguita una guerra di posizione il cui rappresentante, oltre che pratico (per l’Italia), ideologico, per l’Europa, è il fascismo.
Q10b §10 La libertà come identità di storia e di spirito e la libertà come religione-superstizione, come ideologia immediatamente circostanziata, come strumento pratico di governo. Se la storia è storia della libertà – secondo la proposizione di Hegel – la formula è valida per la storia di tutto il genere umano di ogni tempo e di ogni luogo, è libertà anche la storia delle satrapie orientali. Libertà allora significa solo «movimento», svolgimento, dialettica. Anche la storia delle satrapie orientali è stata libertà, perché è stata movimento e svolgimento, tanto è vero che quelle satrapie sono crollate. Ancora: la storia è libertà in quanto è lotta tra libertà e autorità, tra rivoluzione e conservazione, lotta in cui la libertà e la rivoluzione continuamente prevalgono sull’autorità e la conservazione. Ma ogni corrente e ogni partito non sono in tal caso espressioni della libertà, momenti dialettici del processo di libertà? Qual è dunque la caratteristica del secolo XIX in Europa? Non di essere storia della libertà consapevole di esser tale; nel secolo XIX in Europa esiste una coscienza critica prima non esistente, si fa la storia sapendo quello che si fa, sapendo che la storia è storia della libertà, ecc. L’accezione del termine «liberale», in Italia per esempio, è stata in questo periodo molto estesa e comprensiva.
Negli Annali d’Italia di Pietro Vigo liberali sono tutti i non clericali, tutti gli avversari del partito del Sillabo e quindi il liberalismo comprende anche gli Internazionalisti. Ma si è costituita una corrente e un partito che si è specificatamente chiamata liberale, che della posizione speculativa e contemplativa della filosofia hegeliana ha fatto una ideologia politica immediata, uno strumento pratico di dominio e di egemonia sociale, un mezzo di conservazione di particolari istituti politici ed economici fondati nel corso della Rivoluzione francese, e del riflusso che la Rivoluzione francese ebbe in Europa. Un nuovo partito conservatore era nato, una nuova posizione d’autorità si era costituita, e questo nuovo partito tendeva precisamente a fondersi col partito del Sillabo. E questa coalizione sarebbe ancora stata chiamata partito della libertà.
Si pongono alcuni problemi: 1) cosa significa concretamente «libertà» per ognuna delle tendenze europee del secolo XIX? 2) Queste tendenze si muovevano per il concetto di libertà o non piuttosto per il contenuto particolare con cui riempivano il formale concetto di libertà? E il non aver nessun partito centralizzato le aspirazioni delle grandi masse contadine per una riforma agraria non ha appunto impedito a queste masse di diventare fedeli della religione della libertà, ma libertà ha significato per esse solo la libertà e il diritto di conservare le loro superstizioni barbariche, il loro primitivismo e le ha perciò costituite in esercito di riserva del partito del Sillabo? Un concetto come quello di libertà che si presta ad essere impiegato dagli stessi gesuiti, contro i liberali, che diventano libertini di contro ai «veri» partigiani della giusta libertà, non è appunto solo un involucro concettuale che vale solo per il nocciolo reale che ogni gruppo sociale vi pone? E si può quindi parlare di «religione della libertà»? E intanto cosa significa in questo caso «religione»?
Per il Croce è religione ogni concezione del mondo che si presenti come una morale. Ma è avvenuto questo per la «libertà»? Essa è stata religione per un piccolo numero di intellettuali; nelle masse si è presentata come elemento costitutivo di una combinazione o lega ideologica, di cui era parte costitutiva prevalente la vecchia religione cattolica e di cui altro elemento importante, se non decisivo dal punto di vista laico, fu quello di «patria». Né si dica che il concetto di «patria» era un sinonimo di «libertà»; era certo un sinonimo, ma di Stato, cioè d’autorità e non di «libertà», era un elemento di «conservazione» e una sorgente di persecuzioni e di un nuovo Santo Uffizio. Mi pare che il Croce non riesca, neppure dal suo punto di vista, a mantenere la distinzione tra «filosofia» e «ideologia», tra «religione» e «superstizione» che nel suo modo di pensare e nella sua polemica con la filosofia della praxis è essenziale.
Crede di trattare di una filosofia e tratta di una ideologia, crede di trattare di una religione e tratta di una superstizione, crede di scrivere una storia in cui l’elemento di classe sia esorcizzato e invece descrive con grande accuratezza e merito il capolavoro politico per cui una determinata classe riesce a presentare e far accettare le condizioni della sua esistenza e del suo sviluppo di classe come principio universale, come concezione del mondo, come religione, cioè descrive in atto lo sviluppo di un mezzo pratico di governo e di dominio. L’errore di origine pratica non è stato commesso in tal caso dai liberali del secolo XIX, che anzi praticamente hanno trionfato, hanno raggiunto i fini propostisi; l’errore di origine pratica è commesso dal loro storico Croce che dopo aver distinto filosofia da ideologia finisce col confondere una ideologia politica con una concezione del mondo, dimostrando praticamente che la distinzione è impossibile, che non si tratta di due categorie, ma di una stessa categoria storica e che la distinzione è solo di grado; è filosofia la concezione del mondo che rappresenta la vita intellettuale e morale (catarsi di una determinata vita pratica) di un intero gruppo sociale concepito in movimento e visto quindi non solo nei suoi interessi attuali e immediati, ma anche in quelli futuri e mediati; è ideologia ogni particolare concezione dei gruppi interni della classe che si propongono di aiutare la risoluzione di problemi immediati e circoscritti.
Ma per le grandi masse della popolazione governata e diretta, la filosofia o religione del gruppo dirigente e dei suoi intellettuali si presenta sempre come fanatismo e superstizione, come motivo ideologico proprio di una massa servile. E il gruppo dirigente non si propone forse di perpetuare questo stato di cose? Il Croce dovrebbe spiegare come mai la concezione del mondo della libertà non possa diventare elemento pedagogico nell’insegnamento delle scuole elementari e come egli stesso, da ministro, abbia introdotto nelle scuole elementari l’insegnamento della religione confessionale. Questa assenza di «espansività» nelle grandi masse è la testimonianza del carattere ristretto, pratico immediatamente, della filosofia della libertà.
Nota I. A proposito del concetto di autorità e libertà è da meditare specialmente il capitolo «Stato e Chiesa in senso ideale e loro perpetua lotta nella storia» del libro Etica e Politica (pp. 339 e sgg.). Questo capitolo è di estremo interesse perché in esso sono attenuate implicitamente la critica e l’opposizione alla filosofia della praxis e l’elemento «economico» e pratico trova una considerazione nella dialettica storica.
Q10b §11 Si può dire, tuttavia, che nella concezione del Croce, pur dopo l’elaborazione subita in questi ultimi anni, non ci sia più traccia di filosofia della praxis? Lo storicismo del Croce non risente proprio più nessun influsso della sua esperienza intellettuale degli anni dal 90 al 900? La posizione del Croce per questo riguardo risulta da vari scritti; interessanti specialmente la prefazione del 1917 alla nuova edizione del Materialismo storico, la sezione dedicata al materialismo storico nella Storia della Storiografia italiana nel secolo XIX e il Contributo alla critica di me stesso. Ma se interessa ciò che il Croce pensa di se stesso, esso non è sufficiente e non esaurisce la quistione. Secondo il Croce, la sua posizione verso la filosofia della praxis non è quella di un ulteriore sviluppo (di un superamento) per cui la filosofia della praxis sia diventata un momento di una concezione più elaborata, ma il valore dell’esperienza sarebbe stato solo negativo, nel senso che avrebbe contribuito a distruggere pregiudizi, residui passionali, ecc. Per impiegare una metafora presa dal linguaggio della fisica, la filosofia della praxis avrebbe operato nella mentalità del Croce come un corpo catalitico, che è necessario per ottenere il nuovo prodotto, ma di cui non rimane traccia nel prodotto stesso. Ma è poi ciò vero? A me pare che sotto la forma e il linguaggio speculativo sia possibile rintracciare più di un elemento della filosofia della praxis nella concezione del Croce.
Si potrebbe forse dire di più e questa ricerca sarebbe di immenso significato storico e intellettuale nell’epoca presente e cioè: che come la filosofia della praxis è stata la traduzione dell’hegelismo in linguaggio storicistico, così la filosofia del Croce è in una misura volissima una ritraduzione in linguaggio speculativo dello storicismo realistico della filosofia della praxis. Nel febbraio 1917 in un breve corsivo che precedeva la riproduzione dello scritto del Croce Religione e serenità (cfr Etica e Politica, pp. 23‑25) allora uscito di recente nella «Critica» io scrissi che come l’hegelismo era stato la premessa della filosofia della praxis nel secolo XIX, alle origini della civiltà contemporanea, così la filosofia crociana poteva essere la premessa di una ripresa della filosofia della praxis nei giorni nostri, per le nostre generazioni. La quistione era appena accennata, in una forma certo primitiva e certissimamente inadeguata, poiché in quel tempo il concetto di unità di teoria e pratica, di filosofia e politica non era chiaro in me ed io ero tendenzialmente piuttosto crociano. Ma ora, sia pure non colla maturità e la capacità che all’assunto sarebbero necessarie, mi pare che la posizione sia da riprendere, e da presentare in forma criticamente più elaborata. E cioè: occorre rifare per la concezione filosofica del Croce la stessa riduzione che i primi teorici della filosofia della praxis hanno fatto per la concezione hegeliana. È questo il solo modo storicamente fecondo di determinare una ripresa adeguata della filosofia della praxis, di sollevare questa concezione che si è venuta, per la necessità della vita pratica immediata, «volgarizzando», all’altezza che deve raggiungere per la soluzione dei compiti più complessi che lo svolgimento attuale della lotta propone, cioè alla creazione di una nuova cultura integrale, che abbia i caratteri di massa della Riforma protestante e dell’illuminismo francese e abbia i caratteri di classicità della cultura greca e del Rinascimento italiano, una cultura che riprendendo le parole del Carducci sintetizzi Massimiliano Robespierre ed Emanuele Kant, la politica e la filosofia in una unità dialettica intrinseca ad un gruppo sociale non solo francese o tedesco, ma europeo e mondiale. Bisogna che l’eredità della filosofia classica tedesca sia non solo inventariata, ma fatta ridiventare vita operante, e per ciò fare occorre fare i conti con la filosofia di Croce, cioè per noi italiani essere eredi della filosofia classica tedesca significa essere eredi della filosofia crociana, che rappresenta il momento mondiale odierno della filosofia classica tedesca.
Il Croce combatte con troppo accanimento la filosofia della praxis e nella sua lotta ricorre ad alleati paradossali, come il mediocrissimo De Man. Questo accanimento è sospetto, può rivelarsi un alibi per negare una resa dei conti. Occorre invece venire a questa resa di conti, nel modo più ampio e approfondito possibile. Un lavoro di tal genere, un Anti‑Croce che nell’atmosfera culturale moderna potesse avere il significato e l’importanza che ha avuto l’Anti-Dühring per la generazione precedente la guerra mondiale, varrebbe la pena che un intero gruppo di uomini ci dedicasse dieci anni di attività.
Nota I. Le tracce della filosofia della praxis possono trovarsi specialmente nella soluzione che il Croce ha dato di problemi particolari. Un esempio tipico mi pare la dottrina dell’origine pratica dell’errore. In generale si può dire che la polemica contro la filosofia dell’atto puro di Giovanni Gentile ha costretto il Croce a un maggior realismo e a provare un certo fastidio e insofferenza almeno per le esagerazioni del linguaggio speculativo, divenuto gergo e «apriti, sesamo» dei minori fraticelli attualisti.
Nota II. Ma la filosofia del Croce non può essere tuttavia esaminata indipendentemente da quella del Gentile. Un Anti‑Croce deve essere anche un Anti‑Gentile; l’attualismo gentiliano darà gli effetti di chiaroscuro nel quadro che sono necessari per un maggior rilievo.
Q10b §12 Da tutto ciò che è detto precedentemente risulta che la concezione storiografica del Croce della storia come storia etico‑politica non deve essere giudicata una futilità da respingere senz’altro. Occorre invece fissare con grande energia che il pensiero storiografico del Croce, anche nella sua fase più recente, deve essere studiato e meditato con la massima attenzione. Esso rappresenta essenzialmente una reazione all’«economismo» e al meccanicismo fatalista, sebbene si presenti come superamento distruttivo della filosofia della praxis. Anche nel giudizio del pensiero crociano vale il criterio che una corrente filosofica deve essere criticata e valutata non per quello che pretende di essere, ma per quello che è realmente e si manifesta nelle opere storiche concrete. Per la filosofia della praxis lo stesso metodo speculativo non è futilità, ma è stato fecondo di valori «strumentali» del pensiero nello svolgimento della cultura, valori strumentali che la filosofia della praxis si è incorporata (la dialettica, per esempio).
Il pensiero del Croce deve dunque, per lo meno, essere apprezzato come valore strumentale, e così si può dire che esso ha energicamente attirato l’attenzione sull’importanza dei fatti di cultura e di pensiero nello sviluppo della storia, sulla funzione dei grandi intellettuali nella vita organica della società civile e dello Stato, sul momento dell’egemonia e del consenso come forma necessaria del blocco storico concreto. Che ciò non sia «futile» è dimostrato dal fatto che contemporaneamente al Croce, il più grande teorico moderno della filosofia della praxis, nel terreno della lotta e dell’organizzazione politica, con terminologia politica, ha in opposizione alle diverse tendenze «economistiche» rivalutato il fronte di lotta culturale e costruito la dottrina dell’egemonia come complemento della teoria dello Stato‑forza e come forma attuale della dottrina quarantottesca della «rivoluzione permanente». Per la filosofia della praxis, la concezione della storia etico‑politica, in quanto indipendente da ogni concezione realistica, può essere assunta come un «canone empirico» di ricerca storica da tener sempre presente nell’esame e nell’approfondimento dello sviluppo storico, se si vuol fare storia integrale e non storia parziale ed estrinseca (storia delle forze economiche come tali ecc.).
Q10b §13 . 1) Elementi di storia etico‑politica nella filosofia della praxis: concetto di egemonia, rivalutazione del fronte filosofico, studio sistematico della funzione degli intellettuali nella vita statale e storica, dottrina del partito politico come avanguardia di ogni movimento storico progressivo.
2) Croce‑Loria. Si può mostrare che tra il Croce e il Loria la differenza non è poi molto grande nel modo di interpretare la filosofia della praxis. Il Croce, riducendo la filosofia della praxis a un canone pratico di interpretazione storica, col quale si attira l’attenzione degli storici sull’importanza dei fatti economici, non ha fatto che ridurla ad una forma di «economismo». Se si spoglia il Loria di tutte le sue bizzarrie stilistiche e sfrenatezze fantasmagoriche (e certo molto di ciò che è caratteristico del Loria si viene così a perdere) si vede che egli si avvicina al Croce nel nucleo più serio della sua interpretazione (cfr a questo proposito Conversazioni Critiche, I, pp. 291 sgg.).
3) Storia speculativa e necessità di una più grassa Minerva. Leon Battista Alberti ha scritto dei matematici: «Quelli col solo ingegno, separata ogni materia, misurano le forme delle cose. Noi perché vogliamo le cose essere poste da vedere, per questo useremo più grassa Minerva».
4) Se fosse vero, in modo così generico che la storia dell’Europa del secolo XIX è stata storia della libertà, tutta la storia precedente sarebbe stata altrettanto genericamente storia dell’autorità; tutti i secoli precedenti sarebbero stati di uno stesso color bigio e indistinto, senza svolgimento, senza lotta. Inoltre: un principio egemonico (etico‑politico) trionfa dopo aver vinto un altro principio (e averlo assunto come suo momento, direbbe appunto il Croce). Ma perché lo vincerà? Per sue doti intrinseche di carattere «logico» e razionale astratto? Non ricercare le ragioni di questa vittoria significa fare storia esteriormente descrittiva, senza rilievo di nessi necessari e causali. Anche il Borbone rappresentava un principio etico‑politico, impersonava una «religione» che aveva i suoi fedeli nei contadini e nei lazzari.
C’è dunque sempre stata lotta tra due principii egemonici, tra due «religioni», e occorrerà non solo descrivere l’espansione trionfale di una di esse, ma giustificarla storicamente. Bisognerà spiegare perché nel 1848 i contadini croati combatterono contro i liberali milanesi e i contadini lombardo-veneti combatterono contro i liberali viennesi. Allora il nesso reale etico‑politico tra governanti e governati era la persona dell’imperatore o del re («abbiamo scritto ’n bronte, evviva Francische seconde!»), come più tardi il nesso sarà non quello del concetto di libertà, ma il concetto di patria e di nazione. La «religione» popolare sostituita al cattolicismo (o meglio in combinazione con esso) è stata quella del «patriottismo» e del nazionalismo.
Ho letto che durante l’affare Dreyfus uno scienziato francese massone e ministro esplicitamente disse che il suo partito voleva annientare l’influsso della Chiesa in Francia, e poiché la folla aveva bisogno di un fanatismo (i francesi usano in politica il termine «mystique») sarebbe stata organizzata l’esaltazione del sentimento patriottico. Bisogna ricordare, del resto, il significato che assunse il termine «patriotta» durante la Rivoluzione francese (significò certo «liberale» ma con un significato concreto nazionale) e come esso, attraverso le lotte del secolo XIX sia stato sostituito da quello di «repubblicano» per il nuovo significato assunto dal termine patriotta che è diventato monopolio dei nazionalisti e dei destri in generale. Che il contenuto concreto del liberalismo popolare sia stato il concetto di patria e di nazione si può vedere dal suo stesso svolgimento in nazionalismo, e nella lotta contro il nazionalismo da parte sia del Croce, rappresentante della religione della libertà, come del papa, rappresentante del cattolicismo. (In forma popolaresca una documentazione di questa religione popolare della patria si può ricavare dai sonetti sulla Scoperta dell’America di Pascarella).
5) La storia speculativa può essere considerata come un ritorno, in forme letterarie rese più scaltre o meno ingenue dallo sviluppo della capacità critica, a modi di storia già caduti in discredito come vuoti e retoriciNel ms: «cadute in discredito come vuote e retoriche». e registrati in diversi libri dallo stesso Croce. La storia etico‑politica, in quanto prescinde dal concetto di blocco storico in cui contenuto economico sociale e forma etico‑politica si identificano concretamente nella ricostruzione dei vari periodi storici, è niente altro che una presentazione polemica di filosofemi più o meno interessanti, ma non è storia. Nelle scienze naturali ciò equivarrebbe a un ritorno alle classificazioni secondo il colore della pelle, delle piume, del pelo degli animali, e non secondo la struttura anatomica. Il riferimento alle scienze naturali nel materialismo storico e il parlare di «anatomia» della società era solo una metafora e un impulso ad approfondire le ricerche metodologiche e filosofiche. Nella storia degli uomini, che non ha il compito di classificare naturalisticamente i fatti, il «colore della pelle» fa «blocco» con la struttura anatomica e con tutte le funzioni fisiologiche; non si può pensare un individuo «scuoiato» come il vero «individuo», ma neanche l’individuo «disossato» e senza scheletro. Uno scultore, Rodin, ha detto (cfr Maurice Barrès, Mes Cahiers, IV serie): «Si nous n’étions pas prévenus contre le squelette, nous verrions comme il est beau». In un quadro o in una statua di Michelangelo si «vede» lo scheletro delle figure ritratte, si sente la sodezza della struttura sotto i colori o il rilievo del marmo. La storia del Croce rappresenta «figure» disossate, senza scheletro, dalle carni flaccide e cascanti anche sotto il belletto delle veneri letterarie dello scrittore.
6) Il trasformismo come una forma della rivoluzione passiva nel periodo dal 1870 in poi.
7) Per valutare la funzione del Croce nella vita italiana ricordare che tanto le Memorie di Giolitti che quelle di Salandra si concludono con una lettera del Croce.
8) Con linguaggio crociano si può dire che la religione della libertà si oppone alla religione del Sillabo, che nega in tronco la civiltà moderna; la filosofia della praxis è un’«eresia» della religione della libertà, perché è nata nello stesso terreno della civiltà moderna.
QUADERNO 11
Avvertenza
Le contenute in questo quaderno, come negli altri, sono state scritte a penna corrente, per segnare un rapido promemoria. Esse sono tutte da rivedere e controllare minutamente, perché contengono certamente inesattezze, falsi accostamenti, anacronismi. Scritte senza aver presenti i libri cui si accenna, è possibile che dopo il controllo, debbano essere radicalmente corrette perché proprio il contrario di ciò che è scritto risulti vero.
APPUNTI E RIFERIMENTI DI CARATTERE STORICO-CRITICO
Q11 §1 Antonio Labriola. Per costruire un compiuto saggio su Antonio Labriola occorre tener presenti, oltre gli scritti suoi, che sono scarsi e spesso soltanto allusivi o estremamente sintetici, anche gli elementi e i frammenti di conversazione riferiti dai suoi amici ed allievi (il Labriola ha lasciato memoria di eccezionale «conversatore»). Nei libri di B. Croce, sparsamente, si possono raccogliere parecchi di tali elementi e frammenti. Così nelle Conversazioni Critiche (Serie Seconda), pp. 60‑61: «Come fareste a educare moralmente un papuano?» domandò uno di noi scolari, tanti anni fa al prof. Labriola, in una delle sue lezioni di Pedagogia, obiettando contro l’efficacia della Pedagogia. «Provvisoriamente (rispose con vichiana ed hegeliana asprezza l’herbartiano professore), provvisoriamente lo farei schiavo; e questa sarebbe la pedagogia del caso, salvo a vedere se pei suoi nipoti e pronipoti si potrà cominciare ad adoperare qualcosa della pedagogia nostra». Questa risposta del Labriola è da avvicinare alla intervista da lui data sulla quistione coloniale (Libia) verso il 1903 e riportata nel volume degli Scritti vari di filosofia e politica. È da avvicinare anche al modo di pensare del Gentile per ciò che riguarda l’insegnamento religioso nelle scuole primarie. Pare si tratti di un pseudo‑storicismo, di un meccanicismo abbastanza empirico e molto vicino al più volgare evoluzionismo.
Si potrebbe ricordare ciò che dice Bertrando Spaventa a proposito di quelli che vorrebbero tenere sempre gli uomini in culla (cioè nel momento dell’autorità, che pure educa alla libertà i popoli immaturi) e pensano tutta la vita (degli altri) come una culla.
Mi pare che storicamente il problema sia da porre in altro modo: se, cioè, una nazione o un gruppo sociale che è giunto a un grado superiore di civiltà non possa (e quindi debba) «accelerare» il processo di educazione dei popoli e dei gruppi sociali più arretrati, universalizzando e traducendo in modo adeguato la sua nuova esperienza. Così quando gli Inglesi arruolano reclute tra popoli primitivi, che non hanno mai visto un fucile moderno, non istruiscono queste reclute all’impiego dell’arco, del boomerang, della cerbottana, ma proprio le istruiscono al maneggio del fucile, sebbene le norme di istruzione siano necessariamente adattate alla «mentalità» di quel determinato popolo primitivo.
Il modo di pensare implicito nella risposta del Labriola non pare pertanto dialettico e progressivo, ma piuttosto meccanico e retrivo, come quello «pedagogico‑religioso» del Gentile che non è altro che una derivazione del concetto che la «religione è buona per il popolo» (popolo = fanciullo = fase primitiva del pensiero cui corrisponde la religione ecc.) cioè la rinunzia (tendenziosa) a educare il popolo.
Nella intervista sulla quistione coloniale il meccanicismo implicito nel pensiero del Labriola appare anche più evidente. Infatti: può darsi benissimo che sia «necessario ridurre i papuani alla schiavitù» per educarli, ma non è necessario meno che qualcuno affermi che ciò non è necessario che contingentemente, perché esistono determinate condizioni, che cioè questa è una necessità «storica» e non assoluta: è necessario anzi che ci sia una lotta in proposito, e questa lotta è proprio la condizione per cui i nipoti o pronipoti del papuano saranno liberati dalla schiavitù e saranno educati con la Pedagogia moderna. Che ci sia chi affermi recisamente che la schiavitù dei papuani non è che una necessità del momento e si ribelli contro tale necessità è anch’esso un fatto filosofico‑storico: 1) perché contribuirà a ridurre al tempo necessario il periodo di schiavitù; 2) perché indurrà gli stessi papuani a riflettere su se stessi, ad autoeducarsi, in quanto sentiranno di essere appoggiati da uomini di civiltà superiore; 3) perché solo questa resistenza mostra che si è realmente in un periodo superiore di civiltà e di pensiero ecc.
Lo storicismo del Labriola e del Gentile è di un genere molto scadente: è lo storicismo dei giuristi per i quali il knut non è un knut quando è un knut «storico». Si tratta d’altronde di un modo di pensare molto nebuloso e confuso. Che nelle scuole elementari sia necessaria una esposizione «dogmatica» delle nozioni scientifiche o sia necessaria una «mitologia» non significa che il dogma debba essere quello religioso e la mitologia quella determinata mitologia. Che un popolo o un gruppo sociale arretrato abbia bisogno di una disciplina esteriore coercitiva, per essere educato civilmente, non significa che debba essere ridotto in schiavitù, a meno che non si pensi che ogni coercizione statale è schiavitù. C’è una coercizione di tipo militare anche per il lavoro, che si può applicare anche alla classe dominante, e che non è «schiavitù», ma l’espressione adeguata della Pedagogia moderna rivolta ad educare un elemento immaturo (che è bensì immaturo, ma è tale vicino ad elementi già maturi, mentre la schiavitù organicamente è l’espressione di condizioni universalmente immature). Lo Spaventa, che si metteva dal punto di vista della borghesia liberale contro i «sofismi» storicistici delle classi retrive, esprimeva, in forma sarcastica, una concezione ben più progressiva e dialettica che non il Labriola e il Gentile.
Q11 §2 Alessandro Levi. Sono da ricercare i suoi scritti di filosofia e di storia. Come Rodolfo Mondolfo, il Levi è di origine positivistica (della scuola padovana di R. Ardigò). Come punto di riferimento del modo di pensare del Levi è interessante questo brano del suo studio su «Giuseppe Ferrari» («Nuova Rivista Storica», 1931, p. 387): «No; a me non pare che nel Nostro (il Ferrari) ci sia un “certo” e nemmeno... un incerto, materialismo storico. A me sembra, invece, che vaneggi proprio l’abisso, tra la concezione ferrariana della storia e della sua pretesa filosofia della storia ed il materialismo storico, rettamente inteso, cioè non come un mero economismo (ed anche di questo, per verità, ci sono nel Ferrari assai più vaghe tracce che non nella concreta storia di un Carlo Cattaneo), bensì come quella dialettica reale, che intende la storia superandola con l’azione, e non scinde storia e filosofia, ma, rimettendo gli uomini in piedi, fa di questi gli artefici consapevoli della storia, e non i giocattoli della fatalità, in quanto i loro principii, cioè i loro ideali, scintille che sprizzano dalle lotte sociali, sono precisamente stimolo alla praxis che, per opera loro, si rovescia. Superficiale conoscitore della logica hegeliana, il Ferrari era un critico troppo precipitoso della dialettica ideale per riuscire a superarla con la dialettica reale del materialismo storico».
Q11 §3 Alessandro Chiappelli (morto nel novembre 31). Verso la metà del decennio 1890-1900, quando uscirono i saggi di Antonio Labriola e di B. Croce, il Chiappelli scrisse sulla filosofia della prassi. Deve esistere del Chiappelli un volume o un saggio su Le premesse filosofiche del socialismo; è da vedere la bibliografia.
Q11 §4 Luciano Herr. Un Rapport sur l’état des études hégéliennes en France di A. Koyré è riprodotto nei Verhandlungen des ersten Hegelskongresses, vom 22 bis 25 april 1930 im Haag, Mohr, Tübingen, 1931, in 8° gr., pp. 243. Il Koyré, fra gli altri, parla di Luciano Herr, che ha passato venticinque anni della sua vita a studiare il pensiero hegeliano, e che è morto senza aver potuto scrivere il libro che si proponeva di dare e che avrebbe preso posto a lato di quelli del Delbos e di Xavier Léon; tuttavia ha lasciato un saggio di questi suoi studi, nell’articolo sullo Hegel pubblicato nella Grande Encyclopédie, notevole per lucidità e penetrazione. Una Vie de Lucien Herr ha pubblicato Charles Andler nell’«Europe» del 15 ottobre 1931 e seguenti. Scrive l’Andler: «Lucien Herr est présent dans tout le travail scientifique français depuis plus de quarante ans; et son action a été décisive dans la formation du socialisme en France».
Q11 §5 Antonio Labriola (cfr Q11 § a p. 3). Hegel aveva affermato che la servitù è la culla della libertà. Per Hegel, come per il Machiavelli, il «principato nuovo» (cioè il periodo dittatoriale che caratterizza gli inizi di ogni nuovo tipo di Stato) e la connessa servitù sono giustificatiNel ms: «è giustificata». solo come educazione e disciplina dell’uomo non ancora libero. Però B. Spaventa (Principii di etica, Appendice, Napoli, 1904) commenta opportunamente: «Ma la culla non è la vita. Alcuni ci vorrebbero sempre in culla».
(Un esempio tipico della culla che diventa tutta la vita è offerto dal protezionismo doganale, che è sempre propugnato e giustificato come «culla» ma tende a diventare una culla eterna).
Q11 §6 Giovanni Gentile. Sulla filosofia del Gentile è da confrontare l’articolo della «Civiltà Cattolica» (Cultura e filosofia dell’ignoto, 16 agosto 1930) che è interessante per vedere come la logica formale scolastica può essere idonea a criticare i banali sofismi dell’idealismo attuale che pretende essere la perfezione della dialettica. E infatti, perché la dialettica «formale» dovrebbe essere superiore alla logica «formale»? Non si tratta che di strumenti logici e un buon vecchio arnese può essere superiore a uno scadente arnese più moderno; un buon veliero è superiore a una sconquassata motonave. In ogni caso è interessante leggere le critiche dei neoscolastici al pensiero del Gentile (libri del padre Chiocchetti ecc.).
Gentile col suo seguito di Volpicelli, Spirito, ecc. (è da vedere il gruppo di collaboratori al «Giornale critico della filosofia italiana») si può dire che ha instaurato un vero e proprio «secentismo» letterario, poiché nella filosofia le arguzie e le frasi fatte sostituiscono il pensiero. Tuttavia il paragone di questo gruppo a quello dei Bauer satireggiato nella Sacra Famiglia è il più calzante e letterariamente più fecondo di svolgimenti (i «Nuovi Studi» offrono molti spunti e svariati per lo svolgimento).
Q11 §7 A. Rosmini. Da vedere il suo Saggio sul comunismo e sul socialismo, pubblicato a cura e con prefazione di A. Canaletti‑Gaudenti, in 16°, pp. 85, Roma, Signorelli, L. 6. Da confrontare con le encicliche papali emanate prima del 1848 e citate nel Sillabo, per servire da commento storico italiano al primo paragrafo del Manifesto: cfr anche il capitolo bibliografico nel Mazzini di «Rerum Scriptor».
Q11 §8 Antonino Lovecchio, Filosofia della prassi e filosofia dello spirito, Palmi, Zappone, 1928, pp. 112, L. 7. Dalla recensione apparsa nell’«Italia che scrive» e scritta da Giuseppe Tarozzi (giugno 1928) si traggono queste indicazioni: il libro consta di due parti, una sulla filosofia della prassi, l’altra sul pensiero di B. Croce, che sono connesse tra loro dal contributo del Croce alla critica della filosofia della prassi. La parte conclusiva è intitolata «Marx e Croce». Discute le tesi sulla filosofia della prassi specialmente di Antonio Labriola, Croce, Gentile, Rodolfo Mondolfo, Adelchi Baratono, Alfredo Poggi. È un crociano (pare molto inesperto criticamente). Il Tarozzi scrive che il libretto è un abbozzo, ricco di molti e non lievi difetti di forma. (Il Lovecchio è un medico di Palmi).
Q11 §9 Ettore Ciccotti. Il suo volume: Confronti storici, Biblioteca della «Nuova Rivista Storica» n. 10, Società Ed. Dante Alighieri, 1929, pp. XXXIX‑262, è stato recensito favorevolmente da Guido De Ruggiero nella «Critica» del gennaio 1930 e invece con molta cautela e in fondo sfavorevolmente da Mario de Bernardi nella Riforma Sociale (vedere). Un capitolo del libro del Ciccotti (forse l’introduzione generale) è stato pubblicato nella «Rivista d’Italia» del 15 giugno ‑ 15 luglio 1927: «Elementi di “verità” e di “certezza” nella tradizione storica romana» e solo a questo capitolo qui si accenna. Il Ciccotti esamina e combatte una serie di deformazioni professionali della storiografia romana e molte sue osservazioni sono giuste negativamente: è per le affermazioni positive che sussistono dubbi e sono necessarie molte cautele. La recensione del De Ruggiero è molto superficiale: egli giustifica il metodo «analogico» del Ciccotti come un riconoscimento dell’identità fondamentale dello spirito umano, ma così si va molto lontano, fino alla giustificazione dell’evoluzionismo volgare e delle leggi sociologiche astratte, che anch’esse, a loro modo, si fondano, con un linguaggio particolare, sull’ipotesi dell’identità fondamentale dello spirito umano.
Uno degli errori teorici più gravi del Ciccotti pare consista nell’interpretazione sbagliata del principio vichiano che il «certo si converte nel vero». La storia non può essere che certezza (con l’approssimazione della ricerca della «certezza»). La conversione del «certo» nel «vero» può dar luogo a costruzioni filosofiche (della così detta storia eterna) che non hanno che poco in comune con la storia «effettuale»: ma la storia deve essere «effettuale» e non romanzata: la sua certezza deve essere prima di tutto certezza dei documenti storici (anche se la storia non si esaurisce tutta nei documenti storici, la cui nozione d’altronde è talmente complessa ed estesa, da poter dare luogo a concetti sempre nuovi sia di certezza che di verità). La parte sofistica della metodologia del Ciccotti appare molto chiara là dove egli afferma che la storia è dramma, perché ciò non vuol dire che ogni rappresentazione drammatica di un dato periodo storico sia quella «effettuale», anche se viva, artisticamente perfetta, ecc. Il sofisma del Ciccotti porta a dare un valore eccessivo alla belletristica storica come reazione all’erudizione pedantesca e petulante: dalle piccole «congetture» filologiche si passa alle «grandiose» congetture sociologiche, con poco guadagno per la storiografia.
In un esame della attività storica del Ciccotti occorre tenere molto conto di questo libro. La «filosofia della prassi» del Ciccotti è molto superficiale: è la concezione di Guglielmo Ferrero e di C. Barbagallo, cioè un aspetto della sociologia positivistica, condita di qualche degnità vichiana. La metodologia del Ciccotti ha dato luogo appunto alle storie tipo Ferrero e alle curiose elucubrazioni del Barbagallo che finisce col perdere il concetto di distinzione e di concretezza «individua» di ogni momento dello sviluppo storico e con lo scoprire due originali degnità: che «tutto il mondo è paese» e che «più tutto cambia e più si rassomiglia».
Q11 §10 Giuseppe Rensi. Esame di tutto il suo sviluppo politico‑intellettuale. È stato collaboratore della «Critica Sociale» (è stato anche fuoruscito in Isvizzera dopo il 1898). Il suo atteggiamento moralistico e lacrimoso attuale (cfr i suoi articoli nella «Nuova Rivista Storica» di qualche anno fa) è da confrontare con le sue manifestazioni letterarie e giornalistiche del 21‑22‑23, in cui giustifica un ritorno della schiavitù e dà del Machiavelli una interpretazione stupidamente cinica. Ricordare la sua polemica col Gentile nel «Popolo d’Italia» dopo il Congresso dei filosofi tenuto a Milano nel 1926: deve aver firmato il cosiddetto Manifesto degli Intellettuali steso dal Croce.
Q11 §11 Corrado Barbagallo. Il suo libro L’oro e il fuoco deve essere esaminato, tenendo conto del partito preso dell’autore di trovare nell’antichità ciò che è essenzialmente moderno, come il capitalismo, la grande industria e le manifestazioni che ad essi sono collegate. Occorre specialmente esaminare le sue conclusioni a proposito delle corporazioni professionali e delle loro funzioni, ponendole a confronto con le ricerche degli studiosi del mondo classico e del Medio Evo. Cfr le conclusioni del Mommsen e del Marquardt a proposito dei collegia opificum et artificum; per il Marquardt essi erano istituzioni di carattere erariale e servivano all’economia e alla finanza dello Stato in senso stretto e poco o punto istituzioni sociali (cfr il mir russo). A parte l’osservazione che in ogni caso il sindacalismo moderno dovrebbe trovare corrispondenza in istituzioni proprie degli schiavi del mondo classico. Ciò che caratterizza, da questo punto di vista, il mondo moderno è che al disotto dei proletari non c’è classe alla quale sia proibito l’organizzarsi, come avveniva nel Medio Evo e anche nel mondo classico con ogni probabilità; l’artigiano romano poteva servirsi degli schiavi come lavoranti ed essi non appartenevano certo ai collegia e non è escluso che, nella stessa plebe, qualche categoria non servile fosse esclusa dall’organizzazione.
APPUNTI PER UNA INTRODUZIONE E UN AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA FILOSOFIA
E DELLA STORIA DELLA CULTURA
I. Alcuni punti preliminari di riferimento.
Q11 §12 Occorre distruggere il pregiudizio molto diffuso che la filosofia sia un alcunché di molto difficile per il fatto che essa è l’attività intellettuale propria di una determinata categoria di scienziati specialisti o di filosofi professionali e sistematici. Occorre pertanto dimostrare preliminarmente che tutti gli uomini sono «filosofi», definendo i limiti e i caratteri di questa «filosofia spontanea», propria di «tutto il mondo», e cioè della filosofia che è contenuta: 1) nel linguaggio stesso, che è un insieme di nozioni e di concetti determinati e non già e solo di parole grammaticalmente vuote di contenuto; 2) nel senso comune e buon senso; 3) nella religione popolare e anche quindi in tutto il sistema di credenze, superstizioni, opinioni, modi di vedere e di operare che si affacciano in quello che generalmente si chiama «folclore».
Avendo dimostrato che tutti sono filosofi, sia pure a modo loro, inconsapevolmente, perché anche solo nella minima manifestazione di una qualsiasi attività intellettuale, il «linguaggio», è contenuta una determinata concezione del mondo, si passa al secondo momento, al momento della critica e della consapevolezza, cioè alla quistione: è preferibile «pensare» senza averne consapevolezza critica, in modo disgregato e occasionale, cioè «partecipare» a una concezione del mondo «imposta» meccanicamente dall’ambiente esterno, e cioè da uno dei tanti gruppi sociali nei quali ognuno è automaticamente coinvolto fin dalla sua entrata nel mondo cosciente (e che può essere il proprio villaggio o la provincia, può avere origine nella parrocchia e nell’«attività intellettuale» del curato o del vecchione patriarcale la cui «saggezza» detta legge, nella donnetta che ha ereditato la sapienza dalle streghe o nel piccolo intellettuale inacidito nella propria stupidaggine e impotenza a operare) o è preferibile elaborare la propria concezione del mondo consapevolmente e criticamente e quindi, in connessione con tale lavorio del proprio cervello, scegliere la propria sfera di attività, partecipare attivamente alla produzione della storia del mondo, essere guida di se stessi e non già accettare passivamente e supinamente dall’esterno l’impronta alla propria personalità?
Nota I. Per la propria concezione del mondo si appartiene sempre a un determinato aggruppamento, e precisamente a quello di tutti gli elementi sociali che condividono uno stesso modo di pensare e di operare. Si è conformisti di un qualche conformismo, si è sempre uomini‑massa o uomini‑collettivi. La quistione è questa: di che tipo storico è il conformismo, l’uomo‑massa di cui si fa parte? Quando la concezione del mondo non è critica e coerente ma occasionale e disgregata, si appartiene simultaneamente a una molteplicità di uomini‑massa, la propria personalità è composita in modo bizzarro: si trovano in essa elementi dell’uomo delle caverne e principii della scienza più moderna e progredita, pregiudizi di tutte le fasi storiche passate grettamente localistiche e intuizioni di una filosofia avvenire quale sarà propria del genere umano unificato mondialmente. Criticare la propria concezione del mondo significa dunque renderla unitaria e coerente e innalzarla fino al punto cui è giunto il pensiero mondiale più progredito. Significa quindi anche criticare tutta la filosofia finora esistita, in quanto essa ha lasciato stratificazioni consolidate nella filosofia popolare. L’inizio dell’elaborazione critica è la coscienza di quello che è realmente, cioè un «conosci te stesso» come prodotto del processo storico finora svoltosi che ha lasciato in te stesso un’infinità di tracce accolte senza beneficio d’inventario. Occorre fare inizialmente un tale inventario.
Nota II. Non si può separare la filosofia dalla storia della filosofia e la cultura dalla storia della cultura. Nel senso più immediato e aderente, non si può essere filosofi, cioè avere una concezione del mondo criticamente coerente, senza la consapevolezza della Sua storicità, della fase di sviluppo da essa rappresentata e del fatto che essa è in contraddizione con altre concezioni o con elementi di altre concezioni. La propria concezione del mondo risponde a determinati problemi posti dalla realtà, che sono ben determinati e «originali» nella loro attualità. Come è possibile pensare il presente e un ben determinato presente con un pensiero elaborato per problemi del passato spesso ben remoto e sorpassato? Se ciò avviene, significa che si è «anacronistici» nel proprio tempo, che si è dei fossili e non esseri modernamente viventi. O per lo meno che si è «compositi» bizzarramente. E infatti avviene che gruppi sociali che per certi aspetti esprimono la più sviluppata modernità, per altri sono in arretrato con la loro posizione sociale e pertanto sono incapaci di completa autonomia storica.
Nota III. Se è vero che ogni linguaggio contiene gli elementi di una concezione del mondo e di una cultura, sarà anche vero che dal linguaggio di ognuno si può giudicare la maggiore o minore complessità della sua concezione del mondo. Chi parla solo il dialetto o comprende la lingua nazionale in gradi diversi, partecipa necessariamente di una intuizione del mondo più o meno ristretta e provinciale, fossilizzata, anacronistica in confronto delle grandi correnti di pensiero che dominano la storia mondiale. I suoi interessi saranno ristretti, più o meno corporativi o economistici, non universali. Se non sempre è possibile imparare più lingue straniere per mettersi a contatto con vite culturali diverse, occorre almeno imparare bene la lingua nazionale. Una grande cultura può tradursi nella lingua di un’altra grande cultura, cioè una grande lingua nazionale, storicamente ricca e complessa, può tradurre qualsiasi altra grande cultura, cioè essere una espressione mondiale. Ma un dialetto non può fare la stessa cosa.
Nota IV. Creare una nuova cultura non significa solo fare individualmente delle scoperte «originali», significa anche e specialmente diffondere criticamente delle verità già scoperte, «socializzarle» per così dire e pertanto farle diventare base di azioni vitali, elemento di coordinamento e di ordine intellettuale e morale. Che una massa di uomini sia condotta a pensare coerentemente e in modo unitario il reale presente è fatto «filosofico» ben più importante e «originale» che non sia il ritrovamento da parte di un «genio» filosofico di una nuova verità che rimane patrimonio di piccoli gruppi intellettuali.
Connessione tra il senso comune, la religione e la filosofia. La filosofia è un ordine intellettuale, ciò che non possono essere né la religione né il senso comune. Vedere come, nella realtà, neanche religione e senso comune coincidono, ma la religione è un elemento del disgregato senso comune. Del resto «senso comune» è nome collettivo, come «religione»: non esiste un solo senso comune, ché anche esso è un prodotto e un divenire storico. La filosofia è la critica e il superamento della religione e del senso comune e in tal senso coincide col «buon senso» che si contrappone al senso comune.
Relazioni tra scienza ‑ religione ‑ senso comune. La religione e il senso comune non possono costituire un ordine intellettuale perché non possono ridursi a unità e coerenza neanche nella coscienza individuale per non parlare della coscienza collettiva: non possono ridursi a unità e coerenza «liberamente» perché «autoritativamente» ciò potrebbe avvenire come infatti è avvenuto nel passato entro certi limiti. Il problema della religione intesa non nel senso confessionale ma in quello laico di unità di fede tra una concezione del mondo e una norma di condotta conforme; ma perché chiamare questa unità di fede «religione» e non chiamarla «ideologia» o addirittura «politica»?
Non esiste infatti la filosofia in generale: esistono diverse filosofie o concezioni del mondo e si fa sempre una scelta tra di esse. Come avviene questa scelta? È questa scelta un fatto meramente intellettuale o più complesso? E non avviene spesso che tra il fatto intellettuale e la norma di condotta ci sia contraddizione? Quale sarà allora la reale concezione del mondo: quella logicamente affermata come fatto intellettuale, o quella che risulta dalla reale attività di ciascuno, che è implicita nel suo operare? E poiché l’operare è sempre un operare politico, non si può dire che la filosofia reale di ognuno è contenuta tutta nella sua politica? Questo contrasto tra il pensare e l’operare, cioè la coesistenza di due concezioni del mondo, una affermata a parole e l’altra esplicantesi nell’effettivo operare, non è dovuto sempre a malafede. La malafede può essere una spiegazione soddisfacente per alcuni individui singolarmente presi, o anche per gruppi più o meno numerosi, non è soddisfacente però quando il contrasto si verifica nella manifestazione di vita di larghe masse: allora esso non può non essere l’espressione di contrasti più profondi di ordine storico sociale. Significa che un gruppo sociale, che ha una sua propria concezione del mondo, sia pure embrionale, che si manifesta nell’azione, e quindi saltuariamente, occasionalmente, cioè quando tal gruppo si muove come un insieme organico, ha, per ragioni di sottomissione e subordinazione intellettuale, preso una concezione non sua a prestito da un altro gruppo e questa afferma a parole, e questa anche crede di seguire, perché la segue in «tempi normali», cioè quando la condotta non è indipendente e autonoma, ma appunto sottomessa e subordinata. Ecco quindi che non si può staccare la filosofia dalla politica e si può mostrare anzi che la scelta e la critica di una concezione del mondo è fatto politico anch’essa.
Occorre dunque spiegare come avviene che in ogni tempo coesistano molti sistemi e correnti di filosofia, come nascono, come si diffondono, perché nella diffusione seguono certe linee di frattura e certe direzioni ecc. Ciò mostra quanto sia necessario sistemare criticamente e coerentemente le proprie intuizioni del mondo e della vita, fissando con esattezza cosa deve intendersi per «sistema» perché non sia capito nel senso pedantesco e professorale della parola. Ma questa elaborazione deve essere e può solo essere fatta nel quadro della storia della filosofiache mostra quale elaborazione il pensiero abbia subito nel corso dei secoli e quale sforzo collettivo sia costato il nostro attuale modo di pensare che riassume e compendia tutta questa storia passata, anche nei suoi errori e nei suoi delirii, che, d’altronde, per essere stati commessi nel passato ed essere stati corretti non è detto non si riproducano nel presente e non domandino di essere ancora corretti.
Quale è l’idea che il popolo si fa della filosofia? Si può ricostruire attraverso i modi di dire del linguaggio comune. Uno dei più diffusi è quello di «prendere le cose con filosofia», che, analizzato, non è poi da buttar via del tutto. È vero che in esso è contenuto un invito implicito alla rassegnazione e alla pazienza, ma pare che il punto più importante sia invece l’invito alla riflessione, a rendersi conto e ragione che ciò che succede è in fondo razionale e che come tale occorre affrontarlo, concentrando le proprie forze razionali e non lasciandosi trascinare dagli impulsi istintivi e violenti. Si potrebbero raggruppare questi modi di dire popolari con le espressioni simili degli scrittori di carattere popolare – prendendole dai grandi vocabolari – in cui entrano i termini di «filosofia» e «filosoficamente» e si potrà vedere che questi hanno un significato molto preciso, di superamento delle passioni bestiali ed elementari in una concezione della necessità che dà al proprio operare una direzione consapevole. È questo il nucleo sano del senso comune, ciò che appunto potrebbe chiamarsi buon senso e che merita di essere sviluppato e reso unitario e coerente. Così appare che anche perciò non è possibile disgiungere quella che si chiama filosofia «scientifica» da quella filosofia «volgare» e popolare che è solo un insieme disgregato di idee e opinioni.
Ma a questo punto si pone il problema fondamentale di ogni concezione del mondo, di ogni filosofia, che sia diventata un movimento culturale, una «religione», una «fede», cioè che abbia prodotto un’attività pratica e una volontà e in esse sia contenuta come «premessa» teorica implicita (una «ideologia» si potrebbe dire, se al termine ideologia si dà appunto il significato più alto di una concezione del mondo che si manifesta implicitamente nell’arte, nel diritto, nell’attività economica, in tutte le manifestazioni di vita individuali e collettive), cioè il problema di conservare l’unità ideologica in tutto il blocco sociale che appunto da quella determinata ideologia è cementato e unificato. La forza delle religioni e specialmente della chiesa cattolica è consistita e consiste in ciò che esse sentono energicamente la necessità dell’unione dottrinale di tutta la massa «religiosa» e lottano perché gli strati intellettualmente superiori non si stacchino da quelli inferiori. La chiesa romana è stata sempre la più tenace nella lotta per impedire che «ufficialmente» si formino due religioni, quella degli «intellettuali» e quella delle «anime semplici». Questa lotta non è stata senza gravi inconvenienti per la chiesa stessa, ma questi inconvenienti sono connessi al processo storico che trasforma tutta la società civile e che in blocco contiene una critica corrosiva delle religioni; tanto più risalta la capacità organizzatrice nella sfera della cultura del clero e il rapporto astrattamente razionale e giusto che nella sua cerchia la chiesa ha saputo stabilire tra intellettuali e semplici. I gesuiti sono stati indubbiamente i maggiori artefici di questo equilibrio e per conservarlo essi hanno impresso alla chiesa un movimento progressivo che tende a dare certe soddisfazioni alle esigenze della scienza e della filosofia, ma con ritmo così lento e metodico che le mutazioni non sono percepite dalla massa dei semplici, sebbene esse appaiano «rivoluzionarie» e demagogiche agli «integralisti».
Una delle maggiori debolezze delle filosofie immanentistiche in generale consiste appunto nel non aver saputo creare una unità ideologica tra il basso e l’alto, tra i «semplici» e gli intellettuali. Nella storia della civiltà occidentale il fatto si è verificato su scala europea, col fallimento immediato del Rinascimento e in parte anche della Riforma nei confronti della chiesa romana. Questa debolezza si manifesta nella quistione scolastica, in quanto dalle filosofie immanentistiche non è stato neppur tentato di costruire una concezione che potesse sostituire la religione nell’educazione infantile, quindi il sofisma pseudo‑storicistico per cui pedagogisti areligiosi (aconfessionali), e in realtà atei, concedono l’insegnamento della religione perché la religione è la filosofia dell’infanzia dell’umanità che si rinnova in ogni infanzia non metaforica. L’idealismo si è anche mostrato avverso ai movimenti culturali di «andata verso il popolo», che si manifestarono nelle così dette Università popolari e istituzioni simili e non solo per i loro aspetti deteriori, perché in tal caso avrebbero solo dovuto cercare di far meglio. Tuttavia questi movimenti erano degni di interesse, e meritavano di essere studiati: essi ebbero fortuna, nel senso che dimostrarono da parte dei «semplici» un entusiasmo sincero e una forte volontà di innalzarsi a una superiore forma di cultura e di concezione del mondo. Mancava però in essi ogni organicità sia di pensiero filosofico, sia di saldezza organizzativa e di centralizzazione culturale; si aveva l’impressione che rassomigliassero ai primi contatti tra i mercanti inglesi e i negri dell’Africa: si dava merce di paccottiglia per avere pepite d’oro. D’altronde l’organicità di pensiero e la saldezza culturale poteva aversi solo se tra gli intellettuali e i semplici ci fosse stata la stessa unità che deve esserci tra teoria e pratica; se cioè gli intellettuali fossero stati organicamente gli intellettuali di quelle masse, se avessero cioè elaborato e reso coerente i principi e i problemi che quelle masse ponevano con la loro attività pratica, costituendo così un blocco culturale e sociale. Si ripresentava la stessa quistione già accennata: un movimento filosofico è tale solo in quanto si applica a svolgere una cultura specializzata per ristretti gruppi di intellettuali o è invece tale solo in quanto, nel lavoro di elaborazione di un pensiero superiore al senso comune e scientificamente coerente non dimentica mai di rimanere a contatto coi «semplici» e anzi in questo contatto trova la sorgente dei problemi da studiare e risolvere? Solo per questo contatto una filosofia diventa «storica», si depura dagli elementi intellettualistici di natura individuale e si fa «vita».
(Forse è utile «praticamente» distinguere la filosofia dal senso comune per meglio indicare il passaggio dall’uno all’altro momento: nella filosofia sono specialmente spiccati i caratteri di elaborazione individuale del pensiero, nel senso comune invece i caratteri diffusi e dispersi di un pensiero generico di una certa epoca in un certo ambiente popolare. Ma ogni filosofia tende a diventare senso comune di un ambiente anche ristretto – di tutti gli intellettuali –. Si tratta pertanto di elaborare una filosofia che avendo già una diffusione, o diffusività, perché connessa alla vita pratica e implicita in essa, diventi un rinnovato senso comune con la coerenza e il nerbo delle filosofie individuali: ciò non può avvenire se non è sempre sentita l’esigenza del contatto culturale coi «semplici»).
Una filosofia della prassi non può che presentarsi inizialmente in atteggiamento polemico e critico, come superamento del modo di pensare precedente e del concreto pensiero esistente (o mondo culturale esistente). Quindi innanzi tutto come critica del «senso comune» (dopo essersi basata sul senso comune per dimostrare che «tutti» sono filosofi e che non si tratta di introdurre ex novo una scienza nella vita individuale di «tutti», ma di innovare e rendere «critica» un’attività già esistente) e quindi della filosofia degli intellettuali, che ha dato luogo alla storia della filosofia, e che, in quanto individuale (e si sviluppa infatti essenzialmente nell’attività di singoli individui particolarmente dotati) può considerarsi come le «punte» di progresso del senso comune, per lo meno del senso comune degli strati più colti della società, e attraverso questi anche del senso comune popolare. Ecco quindi che un avviamento allo studio della filosofia deve esporre sinteticamente i problemi nati nel processo di sviluppo della cultura generale, che si riflette solo parzialmente nella storia della filosofia, che tuttavia, in assenza di una storia del senso comune (impossibile a costruirsi per l’assenza di materiale documentario) rimane la fonte massima di riferimento per criticarli, dimostrarne il valore reale (se ancora l’hanno) o il significato che hanno avuto come anelli superati di una catena e fissare i problemi nuovi attuali o l’impostazione attuale dei vecchi problemi.
Il rapporto tra filosofia «superiore» e senso comune è assicurato dalla «politica», così come è assicurato dalla politica il rapporto tra il cattolicismo degli intellettuali e quello dei «semplici». Le differenze nei due casi sono però fondamentali. Che la chiesa debba affrontare un problema dei «semplici» significa appunto che c’è stata rottura nella comunità dei «fedeli», rottura che non può essere sanata innalzando i «semplici» al livello degli intellettuali (la chiesa non si propone neppure questo compito, idealmente ed economicamente impari alle sue forze attuali), ma con una disciplina di ferro sugli intellettuali perché non oltrepassino certi limiti nella distinzione e non la rendano catastrofica e irreparabile. Nel passato queste «rotture» nella comunità dei fedeli erano sanate da forti movimenti di massa che determinavano o erano riassunti nella formazione di nuovi ordini religiosi intorno a forti personalità (Domenico, Francesco). (I movimenti ereticali del Medio Evo come reazione simultanea al politicantismo della chiesa e alla filosofia scolastica che ne fu una espressione, sulla base dei conflitti sociali determinati dalla nascita dei Comuni, sono stati una rottura tra massa e intellettuali nella chiesa «rimarginata» dalla nascita di movimenti popolari religiosi riassorbiti dalla chiesa nella formazione degli ordini mendicanti e in una nuova unità religiosa). Ma la Controriforma ha isterilito questo pullulare di forze popolari: la Compagnia di Gesù è l’ultimo grande ordine religioso, di origine reazionario e autoritario, con carattere repressivo e «diplomatico», che ha segnato, con la sua nascita, l’irrigidimento dell’organismo cattolico. I nuovi ordini sorti dopo hanno scarsissimo significato «religioso» e un grande significato «disciplinare» sulla massa dei fedeli, sono ramificazioni e tentacoli della Compagnia di Gesù o ne sono diventati tali, strumenti di «resistenza» per conservare le posizioni politiche acquisite, non forze rinnovatrici di sviluppo. Il cattolicismo è diventato « gesuitismo». Il modernismo non ha creato «ordini religiosi» ma un partito politico, la democrazia cristiana. (Ricordare l’aneddoto, raccontato dallo Steed nelle sue Memorie, del cardinale che al protestante inglese filo‑cattolico spiega che i miracoli di S. Gennaro sono utili per il popolino napoletano, non per gli intellettuali, che anche nell’Evangelo ci sono delle «esagerazioni» e alla domanda: «ma non siamo cristiani?», risponde «noi siamo prelati», cioè «politici» della Chiesa di Roma).
La posizione della filosofia della praxis è antitetica a questa cattolica: la filosofia della praxis non tende a mantenere i «semplici» nella loro filosofia primitiva del senso comune, ma invece a condurli a una concezione superiore della vita. Se afferma l’esigenza del contatto tra intellettuali e semplici non è per limitare l’attività scientifica e per mantenere una unità al basso livello delle masse, ma appunto per costruire un blocco intellettuale‑morale che renda politicamente possibile un progresso intellettuale di massa e non solo di scarsi gruppi intellettuali.
L’uomo attivo di massa opera praticamente, ma non ha una chiara coscienza teorica di questo suo operare che pure è un conoscere il mondo in quanto lo trasforma. La sua coscienza teorica anzi può essere storicamente in contrasto col suo operare. Si può quasi dire che egli ha due coscienze teoriche (o una coscienza contraddittoria), una implicita nel suo operare e che realmente lo unisce a tutti i suoi collaboratori nella trasformazione pratica della realtà e una superficialmente esplicita o verbale che ha ereditato dal passato e ha accolto senza critica. Tuttavia questa concezione «verbale» non è senza conseguenze: essa riannoda a un gruppo sociale determinato, influisce nella condotta morale, nell’indirizzo della volontà, in modo più o meno energico, che può giungere fino a un punto in cui la contradditorietà della coscienza non permette nessuna azione, nessuna decisione, nessuna scelta e produce uno stato di passività morale e politica.
La comprensione critica di se stessi avviene quindi attraverso una lotta di «egemonie» politiche, di direzioni contrastanti, prima nel campo dell’etica, poi della politica, per giungere a una elaborazione superiore della propria concezione del reale. La coscienza di essere parte di una determinata forza egemonica (cioè la coscienza politica) è la prima fase per una ulteriore e progressiva autocoscienza in cui teoria e pratica finalmente si unificano. Anche l’unità di teoria e pratica non è quindi un dato di fatto meccanico, ma un divenire storico, che ha la sua fase elementare e primitiva nel senso di «distinzione», di «distacco», di indipendenza appena istintivo, e progredisce fino al possesso reale e completo di una concezione del mondo coerente e unitaria. Ecco perché è da mettere in rilievo come lo sviluppo politico del concetto di egemonia rappresenta un grande progresso filosofico oltre che politico‑pratico, perché necessariamente coinvolge e suppone una unità intellettuale e una etica conforme a una concezione del reale che ha superato il senso comune ed è diventata, sia pure entro limiti ancora ristretti, critica.
Tuttavia, nei più recenti sviluppi della filosofia della praxis, l’approfondimento del concetto di unità della teoria e della pratica non è ancora che ad una fase iniziale: rimangono ancora dei residui di meccanicismo, poiché si parla di teoria come «complemento», «accessorio» della pratica, di teoria come ancella della pratica. Pare giusto che anche questa quistione debba essere impostata storicamente, e cioè come un aspetto della quistione politica degli intellettuali.
Autocoscienza critica significa storicamente e politicamente creazione di una élite di intellettuali: una massa umana non si «distingue» e non diventa indipendente «per sé» senza organizzarsi (in senso lato) e non c’è organizzazione senza intellettuali, cioè senza organizzatori e dirigenti, cioè senza che l’aspetto teorico del nesso teoria‑pratica si distingua concretamente in uno strato di persone «specializzate» nell’elaborazione concettuale e filosofica. Ma questo processo di creazione degli intellettuali è lungo, difficile, pieno di contraddizioni, di avanzate e di ritirate, di sbandamenti e di riaggruppamenti, in cui la «fedeltà» della massa (e la fedeltà e la disciplina sono inizialmente la forma che assume l’adesione della massa e la sua collaborazione allo sviluppo dell’intero fenomeno culturale) è messa talvolta a dura prova. Il processo di sviluppo è legato a una dialettica intellettuali‑massa; lo strato degli intellettuali si sviluppa quantitativamente e qualitativamente, ma ogni sbalzo verso una nuova «ampiezza» e complessità dello strato degli intellettuali è legato a un movimento analogo della massa di semplici, che si innalza verso livelli superiori di cultura e allarga simultaneamente la sua cerchia di influenza, con punte individuali o anche di gruppi più o meno importanti verso lo strato degli intellettuali specializzati. Nel processo però si ripetono continuamente dei momenti in cui tra massa e intellettuali (o certi di essi, o un gruppo di essi) si forma un distacco, una perdita di contatto, quindi l’impressione di «accessorio», di complementare, di subordinato.
L’insistere sull’elemento «pratico» del nesso teoria‑pratica, dopo aver scisso, separato e non solo distinto i due elementi (operazione appunto meramente meccanica e convenzionale) significa che si attraversa una fase storica relativamente primitiva, una fase ancora economico‑corporativa, in cui si trasforma quantitativamente il quadro generale della «struttura» e la qualità‑superstruttura adeguata è in via di sorgere, ma non è ancora organicamente formata.
È da porre in rilievo l’importanza e il significato che hanno, nel mondo moderno, i partiti politici nell’elaborazione e diffusione delle concezioni del mondo in quanto essenzialmente elaborano l’etica e la politica conforme ad esse, cioè funzionano quasi da «sperimentatori» storici di esse concezioni. I partiti selezionano individualmente la massa operante e la selezione avviene sia nel campo pratico che in quello teorico congiuntamente, con un rapporto tanto più stretto tra teoria e pratica quanto più la concezione è vitalmente e radicalmente innovatrice e antagonistica dei vecchi modi di pensare. Perciò si può dire che i partiti sono gli elaboratori delle nuove intellettualità integrali e totalitarie, cioè il crogiolo dell’unificazione di teoria e pratica intesa come processo storico reale e si capisce come sia necessaria la formazione per adesione individuale e non del tipo «laburista» perché, se si tratta di dirigere organicamente «tutta la massa economicamente attiva» si tratta di dirigerla non secondo vecchi schemi ma innovando, e l’innovazione non può diventare di massa, nei suoi primi stadi, se non per il tramite di una élite in cui la concezione implicita nella umana attività sia già diventata in una certa misura coscienza attuale coerente e sistematica e volontà precisa e decisa. Una di queste fasi si può studiare nella discussione attraverso la quale si sono verificati i più recenti sviluppi della filosofia della praxis, discussione riassunta in un articolo di D. S. Mirsckij, collaboratore della «Cultura». Si può vedere come sia avvenuto il passaggio da una concezione meccanicistica e puramente esteriore a una concezione attivistica, che si avvicina di più, come si è osservato, a una giusta comprensione dell’unità di teoria e pratica, sebbene non ne abbia ancora attinto tutto il significato sintetico. Si può osservare come l’elemento deterministico, fatalistico, meccanicistico sia stato un «aroma» ideologico immediato della filosofia della prassi, una forma di religione e di eccitante (ma al modo degli stupefacenti), resa necessaria e giustificata storicamente dal carattere «subalterno» di determinati strati sociali.
Quando non si ha l’iniziativa nella lotta e la lotta stessa finisce quindi con l’identificarsi con una serie di sconfitte, il determinismo meccanico diventa una forza formidabile di resistenza morale, di coesione, di perseveranza paziente e ostinata. «Io sono sconfitto momentaneamente, ma la forza delle cose lavora per me a lungo andare ecc.». La volontà reale si traveste in un atto di fede, in una certa razionalità della storia, in una forma empirica e primitiva di finalismo appassionato che appare come un sostituto della predestinazione, della provvidenza, ecc., delle religioni confessionali. Occorre insistere sul fatto che anche in tal caso esiste realmente una forte attività volitiva, un intervento diretto sulla «forza delle cose» ma appunto in una forma implicita, velata, che si vergogna di se stessa e pertanto la coscienza è contradditoria, manca di unità critica, ecc. Ma quando il «subalterno» diventa dirigente e responsabile dell’attività economica di massa, il meccanicismo appare a un certo punto un pericolo imminente, avviene una revisione di tutto il modo di pensare perché è avvenuto un mutamento nel modo sociale di essere. I limiti e il dominio della «forza delle cose» vengono ristretti perché? perché, in fondo, se il subalterno era ieri una cosa, oggi non è più una cosa ma una persona storica, un protagonista, se ieri era irresponsabile perché «resistente» a una volontà estranea, oggi sente di essere responsabile perché non più resistente ma agente e necessariamente attivo e intraprendente. Ma anche ieri era egli mai stato mera «resistenza», mera «cosa», mera «irresponsabilità»? Certamente no, ed è anzi da porre in rilievo come il fatalismo non sia che un rivestimento da deboli di una volontà attiva e reale.
Ecco perché occorre sempre dimostrare la futilità del determinismo meccanico, che, spiegabile come filosofia ingenua della massa e in quanto solo tale elemento intrinseco di forza, quando viene assunto a filosofia riflessa e coerente da parte degli intellettuali, diventa causa di passività, di imbecille autosufficienza, e ciò senza aspettare che il subalterno sia diventato dirigente e responsabile. Una parte della massa anche subalterna è sempre dirigente e responsabile e la filosofia della parte precede sempre la filosofia del tutto non solo come anticipazione teorica, ma come necessità attuale.
Che la concezione meccanicistica sia stata una religione di subalterni appare da un’analisi dello sviluppo della religione cristiana, che in un certo periodo storico e in condizioni storiche determinate è stata e continua ad essere una «necessità», una forma necessaria della volontà delle masse popolari, una forma determinata di razionalità del mondo e della vita e dette i quadri generali per l’attività pratica reale. In questo brano di un articolo della «Civiltà Cattolica» (Individualismo pagano e individualismo cristiano, fasc. del 5 marzo 1932) mi pare bene espressa questa funzione del cristianesimo: «La fede in un sicuro avvenire, nell’immortalità dell’anima, destinata alla beatitudine, nella sicurezza di poter arrivare al godimento eterno, fu la molla di propulsione per un lavoro di intensa perfezione interna, e di elevazione spirituale. Il vero individualismo cristiano ha trovato qui l’impulso alle sue vittorie. Tutte le forze del cristiano furono raccolte intorno a questo fine nobile. Liberato dalle fluttazioni speculative che snervano l’anima nel dubbio, e illuminato da principi immortali, l’uomo sentì rinascere le speranze; sicuro che una forza superiore lo sorreggeva nella lotta contro il male, egli fece violenza a se stesso e vinse il mondo». Ma anche in questo caso, è il cristianesimo ingenuo che si intende; non il cristianesimo gesuitizzato, divenuto un puro narcotico per le masse popolari.
Ma la posizione del calvinismo, con la sua concezione ferrea della predestinazione e della grazia, che determina una vasta espansione di spirito di iniziativa (o diventa la forma di questo movimento) è ancora più espressiva e significativa. (A questo proposito si può vedere: Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, pubblicato nei «Nuovi Studi», fascicoli dal 1931 e sgg., e il libro del Groethuysen sulle origini religiose della borghesia in Francia).
Perché e come si diffondono, diventando popolari, le nuove concezioni del mondo? In questo processo di diffusione (che è nello stesso tempo di sostituzione del vecchio e molto spesso di combinazione tra il nuovo e il vecchio) influiscono, e come e in che misura, la forma razionale in cui la nuova concezione è esposta e presentata, l’autorità (in quanto sia riconosciuta ed apprezzata almeno genericamente) dell’espositore e dei pensatori e scienziati che l’espositore chiama in suo sostegno, l’appartenere alla stessa organizzazione di chi sostiene la nuova concezione (dopo però essere entrati nell’organizzazione per altro motivo che non sia il condividere la nuova concezione)? Questi elementi in realtà variano a seconda del gruppo sociale e del livello culturale del gruppo dato. Ma la ricerca interessa specialmente per ciò che riguarda le masse popolari, che più difficilmente mutano di concezione, e che non le mutano mai, in ogni caso, accettandole nella forma «pura», per dir così, ma solo e sempre come combinazione più o meno eteroclita e bizzarra. La forma razionale, logicamente coerente, la completezza del ragionamento che non trascura nessun argomento positivo o negativo di un qualche peso, ha la sua importanza, ma è ben lontana dall’essere decisiva; essa può essere decisiva in via subordinata, quando la persona data è già in condizioni di crisi intellettuale, ondeggia tra il vecchio e il nuovo, ha perduto la fede nel vecchio e ancora non si è decisa per il nuovo ecc.
Così si può dire per l’autorità dei pensatori e scienziati. Essa è molto grande nel popolo, ma di fatto ogni concezione ha i suoi pensatori e scienziati da porre innanzi e l’autorità è divisa; inoltre è possibile per ogni pensatore distinguere, porre in dubbio che abbia proprio detto in tal modo ecc. Si può concludere che il processo di diffusione delle concezioni nuove avviene per ragioni politiche, cioè in ultima istanza sociali, ma che l’elemento formale, della logica coerenza, l’elemento autoritativo e l’elemento organizzativo hanno in questo processo una funzione molto grande subito dopo che l’orientamento generale è avvenuto, sia nei singoli individui che in gruppi numerosi. Da ciò si conclude però che nelle masse in quanto tali la filosofia non può essere vissuta che come una fede.
Si immagini del resto la posizione intellettuale di un uomo del popolo; egli si è formato delle opinioni, delle convinzioni, dei criteri di discriminazione e delle norme di condotta. Ogni sostenitore di un punto di vista contrastante al suo, in quanto è intellettualmente superiore, sa argomentare le sue ragioni meglio di lui, lo mette in sacco logicamente ecc.; dovrebbe perciò l’uomo del popolo mutare le sue convinzioni? Perché nell’immediata discussione non sa farsi valere? ma allora gli potrebbe capitare di dover mutare una volta al giorno, cioè ogni volta che incontra un avversario ideologico intellettualmente superiore. Su quali elementi si fonda dunque la sua filosofia? e specialmente la sua filosofia nella forma che per lui ha maggiore importanza di norma di condotta? L’elemento più importante è indubbiamente di carattere non razionale, di fede. Ma in chi e che cosa? Specialmente nel gruppo sociale al quale appartiene in quanto la pensa diffusamente come lui: l’uomo del popolo pensa che in tanti non si può sbagliare, così in tronco, come l’avversario argomentatore vorrebbe far credere; che egli stesso, è vero, non è capace di sostenere e svolgere le proprie ragioni come l’avversario le sue, ma che nel suo gruppo c’è chi questo saprebbe fare, certo anche meglio di quel determinato avversario ed egli ricorda infatti di aver sentito esporre diffusamente, coerentemente, in modo che egli ne è rimasto convinto, le ragioni della sua fede. Non ricorda le ragioni in concreto e non saprebbe ripeterle, ma sa che esistono perché le ha sentite esporre e ne è rimasto convinto. L’essere stato convinto una volta in modo folgorante è la ragione permanente del permanere della convinzione, anche se essa non si sa più argomentare.
Ma queste considerazioni conducono alla conclusione di una estrema labilità nelle convinzioni nuove delle masse popolari, specialmente se queste nuove convinzioni sono in contrasto con le convinzioni (anche nuove) ortodosse, socialmente conformiste secondo gli interessi generali delle classi dominanti. Si può vedere questo riflettendo alle fortune delle religioni e delle chiese.
La religione, e una determinata chiesa, mantiene la sua comunità di fedeli (entro certi limiti, delle necessità dello sviluppo storico generale) nella misura in cui intrattiene permanentemente e organizzatamente la fede propria, ripetendone l’apologetica indefessamente, lottando in ogni momento e sempre con argomenti simili, e mantenendo una gerarchia di intellettuali che alla fede diano almeno l’apparenza della dignità del pensiero. Ogni volta che la continuità dei rapporti tra chiesa e fedeli è stata interrotta violentemente, per ragioni politiche, come è avvenuto durante la Rivoluzione francese, le perdite subite dalla chiesa sono state incalcolabili e se le condizioni di difficile esercizio delle pratiche abitudinarie si fossero protratte oltre certi limiti di tempo, è da pensare che tali perdite sarebbero state definitive e una nuova religione sarebbe sorta, come del resto in Francia è sorta in combinazione col vecchio cattolicismo.
Se ne deducono determinate necessità per ogni movimento culturale che tenda a sostituire il senso comune e le vecchie concezioni del mondo in generale: 1) di non stancarsi mai dal ripetere i propri argomenti (variandone letterariamente la forma): la ripetizione è il mezzo didattico più efficace per operare sulla mentalità popolare; 2) di lavorare incessantemente per elevare intellettualmente sempre più vasti strati popolari, cioè per dare personalità all’amorfo elemento di massa, ciò che significa di lavorare a suscitare élites di intellettuali di un tipo nuovo che sorgano direttamente dalla massa pur rimanendo a contatto con essa per diventarne le «stecche» del busto. Questa seconda necessità, se soddisfatta, è quella che realmente modifica il «panorama ideologico» di un’epoca. Né, d’altronde, queste élites possono costituirsi e svolgersi senza che nel loro interno si verifichi una gerarchizzazione di autorità e di competenza intellettuale, che può culminare in un grande filosofo individuale, se questo è capace di rivivere concretamente le esigenze della massiccia comunità ideologica, di comprendere che essa non può avere la snellezza di movimento propria di un cervello individuale e pertanto riesce a elaborare formalmente la dottrina collettiva nel modo più aderente e adeguato ai modi di pensare di un pensatore collettivo.
È evidente che una costruzione di massa di tal genere non può avvenire «arbitrariamente», intorno a una qualsiasi ideologia, per la volontà formalmente costruttiva di una personalità o di un gruppo che se lo proponga per fanatismo delle proprie convinzioni filosofiche o religiose. L’adesione di massa a una ideologia o la non adesione è il modo con cui si verifica la critica reale della razionalità e storicità dei modi di pensare. Le costruzioni arbitrarie sono più o meno rapidamente eliminate dalla competizione storica, anche se talvolta, per una combinazione di circostanze immediate favorevoli, riescono a godere di una tal quale popolarità mentre le costruzioni che corrispondono alle esigenze di un periodo storico complesso e organico finiscono sempre con l’imporsi e prevalere anche se attraversano molte fasi intermedie in cui il loro affermarsi avviene solo in combinazioni più o meno bizzarre ed eteroclite.
Questi svolgimenti pongono molti problemi, i più importanti dei quali si riassumono nel modo e nella qualità dei rapporti tra i vari strati intellettualmente qualificati, cioè nell’importanza e nella funzione che deve e può avere l’apporto creativo dei gruppi superiori in connessione con la capacità organica di discussione e di svolgimento di nuovi concetti critici da parte degli strati subordinati intellettualmente. Si tratta cioè di fissare i limiti della libertà di discussione e di propaganda, libertà che non deve essere intesa nel senso amministrativo e poliziesco, ma nel senso di autolimite che i dirigenti pongono alla propria attività ossia, in senso proprio, di fissazione di un indirizzo di politica culturale. In altre parole: chi fisserà i «diritti della scienza» e i limiti della ricerca scientifica, e potranno questi diritti e questi limiti essere propriamente fissati? Pare necessario che il lavorio di ricerca di nuove verità e di migliori, più coerenti e chiare formulazioni delle verità stesse sia lasciato all’iniziativa libera dei singoli scienziati, anche se essi continuamente ripongono in discussione gli stessi principi che paiono i più essenziali. Non sarà del resto difficile mettere in chiaro quando tali iniziative di discussione abbiano motivi interessati e non di carattere scientifico. Non è del resto impossibile pensare che le iniziative individuali siano disciplinate e ordinate, in modo che esse passino attraverso il crivello di accademie o istituti culturali di vario genere e solo dopo essere state selezionate diventino pubbliche ecc.
Sarebbe interessante studiare in concreto, per un singolo paese, l’organizzazione culturale che tiene in movimento il mondo ideologico ed esaminarne il funzionamento pratico. Uno studio del rapporto numerico tra il personale che professionalmente è dedito al lavoro attivo culturale e la popolazione dei singoli paesi sarebbe anche utile, con approssimativo calcolo delle forze libere. La scuola, in tutti i suoi gradi, e la chiesa sono le due maggiori organizzazioni culturali in ogni paese, per il numero del personale che occupano. I giornali, le riviste, e l’attività libraria, le istituzioni scolastiche private, sia in quanto integrano la scuola di Stato, sia come istituzioni di cultura del tipo Università popolare. Altre professioni incorporano nella loro attività specializzata una frazione culturale non indifferente, come quella dei medici, degli ufficiali dell’esercito, della magistratura. Ma è da notare che in tutti i paesi, sia pure in misura diversa, esiste una grande frattura tra le masse popolari e i gruppi intellettuali, anche quelli più numerosi e più vicini alla periferia nazionale, come i maestri e i preti. E che ciò avviene perché, anche dove i governanti ciò affermano a parole, lo Stato come tale non ha una concezione unitaria, coerente e omogenea, per cui i gruppi intellettuali sono disgregati tra strato e strato e nella sfera dello stesso strato. L’università, eccetto che in alcuni paesi, non esercita nessuna funzione unificatrice; spesso un pensatore libero ha più influsso di tutta la istituzione universitaria ecc.
Nota I. A proposito della funzione storica svolta dalla concezione fatalistica della filosofia della praxis si potrebbe fare un elogio funebre di essa, rivendicandone la utilità per un certo periodo storico, ma appunto per ciò sostenendo la necessità di seppellirla con tutti gli onori del caso. Si potrebbe veramente paragonare la sua funzione a quella della teoria della grazia e della predestinazione per gli inizi del mondo moderno che poi ha però culminato con la filosofia classica tedesca e con la sua concezione della libertà come coscienza della necessità. Essa è stato un surrogato popolare del grido «dio lo vuole», tuttavia anche su questo piano primitivo ed elementare era un inizio di concezione più moderna e feconda di quella contenuta nel «dio lo vuole» o nella teoria della grazia. È possibile che «formalmente» una nuova concezione si presenti in altra veste che quella rozza e incondita di una plebe? E tuttavia lo storico, con tutta la prospettiva necessaria, riesce a fissare e a capire che gli inizi di un mondo nuovo, sempre aspri e pietrosi, sono superiori al declinare di un mondo in agonia e ai canti del cigno che esso produce.
Il deperimento del «fatalismo» e del «meccanicismo» indica una grande svolta storica; perciò la grande impressione fatta dallo studio riassuntivo del Mirskij. Ricordi che esso ha destato; ricordare a Firenze nel novembre 1917 la discussione con l’avv. Mario Trozzi e il primo accenno di bergsonismo, di volontarismo ecc. Si potrebbe fare un quadro semiserio di come questa concezione realmente si presentava.
Ricordare anche la discussione col prof. Presutti a Roma nel giugno 1924. Paragone col capitano Giulietti fatto da G. M. Serrati e che per lui era decisivo e di condanna capitale. Per G. M. Serrati, Giulietti era come il confuciano per il taoista, il chinese del sud, mercante attivo e operoso per il letterato mandarino del Nord, che guardava, con supremo disprezzo da illuminato e da saggio per cui la vita non ha più misteri, questi omiciattoli del Sud che credevano coi loro movimenti irrequieti di formiche di poter forzare la «via». Discorso di Claudio Treves sull’espiazione. C’era in questo discorso un certo spirito da profeta biblico: chi aveva voluto e fatto la guerra, chi aveva sollevato il mondo dai suoi cardini ed era quindi responsabile del disordine del dopoguerra doveva espiare portando la responsabilità di questo disordine stesso. Avevano peccato di «volontarismo», dovevano essere puniti nel loro peccato ecc. C’era una certa grandezza sacerdotale in questo discorso, uno stridore di maledizioni che dovevano impietrire di spavento e invece furono una grande consolazione, perché indicava che il becchino non era ancora pronto e Lazzaro poteva risorgere.
II. Osservazioni e critiche su un tentativo di «Saggio popolare di sociologia».
Q11 §13 Un lavoro come il Saggio popolare, destinato essenzialmente a una comunità di lettori che non sono intellettuali di professione, avrebbe dovuto prendere le mosse dall’analisi critica della filosofia del senso comune, che è la «filosofia dei non filosofi», cioè la concezione del mondo assorbita acriticamente dai vari ambienti sociali e culturali in cui si sviluppa l’individualità morale dell’uomo medio. Il senso comune non è una concezione unica, identica nel tempo e nello spazio: è il «folclore» della filosofia e come il folclore si presenta in forme innumerevoli: il suo tratto fondamentale e più caratteristico è di essere una concezione (anche nei singoli cervelli) disgregata, incoerente, inconseguente, conforme alla posizione sociale e culturale delle moltitudini di cui esso è la filosofia. Quando nella storia si elabora un gruppo sociale omogeneo, si elabora anche, contro il senso comune, una filosofia omogenea, cioè coerente e sistematica.
Il Saggio popolare sbaglia nel partire (implicitamente) dal presupposto che a questa elaborazione di una filosofia originale delle masse popolari si oppongano i grandi sistemi delle filosofie tradizionali e la religione dell’alto clero, cioè le concezioni del mondo degli intellettuali e dell’alta cultura. In realtà questi sistemi sono ignoti alla moltitudine e non hanno efficacia diretta nel suo modo di pensare e di operare. Certo ciò non significa che essi siano del tutto senza efficacia storica: ma questa efficacia è d’altro genere. Questi sistemi influiscono sulle masse popolari come forza politica esterna, come elemento di forza coesiva delle classi dirigenti, come elemento quindi di subordinazione a una egemonia esteriore, che limita il pensiero originale delle masse popolari negativamente, senza influirvi positivamente, come fermento vitale di trasformazione intima di ciò che le masse pensano embrionalmente e caoticamente intorno al mondo e alla vita.
Gli elementi principali del senso comune sono forniti dalle religioni e quindi il rapporto tra senso comune e religione è molto più intimo che tra senso comune e sistemi filosofici degli intellettuali. Ma anche per la religione occorre distinguere criticamente. Ogni religione, anche la cattolica (anzi specialmente la cattolica, appunto per i suoi sforzi di rimanere unitaria «superficialmente», per non frantumarsi in chiese nazionali e in stratificazioni sociali) è in realtà una molteplicità di religioni distinte e spesso contraddittorie: c’è un cattolicismo dei contadini, un cattolicismo dei piccoli borghesi e operai di città, un cattolicismo delle donne e un cattolicismo degli intellettuali anch’esso variegato e sconnesso. Ma nel senso comune influiscono non solo le forme più rozze e meno elaborate di questi varii cattolicismi, attualmente esistenti; hanno influito e sono componenti dell’attuale senso comune le religioni precedenti e le forme precedenti dell’attuale cattolicismo, i movimenti ereticali popolari, le superstizioni scientifiche legate alle religioni passate ecc.
Nel senso comune predominano gli elementi «realistici», materialistici, cioè il prodotto immediato della sensazione grezza, ciò che d’altronde non è in contraddizione con l’elemento religioso, tutt’altro; ma questi elementi sono «superstiziosi», acritici. Ecco pertanto un pericolo rappresentato dal «Saggio popolare»; il quale spesso conferma questi elementi acritici, per cui il senso comune è ancora rimasto tolemaico, antropomorfico, antropocentrico, invece di criticarli scientificamente.
Ciò che si è detto sopra a proposito del Saggio popolare che critica le filosofie sistematiche invece di prender le mosse dalla critica del senso comune, deve essere inteso come appunto metodologico, e in certi limiti. Certo non vuol dire che sia da trascurare la critica alle filosofie sistematiche degli intellettuali. Quando, individualmente, un elemento di massa supera criticamente il senso comune, accetta, per questo fatto stesso, una filosofia nuova: ecco quindi la necessità, in una esposizione della filosofia della praxis, della polemica con le filosofie tradizionali. Anzi per questo suo carattere tendenziale di filosofia di massa, la filosofia della praxis non può essere concepita che in forma polemica, di perpetua lotta. Tuttavia il punto di partenza deve sempre essere il senso comune, che spontaneamente è la filosofia delle moltitudini che si tratta di rendere omogenee ideologicamente.
Nella letteratura filosofica francese esistono trattazioni del «senso comune» più che in altre letterature nazionali: ciò è dovuto al carattere più strettamente «popolare‑nazionale» della cultura francese, cioè al fatto che gli intellettuali tendono, più che altrove, per determinate condizioni tradizionali, ad avvicinarsi al popolo per guidarlo ideologicamente e tenerlo collegato al gruppo dirigente. Si potrà trovare quindi nella letteratura francese molto materiale sul senso comune da utilizzare ed elaborare; l’atteggiamento della cultura filosofica francese verso il senso comune può offrire anzi un modello di costruzione ideologica egemonica. Anche la cultura inglese e americana possono offrire molti spunti, ma non in modo così completo e organico come quella francese.
Il «senso comune» è stato considerato in vari modi; addirittura come base della filosofia; o è stato criticato dal punto di vista di un’altra filosofia. In realtà, in tutti i casi, il risultato fu di superare un determinato senso comune per crearne un altro più aderente alla concezione del mondo del gruppo dirigente.
Nelle Nouvelles Littéraires del 17.X.1931, in un articolo di Henri Gouhier su Léon Brunschvicg, parlando della filosofia del B. si dice: «Il n’y a qu’un seul et même mouvement de spiritualisation, qu’il s’agisse de mathématiques, de physique, de biologie, de philosophie et de morale; c’est l’effort par lequel l’esprit se débarasse du sens commun et de sa méthaphysique spontanée qui pose un monde de choses sensibles réelles et l’homme au milieu de ce monde». Opere di Léon Brunschvicg: Les étapes de la philosophie mathématique, L’expérience humaine et la causalité phisique, Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, La connaissance de soi, Introduction à la vie de l’esprit.
Atteggiamento del Croce verso il «senso comune»; non pare chiaro. Nel Croce, la proposizione che ogni uomo è un filosofo, grava troppo sul giudizio intorno al senso comune. Pare che il Croce spesso si compiaccia che determinate proposizioni filosofiche siano condivise dal senso comune, ma che cosa può ciò significare in concreto? Il senso comune è un aggregato caotico di concezioni disparate e in esso si può trovare tutto ciò che si vuole. D’altronde questo atteggiamento del Croce verso il senso comune non ha portato ad una concezione della cultura feconda dal punto di vista nazionale‑popolare, cioè ad una concezione più concretamente storicistica della filosofia, ciò che del resto può avvenire solo nella filosofia della praxis.
Per il Gentile è da vedere il suo articolo La concezione umanistica del mondo (nella Nuova Antologia del 1° giugno 1931). Scrive il Gentile: «La filosofia si potrebbe definire come un grande sforzo compiuto dal pensiero riflesso per conquistare la certezza critica delle verità del senso comune e della coscienza ingenua, di quelle verità che ogni uomo si può dire che senta naturalmente e che costituiscono la struttura solida della mentalità di cui egli si serve per vivere». Pare questo un altro esempio della rozzezza incondita del pensiero gentiliano: l’affermazione pare derivata «ingenuamente» dalle affermazioni del Croce sul modo di pensare del popolo come riprova delle verità di determinate proposizioni filosofiche. Più oltre il Gentile scrive: «L’uomo sano crede in Dio e nella libertà del suo spirito». Così già in queste due proposizioni del Gentile vediamo: 1) una «natura umana» extrastorica che non si sa cosa sia esattamente; 2) la natura umana dell’uomo sano; 3) il senso comune dell’uomo sano e perciò anche un senso comune dell’uomo non‑sano. E cosa vorrà dire uomo sano? Fisicamente sano, non pazzo? oppure che pensa sanamente, benpensante, filisteo ecc.? E cosa vorrà dire «verità del senso comune»? La filosofia del Gentile, per esempio, è tutta contraria al senso comune, sia che si intenda per esso la filosofia ingenua del popolo, che abborre da ogni forma di idealismo soggettivistico, sia che si intenda come buon senso, come atteggiamento di sprezzo per le astruserie, le macchinosità, le oscurità di certe esposizioni scientifiche e filosofiche. Questo civettare del Gentile col senso comune è una cosa molto amena.
Ciò che si è detto finora non significa che nel senso comune non ci siano delle verità. Significa che il senso comune è un concetto equivoco, contradditorio, multiforme, e che riferirsi al senso comune come riprova di verità è un non senso. Si potrà dire con esattezza che una certa verità è diventata di senso comune per indicare che essa si è diffusa oltre la cerchia dei gruppi intellettuali, ma non si fa altro in tal caso che una constatazione di carattere storico e un’affermazione di razionalità storica; in questo senso, e purché sia impiegato con sobrietà, l’argomento ha un suo valore, appunto perché il senso comune è grettamente misoneista e conservatore ed essere riusciti a farci penetrare una verità nuova è prova che tale verità ha una bella forza di espansività e di evidenza.
Ricordare l’epigramma del Giusti: «Il buon senso, che un dì fu caposcuola – or nelle nostre scuole è morto affatto. – La scienza, sua figliola, – l’uccise per veder com’era fatto». Può servire per introdurre un capitolo e può servire a indicare come si impieghi il termine di buon senso e di senso comune in modo equivoco: come «filosofia», come determinato modo di pensare, con un certo contenuto di credenze e di opinioni, e come atteggiamento benevolmente indulgente, nel suo disprezzo, per l’astruso e il macchinoso. Era perciò necessario che la scienza uccidesse un determinato buon senso tradizionale, per creare un «nuovo» buon senso.
Un accenno al senso comune e alla saldezza delle sue credenze si trova spesso in Marx. Ma si tratta di riferimento non alla validità del contenuto di tali credenze ma appunto alla loro formale saldezza e quindi alla loro imperatività quando producono norme di condotta. Nei riferimenti è anzi implicita l’affermazione della necessità di nuove credenze popolari, cioè di un nuovo senso comune e quindi di una nuova cultura e di una nuova filosofia che si radichino nella coscienza popolare con la stessa saldezza e imperatività delle credenze tradizionali.
Nota I. Occorre aggiungere a proposito delle proposizioni del Gentile sul senso comune, che il linguaggio dello scrittore è volutamente equivoco per un poco pregevole opportunismo ideologico. Quando il Gentile scrive: «L’uomo sano crede in Dio e nella libertà del suo spirito» come esempio di una di quelle verità del senso comune di cui il pensiero riflesso elabora la certezza critica, vuol far credere che la sua filosofia è la conquista della certezza critica delle verità del cattolicesimo, ma i cattolici non abboccano e sostengono che l’idealismo gentiliano è pretto paganesimo ecc. ecc. Tuttavia il Gentile insiste e mantiene un equivoco che non è senza conseguenze per creare un ambiente di cultura demi‑monde, in cui tutti i gatti son bigi, la religione si abbraccia con l’ateismo, l’immanenza civetta con la trascendenza e Antonio Bruers se la gode un mondo perché quanto più la matassa s’imbroglia e il pensiero si oscura, e tanto più riconosce di aver avuto ragione nel suo «sincretismo» maccheronico. (In una nota è riportato un brano del Bruers del più comico pagliettismo filosofico). Se le parole del Gentile significassero quel che dicono alla lettera, l’idealismo attuale sarebbe divenuto, «l’ancello della teologia».
Nota II. Nell’insegnamento della filosofia, rivolto non ad informare storicamente il discente sullo svolgimento della filosofia passata, ma a formarlo culturalmente, ad aiutarlo a elaborare criticamente il proprio pensiero per partecipare a una comunità ideologica e culturale, è necessario prendere le mosse da ciò che il discente già conosce, dalla sua esperienza filosofica (dopo avergli dimostrato appunto che egli ha una tale esperienza, che è «filosofo» senza saperlo). E poiché si presuppone una certa media intellettuale e culturale di discenti, che verosimilmente non hanno avuto ancora che informazioni saltuarie e frammentarie, e mancano di ogni preparazione metodologica e critica, non si può non prendere le mosse dal «senso comune», in primo luogo, secondariamente dalla religione, e solo in un terzo tempo dai sistemi filosofici elaborati dai gruppi intellettuali tradizionali.
Q11 §14 Sulla metafisica. Si può ricavare dal Saggio popolare una critica della metafisica e della filosofia speculativa? Occorre dire che all’autore sfugge il concetto stesso di metafisica, in quanto gli sfuggono i concetti di movimento storico, di divenire e quindi della stessa dialettica. Pensare un’affermazione filosofica come vera in un determinato periodo storico, cioè come espressione necessaria e inscindibile di una determinata azione storica, di una determinata praxis, ma superata e «vanificata» in un periodo successivo, senza però cadere nello scetticismo e nel relativismo morale e ideologico, cioè concepire la filosofia come storicità, è operazione mentale un po’ ardua e difficile. L’autore invece cade in pieno nel dogmatismo e quindi in una forma, sia pure ingenua, di metafisica; ciò è chiaro fin dall’inizio, dall’impostazione del problema, dalla volontà di costruire una «sociologia» sistematica della filosofia della praxis; sociologia, in questo caso, significa appunto metafisica ingenua. Nel paragrafo finale dell’introduzione, l’autore non sa rispondere all’obbiezione di alcuni critici, i quali sostengono la filosofia della praxis poter solo vivere in concrete opere di storia. Egli non riesce a elaborare il concetto di filosofia della praxis come «metodologia storica» e questa come «filosofia», come la sola filosofia concreta non riesce cioè a porsi e a risolvere dal punto di vista della dialettica reale il problema che il Croce si è posto e ha cercato risolvere dal punto di vista speculativo.
Invece di una metodologia storica, di una filosofia, egli costruisce una casistica di quistioni particolari concepite e risolte dogmaticamente quando non sono risolte in modo puramente verbale, con dei paralogismi ingenui quanto pretensiosi. Questa casistica potrebbe pur essere utile e interessante, se però si presentasse come tale, senza altra pretesa che di dare degli schemi approssimativi di carattere empirico, utili per la pratica immediata. Del resto si capisce che così debba essere perché nel Saggio popolare la filosofia della praxis non è una filosofia autonoma e originale, ma la «sociologia» del materialismo metafisico. Metafisica per esso significa solo una determinata formulazione filosofica, quella speculativa dell’idealismo e non già ogni formulazione sistematica che si ponga come verità extrastorica come un universale astratto fuori del tempo e dello spazio.
La filosofia del Saggio popolare (implicita in esso) può essere chiamata un aristotelismo positivistico, un adattamento della logica formale ai metodi delle scienze fisiche e naturali. La legge di causalità, la ricerca della regolarità, normalità, uniformità sono sostituite alla dialettica storica. Ma come da questo modo di concepire può dedursi il superamento, il «rovesciamento della praxis»? L’effetto, meccanicamente, non può mai superare la causa o il sistema di cause, quindi non può aversi altro svolgimento che quello piatto e volgare dell’evoluzionismo.
Se l’«idealismo speculativo» è la scienza delle categorie e della sintesi a priori dello spirito, cioè una forma di astrazione antistoricistica, la filosofia implicita nel Saggio popolare è un idealismo alla rovescia, nel senso che dei concetti e delle classificazioni empiriche sostituiscono le categorie speculative, altrettanto astratte e antistoriche di queste.
Q11 §15 Il concetto di «scienza». La posizione del problema come una ricerca di leggi, di linee costanti, regolari, uniformi è legata a una esigenza, concepita in modo un po’ puerile e ingenuo, di risolvere perentoriamente il problema pratico della prevedibilità degli accadimenti storici. Poiché «pare», per uno strano capovolgimento delle prospettive, che le scienze naturali diano la capacità di prevedere l’evoluzione dei processi naturali, la metodologia storica è stata concepita «scientifica» solo se e in quanto abilita astrattamente a «prevedere» l’avvenire della società. Quindi la ricerca delle cause essenziali, anzi della «causa prima», della «causa delle cause». Ma le «Tesi su Feuerbach» avevano già criticato anticipatamente questa concezione semplicistica. In realtà si può prevedere «scientificamente» solo la lotta, ma non i momenti concreti di essa, che non possono non essere risultati di forze contrastanti in continuo movimento, non riducibili mai a quantità fisse, perché in esse la quantità diventa continuamente qualità. Realmente si «prevede» nella misura in cui si opera, in cui si applica uno sforzo volontario e quindi si contribuisce concretamente a creare il risultato «preveduto». La previsione si rivela quindi non come un atto scientifico di conoscenza, ma come l’espressione astratta dello sforzo che si fa, il modo pratico di creare una volontà collettiva.
E come potrebbe la previsione essere un atto di conoscenza? Si conosce ciò che è stato o è, non ciò che sarà, che è un «non esistente» e quindi inconoscibile per definizione. Il prevedere è quindi solo un atto pratico che non può, in quanto non sia una futilità o un perditempo, avere altra spiegazione che quella su esposta. È necessario impostare esattamente il problema della prevedibilità degli accadimenti storici per essere in grado di criticare esaurientemente la concezione del causalismo meccanico, per svuotarla di ogni prestigio scientifico e ridurla a puro mito che fu forse utile nel passato, in un periodo arretrato di sviluppo di certi gruppi sociali subalterni (vedere una nota precedente).
Ma è il concetto stesso di «scienza», quale risulta dal Saggio popolare, che occorre distruggere criticamente; esso è preso di sana pianta dalle scienze naturali, come se queste fossero la sola scienza, o la scienza per eccellenza, così come è stato fissato dal positivismo. Ma nel «Saggio popolare» il termine di scienza è impiegato in molti significati, alcuni espliciti altri sottintesi o appena accennati. Il senso esplicito è quello che «scienza» ha nelle ricerche fisiche. Altre volte però pare indichi il metodo. Ma esiste un metodo in generale e se esiste non significa poi niente altro che filosofia? Potrebbe significare altre volte niente altro che la logica formale, ma si può chiamare questa un metodo e una scienza? Occorre fissare che ogni ricerca ha un suo determinato metodo e costruisce una sua determinata scienza, e che il metodo si è sviluppato ed è stato elaborato insieme allo sviluppo e alla elaborazione di quella determinata ricerca e scienza, e forma tutt’uno con esse. Credere di poter far progredire una ricerca scientifica applicandole un metodo tipo, scelto perché ha dato buoni risultati in altra ricerca alla quale era connaturato, è uno strano abbaglio che ha poco che vedere con la scienza. Ci sono però anche dei criteri generali che si può dire costituiscano la coscienza critica di ogni scienziato, qualunque sia la sua «specializzazione» e che devono sempre essere spontaneamente vigili nel suo lavoro. Così si può dire che non è scienziato chi dimostra scarsa sicurezza nei suoi criteri particolari, che non ha una piena intelligenza dei concetti adoperati, che ha scarsa informazione e intelligenza dello stato precedente dei problemi trattati, che non è molto cauto nelle sue affermazioni, che non progredisce in modo necessario ma arbitrario e senza concatenamento, che non sa tener conto delle lacune che esistono nelle cognizioni raggiunte ma le sottace e si accontenta di soluzioni o nessi puramente verbali invece di dichiarare che si tratta di posizioni provvisorie che potranno essere riprese e sviluppate ecc. (Ognuno di questi punti può essere sviluppato, con le opportune esemplificazioni).
Un appunto che può farsi a molti riferimenti polemici del Saggio è il misconoscimento sistematico della possibilità di errore da parte dei singoli autori citati, per cui si attribuiscono a un gruppo sociale, di cui gli scienziati sarebbero sempre i rappresentanti, le opinioni più disparate e le volontà più contradditorie. Questo appunto è legato a un criterio metodico più generale e cioè: non è molto «scientifico» o più semplicemente «molto serio» scegliere gli avversari tra i più stupidi e mediocri o ancora, scegliere tra le opinioni dei propri avversari le meno essenziali e le più occasionali e presumere di aver «distrutto» «tutto» l’avversario perché si è distrutta una sua opinione secondaria e incidentale o di aver distrutto un’ideologia o una dottrina perché si è dimostrata l’insufficienza teorica dei suoi campioni di terzo o quarto ordine. Ancora «occorre essere giusti cogli avversari», nel senso che bisogna sforzarsi di comprendere ciò che essi realmente hanno voluto dire e non fermarsi maliziosamente ai significati superficiali e immediati delle loro espressioni. Ciò si dica, se il fine propostosi è di elevare il tono e il livello intellettuale dei propri seguaci e non quello immediato di fare il deserto intorno a sé, con ogni mezzo e maniera. Occorre porsi da questo punto di vista: che il proprio seguace debba discutere e sostenere il proprio punto di vista in discussione con avversari capaci e intelligenti e non solo con persone rozze e impreparate che si convincono «autoritativamente» o per via «emozionale». La possibilità dell’errore deve essere affermata e giustificata, senza con ciò venir meno alla propria concezione, perché ciò che importa non è già l’opinione di Tizio, Caio o Sempronio, ma quell’insieme di opinioni che sono diventate collettive, un elemento e una forza sociale; queste occorre confutare, nei loro esponenti teorici più rappresentativi e degni anzi di rispetto per altezza di pensiero e anche per «disinteresse» immediato e non già pensando di aver con ciò «distrutto» l’elemento e la forza sociale corrispondente (che sarebbe puro razionalismo illuministico), ma solo di aver contribuito: 1) a mantenere nella propria parte e rafforzare lo spirito di distinzione e di scissione; 2) a creare il terreno perché la propria parte assorba e vivifichi una propria dottrina originale, corrispondente alle proprie condizioni di vita.
È da osservare che molte deficienze del Saggio popolare sono connesse all’«oratoria». L’autore, nella prefazione, ricorda, quasi a titolo di onore, l’origine «parlata» della sua opera. Ma, come ha osservato già il Macaulay a proposito delle discussioni orali presso i greci, è appunto alle «dimostrazioni orali» e alla mentalità degli oratori che si collegano le superficialità logiche e di argomentazione le più stupefacenti. Ciò del resto non diminuisce la responsabilità degli autori, che non rivedono, prima di stamparle, le trattazioni tenute oralmente, spesso improvvisando, quando la meccanica e casuale associazione delle idee spesso sostituisce il nerbo logico. Il peggio è quando, in questa pratica oratoria, la mentalità facilona si solidifica e i freni critici non funzionano più. Si potrebbe fare una lista delle ignorantiae e mutationes elenchi del Saggio popolare probabilmente dovute alla «foga» oratoria. Un esempio tipico mi pare il paragrafo dedicato al prof. Stammler, dei più superficiali e sofistici.
Q11 §16 Quistioni di nomenclatura e di contenuto. Una delle caratteristiche degli intellettuali come categoria sociale cristallizzata (che cioè concepisce se stessa come continuazione ininterrotta nella storia, quindi indipendentemente dalla lotta dei gruppi e non come espressione di un processo dialettico, per cui ogni gruppo sociale dominante elabora una propria categoria di intellettuali) è appunto di ricongiungersi, nella sfera ideologica, a una precedente categoria intellettuale attraverso una stessa nomenclatura di concetti. Ogni nuovo organismo storico (tipo di società) crea una nuova superstruttura, i cui rappresentanti specializzati e portabandiera (gli intellettuali) non possono non essere concepiti come anch’essi «nuovi» intellettuali, sorti dalla nuova situazione e non continuazione della precedente intellettualità. Se i «nuovi» intellettuali si pongono come continuazione diretta della precedente intellighenzia essi non sono affatto «nuovi», cioè non sono legati al nuovo gruppo sociale che rappresenta organicamente la nuova situazione storica, ma sono un rimasuglio conservatore e fossilizzato del gruppo sociale superato storicamente (ciò che poi è lo stesso che dire che la nuova situazione storica non è ancora giunta al grado di sviluppo necessario per avere la capacità di creare nuove superstrutture, ma vive ancora nell’involucro tarlato della vecchia storia).
È tuttavia da tener conto che nessuna nuova situazione storica, sia pur essa dovuta al mutamento più radicale, trasforma completamente il linguaggio, almeno nel suo aspetto esterno, formale. Ma il contenuto del linguaggio dovrebbe essere mutato, anche se di tale mutazione è difficile avere coscienza esatta immediatamente. Il fenomeno è d’altronde storicamente complesso e complicato per l’esistenza di diverse culture tipiche nei diversi strati del nuovo gruppo sociale, alcuni dei quali, nel terreno ideologico, sono ancora immersi nella cultura di situazioni storiche precedenti talvolta anche alla più recentemente superata. Una classe, di cui alcuni strati sono ancora rimasti alla concezione tolemaica del mondo, può tuttavia essere la rappresentante di una situazione storica molto progredita; arretrati ideologicamente (o almeno per alcune sezioni della concezione del mondo, che è in essi ancora disgregata e ingenua) questi strati sono tuttavia avanzatissimi praticamente, cioè come funzione economica e politica. Se il compito degli intellettuali è quello di determinare e organizzare la riforma morale e intellettuale, cioè di adeguare la cultura alla funzione pratica, è evidente che gli intellettuali «cristallizzati» sono conservatori e reazionari. Perché mentre il gruppo sociale nuovo sente almeno di essere scisso e distinto da quello precedente, essi non sentono neppure tale distinzione ma pensano di potersi riallacciare al passato.
D’altronde non è detto che tutta l’eredità del passato debba essere respinta: ci sono dei «valori strumentali» che non possono non essere accolti integralmente per continuare ad essere elaborati e raffinati. Ma come distinguere il valore strumentale dal valore filosofico caduco e da respingere senz’altro? Spesso avviene che perché si è accettato un valore filosofico caduco di una determinata tendenza passata, si respinge poi un valore strumentale di altra tendenza perché contrastante con la prima, anche se tale valore strumentale sarebbe stato utile ad esprimere il nuovo contenuto storico culturale.
Così si è visto il termine «materialismo» accolto con contenuto passato e invece il termine «immanenza» respinto perché nel passato aveva un determinato contenuto storico culturale. La difficoltà di adeguare l’espressione letteraria al contenuto concettuale e di confondere le quistioni di terminologia con le quistioni sostanziali e viceversa è caratteristica del dilettantismo filosofico, della mancanza di senso storico nel cogliere i diversi momenti di un processo di sviluppo culturale, cioè di una concezione antidialettica dogmatica, prigioniera degli schemi astratti della logica formale.
Il termine di «materialismo» nel primo cinquantennio del secolo XIX occorre intenderlo non solo nel significato tecnico filosofico stretto, ma nel significato più estensivo che venne assumendo polemicamente nelle discussioni sorte in Europa col sorgere e lo svilupparsi vittorioso della cultura moderna. Si chiamò materialismo ogni dottrina filosofica che escludesse la trascendenza dal dominio del pensiero e quindi in realtà tutto il panteismo e l’immanentismo non solo, ma si chiamò materialismo anche ogni atteggiamento pratico ispirato al realismo politico, che si opponesse cioè a certe correnti deteriori del romanticismo politico, come le dottrine di Mazzini popolarizzate e che non parlavano che di «missioni», di «ideali» e di altre consimili nebulosità vaghe e astrattezze sentimentalistiche. Nelle polemiche anche odierne dei cattolici il termine di materialismo è spesso usato in questo senso; materialismo è l’opposto di spiritualismo in senso stretto, cioè di spiritualismo religioso e quindi si comprende in esso tutto lo hegelismo e in generale la filosofia classica tedesca, oltre al sensismo e illuminismo francese. Così, nei termini del senso comune, si chiama materialismo tutto ciò che tende a trovare in questa terra, e non in paradiso, il fine della vita. Ogni attività economica che uscisse dai limiti della produzione medioevale era «materialismo» perché pareva «fine a se stessa», l’economia per l’economia, l’attività per l’attività, così come oggi per l’europeo medio è «materialista» l’America, perché l’impiego delle macchine e il volume delle aziende e degli affari eccede un certo limite che all’europeo medio appare il «giusto», quello entro il quale le esigenze «spirituali» non sono mortificate. Così una ritorsione polemica della cultura feudale contro la borghesia in isviluppo è oggi fatta propria dalla cultura borghese europea contro un capitalismo più sviluppato di quello europeo da una parte e dall’altra contro l’attività pratica dei gruppi sociali subalterni per i quali, inizialmente e per una intera epoca storica, cioè fino a quando essi non avranno costruito una propria economia e una propria struttura sociale, l’attività non può non essere prevalentemente economica o almeno esprimersi in termini economici e di struttura. Tracce di questa concezione del materialismo rimangono nel linguaggio: in tedesco geistlich significa anche «clericale», proprio del clero, così come nel russo dukhoviez; e che essa sia la prevalente si può ricavare da molti scrittori di filosofia della praxis, per i quali, giustamente, la religione, il teismo ecc. sono i punti di riferimento per riconoscere i «materialisti conseguenti».
Una delle ragioni, e forse la prevalente, della riduzione al materialismo metafisico tradizionale del materialismo storico, è da ricercare in ciò che il materialismo storico non poteva non essere una fase prevalentemente critica e polemica della filosofia, mentre si aveva bisogno di un sistema già compiuto e perfetto. Ma i sistemi compiuti e perfetti sono sempre opera di singoli filosofi, e in essi, accanto alla parte storicamente attuale, cioè corrispondente alle contemporanee condizioni di vita, esiste sempre una parte astratta, «astorica», nel senso che è legata alle precedenti filosofie e risponde a necessità esteriori e pedantesche di architettura del sistema o è dovuta a idiosincrasie personali; perciò la filosofia di un’epoca non può essere nessun sistema individuale o di tendenza: essa è l’insieme di tutte le filosofie individuali e di tendenza, più le opinioni scientifiche, più la religione, più il senso comune. Si può formare un sistema di tal genere artificiosamente? per opera di individui e di gruppi? L’attività critica è la sola possibile, specialmente nel senso di porre e risolvere criticamente i problemi che si presentano come espressione dello svolgimento storico. Ma il primo di questi problemi che occorre impostare e comprendere è questo: che la nuova filosofia non può coincidere con nessun sistema del passato, comunque esso si chiami. Identità di termini non significa identità di concetti.
Un libro da studiare a proposito di questo argomento è la Storia del materialismo del Lange. L’opera sarà più o meno superata, per gli studi successivi sui singoli filosofi materialisti, ma la sua importanza culturale rimane intatta da questo punto di vista: ad essa si sono riferiti, per informarsi dei precedenti e per avere i concetti fondamentali del materialismo, tutta una serie di seguaci del materialismo storico. Si può dire che sia avvenuto questo, schematicamente: si è partiti dal presupposto dogmatico che il materialismo storico è senz’altro il materialismo tradizionale un po’ riveduto e corretto (corretto con la «dialettica» che così viene assunta come un capitolo della logica formale e non come essa stessa una logica, cioè una teoria della conoscenza); si è studiato nel Lange cos’è stato il materialismo tradizionale e i concetti di questo sono stati ripresentati come concetti del materialismo storico. Sicché si può dire che per la maggior parte del corpo di concetti che si presenta sotto l’etichetta del materialismo storico, il caposcuola e fondatore è stato il Lange e nessun altro. Ecco perché lo studio di questa opera presenta un grande interesse culturale e critico, tanto più che il Lange è uno storico coscienzioso e acuto, che ha del materialismo un concetto assai preciso, definito e limitato e perciò, con grande stupore e quasi sdegno di alcuni (come il Plekhanov), non considera materialistici né il materialismo storico e neanche la filosofia di Feuerbach. Si potrà anche qui vedere come la terminologia è convenzionale, ma ha la sua importanza nel determinare errori e deviazioni quando si dimentica che occorre sempre risalire alle fonti culturali per identificare il valore esatto dei concetti, poiché sotto lo stesso cappello possono stare teste diverse. È noto, d’altra parte, che il caposcuola della filosofia della pratica non ha chiamato mai «materialistica» la sua concezione e come parlando del materialismo francese lo critichi e affermi che la critica dovrebbe essere più esauriente. Così non adopera mai la formula di «dialettica materialistica» ma «razionale» in contrapposto a «mistica», ciò che dà al termine «razionale» un significato ben preciso.
Su questa quistione è da rivedere ciò che scrive Antonio Labriola nei suoi saggi. Della Storia del Lange era annunziata una traduzione italiana presso la Casa Editrice Athena di Milano e ne è uscita una recentemente presso l’editore Monanni di Milano.
Q11 §17 La così detta «realtà del mondo esterno». Tutta la polemica contro la concezione soggettivistica della realtà, con la quistione «terribile» della «realtà oggettiva del mondo esterno», è male impostata, peggio condotta e in gran parte futile e oziosa (mi riferisco anche alla memoria presentata al Congresso di storia delle scienze, tenuto a Londra nel giugno‑luglio 1931). Dal punto di vista di un «saggio popolare» tutta la trattazione risponde più a un prurito di pedanteria intellettuale che ad una necessità logica. Il pubblico popolare non crede neanche che si possa porre un tale problema, se il mondo esterno esista obbiettivamente. Basta enunziare così il problema per sentire un irrefrenabile e gargantuesco scoppio di ilarità. Il pubblico «crede» che il mondo esterno sia obbiettivamente reale, ma qui appunto nasce la quistione: qual è l’origine di questa «credenza» e quale valore critico ha «obbiettivamente»? Infatti questa credenza è di origine religiosa anche se vi partecipa è religiosamente indifferente. Poiché tutte le religioni hanno insegnato e insegnano che il mondo, la natura, l’universo è stato creato da dio prima della creazione dell’uomo e quindi l’uomo ha trovato il mondo già bell’e pronto, catalogato e definito una volta per sempre, questa credenza è diventata un dato ferreo del «senso comune» e vive con la stessa saldezza anche se il sentimento religioso è spento o sopito. Ecco allora che fondarsi su questa esperienza del senso comune per distruggere con la «comicità» la concezione soggettivistica ha un significato piuttosto «reazionario», di ritorno implicito al sentimento religioso; infatti gli scrittori o gli oratori cattolici ricorrono allo stesso mezzo per ottenere lo stesso effetto di ridicolo corrosivo.
Nella memoria presentata al Congresso di Londra, l’autore del Saggio popolare implicitamente risponde a questo appunto (che è poi di carattere esterno, sebbene abbia la sua importanza) notando che il Berkeley, al quale si deve la prima enunziazione compiuta della concezione soggettivistica, era un arcivescovo (quindi pare si debba dedurre l’origine religiosa della teoria) e poi dicendo che solo un «Adamo» che si trova per la prima volta nel mondo, può pensare che questo esista solo perché egli lo pensa (e anche qui si insinua l’origine religiosa della teoria, ma senza molto o nessuno vigore di convinzione).
Il problema invece è questo, mi pare: come si può spiegare che una tale concezione, che non è certo una futilità, anche per un filosofo della praxis, oggi, esposta al pubblico, possa solo provocare il riso e lo sberleffo? Mi pare il caso più tipico della distanza che si è venuta formando tra scienza e vita, tra certi gruppi di intellettuali, che pure sono alla direzione «centrale» dell’alta coltura e le grandi masse popolari: e come il linguaggio della filosofia sia diventato un gergo che ottiene lo stesso effetto di quello di Arlecchino. Ma se il «senso comune» si esilara, il filosofo della praxis dovrebbe lo stesso cercare una spiegazione e del reale significato che la concezione ha, e del perché essa sia nata e si sia diffusa tra gli intellettuali, e anche del perché essa faccia ridere il senso comune. È certo che la concezione soggettivistica è propria della filosofia moderna nella sua forma compiuta e avanzata, se da essa e come superamento di essa è nato il materialismo storico, che nella teoria delle superstrutture pone in linguaggio realistico e storicistico ciò che la filosofia tradizionale esprimeva in forma speculativa La dimostrazione di questo assunto, che qui è appena accennato, avrebbe la più grande portata culturale, perché metterebbe fine a una serie di discussioni futili quanto oziose e permetterebbe uno sviluppo organico della filosofia della praxis, fino a farla diventare l’esponente egemonico dell’alta cultura. Fa anzi meraviglia che il nesso tra l’affermazione idealistica che la realtà del mondo è una creazione dello spirito umano e l’affermazione della storicità e caducità di tutte le ideologie da parte della filosofia della praxis, perché le ideologie sono espressioni della struttura e si modificano col modificarsi di essa, non sia stato mai affermato e svolto convenientemente.
La quistione è strettamente connessa, e si capisce, alla quistione del valore delle scienze così dette esatte o fisiche e alla posizione che esse sono venute assumendo nel quadro della filosofia della praxis di un quasi feticismo, anzi della sola e vera filosofia o conoscenza del mondo.
Ma cosa sarà da intendere per concezione soggettivistica della realtà? Si potrà assumere una qualsiasi delle tante teorie soggettivistiche elucubrate da tutta una serie di filosofi e professori fino a quelle solipsistiche? È evidente che la filosofia della praxis, anche in questo caso, non può che essere messa in rapporto con lo hegelismo, che di questa concezione rappresenta la forma più compiuta e geniale e che delle successive teorie saranno da prendere in considerazione solo alcuni aspetti parziali e i valori strumentali. E occorrerà ricercare le forme bizzarre che la concezione ha assunto sia nei seguaci sia nei critici più o meno intelligenti. Così è da ricordare ciò che scrive il Tolstoi nelle sue memorie di infanzia e di giovinezza: il Tolstoi racconta che si era tanto infervorato per la concezione soggettivistica della realtà, che spesso ebbe il capogiro, perché si voltava di colpo indietro, persuaso di poter cogliere il momento in cui non avrebbe visto nulla perché il suo spirito non poteva aver avuto il tempo di «creare» la realtà (o qualcosa di simile: il brano del Tolstoi è caratteristico e molto interessante letterariamente).
Così nelle sue Linee di filosofia critica (p. 159) Bernardino Varisco scrive: «Apro un giornale per informarmi della realtà; vorreste sostenere che le novità le ho create io con l’aprire il giornale?». Che il Tolstoi desse alla proposizione soggettivistica un significato così immediato e meccanico può spiegarsi. Ma non è stupefacente che in tal modo possa aver scritto il Varisco, il quale, se oggi si è orientato verso la religione e il dualismo trascendentale, tuttavia è uno studioso serio e dovrebbe conoscere la sua materia? La critica del Varisco è quella del senso comune ed è notevole che proprio tale critica è trascurata dai filosofi idealisti, mentre invece essa è di estrema importanza per impedire la diffusione di un modo di pensare e di una cultura.
Si può ricordare un articolo di Mario Missiroli nell’«Italia Letteraria» in cui il Missiroli scrive che si troverebbe molto imbarazzato se dovesse sostenere, dinanzi a un pubblico comune e in contradditorio con un neoscolastico, per esempio, il punto di vista soggettivistico: il Missiroli osserva quindi come il cattolicismo tende, in concorrenza con la filosofia idealista, ad accaparrarsi le scienze naturali e fisiche. Altrove il Missiroli ha scritto prevedendo un periodo di decadenza della filosofia speculativa e un sempre maggior diffondersi delle scienze sperimentali e «realistiche» (in questo secondo scritto, però, pubblicato dal «Saggiatore», egli prevede anche un’ondata di anticlericalismo, cioè non pare creda più all’accaparramento delle scienze da parte del cattolicismo). Così è da ricordare nel volume di Scritti vari di Roberto Ardigò, raccolto e ordinato da G. Marchesini (Lemonnier, 1922) la «polemica della zucca»: in un giornaletto clericale di provincia, uno scrittore (un prete della Curia vescovile) per squalificare l’Ardigò di fronte al pubblico popolare lo chiamò su per giù «uno di quei filosofi i quali sostengono che la cattedrale (di Mantova o di altra città) esiste solo perché essi la pensano e quando essi non la pensano più, la cattedrale sparisce ecc.», con aspro risentimento dell’Ardigò che era positivista ed era d’accordo coi cattolici nel modo di concepire la realtà esterna.
Occorre dimostrare che la concezione «soggettivistica», dopo aver servito a criticare la filosofia della trascendenza da una parte e la metafisica ingenua del senso comune e del materialismo filosofico, può trovare il suo inveramento e la sua interpretazione storicistica solo nella concezione delle superstrutture mentre nella sua forma speculativa non è altro che un mero romanzo filosofico. Un accenno a una interpretazione un po’ più realistica del soggettivismo nella filosofia classica tedesca si può trovare in una recensione di G. De Ruggiero a degli scritti postumi (mi pare, lettere) di B. Constant (mi pare) pubblicati nella «Critica» di qualche anno fa.
L’appunto che si deve fare al Saggio popolare è di avere presentato la concezione soggettivistica così come essa appare dalla critica del senso comune e di avere accolto la concezione della realtà oggettiva del mondo esterno nella sua forma più triviale e acritica, senza neanche sospettare che a questa può esser mossa l’obbiezione di misticismo, come infatti fu fatto. (Nella memoria presentata al Congresso di Londra, l’autore del Saggio popolare accenna all’accusa di misticismo attribuendola al Sombart e trascurandola sprezzantemente: il Sombart l’ha certamente presa dal Croce). Solo che analizzando questa concezione, non è poi tanto facile giustificare un punto di vista di oggettività esteriore così meccanicamente intesa. Pare che possa esistere una oggettività extrastorica ed extraumana? Ma chi giudicherà di tale oggettività? Chi potrà mettersi da questa specie di «punto di vista del cosmo in sé» e che cosa significherà un tal punto di vista? Può benissimo sostenersi che si tratta di un residuo del concetto di dio, appunto nella sua concezione mistica di un dio ignoto.
La formulazione di Engels che «l’unità del mondo consiste nella sua materialità dimostrata... dal lungo e laborioso sviluppo della filosofia e delle scienze naturali» contiene appunto il germe della concezione giusta, perché si ricorre alla storia e all’uomo per dimostrare la realtà oggettiva. Oggettivo significa sempre «umanamente oggettivo», ciò che può corrispondere esattamente a «storicamente soggettivo», cioè oggettivo significherebbe «universale soggettivo». L’uomo conosce oggettivamente in quanto la conoscenza è reale per tutto il genere umano storicamente unificato in un sistema culturale unitario; ma questo processo di unificazione storica avviene con la sparizione delle contraddizioni interne che dilaniano la società umana, contraddizioni che sono la condizione della formazione dei gruppi e della nascita delle ideologie non universali concrete ma rese caduche immediatamente dall’origine pratica della loro sostanza. C’è quindi una lotta per l’oggettività (per liberarsi dalle ideologie parziali e fallaci) e questa lotta è la stessa lotta per l’unificazione culturale del genere umano. Ciò che gli idealisti chiamano «spirito» non è un punto di partenza, ma di arrivo, l’insieme delle soprastrutture in divenire verso l’unificazione concreta e oggettivamente universale e non già un presupposto unitario ecc.
La scienza sperimentale è stata (ha offerto) finora il terreno in cui una tale unità culturale ha raggiunto il massimo di estensione: essa è stata l’elemento di conoscenza che ha più contribuito a unificare lo «spirito», a farlo diventare più universale; essa è la soggettività più oggettivata e universalizzata concretamente.
Il concetto di «oggettivo» del materialismo metafisico pare voglia significare una oggettività che esiste anche all’infuori dell’uomo, ma quando si afferma che una realtà esisterebbe anche se non esistesse l’uomo o si fa una metafora o si cade in una forma di misticismo. Noi conosciamo la realtà solo in rapporto all’uomo e siccome l’uomo è divenire storico anche la conoscenza e la realtà sono un divenire, anche l’oggettività è un divenire ecc.
Q11 §18 Giudizio sulle filosofie passate. La superficiale critica del soggettivismo nel Saggio popolare rientra in una quistione più generale, che è quella dell’atteggiamento preso verso le filosofie e i filosofi passati. Giudicare tutto il passato filosofico come un delirio e una follia non è solo un errore di antistoricismo, perché contiene la pretesa anacronistica che nel passato si dovesse pensare come oggi, ma è un vero e proprio residuo di metafisica perché suppone un pensiero dogmatico valido in tutti i tempi e in tutti i paesi, alla cui stregua si giudica tutto il passato. L’antistoricismo metodico non è altro che metafisica. Che i sistemi filosofici passati siano stati superati non esclude che essi siano stati validi storicamente e abbiano svolto una funzione necessaria: la loro caducità è da considerare dal punto di vista dell’intero svolgimento storico e della dialettica reale; che essi fossero degni di cadere non è un giudizio morale o di igiene del pensiero, emesso da un punto di vista «obbiettivo», ma un giudizio dialettico‑storico. Si può confrontare la presentazione fatta da Engels della proposizione hegeliana che «tutto ciò che è razionale è reale e il reale è razionale», proposizione che sarà valida anche per il passato.
Nel Saggio si giudica il passato come «irrazionale» e «mostruoso» e la storia della filosofia diventa un trattato storico di teratologia, perché si parte da un punto di vista metafisico. (E invece nel Manifesto è contenuto il più alto elogio del mondo morituro). Se questo modo di giudicare il passato è un errore teorico, è una deviazione dalla filosofia della praxis, potrà avere un qualunque significato educativo, sarà ispiratore di energie? Non pare, perché la quistione si ridurrebbe a presumere di essere qualcosa solo perché si è nati nel tempo presente, invece che in uno dei secoli passati. Ma in ogni tempo c’è stato un passato e una contemporaneità e l’essere «contemporaneo» è un titolo buono solo per le barzellette. (Si racconta l’aneddoto di un borghesuccio francese che nel suo biglietto da visita aveva fatto stampare appunto «contemporaneo»: credeva di non essere nulla e un giorno scoperse di essere qualcosa invece, proprio un «contemporaneo»).
Q11 §19 Sull’arte. Nel capitolo dedicato all’arte, si afferma che anche le più recenti opere sull’estetica pongono l’identità di forma e contenuto. Questo può essere assunto come uno degli esempi più vistosi dell’incapacità critica nello stabilire la storia dei concetti e nell’identificare il reale significato dei concetti stessi a seconda delle diverse teorie. Infatti l’identificazione di contenuto e forma è affermata dall’estetica idealistica (Croce) ma su presupposti idealistici e con terminologia idealistica. «Contenuto» e «forma» non hanno quindi il significato che il Saggio suppone. Che forma e contenuto si identifichino significa che nell’arte il contenuto non è l’«astratto soggetto» cioè l’intrigo romanzesco e la particolare massa di sentimenti generici, ma l’arte stessa, una categoria filosofica un momento «distinto» dello spirito ecc. Né quindi forma significa «tecnica» come il Saggio suppone. Tutti gli spunti e gli accenni di estetica e di critica artistica contenuti nel Saggio sono da raccogliere e da analizzare. Ma può servire intanto da esempio il paragrafo dedicato al Prometeo di Goethe. Il giudizio dato è superficiale ed estremamente generico. L’autore, a quanto pare, non conosce né la storia esatta di questa ode del Goethe, né la storia del mito di Prometeo nella letteratura mondiale prima di Goethe e specialmente nel periodo precedente e contemporaneo all’attività letteraria del Goethe. Ma si può dare un giudizio, come quello dato nel Saggio, senza conoscere proprio questi elementi?
Come altrimenti distinguere ciò che è più strettamente personale di Goethe da ciò che è rappresentativo di un’epoca e di un gruppo sociale? Questo genere di giudizi in tanto sono giustificati appunto in quanto non sono vuote generalità in cui possono rientrare le cose più disparate ma sono precisi, dimostrati, perentori; altrimenti sono destinati solo a diffamare una teoria e a suscitare un modo superficiale di trattare le quistioni (è sempre da ricordare la frase di Engels contenuta nella lettera a uno studente pubblicata dal «Sozialistische Akademiker»).
Q11 §20 Oggettività e realtà del mondo esterno. Il neoscolastico Casotti (Mario Casotti, Maestro e scolaro, p. 49) scrive: «Le ricerche dei naturalisti e dei biologi presuppongono già esistenti la vita e l’organismo reale, espressione che si avvicina a quella di Engels dell’Antidühring.
Accordo del cattolicismo con l’aristotelismo sulla quistione dell’oggettività del reale.
Per intendere esattamente i significati che può avere il problema della realtà del mondo esterno, può essere opportuno svolgere l’esempio delle nozioni di «Oriente» e «Occidente» che non cessano di essere «oggettivamente reali» seppure all’analisi si dimostrano niente altro che una «costruzione» convenzionale cioè «storico‑culturale» (spesso i termini «artificiale» e «convenzionale» indicano fatti «storici», prodotti dallo sviluppo della civiltà e non già costruzioni razionalisticamente arbitrarie o individualmente artificiose). È da ricordare anche l’esempio contenuto in un libretto di Bertrand Russell tradotto in italiano e stampato in una collezione nuova scientifica della Casa ed. Sonzogno (è uno dei primi volumetti della collezione) Bertrand Russell, I problemi della filosofia (N. 5 della «Sezione Scientifica Sonzogno», L. 5). Il Russell dice presso a poco così: «Noi non possiamo pensare, senza l’esistenza dell’uomo sulla terra, all’esistenza di Londra e di Edimburgo, ma possiamo pensare all’esistenza di due punti nello spazio, dove oggi sono Londra ed Edimburgo, uno a Nord e l’altro a Sud». Si può obbiettare che senza pensare all’esistenza dell’uomo non si può pensare di «pensare», non si può pensare in genere a nessun fatto o rapporto che esiste solo in quanto esiste l’uomo.
Cosa significherebbe Nord‑Sud, Est‑Ovest senza l’uomo? Essi sono rapporti reali e tuttavia non esisterebbero senza l’uomo e senza lo sviluppo della civiltà. È evidente che Est e Ovest sono costruzioni arbitrarie, convenzionali, cioè storiche, poiché fuori della storia reale ogni punto della terra è Est e Ovest nello stesso tempo. Ciò si può vedere più chiaramente dal fatto che questi termini si sono cristallizzati non dal punto di vista di un ipotetico e malinconico uomo in generale ma dal punto di vista delle classi colte europee che attraverso la loro egemonia mondiale li hanno fatti accettare dovunque. Il Giappone è Estremo Oriente non solo per l’Europeo ma forse anche per l’Americano della California e per lo stesso Giapponese, il quale attraverso la cultura politica inglese potrà chiamare Prossimo Oriente l’Egitto. Così attraverso il contenuto storico che si è andato agglutinando al termine geografico, le espressioni Oriente e Occidente hanno finito con l’indicare determinati rapporti tra complessi di civiltà diverse. Così gli italiani spesso parlando del Marocco lo indicheranno come un paese «orientale», per riferirsi alla civiltà mussulmana e araba. Eppure questi riferimenti sono reali, corrispondono a fatti reali, permettono di viaggiare per terra e per mare e di giungere proprio dove si era deciso di giungere, di «prevedere» il futuro, di oggettivare la realtà, di comprendere la oggettività del mondo esterno. Razionale e reale si identificano. Pare che senza aver capito questo rapporto non si può capire la filosofia della praxis, la sua posizione in confronto dell’idealismo e del materialismo meccanico, l’importanza e il significato della dottrina delle superstrutture. Non è esatto che nella filosofia della praxis l’«idea» hegeliana sia stata sostituita con il «concetto» di struttura, come afferma il Croce. L’«idea» hegeliana è risolta tanto nella struttura che nelle soprastrutture e tutto il modo di concepire la filosofia è stato «storicizzato», cioè si è iniziato il nascere di un nuovo modo di filosofare più concreto e storico di quello precedente.
Q11 §21 La scienza e gli strumenti scientifici. Si afferma, nel Saggio popolare, che i progressi delle scienze sono dipendenti, come l’effetto dalla causa, dallo sviluppo degli strumenti scientifici. È questo un corollario del principio generale, accolto dal Saggio, e di origine loriana, sulla funzione storica dello «strumento di produzione e di lavoro» che viene sostituito all’insieme dei rapporti sociali di produzione. Ma nella scienza geologica non si impiega altro strumento oltre il martello e i progressi tecnici del martello non sono certo paragonabili ai progressi della geologia. Se la storia delle scienze può ridursi, secondo il Saggio, alla storia dei loro strumenti particolari, come potrà costruirsi una storia della geologia? Né vale dire che la geologia si fonda anche sui progressi di un insieme di altre scienze, per cui la storia degli strumenti di queste servono a indicare lo sviluppo della geologia, perché con questa scappatoia si finirebbe col dire una vuota generalità e col risalire a movimenti sempre più vasti, fino ai rapporti di produzione. È giusto che per la geologia il motto sia «mente et malleo».
Si può dire in generale che il progredire delle scienze non può essere documentato materialmente; la storia delle scienze può solo essere ravvivata nel ricordo, e non per tutte, con la descrizione del successivo perfezionarsi degli strumenti che sono stati uno dei mezzi del progresso, e con la descrizione delle macchine che sono state l’applicazione delle scienze stesse. I principali «strumenti» del progresso scientifico sono di ordine intellettuale (e anche politico), metodologico, e giustamente l’Engels ha scritto che gli «strumenti intellettuali» non sono nati dal nulla, non sono innati nell’uomo, ma sono acquisiti, si sono sviluppati e si sviluppano storicamente. Quanto ha contribuito al progresso delle scienze l’espulsione dell’autorità di Aristotele e della Bibbia dal campo scientifico? E questa espulsione non fu dovuta al progresso generale della società moderna? Ricordare l’esempio delle teorie sull’origine delle sorgenti. La prima formulazione esatta del modo con cui si producono le sorgenti si trova nell’Enciclopedia di Diderot ecc.; mentre si può dimostrare che gli uomini del popolo anche prima avevano opinioni esatte in proposito, nel campo degli scienziati si succedevano le teorie più arbitrarie e bizzarre che tendevano a mettere d’accordo la Bibbia e Aristotele con le osservazioni sperimentali del buon senso.
Un’altra quistione è questa: se fosse vera l’affermazione del Saggio, in che si distinguerebbe la storia delle scienze dalla storia della tecnologia? Con lo svilupparsi degli strumenti «materiali» scientifici, che si inizia storicamente con l’avvento del metodo sperimentale, si è sviluppata una particolare scienza, la scienza degli strumenti, strettamente legata allo sviluppo generale della produzione e della tecnologia.
Su questo argomento è da vedere: G. Boffito, Gli strumenti della scienza e la scienza degli strumenti, Libreria Internazionale Sceber, Firenze 1929.
Quanto sia superficiale l’affermazione del Saggio si può vedere dall’esempio delle scienze matematiche, che non hanno bisogno di strumento materiale alcuno (lo sviluppo del pallottoliere non credo si possa avanzare) e che sono esse stesse «strumento» di tutte le scienze naturali.
Q11 §22 Quistioni generali. I. Non è trattato questo punto
fondamentale: come nasce il movimento storico sulla base della
struttura. Tuttavia il problema è almeno accennato nei Problemi
fondamentali del Plekhanov e si poteva svolgere. Questo è poi il
punto cruciale di tutte le quistioni che sono nate intorno alla
filosofia della praxis e senza averlo risolto non si può
risolvere l’altro dei rapporti tra la società e la «natura», al
quale nel Saggio è dedicato uno speciale capitolo. Le due
proposizioni della prefazione alla Critica dell’Economia
politica: 1) L’umanità si pone sempre solo quei compiti che essa
può risolvere;... il compito stesso sorge solo dove le
condizioni materiali della sua risoluzione esistono già o almeno
sono nel processo del loro divenire; 2) Una formazione sociale
non perisce prima che non si siano sviluppate tutte le forze
produttive per le quali essa è ancora sufficiente e nuovi, più
alti rapporti di produzione non ne abbiano preso il posto; prima
che le condizioni materiali di esistenza di questi ultimi siano
state covate nel seno stesso della vecchia società, – avrebbero
dovuto essere analizzate in tutta la loro portata e conseguenza.
Solo su questo terreno può essere eliminato ogni meccanicismo e
ogni traccia di «miracolo» superstizioso, deve essere posto il
problema del formarsi dei gruppi politici attivi e, in ultima
analisi, anche il problema della funzione delle grandi
personalità della storia.
II. Sarebbe da compilare un registro «ponderato» degli scienziati le cui opinioni sono citate o combattute con qualche diffusione, accompagnando ogni nome con annotazioni sul loro significato e la loro importanza scientifica (ciò anche per i sostenitori della filosofia della praxis, che sono citati non certo alla stregua della loro originalità e significato). In realtà gli accenni ai grandi intellettuali sono fugacissimi. Si pone la quistione: non occorreva invece riferirsi solo ai grandi intellettuali avversari, e trascurare i secondari, i rimasticatori di frasi fatte? Si ha l’impressione appunto che si voglia combattere solo contro i più deboli e magari contro le posizioni più deboli (o più inadeguatamente sostenute dai più deboli) per ottenere facili vittorie verbali (poiché non si può parlare di vittorie reali). Ci si illude che esista una qualsiasi somiglianza (altro che formale e metaforica) tra un fronte ideologico e un fronte politico‑militare. Nella lotta politica e militare può convenire la tattica di sfondare nei punti di minore resistenza per essere in grado di investire il punto più forte col massimo di forze rese appunto disponibili dall’aver eliminato gli ausiliari più deboli ecc. Le vittorie politiche e militari, entro certi limiti, hanno un valore permanente e universale e il fine strategico può essere raggiunto in modo decisivo con effetti generali per tutti. Sul fronte ideologico, invece, la sconfitta degli ausiliari e dei minori seguaci ha importanza quasi trascurabile; in esso occorre battere contro i più eminenti. Altrimenti si confonde il giornale col libro, la piccola polemica quotidiana col lavoro scientifico; i minori devono essere abbandonati alla infinita casistica della polemica da giornali.
Una scienza nuova raggiunge la prova della sua efficienza e vitalità feconda quando mostra di saper affrontare i grandi campioni delle tendenze opposte, quando risolve coi propri mezzi le quistioni vitali che essi hanno posto o dimostra perentoriamente che tali quistioni sono falsi problemi.
È vero che un’epoca storica e una data società sono piuttosto rappresentate dalla media degli intellettuali e quindi dai mediocri, ma l’ideologia diffusa, di massa, deve essere distinta dalle opere scientifiche, dalle grandi sintesi filosofiche che ne sono poi le reali chiavi di volta e queste devono essere nettamente superate o negativamente, dimostrandone l’infondatezza, o positivamente, contrapponendo sintesi filosofiche di maggiore importanza e significato. Leggendo il Saggio si ha l’impressione di uno che non possa dormire per il chiarore lunare, e si sforzi di ammazzare quante più lucciole può, persuaso che il chiarore diminuirà o sparirà.
III. È possibile scrivere un libro elementare, un manuale, un Saggio popolare di una dottrina che è ancora allo stadio della discussione, della polemica, dell’elaborazione? Un manuale popolare non può essere concepito se non come l’esposizione, formalmente dogmatica, stilisticamente posata, scientificamente serena, d’un determinato argomento; esso non può essere che un’introduzione allo studio scientifico, e non già l’esposizione di ricerche scientifiche originali, destinato ai giovani o a un pubblico che dal punto di vista della disciplina scientifica è nelle condizioni preliminari dell’età giovanile e che perciò ha immediatamente bisogno di «certezze», di opinioni che si presentano come veridiche e fuori discussione, almeno formalmente. Se una determinata dottrina non ha ancora raggiunto questa fase «classica» del suo sviluppo, ogni tentativo di «manualizzarla» deve necessariamente fallire, la sua sistemazione logica è solo apparente e illusoria, si tratterà, invece, come appunto il Saggio, di una meccanica giustapposizione di elementi disparati, e che rimangono inesorabilmente sconnessi e slegati nonostante la vernice unitaria data dalla stesura letteraria. Perché allora non porre la quistione nei suoi giusti termini teorici e storici e accontentarsi di un libro in cui la serie dei problemi essenziali della dottrina sia esposta monograficamente? Sarebbe più serio e più «scientifico». Ma si crede volgarmente che scienza voglia assolutamente dire «sistema» e perciò si costruiscono sistemi purchessia, che del sistema non hanno la coerenza intima e necessaria ma solo la meccanica esteriorità.
IV. Nel Saggio manca una trattazione qualsiasi della dialettica. La dialettica viene presupposta, molto superficialmente, non esposta, cosa assurda in un manuale che dovrebbe contenere gli elementi essenziali della dottrina trattata e i cui riferimenti bibliografici devono essere rivolti a stimolare allo studio per allargare e approfondire l’argomento e non sostituire il manuale stesso. L’assenza di una trattazione della dialettica può avere due origini; la prima può essere costituita dal fatto che si suppone la filosofia della praxis scissa in due elementi: una teoria della storia e della politica concepita come sociologia, cioè da costruirsi secondo il metodo delle scienze naturali (sperimentale nel senso grettamente positivistico) e una filosofia propriamente detta, che poi sarebbe il materialismo filosofico o metafisico o meccanico (volgare).
(Anche dopo la grande discussione avvenuta contro il meccanicismo, l’autore del Saggio non pare abbia mutato molto l’impostazione del problema filosofico. Come appare dalla memoria presentata al Congresso di Londra di Storia della Scienza, egli continua a ritenere che la filosofia della praxis sia sempre scissa in due: la dottrina della storia e della politica e la filosofia che egli però dice essere il materialismo dialettico e non più il vecchio materialismo filosofico).
Posta così la quistione, non si capisce più l’importanza e il significato della dialettica che, da dottrina della conoscenza e sostanza midollare della storiografia e della scienza della politica viene degradata a una sottospecie di logica formale, a una scolastica elementare. Il significato della dialettica può essere solo concepito in tutta la sua fondamentalità, solo se la filosofia della praxis è concepita come una filosofia integrale e originale che inizia una nuova fase nella storia e nello sviluppo mondiale del pensiero in quanto supera (e superando ne include in sé gli elementi vitali) sia l’idealismo che il materialismo tradizionali espressioni delle vecchie società. Se la filosofia della praxis non è pensata che subordinatamente a un’altra filosofia, non si può concepire la nuova dialettica, nella quale appunto quel superamento si effettua e si esprime.
La seconda origine pare sia di carattere psicologico. Si sente che la dialettica è cosa molto ardua e difficile, in quanto il pensare dialetticamente va contro il volgare senso comune che è dogmatico, avido di certezze perentorie ed ha la logica formale come espressione. Per capire meglio si può pensare a ciò che avverrebbe se nelle scuole primarie e secondarie le scienze naturali e fisiche fossero insegnate sulla base del relativismo di Einstein e accompagnando alla nozione tradizionale di «legge della natura» quella di legge statistica o dei grandi numeri. I ragazzi non capirebbero nulla di nulla e l’urto tra l’insegnamento scolastico e la vita famigliare e popolare sarebbe tale che la scuola diverrebbe oggetto di ludibrio e di scetticismo caricaturale.
Questo motivo mi pare sia un freno psicologico per l’autore del Saggio; egli realmente capitola dinanzi al senso comune e al pensiero volgare, perché non si è posto il problema nei termini teorici esatti e quindi è praticamente disarmato e impotente. L’ambiente ineducato e rozzo ha dominato l’educatore, il volgare senso comune si è imposto alla scienza e non viceversa; se l’ambiente è l’educatore, esso deve essere educato a sua volta, ma il Saggio non capisce questa dialettica rivoluzionaria. La radice di tutti gli errori del Saggio e del suo autore (la cui posizione non è mutata anche dopo la grande discussione, in conseguenza della quale pare che egli abbia ripudiato il suo libro, come appare dalla memoria presentata al Congresso di Londra) consiste appunto in questa pretesa di dividere la filosofia della praxis in due parti: una «sociologia» e una filosofia sistematica.
Scissa dalla teoria della storia e della politica, la filosofia non può essere che metafisica, mentre la grande conquista nella storia del pensiero moderno, rappresentata dalla filosofia della praxis è appunto la storicizzazione concreta della filosofia e la sua identificazione con la storia.
Q11 §23 La teleologia. Nella concezione di «missione storica» non potrebbe scoprirsi una radice teleologica? E infatti in molti casi essa assume un significato equivoco e mistico. Ma in altri casi essa ha un significato, che, dopo il concetto kantiano della teleologia, può essere sostenuto e giustificato dalla filosofia della praxis.
Q11 §24 Il linguaggio e le metafore. In alcuni punti del Saggio si afferma, così, senz’altra spiegazione, che i primi scrittori della filosofia della praxis impiegano i termini di «immanenza» e «immanente» solo in senso metaforico; pare che la pura affermazione sia in se stessa esauriente. Ma la quistione dei rapporti tra il linguaggio e le metafore non è semplice, tutt’altro. Il linguaggio, intanto, è sempre metaforico. Se forse non si può dire esattamente che ogni discorso è metaforico per rispetto alla cosa od oggetto materiale e sensibile indicati (o al concetto astratto) per non allargare troppo il concetto di metafora, si può però dire che il linguaggio attuale è metaforico per rispetto ai significati e al contenuto ideologico che le parole hanno avuto nei precedenti periodi di civiltà. Un trattato di semantica, quello di Michel Bréal per esempio, può dare un catalogo storicamente e criticamente ricostruito delle mutazioni semantiche di determinati gruppi di parole.
Dal non tener conto di questo fatto, e cioè dal non avere un concetto critico e storicista del fenomeno linguistico, derivano molti errori sia nel campo della scienza che nel campo pratico: 1) Un errore di carattere estetico che oggi va sempre più correggendosi, ma che nel passato è stato dottrina dominante, è quello di ritenere «belle» in sé certe espressioni a differenza di altre in quanto sono metafore cristallizzate; i retori e i grammatici si sdilinquiscono per certe parolette, nelle quali scoprono chissà mai quali virtù ed essenzialità artistiche astratte. Si confonde la «gioia» tutta libresca del filologo che spasima per il risultato di certe sue analisi etimologiche o semantiche con il godimento propriamente artistico: recentemente si è avuto il caso patologico dello scritto Linguaggio e poesia di Giulio Bertoni. 2) Un errore pratico che ha molti seguaci è l’utopia delle lingue fisse e universali. 3) Una tendenza arbitraria al neolalismo, che nasce dalla quistione posta dal Pareto e dai pragmatisti a proposito del «linguaggio come causa di errore».
Il Pareto, come i pragmatisti, in quanto credono di aver originato una nuova concezione del mondo o almeno di avere innovato una determinata scienza (e di aver quindi dato alle parole un significato o almeno una sfumatura nuova, o di aver creato nuovi concetti) si trovano dinanzi al fatto che le parole tradizionali, nell’uso comune specialmente ma anche nell’uso della classe colta e perfino nell’uso di quella sezione di specialisti che trattano la stessa scienza, continuano a mantenere il vecchio significato nonostante l’innovazione di contenuto e reagiscono. Il Pareto crea un suo «dizionario» manifestando la tendenza a creare una sua lingua «pura» o «matematica». I pragmatisti teorizzano astrattamente sul linguaggio come causa di errore (vedi libretto di G. Prezzolini).
Ma è possibile togliere al linguaggio i suoi significati metaforici ed estensivi? È impossibile. Il linguaggio si trasforma col trasformarsi di tutta la civiltà, per l’affiorare di nuove classi alla coltura, per l’egemonia esercitata da una lingua nazionale sulle altre ecc., e precisamente assume metaforicamente le parole delle civiltà e culture precedenti. Nessuno oggi pensa che la parola «dis‑astro» sia legata all’astrologia e si ritiene indotto in errore sulle opinioni di chi la usa; così anche un ateo può parlare di «dis‑grazia» senza essere ritenuto seguace della predestinazione ecc. Il nuovo significato «metaforico» si estende con l’estendersi della nuova cultura, che d’altronde crea anche parole nuove di zecca e le assume in prestito da altre lingue con un significato preciso, cioè senza l’alone estensivo che avevano nella lingua originale. Così è probabile che per molti il termine di «immanenza» sia conosciuto e capito e usato per la prima volta solo nel nuovo significato «metaforico» che gli è stato dato dalla filosofia della praxis.
Q11 §25 Riduzione della filosofia della praxis a una sociologia. Questa riduzione ha rappresentato la cristallizzazione della tendenza deteriore già criticata da Engels (nelle lettere a due studenti pubblicate nel «Sozialistische Akademiker») e consistenti nel ridurre una concezione del mondo a un formulario meccanico che dà l’impressione di avere tutta la storia in tasca. Essa è stata il maggiore incentivo alle facili improvvisazioni giornalistiche dei «genialoidi». L’esperienza su cui si basa la filosofia della praxis non può essere schematizzata; essa è la storia stessa nella sua infinita varietà e molteplicità il cui studio può dar luogo alla nascita della «filologia» come metodo dell’erudizione nell’accertamento dei fatti particolari e alla nascita della filosofia intesa come metodologia generale della storia. Questo forse volevano dire quegli scrittori che, come accenna molto affrettatamente il saggio nel primo capitolo, negano si possa costruire una sociologia dalla filosofia della praxis e affermano che la filosofia della praxis vive solo nei saggi storici particolari (l’affermazione, così nuda e cruda, è certamente erronea e sarebbe una nuova curiosa forma di nominalismo e di scetticismo filosofico).
Negare che si possa costruire una sociologia, intesa come scienza della società, cioè come scienza della storia e della politica, che non sia la stessa filosofia della praxis, non significa che non si possa costruire una compilazione empirica di osservazioni pratiche che allarghino la sfera della filologia come è intesa tradizionalmente. Se la filologia è l’espressione metodologica dell’importanza che i fatti particolari siano accertati e precisati nella loro inconfondibile «individualità», non si può escludere l’utilità pratica di identificare certe «leggi di tendenza» più generali che corrispondono nella politica alle leggi statistiche o dei grandi numeri che hanno servito a far progredire alcune scienze naturali. Ma non è stato messo in rilievo che la legge statistica può essere impiegata nella scienza e nell’arte politica solo fino a quando le grandi masse della popolazione rimangono essenzialmente passive – per rispetto alle quistioni che interessano lo storico e il politico – o si suppone rimangano passive. D’altronde l’estensione della legge statistica alla scienza e all’arte politica può avere conseguenze molto gravi in quanto si assume per costruire prospettive e programmi d’azione; se nelle scienze naturali la legge può solo determinare spropositi e strafalcioni, che potranno essere facilmente corretti da nuove ricerche e in ogni modo rendono solo ridicolo il singolo scienziato che ne ha fatto uso, nella scienza e nell’arte politica può avere come risultato delle vere catastrofi, i cui danni «secchi» non potranno mai essere risarciti. Infatti nella politica l’assunzione della legge statistica come legge essenziale, fatalmente operante, non è solo errore scientifico, ma diventa errore pratico in atto; essa inoltre favorisce la pigrizia mentale e la superficialità programmatica.
È da osservare che l’azione politica tende appunto a far uscire le moltitudini dalla passività, cioè a distruggere la legge dei grandi numeri; come allora questa può essere ritenuta una legge sociologica? Se si riflette bene la stessa rivendicazione di una economia secondo un piano, o diretta, è destinata a spezzare la legge statistica meccanicamente intesa, cioè prodotta dall’accozzo casuale di infiniti atti arbitrari individuali, sebbene dovrà basarsi sulla statistica, il che però non significa lo stesso: in realtà la consapevolezza umana si sostituisce alla «spontaneità» naturalistica.
Un altro elemento che nell’arte politica porta allo sconvolgimento dei vecchi schemi naturalistici è il sostituirsi, nella funzione direttiva, di organismi collettivi (i partiti) ai singoli individui, ai capi individuali (o carismatici, come dice il Michels). Con l’estendersi dei partiti di massa e il loro aderire organicamente alla vita più intima (economico‑produttiva) della massa stessa, il processo di standardizzazione dei sentimenti popolari da meccanico e casuale (cioè prodotto dall’esistenza ambiente di condizioni e di pressioni simili) diventa consapevole e critico. La conoscenza e il giudizio di importanza di tali sentimenti non avviene più da parte dei capi per intuizione sorretta dalla identificazione di leggi statistiche, cioè per via razionale e intellettuale, troppo spesso fallace, – che il capo traduce in idee‑forza, in parole‑forza – ma avviene da parte dell’organismo collettivo per «compartecipazione attiva e consapevole», per «con‑passionalità», per esperienza dei particolari immediati, per un sistema che si potrebbe dire di «filologia vivente». Così si forma un legame stretto tra grande massa, partito, gruppo dirigente e tutto il complesso, bene articolato, si può muovere come un «uomo‑collettivo».
Il libro di Henri De Man, se ha un suo valore, lo ha appunto in questo senso: che incita a «informarsi» particolarmente dei sentimenti reali e non di quelli supposti secondo leggi sociologiche, dei gruppi e degli individui. Ma il De Man non ha fatto nessuna scoperta nuova né ha trovato un principio originale che possa superare la filosofia della praxis o dimostrarla scientificamente errata o sterile: ha elevato a principio scientifico un criterio empirico di arte politica già noto e applicato sebbene forse insufficientemente definito e sviluppato. Il De Man non ha neanche saputo limitare esattamente il suo criterio, perché ha finito col creare una nuova legge statistica e inconsapevolmente, con altro nome, un nuovo metodo di matematica sociale e di classificazione esterna, una nuova sociologia astratta.
Q11 §26 Quistioni generali. Una delle osservazioni preliminari è questa: che il titolo non corrisponde al contenuto del libro. «Teoria della filosofia della praxis» dovrebbe significare sistemazione logica e coerente dei concetti filosofici che sono sparsamente noti sotto il nome di filosofia della praxis (e che molti spesso sono spurii, di derivazione estranea e come tali dovrebbero essere criticati ed esposti). Nei primi capitoli dovrebbero essere trattate le quistioni: che cosa è la filosofia? in che senso una concezione del mondo può chiamarsi filosofia? come è stata finora concepita la filosofia? la filosofia della praxis innova questa concezione? cosa significa una filosofia «speculativa»? la filosofia della praxis potrà mai avere una forma speculativa? quali rapporti esistono tra le ideologie, le concezioni del mondo, le filosofie? quali sono o debbono essere i rapporti tra teoria e pratica? questi rapporti come sono concepiti dalle filosofie tradizionali? ecc. ecc. La risposta a queste ed altre domande costituisce la «teoria» della filosofia della praxis.
Nel Saggio popolare non è neanche giustificata coerentemente la premessa implicita nell’esposizione ed esplicitamente accennata in qualche posto, casualmente, che la vera filosofia è il materialismo filosofico e che la filosofia della praxis è una pura «sociologia». Cosa significa realmente questa affermazione? Se essa fosse vera la teoria della filosofia della praxis sarebbe il materialismo filosofico. Ma in tal caso cosa significa che la filosofia della praxis è una sociologia? E cosa sarebbe questa sociologia? Una scienza della politica e della storiografia? Oppure una raccolta sistematica e classificata secondo un certo ordine di osservazioni puramente empiriche di arte politica e di canoni esterni di ricerca storica? Le risposte a queste domande non si hanno nel libro, eppure esse solo sarebbero una teoria. Così non è giustificato il nesso tra il titolo generale Teoria ecc. e il sottotitolo Saggio popolare. Il sottotitolo sarebbe il titolo più esatto se al termine di «sociologia» si desse un significato molto circoscritto. Infatti si presenta la quistione di che cosa è la «sociologia»? Non è essa un tentativo di una cosidetta scienza esatta (cioè positivista) dei fatti sociali, cioè della politica e della storia? cioè un embrione di filosofia? La sociologia non ha cercato di fare qualcosa di simile alla filosofia della praxis?
Bisogna però intendersi: la filosofia della praxis è nata sotto forma di aforismi e di criteri pratici per un puro caso, perché il suo fondatore ha dedicato le sue forze intellettuali ad altri problemi, specialmente economici (in forma sistematica): ma in questi criteri pratici e in questi aforismi è implicita tutta una concezione del mondo, una filosofia. La sociologia è stata un tentativo di creare un metodo della scienza storico‑politica, in dipendenza di un sistema filosofico già elaborato, il positivismo evoluzionistico, sul quale la sociologia ha reagito, ma solo parzialmente. La sociologia è quindi diventata una tendenza a sé, è diventata la filosofia dei non filosofi, un tentativo di descrivere e classificare schematicamente fatti storici e politici, secondo criteri costruiti sul modello delle scienze naturali.
La sociologia è dunque un tentativo di ricavare «sperimentalmente» le leggi di evoluzione della società umana in modo da «prevedere» l’avvenire con la stessa certezza con cui si prevede che da una ghianda si svilupperà una quercia. L’evoluzionismo volgare è alla base della sociologia che non può conoscere il principio dialettico col passaggio della quantità alla qualità, passaggio che turba ogni evoluzione e ogni legge di uniformità intesa in senso volgarmente evoluzionistico. In ogni caso ogni sociologia presuppone una filosofia, una concezione del mondo, di cui è un frammento subordinato. Né bisogna confondere con la teoria generale, cioè con la filosofia, la particolare «logica» interna delle diverse sociologie, logica per cui esse acquistano una meccanica coerenza. Ciò non vuol dire naturalmente che la ricerca delle «leggi» di uniformità non sia cosa utile e interessante e che un trattato di osservazioni immediate di arte politica non abbia la sua ragion d’essere; ma occorre dire pane al pane e presentare i trattati di tal genere per quello che sono.
Tutti questi sono problemi «teorici», non quelli che l’autore del Saggio pone come tali. Le quistioni che egli pone sono quistioni di ordine immediato, politico, ideologico, intesa l’ideologia come fase intermedia tra la filosofia e la pratica quotidiana, sono riflessioni sui fatti singoli storico‑politici, slegati e casuali. Una quistione teorica si presenta all’autore fin dall’inizio quando accenna a una tendenza che nega la possibilità di costruire una sociologia dalla filosofia della praxis e sostiene che questa può esprimersi solo in lavori storici concreti. L’obbiezione, che è importantissima, non è risolta dall’autore che a parole. Certo la filosofia della praxis si realizza nello studio concreto della storia passata e nell’attività attuale di creazione di nuova storia. Ma si può fare la teoria della storia e della politica, poiché se i fatti sono sempre individuati e mutevoli nel flusso del movimento storico, i concetti possono essere teorizzati; altrimenti non si potrebbe neanche sapere cosa è il movimento o la dialettica e si cadrebbe in una nuova forma di nominalismo. (È il non aver posto con esattezza la quistione di cosa sia la «teoria» che ha impedito di porre la quistione di che cosa è la religione e di dare un giudizio storico realistico delle filosofie passate che sono presentate tutte come delirio e follia).
Nota I. Le cosidette leggi sociologiche, che vengono assunte come cause – il tal fatto avviene per la tal legge ecc. – non hanno nessuna portata causativa; esse sono quasi sempre tautologie e paralogismi. Di solito esse non sono che un duplicato del fatto stesso osservato. Si descrive il fatto o una serie di fatti, con un processo meccanico di generalizzazione astratta, si deriva un rapporto di somiglianza e questo si chiama legge, che viene assunta in funzione di causa. Ma in realtà cosa si è trovato di nuovo? Di nuovo c’è solo il nome collettivo dato a una serie di fatterelli, ma i nomi non sono novità. (Nei trattati del Michels si può trovare tutto un registro di tali generalizzazioni tautologiche: l’ultima e più famosa è quella del «capo carismatico»). Non si osserva che così si cade in una forma barocca di idealismo platonico, perché queste leggi astratte rassomigliano stranamente alle idee pure di Platone che sono l’essenza dei fatti reali terrestri.
Q11 § 27. Concetto di «ortodossia». Da alcuni punti svolti precedentemente, appare che il concetto di «ortodossia» deve essere rinnovato e riportato alle sue origini autentiche. L’ortodossia non deve essere ricercata in questo o quello dei seguaci della filosofia della praxis, in questa o quella tendenza legata a correnti estranee alla dottrina originale, ma nel concetto fondamentale che la filosofia della praxis «basta a se stessa», contiene in sé tutti gli elementi fondamentali per costruire una totale ed integrale concezione del mondo, una totale filosofia e teoria delle scienze naturali, non solo, ma anche per vivificare una integrale organizzazione pratica della società, cioè per diventare una totale, integrale civiltà. Questo concetto così rinnovato di ortodossia, serve a precisare meglio l’attributo di «rivoluzionario» che si suole con tanta facilità applicare a diverse concezioni del mondo, teorie, filosofie. Il cristianesimo fu rivoluzionario in confronto del paganesimo perché fu un elemento di completa scissione tra i sostenitori del vecchio e del nuovo mondo.
Una teoria è appunto «rivoluzionaria» nella misura in cui è elemento di separazione e distinzione consapevole in due campi, in quanto è un vertice inaccessibile al campo avversario. Ritenere che la filosofia della praxis non sia una struttura di pensiero completamente autonoma e indipendente, in antagonismo con tutte le filosofie e le religioni tradizionali, significa in realtà non aver tagliato i legami col vecchio mondo, se non addirittura aver capitolato. La filosofia della praxis non ha bisogno di sostegni eterogenei, essa stessa è così robusta e feconda di nuove verità che il vecchio mondo vi ricorre per fornire il suo arsenale di armi più moderne ed efficaci. Ciò significa che la filosofia della praxis comincia ad esercitare una propria egemonia sulla cultura tradizionale, ma questa, che è ancora robusta e soprattutto è più raffinata e leccata, tenta di reagire come la Grecia vinta, per finire di vincere il rozzo vincitore romano.
Si può dire che una gran parte dell’opera filosofica di B. Croce rappresenta questo tentativo di riassorbire la filosofia della praxis e incorporarla come ancella alla cultura tradizionale. Ma come si vede dal Saggio, anche dei seguaci che si chiamano «ortodossi» della filosofia della praxis, cadono nel tranello ed essi stessi concepiscono la loro filosofia come subordinata a una teoria generale materialistica (volgare) come altri a quella idealistica. (Ciò non vuol dire che tra la filosofia della praxis e le vecchie filosofie non vi siano rapporti, ma essi sono minori rispetto a quelli esistenti tra il cristianesimo e la filosofia greca). Nel volumetto di Otto Bauer sulla religione si possono trovare alcuni accenni sulle combinazioni a cui ha dato luogo questo erroneo concetto che la filosofia della praxis non è autonoma e indipendente, ma ha bisogno di sostenersi con un’altra filosofia, materialistica o idealistica, volta a volta. Il Bauer sostiene, come tesi politica, l’agnosticismo dei partiti e il permesso dato ai soci di aggrupparsi in idealisti, materialisti, atei, cattolici ecc. cioè del più abbietto e vile opportunismo.
Nota I. Una delle cause dell’errore per cui si va alla ricerca di una filosofia generale che stia alla base della filosofia della praxis e si nega implicitamente a questa una originalità di contenuto e di metodo pare consista in ciò: che si fa confusione tra la cultura filosofica personale del fondatore della filosofia della praxis, cioè tra le correnti filosofiche e i grandi filosofi di cui egli si è fortemente interessato da giovane e il cui linguaggio spesso riproduce (sempre però con spirito di distacco e facendo notare talvolta che così vuol far capire meglio il suo proprio concetto) e le origini o le parti costitutive della filosofia della praxis. Questo errore ha tutta una storia, specialmente nella critica letteraria, ed è noto che il lavoro di ridurre grandi opere poetiche alle loro fonti era diventato, in un certo tempo, la fatica massima di molti insigni eruditi. La quistione si pone nella sua forma esterna nei cosidetti plagi, ma è anche noto che anche per alcuni «plagi» e anzi riproduzioni letterali non è escluso che si possa sostenere una originalità per l’opera plagiata o riprodotta.
Si possono citate due esempli insigni: 1) Il sonetto del Tansillo riprodotto da Giordano Bruno negli Eroici furori (o nella Cena delle Ceneri) «Poiché spiegate ho l’ali al bel desio» (che nel Tansillo era un sonetto d’amore per la marchesana del Vasto); 2) I versi per i morti di Dogali offerti dal D’Annunzio come propri per un numero unico e che erano ricopiati alla lettera da una raccolta del Tommaseo di canti serbi. Tuttavia in Bruno e in D’Annunzio queste riproduzioni acquistano un gusto nuovo e originale che fa dimenticare la loro origine.
Lo studio della cultura filosofica di un uomo come il fondatore della filosofia della praxis non solo è interessante ma è necessario purché tuttavia non si dimentichi che esso fa parte esclusivamente della ricostruzione della sua biografia intellettuale e che gli elementi di spinozismo, di feuerbachismo, di hegelismo, di materialismo francese, ecc., non sono per nulla parti essenziali della filosofia della praxis né questa si riduce a quelli, ma che ciò che più interessa è appunto il superamento delle vecchie filosofie, la nuova sintesi o gli elementi di una nuova sintesi, il nuovo modo di concepire la filosofia i cui elementi sono contenuti negli aforismi o dispersi negli scritti del fondatore della filosofia della praxis e che appunto bisogna sceverare e sviluppare coerentemente.
In sede teorica la filosofia della praxis non si confonde e non si riduce a nessun’altra filosofia: essa non è solo originale in quanto supera le filosofie precedenti, ma specialmente in quanto apre una strada completamente nuova, cioè rinnova da cima a fondo il modo di concepire la filosofia stessa. In sede di ricerca storico‑biografica si studierà da quali interessi il fondatore della filosofia della praxis ha preso occasione per il suo filosofare, tenendo conto della psicologia del giovane studioso che volta per volta si lascia attrarre intellettualmente da ogni nuova corrente che studia ed esamina, e che si forma una sua individualità per questo stesso errare che crea lo spirito critico e la potenza di pensiero originale dopo avere sperimentato e messi a confronto tanti pensieri contrastanti, – quali elementi ha incorporato rendendoli omogenei al suo pensiero, ma specialmente ciò che è nuova creazione. È certo che l’hegelismo è il più importante (relativamente) dei motivi al filosofare del nostro autore, anche e specialmente perché l’hegelismo ha tentato di superare le concezioni tradizionali di idealismo e di materialismo in una nuova sintesi che ebbe certo una importanza eccezionale e rappresenta un momento storico‑mondiale della ricerca filosofica.
Così avviene che quando nel Saggio si dice che il termine «immanenza» nella filosofia della praxis è impiegato in senso metaforico, non si dice proprio nulla; in realtà il termine di immanenza ha acquistato un significato peculiare che non è quello dei «panteisti», né ha altro significato metafisico‑tradizionale, ma è nuovo e occorre sia stabilito. Si è dimenticato in una espressione molto comune che occorreva posare l’accento sul secondo termine «storico» e non sul primo di origine metafisica. La filosofia della praxis è lo «storicismo» assoluto, la mondanizzazione e terrestrità assoluta del pensiero, un umanesimo assoluto della storia. In questa linea è da scavare il filone della nuova concezione del mondo.
Nota II. A proposito dell’importanza che può avere la nomenclatura per le cose nuove. Nel «Marzocco» del 2 ottobre 1927, nel capitolo XI dei Bonaparte a Roma di Diego Angeli, dedicato alla principessa Carlotta Napoleone (figlia del re Giuseppe e moglie di Napoleone Luigi, fratello di Napoleone III, morto nell’insurrezione di Romagna del 1831) è riportata una lettera di Pietro Giordani alla principessa Carlotta, in cui il Giordani scrive alcuni suoi pensieri personali su Napoleone I. Nel 1805 a Bologna Napoleone si era recato a visitare l’«Istituto» (Accademia di Bologna) e conversò a lungo con quegli scienziati (fra cui il Volta). Fra l’altro disse: «...Io credo che quando nelle scienze si trova qualche cosa veramente nuova, bisogna appropriargli un vocabolo affatto nuovo, acciocché l’idea rimanga precisa e distinta. Se date nuovo significato a un vecchio vocabolo, per quanto professiate che l’antica idea attaccata a quella parola non ha niente di comune coll’idea attribuitagli nuovamente, le menti umane non possono mai ritenersi affatto che non concepiscano qualche somiglianza e connessione fra l’antica e la nuova idea; e ciò imbroglia la scienza e produce poi inutili dispute». Secondo l’Angeli, la lettera del Giordani, senza data, si può ritenere che risalga alla primavera del 1831 (quindi è da pensare che il Giordani ricordasse il contenuto generale della conversazione con Napoleone, ma non la forma esatta). Sarebbe da vedere se il Giordani nei suoi libri sulla lingua espone concetti suoi su questo argomento.
Q11 §28 L’immanenza e la filosofia della praxis. Nel Saggio si nota che nella filosofia della praxis i termini di «immanenza» e «immanente» sono usati bensì, ma che «evidentemente» questo uso è solo «metaforico». Benissimo. Ma si è così spiegato cosa «metaforicamente» immanenza e immanente significhino? Perché questi termini sono continuati ad essere usati e non sono sostituiti? Solo per l’orrore di creare nuovi vocaboli? Di solito quando una nuova concezione del mondo succede a una precedente, il linguaggio precedente continua ad essere usato ma appunto viene usato metaforicamente. Tutto il linguaggio è un continuo processo di metafore, e la storia della semantica è un aspetto della storia della cultura: il linguaggio è insieme una cosa vivente ed un museo di fossili della vita e delle civiltà passate. Quando io adopero la parola disastro nessuno può incolparmi di credenze astrologiche e quando dico «per Bacco» nessuno può credere che io sia un adoratore delle divinità pagane, tuttavia quelle espressioni sono una prova che la civiltà moderna è uno sviluppo anche del paganesimo e dell’astrologia.
Il termine «immanenza» nella filosofia della praxis ha un suo preciso significato, che si nasconde sotto la metafora e questo occorreva definire e precisare; in realtà questa definizione sarebbe stata veramente «teoria». La filosofia della praxis continua la filosofia dell’immanenza, ma la depura di tutto il suo apparato metafisico e la conduce sul terreno concreto della storia. L’uso è metaforico solo nel senso che la vecchia immanenza è superata, è stata superata, tuttavia è sempre supposta come anello nel processo di pensiero da cui è nato il nuovo. D’altronde, il nuovo concetto di immanenza è completamente nuovo? Pare che in Giordano Bruno, per esempio, ci siano molte tracce di una tale concezione nuova; i fondatori della filosofia della praxis conoscevano il Bruno. Lo conoscevano e rimangono tracce di opere del Bruno postillate da loro. D’altronde il Bruno non fu senza influenza sulla filosofia classica tedesca ecc. Ecco molti problemi di storia della filosofia che non sarebbero senza utilità.
Q11 §29 Lo «strumento tecnico». La concezione dello «strumento tecnico» è completamente errata nel Saggio popolare. Dal saggio di B. Croce su Achille Loria (Materialismo storico ed economia marxistica) sembra che appunto il Loria sia stato il primo a sostituire arbitrariamente (o per vanità puerile di scoperte originali) l’espressione di «strumento tecnico» a quella di «forze materiali di produzione» e di «complesso dei rapporti sociali».
Nella prefazione alla Critica dell’Economia politica è detto: «Nella produzione sociale della loro vita gli uomini entran fra loro in rapporti determinati, necessari ed indipendenti dal loro arbitrio, cioè in rapporti di produzione, i quali corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle materiali forze di produzione. L’insieme di tali rapporti costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una soprastruzione politica e giuridica, e alla quale corrispondono determinate forme sociali della coscienza... A un determinato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società si trovano in contraddizione coi preesistenti rapporti della produzione (cioè coi rapporti della proprietà, il che è l’equivalente giuridico di tale espressione), dentro dei quali esse forze per l’innanzi s’eran mosse. Questi rapporti della produzione, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro impedimento. E allora subentra un’epoca di rivoluzione sociale. Col cangiare del fondamento economico si rivoluziona e precipita, più o meno rapidamente, la soprastante colossale soprastruzione... Una formazione sociale non perisce, finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive per le quali essa ha campo sufficiente; e nuovi rapporti di produzione non subentrano, se prima le condizioni materiali di loro esistenza non siano state covate nel seno della società che è in essere». (Traduzione di Antonio Labriola nel suo scritto: In memoria).
Ed ecco il rifacimento del Loria (in La terra e il sistema sociale, p. 19, Verona, Drucker, 1892; ma il Croce afferma che in altri scritti del Loria ne esistono altri): «Ad un dato stadio dello stromento produttivo corrisponde, e sovr’esso si erige, un dato sistema di produzione, quindi di rapporti economici, i quali foggiano poi tutto il modo di essere della società. Ma l’evoluzione incessante dei metodi produttivi genera tosto o tardi una metamorfosi radicale dello stromento tecnico la quale rende intollerabile quel sistema di produzione e di economia, che sullo stadio anteriore della tecnica era fondato. Allora la forza economica invecchiata vien distrutta mediante una rivoluzione sociale e sostituita con una forma economica superiore, rispondente alla nuova fase dello stromento produttivo». (Un saggio brillantissimo e degno di fama il Loria ha scritto sulle virtù mirabolanti dello stromento tecnico nell’articolo L’influenza sociale dell’aeroplano pubblicato dalla «Rassegna Contemporanea» del duca di Cesarò in un fascicolo del 1912).
Il Croce aggiunge che nella Critica dell’Economia Politica (vol. I, p. 143 n. e 335‑6 n.) e altrove è messa in rilievo l’importanza delle invenzioni tecniche ed è invocata una storia della tecnica, ma non esiste nessuno scritto in cui lo «stromento tecnico» sia fatto diventare la causa unica e suprema dello svolgimento economico. Il brano della prefazione a Zur Kritik contiene le espressioni «grado di sviluppo delle materiali forze di produzione», «modo di produzione della vita materiale», «condizioni economiche della produzione» e simili, le quali affermano bensì che lo svolgimento economico è determinato da condizioni materiali, ma non riducono queste mai alla sola «metamorfosi dello strumento tecnico». Il Croce aggiunge poi che il fondatore della filosofia della praxis non si è mai proposto questa indagine intorno alla causa ultima della vita economica. «La sua filosofia non era così a buon mercato. Non aveva “civettato” invano con la dialettica dello Hegel, per andar poi a cercare le cause ultime».
È da notare che nel Saggio popolare né è riportato il brano della prefazione al Zur Kritik né vi si fa accenno. Ciò che è assai strano trattandosi della fonte autentica più importante per una ricostruzione della filosofia della praxis. D’altronde, per questo riguardo, il modo di pensare esposto nel Saggio non è differente da quello del Loria, se non è addirittura più criticabile e superficiale. Nel Saggio non si capisce esattamente cosa sia la struttura, la superstruttura, lo strumento tecnico: tutti i concetti generali vi sono nebulosi e vaghi. Lo strumento tecnico è concepito in modo così generico che esso significa ogni arnese e utensile, fino agli strumenti che adoperano gli scienziati nel loro esperimento e... gli strumenti musicali. Questo modo di porre la quistione rende inutilmente complicate le cose.
Partendo da questo barocco modo di pensare tutta una serie di questioni barocche sorgono: per esempio, le biblioteche sono strutture o superstrutture? e i gabinetti sperimentali degli scienziati? Se può essere sostenuto che un’arte o una scienza si sviluppano per lo svilupparsi dei rispettivi strumenti tecnici, perché non potrebbe sostenersi precisamente il contrario o addirittura che certe forme strumentali sono nello stesso tempo struttura e superstruttura? Si potrebbe dire che certe superstrutture hanno una propria struttura particolare pur rimanendo superstrutture: così l’arte tipografica sarebbe la struttura materiale di tutta una serie anzi di tutte le ideologie e basterebbe l’esistenza dell’industria tipografica per giustificare materialisticamente tutta la storia. Rimarrebbe poi il caso della matematica pura, dell’algebra, che non avendo strumenti propri non potrebbero svilupparsi. È evidente che tutta la teoria dello strumento tecnico del Saggio è solo un abrakadabra e che può essere paragonata alla teoria della «memoria» escogitata dal Croce per spiegare il perché gli artisti non si accontentino di concepire le loro opere solo idealmente ma le scrivano o le scolpiscano, ecc. (con la fenomenale obbiezione del Tilgher a proposito dell’architettura in cui sarebbe un po’ grossa che per mantenere la memoria di un palazzo, l’ingegnere lo costruisca) ecc. È certo che tutto ciò è una deviazione infantile della filosofia della praxis, determinata dalla convinzione barocca che quanto più si ricorre a oggetti«materiali» tanto più si è ortodossi.
Q11 §30 La «materia». Che cosa intende per «materia» il Saggio Popolare? In un saggio popolare ancor più che in un libro per i dotti, e specialmente in questo che pretende di essere il primo lavoro del genere, occorre definire con esattezza non solo i concetti fondamentali, ma tutta la terminologia, per evitare le cause di errore occasionate dalle accezioni popolari e volgari delle parole scientifiche. È evidente che per la filosofia della praxis la «materia» non deve essere intesa né nel significato quale risulta dalle scienze naturali (fisica, chimica, meccanica ecc., e questi significati sono da registrare e da studiare nel loro sviluppo storico) né nei suoi significati quali risultano dalle diverse metafisiche materialistiche. Le diverse proprietà fisiche (chimiche, meccaniche ecc.) della materia che nel loro insieme costituiscono la materia stessa (a meno che non si ricaschi in una concezione del noumeno kantiano) sono considerate, ma solo in quanto diventano «elemento economico» produttivo. La materia non è quindi da considerare come tale, ma come socialmente e storicamente organizzata per la produzione e quindi la scienza naturale come essenzialmente una categoria storica, un rapporto umano.
L’insieme delle proprietà di ogni tipo di materiale è mai stato lo stesso? La storia delle scienze tecniche dimostra di no. Per quanto tempo non si curò la forza meccanica del vapore? E si può dire che tale forza meccanica esistesse prima di essere utilizzata dalle macchine umane? Allora in che senso e fino a che punto non è vero che la natura non dà luogo a scoperte e invenzioni di forze preesistenti, di qualità preesistenti della materia, ma solo a «creazioni» che sono strettamente legate agli interessi della società, allo sviluppo e alle ulteriori necessità di sviluppo delle forze produttive? E il concetto idealistico che la natura non è altro che la categoria economica, non potrebbe, depurato dalle sue superstrutture speculative, essere ridotto in termini di filosofia della praxis ed essere dimostrato storicamente legato a questa e uno sviluppo di questa?
In realtà la filosofia della praxis non studia una macchina per conoscerne e stabilirne la struttura atomica del materiale, le proprietà fisico‑chimico-meccaniche dei suoi componenti naturali (oggetto di studio delle scienze esatte e della tecnologia), ma in quanto è un momento delle forze materiali di produzione, in quanto è oggetto di proprietà di determinate forze sociali, in quanto essa esprime un rapporto sociale e questo corrisponde a un determinato periodo storico. L’insieme delle forze materiali di produzione è l’elemento meno variabile nello sviluppo storico, è quello che volta per volta può essere accertato e misurato con esattezza matematica, che può dar luogo pertanto a osservazioni e a criteri di carattere sperimentale e quindi alla ricostruzione di un robusto scheletro del divenire storico. La variabilità dell’insieme delle forze materiali di produzione è anch’essa misurabile e si può stabilire con una certa precisione quando il suo sviluppo da quantitativo diventa qualitativo. L’insieme delle forze materiali di produzione è insieme una cristallizzazione di tutta la storia passata e la base della storia presente e avvenire, è un documento e insieme una forza attiva attuale di propulsione. Ma il concetto di attività di queste forze non può essere confuso e neppure paragonato all’attività nel senso fisico o metafisico. L’elettricità è storicamente attiva, ma non come mera forza naturale (come scarica elettrica che provoca incendi, per esempio), ma come un elemento di produzione dominato dall’uomo e incorporato nell’insieme delle forze materiali di produzione; oggetto di proprietà privata. Come forza naturale astratta, l’elettricità esisteva anche prima della sua riduzione a forza produttiva, ma non operava nella storia, ed era un argomento di ipotesi nella storia naturale (e prima era il «nulla» storico, perché nessuno se ne occupava e anzi tutti la ignoravano).
Queste osservazioni servono a far capire come l’elemento causale assunto dalle scienze naturali per spiegare la storia umana è un puro arbitrio, quando non è un ritorno alle vecchie interpretazioni ideologiche. Per esempio, il Saggio afferma che la nuova teoria atomica distrugge l’individualismo (le robinsonate). Ma cosa significa ciò? Cosa significa questo accostamento della politica alle teorie scientifiche se non che la storia è mossa da queste teorie scientifiche, cioè dalle ideologie, per cui per voler essere ultra‑materialisti si cade in una forma barocca di idealismo astratto? Né si può rispondere che non la teoria atomistica ha distrutto l’individualismo, ma la realtà naturale che la teoria descrive e constata, senza cadere nelle più complicate contraddizioni poiché questa realtà naturale si suppone precedente alla teoria e quindi operante quando l’individualismo era in auge. Come mai allora non operava la realtà «atomistica» sempre, se essa è ed era una legge naturale, ma per operare dovette aspettare che ne fosse costruita una teoria dagli uomini? Gli uomini ubbidiscono solo allora alle leggi che conoscono, come fossero leggi emanate dai Parlamenti? E chi potrebbe far osservare agli uomini le leggi che ignorano, secondo il principio della legislazione moderna per cui l’ignoranza della legge non può essere invocata dal reo? (Né può dirsi che leggi di una determinata scienza naturale sono identiche alle leggi della storia, o che essendo tutto il complesso delle idee scientifiche una unità omogenea, si può ridurre una scienza all’altra o una legge all’altra, perché in questo caso per quale privilegio questo determinato elemento della fisica e non un altro può essere quello riducibile all’unità della concezione del mondo?)
In realtà, questo è solo uno dei tanti elementi del Saggio popolare che dimostrano la superficiale impostazione del problema della filosofia della praxis, il non aver saputo dare a questa concezione del mondo la sua autonomia scientifica e la posizione che le spetta di fronte alle scienze naturali, anzi, peggio, a quel vago concetto di scienza in generale che è proprio della concezione volgare del popolo (per il quale anche i giochi di prestigio sono scienza). La teoria atomistica moderna è una teoria «definitiva» stabilita una volta per sempre? Chi, quale scienziato oserebbe affermarlo? O non è invece anch’essa semplicemente una ipotesi scientifica che potrà essere superata, cioè assorbita in una teoria più vasta e comprensiva? Perché dunque il riferimento a questa teoria dovrebbe essere stato decisivo e aver posto fine alla quistione dell’individualismo e delle robinsonate? (A parte il fatto che le robinsonate possono essere talvolta schemi pratici costruiti per indicare una tendenza o per una dimostrazione per assurdo: anche l’autore della Economia critica ha fatto ricorso a delle robinsonate). Ma ci sono altre quistioni: se la teoria atomistica fosse quello che il Saggio pretende, dato che la storia della società è una serie di rivolgimenti e le forme di società sono state numerose, mentre la teoria atomistica sarebbe il riflesso di una realtà naturale sempre simile, come mai anche la società non ha obbedito sempre a questa legge? O si pretenderebbe che il passaggio dal regime corporativo medioevale all’individualismo economico sia stato antiscientifico, uno sbaglio della storia e della natura? Secondo la teoria della praxis è evidente che non la teoria atomistica spiega la storia umana, ma viceversa, che cioè la teoria atomistica come tutte le ipotesi e le opinioni scientifiche sono superstrutture. La teoria atomistica servirebbe a spiegare l’uomo biologico come aggregato di corpi diversi e a spiegare la società degli uomini. Che teoria comprensiva!
Q11 §31 La causa ultima. Una delle tracce più vistose di vecchia metafisica nel Saggio popolare è la ricerca di ridurre tutto a una causa, la causa ultima, la causa finale. Si può ricostruire la storia del problema della causa unica e ultima e dimostrare che essa è una delle manifestazioni della «ricerca di dio». Contro questo dogmatismo ricordare ancora le due lettere di Engels pubblicate nel «Sozialistische Akademiker».
Q11 §32 Quantità e qualità. Nel Saggio popolare si dice (occasionalmente, perché l’affermazione non è giustificata, valutata, non esprime un concetto fecondo, ma è casuale, senza nessi antecedenti e susseguenti) che ogni società è qualcosa di più della mera somma dei suoi componenti individuali. Ciò è vero astrattamente, ma cosa significa concretamente? La spiegazione che ne è stata data, empiricamente, è spesso stata una cosa barocca. Si è detto che cento vacche una per una sono ben diverse da cento vacche insieme che allora sono un armento, facendo una semplice quistione di parole. Così si è detto che nella numerazione arrivati a dieci abbiamo una decina, come se non ci fosse la coppia, il terzetto, il quartetto, ecc., cioè un semplice diverso modo di numerare. La spiegazione teorico‑pratica più concreta si ha nel I volume della Critica dell’Economia politica, dove si dimostra che nel sistema di fabbrica, esiste una quota di produzione che non può essere attribuita a nessun lavoratore singolo ma all’insieme delle maestranze, all’uomo collettivo. Qualcosa di simile avviene per l’intera società che è basata sulla divisione del lavoro e delle funzioni e pertanto vale più della somma dei suoi componenti. Come la filosofia della praxis abbia «concretato» la legge hegeliana della quantità che diventa qualità è un altro di quei nodi teorici che il Saggio popolare non svolge, ma ritiene già noti, quando non si accontenta di semplici giochi di parole come quelli sull’acqua che col cambiare di temperatura cambia di stato (ghiacciato, liquido, gasoso), che è un fatto puramente meccanico, determinato da un agente esterno (il fuoco, il sole, o l’evaporazione dell’acido carbonico solido ecc.).
Nell’uomo chi sarà questo agente esterno? Nella fabbrica è la divisione del lavoro ecc., condizioni create dall’uomo stesso. Nella società l’insieme delle forze produttive. Ma l’autore del Saggio non ha pensato che se ogni aggregato sociale è qualcosa di più (e anche di diverso) della somma dei suoi componenti, ciò significa che la legge o il principio che spiega lo svolgersi delle società non può essere una legge fisica poiché nella fisica non si esce mai dalla sfera della quantità altro che per metafora. Tuttavia nella filosofia della praxis la qualità è sempre connessa alla quantità, e anzi forse in tale connessione è la sua parte più originale e feconda. Infatti l’idealismo ipostatizza questo qualcosa in più, la qualità, ne fa un ente a sé, lo «spirito», come la religione ne aveva fatto la divinità. Ma se è ipostasi quella della religione e dell’idealismo, cioè astrazione arbitraria non processo di distinzione analitica praticamente necessario per ragioni pedagogiche, è anche ipostasi quella del materialismo volgare, che «divinizza» una materia ipostatica.
È da confrontare questo modo di vedere nella concezione della società con la concezione dello Stato proprio degli idealisti attuali. Per gli attualisti lo Stato finisce con l’essere proprio questo qualcosa di superiore agli individui (sebbene dopo le conseguenze che lo Spirito ha tratto a proposito della proprietà dell’identificazione idealistica dell’individuo e dello Stato, il Gentile nell’«Educazione fascista» dell’agosto 1932 ha precisato prudentemente). La concezione degli attualisti volgari era caduta così in basso nel puro psittacismo che l’unica critica possibile era la caricatura umoristica. Si poteva pensare una recluta che agli ufficiali arruolatori espone la teoria dello Stato superiore agli individui e domanda che lascino libera la sua persona fisica e materiale e arruolino quel tantino di qualcosa che contribuisce a costruire il qualcosa nazionale che è lo Stato. O ricordare la storia del Novellino in cui il saggio Saladino dirime la vertenza tra il rosticciere che vuol essere pagato per l’uso delle emanazioni aromatiche delle sue vivande e il mendicante che non vuol pagare: il Saladino fa pagare col tintinnio delle monete e dice al rosticciere di intascare il suono come il mendicante ha mangiato gli effluvi aromatici.
Q11 §33 Quistioni generali. Una trattazione sistematica della filosofia della praxis non può trascurare nessuna delle parti costitutive della dottrina del suo fondatore. Ma in che senso ciò deve essere inteso? Essa deve trattare tutta la parte generale filosofica, deve svolgere quindi coerentemente tutti i concetti generali di una metodologia della storia e della politica, e inoltre dell’arte, dell’economia, dell’etica e deve nel nesso generale trovare il posto per una teoria delle scienze naturali. Una concezione molto diffusa è che la filosofia della praxis è una pura filosofia, la scienza della dialettica, e che le altre parti sono l’economia e la politica, per cui si dice che la dottrina è formata di tre parti costitutive, che sono nello stesso tempo il coronamento e il superamento del grado più alto che verso il 48 aveva raggiunto la scienza delle nazioni più progredite d’Europa: la filosofia classica tedesca, l’economia classica inglese e l’attività e scienza politica francese. Questa concezione, che è più una generica ricerca delle fonti storiche che non una classificazione che nasca dall’intimo della dottrina, non può contrapporsi come schema definitivo, a ogni altra organizzazione della dottrina che sia più aderente alla realtà. Si domanderà se la filosofia della praxis non sia appunto specificatamente una teoria della storia e si risponde che ciò è vero ma perciò dalla storia non possono staccarsi la politica e l’economia, anche nelle fasi specializzate, di scienza e arte della politica e di scienza e politica economica. Cioè: dopo avere, nella parte filosofica generale (che è la filosofia della praxis vera e propria, la scienza della dialettica o gnoseologia, in cui i concetti generali di storia, di politica, di economia si annodano in unità organica) svolto il compito principale, è utile, in un saggio popolare, dare le nozioni generali di ogni momento o parte costitutiva, anche in quanto scienza indipendente e distinta. Se si osserva bene si vede che nel Saggio popolare tutti questi punti sono almeno accennati, ma casualmente, non coerentemente, in modo caotico e indistinto, perché manca ogni concetto chiaro e preciso di che sia la stessa filosofia della praxis.
Q11 §34 La oggettività del mondo esterno. L’espressione di Engels che «la materialità del mondo è dimostrata dal lungo e laborioso sviluppo della filosofia e delle scienze naturali» dovrebbe essere analizzata e precisata. S’intende per scienza l’attività teorica o l’attività pratico‑sperimentale degli scienziati? o la sintesi delle due attività? Si potrebbe dire che in ciò si avrebbe il processo unitario tipico del reale, nell’attività sperimentale dello scienziato che è il primo modello di mediazione dialettica tra l’uomo e la natura, la cellula storica elementare per cui l’uomo, ponendosi in rapporto con la natura attraverso la tecnologia, la conosce e la domina. È indubbio che l’affermarsi del metodo sperimentale separa due mondi della storia, due epoche e inizia il processo di dissoluzione della teologia e della metafisica, e di sviluppo del pensiero moderno, il cui coronamento è nella filosofia della praxis. L’esperienza scientifica è la prima cellula del nuovo metodo di produzione, della nuova forma di unione attiva tra l’uomo e la natura. Lo scienziato‑sperimentatore è anche un operaio, non un puro pensatore e il suo pensare è continuamente controllato dalla pratica e viceversa, finché si forma l’unità perfetta di teoria e pratica.
Nota I. È da studiare la posizione del prof. Lukacz verso la filosofia della praxis. Pare che il Lukacz affermi che si può parlare di dialettica solo per la storia degli uomini e non per la natura. Può aver torto e può aver ragione. Se la sua affermazione presuppone un dualismo tra la natura e l’uomo egli ha torto perché cade in una concezione della natura propria della religione e della filosofia greco‑cristiana e anche propria dell’idealismo, che realmente non riesce a unificare e mettere in rapporto l’uomo e la natura altro che verbalmente. Ma se la storia umana deve concepirsi anche come storia della natura (anche attraverso la storia della scienza) come la dialettica può essere staccata dalla natura? Forse il Lukacz, per reazione alle teorie barocche del Saggio popolare, è caduto nell’errore opposto, in una forma di idealismo. É certo che in Engels (Antidühring) si trovano molti spunti che possono portare alle deviazioni del Saggio. Si dimentica che Engels, nonostante che vi abbia lavorato a lungo, ha lasciato scarsi materiali sull’opera promessa per dimostrare la dialettica legge cosmica e si esagera nell’affermare l’identità di pensiero tra i due fondatori della filosofia della praxis.
Q11 §35 La teleologia. Nella quistione della teleologia appare ancora più vistosamente il difetto del Saggio nel presentare le dottrine filosofiche passate su uno stesso piano di trivialità e banalità, così che al lettore pare che tutta la cultura passata sia stata una fantasmagoria di baccanti in delirio. Il metodo è riprovevole da molti punti di vista: un lettore serio, che estenda le sue nozioni e approfondisca i suoi studi, crede di essere stato preso in giro ed estende il sospetto a tutto l’insieme del sistema. È facile parere di aver superato una posizione abbassandola, ma si tratta di pura illusione verbale. Presentare così burlescamente le quistioni può avere un significato in Voltaire, ma non è Voltaire chiunque voglia, cioè non è grande artista.
Così il Saggio presenta la quistione della teleologia nelle sue manifestazioni più infantili, mentre dimentica la soluzione data da Kant. Si potrebbe forse dimostrare che nel Saggio c’è molta teleologia inconscia che riproduce senza saperlo il punto di vista di Kant: per esempio il capitolo sull’«Equilibrio tra la natura e la società».
Dalle Xenie di Goethe: «Il Teleologo: – Il Creatore buono adoriamo del mondo, che, quando – il sughero creò, inventò insieme il tappo» (trad. di B. Croce nel vol. su Goethe, p. 262). Il Croce mette questa nota: «Contro il finalismo estrinseco, generalmente accolto nel secolo decimottavo, e che il Kant aveva di recente criticato surrogandolo con un più profondo concetto della finalità». Altrove e in altra forma il Goethe ripete questo stesso motivo e dice di averlo derivato dal Kant: «Il Kant è il più eminente dei moderni filosofi, quello le cui dottrine hanno maggiormente influito sulla mia cultura. La distinzione del soggetto dall’oggetto e il principio scientifico che ogni cosa esiste e si svolge per ragion sua propria ed intrinseca (che il sughero, a dirla proverbialmente, non nasce per servir di turacciolo alle nostre bottiglie) ebb’io comune col Kant, ed io in seguito applicai molto studio alla sua filosofia».
III. La scienza e le ideologie «scientifiche».
Q11 §36 L’affermazione di Eddington: «Se nel corpo di un uomo eliminassimo tutto lo spazio privo di materia e riunissimo i suoi protoni ed elettroni in una sola massa, l’uomo (il corpo dell’uomo) sarebbe ridotto a un corpuscolo appena visibile al microscopio» (cfr La natura del mondo fisico, edizione francese, p. 20) ha colpito e messo in moto la fantasia di G. A. Borgese (cfr il suo libretto). Ma che significa concretamente l’affermazione di Eddington? A rifletterci un po’, non significa proprio nulla, oltre il suo significato letterale. Se anche la riduzione su descritta venisse fatta (da chi?) e fosse però estesa a tutto il mondo, i rapporti non muterebbero, le cose rimarrebbero tali come sono. Le cose muterebbero se solamente gli uomini o determinati uomini subissero questa riduzione in modo da avere, nell’ipotesi, una realizzazione di alcuni capitoli dei Viaggi di Gulliver, con i Lillipuziani, i giganti e Borgese‑Gulliver tra di loro.
In realtà si tratta di puri giochi di parole, di scienza romanzata, non di un nuovo pensiero scientifico o filosofico, di un modo di porre le questioni atto solo a far fantasticare le teste vuote. Forse la materia vista al microscopio non è più materia realmente oggettiva, ma una creazione dello spirito umano che non esiste oggettivamente o empiricamente? Si potrebbe ricordare, a questo proposito, la novellina ebrea della ragazza che ha subito un guasto piccolo, piccolo, tic... come un colpetto d’unghia. Nella fisica di Eddington e in molte altre manifestazioni scientifiche moderne, la sorpresa del lettore ingenuo dipende dal fatto che le parole adoperate per indicare determinati fatti sono piegate ad indicare arbitrariamente fatti assolutamente diversi. Un corpo rimane «massiccio» nel senso tradizionale anche se la «nuova» fisica dimostra che esso è costituito di 1 / 1000000 di materia e di 999999 parti di vuoto. Un corpo è «poroso» nel senso tradizionale e non lo diventa nel senso della «nuova» fisica anche dopo l’affermazione di Eddington. La posizione dell’uomo rimane la stessa, nessuno dei concetti fondamentali della vita viene minimamente scosso e tanto meno capovolto. Le glosse dei diversi Borgese varranno solo, a lungo andare, a rendere ridicole le concezioni soggettivistiche della realtà che permettono simili banali giochetti di parole.
Il prof. Mario Camis (Nuova Antologia del 1° novembre 1931, nella rubrica «Scienze biologiche e mediche») scrive: «Considerando la insuperata minutezza di questi metodi di indagine ci tornava alla memoria la espressione di un membro dell’ultimo Congresso filosofico di Oxford il quale, secondo riferisce il Borgese, parlando dei fenomeni infinitamente piccoli cui l’attenzione dei tanti è oggi rivolta, osservava che “essi non si possono considerare indipendentemente dal soggetto che li osserva”. Sono parole che inducono a molte riflessioni e che rimettono in campo, da punti di vista completamente nuovi, i grandi problemi dell’esistenza soggettiva dell’universo e del significato delle informazioni sensoriali nel pensiero scientifico».
A quanto consta, è questo uno dei pochi esempi di infiltrazione fra gli scienziati italiani del modo di pensare funambolesco di certi scienziati specialmente inglesi a proposito della «nuova» fisica. Il prof. Camis avrebbe dovuto riflettere che se l’osservazione riportata dal Borgese fa riflettere, la prima riflessione dovrebbe essere questa: che la scienza non può più esistere, così come è concepita finora, ma deve trasformarsi in una serie di atti di fede nelle affermazioni dei singoli sperimentatori, perché i fatti osservati non esistono indipendentemente dal loro spirito. Tutto il progresso scientifico non si è manifestato finora nel fatto che le nuove esperienze ed osservazioni hanno corretto e ampliato le esperienze ed osservazioni precedenti? Come questo potrebbe avvenire se l’esperienza data non si riproducesse anche se, mutato l’osservatore, non potesse essere controllata, ampliata, dando luogo a nessi nuovi e originali?
Ma la superficialità dell’osservazione del Camis risulta proprio dal contesto dell’articolo da cui è fatta la citazione riferita, poiché in esso il Camis spiega implicitamente come l’espressione che ha fatto tanto vaneggiare il Borgese possa e debba intendersi in un senso meramente empirico e non filosofico. Lo scritto del Camis è una recensione dell’opera On the principles of renal function di Gösta Ekehorn (Stoccolma, 1931). Si parla di esperienze su elementi così piccoli che non possono essere descritti (e si intende anche ciò in senso relativo) con parole che siano valide e rappresentative per gli altri e che pertanto l’esperimentatore non riesce ancora a scindere dalla propria personalità soggettiva e ad oggettivare: ogni sperimentatore deve giungere alla percezione con mezzi propri, direttamente, seguendo minutamente tutto il processo.
Si faccia questa ipotesi: che non esistano microscopi e che solo alcuni uomini abbiano la forza visiva naturale uguale a quella dell’occhio normale armato di microscopio. In questa ipotesi è evidente che le esperienze dell’osservatore munito di una vista eccezionale non possono essere scisse dalla sua personalità fisica e psichica e non possono essere «ripetute». Solo l’invenzione del microscopio pareggerà le condizioni fisiche di osservazione e permetterà a tutti gli scienziati di riprodurre l’esperienza e di svilupparla collettivamente. Ma questa ipotesi permette di osservare e identificare solo una parte delle difficoltà; nelle esperienze scientifiche non è solo la forza visiva in gioco. Come dice il Camis: l’Ekehorn punge un glomerulo di rene di rana con una cannula «la cui preparazione è opera di tanta finezza e tanto legata alle indefinibili ed inimitabili intuizioni manuali dello sperimentatore, che lo stesso Ekehorn, nel descrivere l’operazione del taglio a sghembo del capillare di vetro, dice di non poterne dare i precetti a parole, ma deve accontentarsi di una vaga indicazione». L’errore è di credere che simili fenomeni si verifichino solo nell’esperimento scientifico. In realtà, in ogni officina, per certe operazioni industriali di precisione, esistono specialisti individuali, la cui capacità si basa proprio e solo sull’estrema sensibilità della vista, del tatto, della rapidità del gesto.
Nei libri di Ford si possono trovare esempi in proposito: nella lotta contro l’attrito, per ottenere superfici senza minime granulosità o ineguaglianze (ciò che permette un risparmio notevole di materiale) si sono fatti passi in avanti incredibili, con l’aiuto delle macchine elettriche, che collaudano l’aderenza perfetta del materiale come l’uomo non potrebbe fare. È da ricordare il fatto riferito dal Ford di un tecnico scandinavo che riesce a dare all’acciaio una tale eguaglianza di superficie che per staccare due superfici fatte aderire tra loro occorre il peso di alcuni quintali.
Ciò che pertanto osserva il Camis non ha nessuna coerenza con le fantasticherie del Borgese e delle sue fonti. Se fosse vero che i fenomeni infinitamente piccoli in questione non si possono considerare esistenti indipendentemente dal soggetto che li osserva, essi in realtà non sarebbero neppure «osservati», ma «creati» e cadrebbero nello stesso dominio della pura intuizione fantastica dell’individuo. Sarebbe anche da porre la quistione se lo stesso individuo può «due volte» creare (osservare) lo stesso fatto. Non si tratterebbe neppure di «solipsismo» ma di demiurgia o di stregoneria. Non i fenomeni (inesistenti) ma queste intuizioni fantastiche sarebbero allora oggetto di scienza, come le opere d’arte. Il gregge degli scienziati, che non gode di facoltà demiurgiche, studierebbe scientificamente il piccolo gruppo dei grandi scienziati taumaturghi. Ma se invece, nonostante tutte le difficoltà pratiche inerenti alla diversa sensibilità individuale, il fenomeno si ripete, e può essere osservato oggettivamente da vari scienziati, indipendentemente gli uni dagli altri, cosa significa l’affermazione riportata dal Borgese se non appunto che si fa una metafora per indicare le difficoltà inerenti alla descrizione e alla rappresentazione oggettiva dei fenomeni osservati? E non pare difficile spiegare questa difficoltà: 1) con l’incapacità letteraria degli scienziati, didatticamente preparati finora a descrivere e rappresentare solo i fenomeni macroscopici; 2) con l’insufficienza del linguaggio comune, foggiato anch’esso per i fenomeni macroscopici; 3) col relativamente piccolo sviluppo di queste scienze minimoscopiche, che attendono un ulteriore sviluppo dei loro metodi e criteri per essere comprese dai molti per comunicazione letteraria (e non solo per diretta visione sperimentale, che è privilegio di pochissimi); 4) occorre ancora ricordare che molte esperienze minimoscopiche sono esperienze indirette, a catena, il cui risultato «si vede» nei risultati e non in atto (così le esperienze di Rutherford).
Si tratta, in ogni modo, di una fase transitoria e iniziale di una nuova epoca scientifica, che ha prodotto, combinandosi con una grande crisi intellettuale e morale, una nuova forma di «sofistica», che richiama i classici sofismi di Achille e della tartaruga, del mucchio e del granello, della freccia scoccata dall’arco che non può non essere ferma ecc. Sofismi che tuttavia hanno rappresentato una fase nello sviluppo della filosofia e della logica e hanno servito a raffinare gli strumenti del pensiero.
Q11 §37 Raccogliere le principali definizioni che sono state date della scienza (nel senso di scienza naturale). «Studio dei fenomeni e delle loro leggi di somiglianza (regolarità), di coesistenza (coordinazione), di successione (causalità)». Altre tendenze, tenendo conto dell’ordinamento più comodo che la scienza stabilisce tra i fenomeni, in modo da poterli meglio far padroneggiare dal pensiero e dominarli per i fini dell’azione, definiscono la scienza come «la descrizione più economica della realtà». La quistione più importante da risolvere intorno al concetto di scienza è questa: se la scienza può dare, e in che modo, la «certezza» dell’esistenza obbiettiva della così detta realtà esterna.
Per il senso comune la quistione non esiste neppure; ma da che cosa è originata la certezza del senso comune? Essenzialmente dalla religione (almeno dal cristianesimo in occidente); ma la religione è un’ideologia, l’ideologia più radicata e diffusa, non una prova o una dimostrazione. Si può sostenere come sia un errore domandare alla scienza come tale la prova dell’obbiettività del reale, poiché questa obbiettività è una concezione del mondo, una filosofia e non può essere un dato scientifico. Cosa può dare la scienza in questa direzione? La scienza seleziona le sensazioni, gli elementi primordiali della conoscenza: considera certe sensazioni come transitorie, come apparenti, come fallaci perché dipendono da speciali condizioni individuali e certe altre come durature, come permanenti, come superiori alle condizioni speciali individuali.
Il lavoro scientifico ha due aspetti principali: uno che incessantemente rettifica il modo della conoscenza, rettifica e rafforza gli organi delle sensazioni, elabora principi nuovi e complessi di induzione e deduzione, cioè affina gli strumenti stessi dell’esperienza e del suo controllo; l’altro che applica questo complesso strumentale (di strumenti materiali e mentali) a stabilire ciò che nelle sensazioni è necessario da ciò che è arbitrario, individuale, transitorio. Si stabilisce ciò che è comune a tutti gli uomini, ciò che tutti gli uomini possono controllare nello stesso modo, indipendentemente gli uni dagli altri, purché essi abbiano osservato ugualmente le condizioni tecniche di accertamento. «Oggettivo» significa proprio e solo questo: che si afferma essere oggettivo, realtà oggettiva, quella realtà che è accertata da tutti gli uomini, che è indipendente da ogni punto di vista che sia meramente particolare o di gruppo. Ma in fondo anche questa è una particolare concezione del mondo, è una ideologia. Tuttavia questa concezione, nel suo insieme e per la direzione che segna, può essere accettata dalla filosofia della praxis mentre è da rigettare quella del senso comune, che pure conclude materialmente nello stesso modo. Il senso comune afferma l’oggettività del reale in quanto la realtà, il mondo, è stato creato da dio indipendentemente dall’uomo, prima dell’uomo; essa è pertanto espressione della concezione mitologica del mondo; d’altronde il senso comune, nel descrivere questa oggettività, cade negli errori più grossolani, in gran parte è ancora rimasto alla fase dell’astronomia tolemaica, non sa stabilire i nessi reali di causa ed effetto ecc., cioè afferma «oggettiva» una certa «soggettività» anacronistica, perché non sa neanche concepire che possa esistere una concezione soggettiva del mondo e cosa ciò voglia o possa significare. Ma tutto ciò che la scienza afferma è «oggettivamente» vero? In modo definitivo?
Se le verità scientifiche fossero definitive, la scienza avrebbe cessato di esistere come tale, come ricerca, come nuovi esperimenti e l’attività scientifica si ridurrebbe a una divulgazione del già scoperto. Ciò che non è vero, per fortuna della scienza. Ma se le verità scientifiche non sono neanche esse definitive e perentorie, anche la scienza è una categoria storica, è un movimento in continuo sviluppo. Solo che la scienza non pone nessuna forma di «inconoscibile» metafisico, ma riduce ciò che l’uomo non conosce a un’empirica «non conoscenza» che non esclude la conoscibilità, ma la condiziona allo sviluppo degli elementi fisici strumentali e allo sviluppo della intelligenza storica dei singoli scienziati.
Se è così, ciò che interessa la scienza non è tanto dunque l’oggettività del reale, ma l’uomo che elabora i suoi metodi di ricerca, che rettifica continuamente i suoi strumenti materiali che rafforzano gli organi sensori e gli strumenti logici (incluse le matematiche) di discriminazione e di accertamento, cioè la cultura, cioè la concezione del mondo, cioè il rapporto tra l’uomo e la realtà con la mediazione della tecnologia. Anche nella scienza cercare la realtà fuori degli uomini, inteso ciò nel senso religioso o metafisico, appare niente altro che un paradosso. Senza l’uomo, cosa significherebbe la realtà dell’universo? Tutta la scienza è legata ai bisogni, alla vita, all’attività dell’uomo. Senza l’attività dell’uomo, creatrice di tutti i valori, anche scientifici, cosa sarebbe l’«oggettività»? Un caos, cioè niente, il vuoto, se pure così si può dire, perché realmente, se si immagina che non esiste l’uomo, non si può immaginare la lingua e il pensiero. Per la filosofia della praxis l’essere non può essere disgiunto dal pensare, l’uomo dalla natura, l’attività dalla materia, il soggetto dall’oggetto; se si fa questo distacco si cade in una delle tante forme di religione o nell’astrazione senza senso.
Q11 §38 Porre la scienza a base della vita, fare della scienza la concezione del mondo per eccellenza, quella che snebbia gli occhi da ogni illusione ideologica, che pone l’uomo dinanzi alla realtà così come essa è, significa ricadere nel concetto che la filosofia della praxis abbia bisogno di sostegni filosofici all’infuori di se stessa. Ma in realtà anche la scienza è una superstruttura, una ideologia. Si può dire, tuttavia, che nello studio delle superstrutture la scienza occupi un posto privilegiato, per il fatto che la sua reazione sulla struttura ha un carattere particolare, di maggiore estensione e continuità di sviluppo, specialmente dopo il Settecento, da quando alla scienza fu fatto un posto a patte nell’apprezzamento generale?
Che la scienza sia una superstruttura è dimostrato anche dal fatto che essa ha avuto dei periodi interi di ecclisse, oscurata come essa fu da un’altra ideologia dominante, la religione, che affermava di aver assorbito la scienza stessa: così la scienza e la tecnica degli arabi apparivano ai cristiani pura stregoneria. Inoltre: la scienza, nonostante tutti gli sforzi degli scienziati non si presenta mai come nuda nozione obbiettiva: essa appare sempre rivestita da una ideologia e concretamente è scienza l’unione del fatto obbiettivo con un’ipotesi o un sistema d’ipotesi che superano il mero fatto obbiettivo. È vero però che in questo campo è relativamente facile distinguere la nozione obbiettiva dal sistema d’ipotesi, con un processo di astrazione che è insito nella stessa metodologia scientifica, in modo che si può appropriarsi dell’una e respingere l’altro. Ecco perché un gruppo sociale può appropriarsi la scienza di un altro gruppo senza accettarne l’ideologia (l’ideologia dell’evoluzione volgare, per esempio) così che le osservazioni in proposito del Missiroli (e del Sorel) cadono.
Q11 §39 È da notare che accanto alla più superficiale infatuazione per le scienze, esiste in realtà la più grande ignoranza dei fatti e dei metodi scientifici, cose molto difficili e che sempre più diventano difficili per il progressivo specializzarsi di nuovi rami di ricerca. La superstizione scientifica porta con sé illusioni così ridicole e concezioni così infantili che la stessa superstizione religiosa ne viene nobilitata. Il progresso scientifico ha fatto nascere la credenza e l’aspettazione di un nuovo tipo di Messia, che realizzerà in questa terra il paese di Cuccagna; le forze della natura, senza nessun intervento della fatica umana, ma per opera di meccanismi sempre più perfezionati, daranno alla società in abbondanza tutto il necessario per soddisfare i suoi bisogni e vivere agiatamente. Contro questa infatuazione, i cui pericoli sono evidenti (la superstiziosa fede astratta nella forza taumaturgica dell’uomo, paradossalmente porta ad isterilire le basi stesse di questa stessa forza e a distruggere ogni amore al lavoro concreto e necessario, per fantasticare, come se si fosse fumato una nuova specie di oppio) bisogna combattere con vari mezzi, dei quali il più importante dovrebbe essere una migliore conoscenza delle nozioni scientifiche essenziali, divulgando la scienza per opera di scienziati e di studiosi seri e non più di giornalisti onnisapienti e di autodidatti presuntuosi. In realtà, poiché si aspetta troppo dalla scienza, la si concepisce come una superiore stregoneria, e perciò non si riesce a valutare realisticamente ciò che di concreto la scienza offre.
IV. Gli strumenti logici del pensiero.
Q11 §40 Cfr Mario Govi, Fondazione della Metodologia. Logica ed Epistemologia, Torino, Bocca, 1929, pp. 579. Il Govi è un positivista e il suo libro tende a rinnovare il vecchio positivismo classico, a creare un neopositivismo. In fondo per il Govi «metodologia» ha un significato molto ristretto, di «piccola logica»: si tratta per lui di costruire una nuova logica formale, astratta da ogni contenuto, anche dove egli parla delle varie scienze (classificate secondo la metodologia generale, ma sempre esteriormente) che sono presentate nella loro particolare logica astratta (specializzata, ma astratta), che il Govi chiama Epistemologia. Il Govi appunto divide la Metodologia in due parti: Metodologia generale o Logica propriamente detta e Metodologia speciale o Epistemologia. La Epistemologia ha come scopo primario e principale la conoscenza esatta di quello speciale scopo conoscitivo a cui ciascuna diversa ricerca è diretta, per poter poi determinare i mezzi e il procedimento per conseguirlo. Il Govi riduce a tre i diversi scopi conoscitivi legittimi della ricerca umana; questi tre scopi costituiscono lo scibile umano e sono irriducibili a uno solo, ossia sono essenzialmente diversi. Due sono scopi conoscitivi finali: la conoscenza teoretica o della realtà, la conoscenza pratica o di ciò che si deve o non si deve fare; il terzo consiste nelle conoscenze le quali sono mezzi per l’acquisizione delle precedenti. Si hanno dunque tre parti nella Epistemologia: scienza teorica o della realtà, scienza pratica, scienza strumentale. Da ciò tutta una analitica classificazione delle scienze. Il concetto di legittimo ha una grande importanza nel sistema del Govi (esso è parte della metodologia generale o scienza del giudizio): ogni giudizio, considerato in sé, è vero o falso; considerato soggettivamente, ossia come prodotto dell’attività del pensiero di chi lo fa, è legittimo o illegittimo. Un giudizio può essere conosciuto vero o falso solo in quanto è riconosciuto legittimo o illegittimo. Sono legittimi i giudizi che sono eguali in tutti gli uomini (che li abbiano o li facciano) e vengono formati in tutti egualmente: sono quindi legittimi i concetti primitivi formati naturalmente e senza dei quali non si può pensare, i concetti scientifici formati metodologicamente, i giudizi primitivi e i giudizi metodologicamente derivati dai giudizi legittimi.
Questi cenni sono tratti dall’articolo Metodologia o agnosticismo, nella «Civiltà Cattolica» del 15 novembre 1930. Pare che il libro del Govi sia interessante per il materiale storico che raccoglie specialmente intorno alla Logica generale e speciale, al problema della conoscenza e alle teorie sull’origine delle idee, alla classificazione delle scienze e alle varie divisioni dello scibile umano, alle varie concezioni e divisioni della Scienza teoretica, pratica ecc. La sua filosofia il Govi la chiama «empiristico‑integralista», distinguendola dalla concezione religiosa e da quella razionalistica, nella quale primeggia la filosofia kantiana: la distingue anche, ma in modo subordinato, dalla concezione «empiristico-particolaristica» che è il positivismo. Egli si distingue dal positivismo in quanto ne ribatte alcuni eccessi e cioè la negazione non solo di ogni metafisica religiosa o razionalistica, ma anche ogni possibilità e legittimità di una metafisica; il Govi ammette invece la legittimità di una metafisica, ma con fondamenti puramente empirici (!) e costruita, in parte, dopo e sulla base delle scienze reali particolari. (Cfr quanto delle teorie del Govi sono prese dai neo‑realisti inglesi e specialmente da Bertrand Russell).
Q11 §41 La dialettica come parte della logica formale e della retorica. Cfr per il modo di concepire la dialettica dei neotomisti, il libretto Dialectica dei padri Liberatore e Corsi della Compagnia di Gesù (Napoli, Tipografia commerciale, 1930, in‑8°, pp. 80, L. 7). Il padre Liberatore è stato uno dei più celebri polemisti gesuiti e direttore della «Civiltà Cattolica».
Sono da confrontare anche i due volumi sulla Dialettica di B. Labanca, cattolico. Del resto nel suo capitolo su «Dialettica e logica» nei Problemi fondamentali Plekhanov concepisce la dialettica come una sezione della logica formale, come la logica del movimento in confronto alla logica della stasi. Il legame tra dialettica e retorica continua anche oggi nel linguaggio comune, in senso superiore quando si vuole indicare una oratoria stringente, in cui la deduzione o il nesso tra causa ed effetto è di carattere particolarmente convincente e in senso deteriore per l’oratoria pagliettesca, che fa stare a bocca aperta i villani.
Q11 §42 Valore puramente strumentale della logica e della metodologia formali. Si può accostare la logica formale e la metodologia astratta alla «filologia». Anche la filologia ha un valore schiettamente strumentale, insieme con l’erudizione. Una funzione analoga è quella delle scienze matematiche. Concepita come valore strumentale, la logica formale ha un suo significato e un suo contenuto (il contenuto è nella sua funzione) così come hanno un loro valore e un loro significato gli strumenti e gli utensili da lavoro. Che una «lima» possa indifferentemente essere usata per limare ferro, rame, legno, diverse leghe metalliche ecc., non significa che sia «senza contenuto», puramente formale ecc. Così la logica formale ha un suo sviluppo, una sua storia, ecc.; può essere insegnata, arricchita ecc.
Q11 §43 Bibliografia. Vedere il libro di Tobias Dantzig, professore di matematica all’Università di Maryland, Le nombre (Payot, Parigi, 1931 o 32?), storia del numero e della successiva formazione dei metodi, delle nozioni, delle ricerche matematiche.
Q11 §44 La tecnica del pensare. Su questo argomento è da confrontare l’affermazione contenuta nella prefazione dell’Antidühring (3a ed., Stoccarda, 1894, p. XIX) che «l’arte di operare coi concetti non è alcunché di innato o di dato nella coscienza comune, ma è un lavoro tecnico del pensiero, che ha una lunga storia, né più né meno della ricerca sperimentale delle scienze naturali» (citato dal Croce in Materialismo storico ed economia marxistica, 1921, IV, p. 31). Questo concetto è richiamato in parecchie . È da vedere il testo originale di Engels, per collocare il brano nel suo nesso generale. Il Croce, citandolo, nota tra parentesi che non si tratta di un concetto «peregrino», ma che esso era diventato di senso comune già prima di Engels. Ma non si tratta della maggiore o minore originalità o peregrinità del concetto, in questo caso e per questa trattazione: si tratta della sua importanza e del posto che deve occupare in un sistema di filosofia della praxis e si tratta di vedere se esso ha quel riconoscimento «pratico e culturale» che deve avere.
A questo concetto occorre richiamarsi per intendere ciò che vuol dire Engels quando scrive che, dopo le innovazioni portate dalla filosofia della praxis, della vecchia filosofia rimane, tra l’altro, la logica formale, affermazione che il Croce riporta nel suo saggio sullo Hegel accompagnandola di un punto esclamativo. Lo stupore del Croce per la «riabilitazione» della logica formale che pare implicita nell’affermazione dell’Engels deve essere collegato alla sua dottrina della tecnica dell’arte, per esempio, e a tutta una serie di altre sue opinioni che costituiscono la somma del suo effettivo «antistoricismo» e astrattismo metodico (le «distinzioni», il cui principio «metodico» è vanto del Croce aver introdotto nella tradizione «dialettica», diventano da principio scientifico, causa di «astrattezza» e di antistoricismo nella loro formalistica applicazione). Ma l’analogia tra la tecnica artistica e la tecnica del pensiero è superficiale e fallace, almeno in un certo senso. Può esistere un artista che «consapevolmente» o «riflessamente» non conosce nulla dell’elaborazione tecnica precedente (la sua tecnica egli la prenderà ingenuamente dal senso comune); ma ciò non può avvenire nella sfera della scienza in cui esiste progresso e deve esistere progresso, in cui il progresso della conoscenza è strettamente connesso al progresso strumentale, tecnico, metodologico e ne è anzi condizionato, proprio come nelle scienze sperimentali in senso stretto.
È da porre addirittura la quistione se l’idealismo moderno e particolarmente il crocismo, con la sua riduzione della filosofia a una metodologia della storia non sia essenzialmente una «tecnica»; se lo stesso concetto di «speculazione» non sia essenzialmente una ricerca «tecnica», intesa certo in un significato superiore, meno estrinseco e materiale della ricerca che culminò nella costruzione della scolastica logica formale. Non pare che sia lontano da un tale punto di vista Adolfo Omodeo quando scrive («Critica» del 20 luglio 1932, p. 295): (Il Loisy) «che aveva fatto l’esperienza dei sistemi di teologia, diffida di quelli di filosofia. Teme che una formula di sistema uccida ogni interesse per la storia concreta, che una deduzione più o meno dialettica annienti la pienezza umana dell’effettiva formazione spirituale. E in vero, in tutte le filosofie post‑kantiane insieme con l’avviamento ad una visione panistorica, è attiva una tendenza metaistorica che vorrebbe dare di per sé un concetto metafisico dello spirito. Il Loisy avverte lo stesso bisogno che in Italia ha generato il tentativo di ridurre la filosofia a mera metodologia astratta della storia, contro la boria metafisica che disprezza “le grosse materialità della storia”. Egli chiarisce assai bene il suo concetto nel problema della morale. Scarta le formole filosofiche perché esse, con una considerazione riflessa sulla morale, annullano il problema della vita e dell’azione morale, della formazione della personalità e della coscienza, ciò che noi siamo soliti chiamare la storicità dello spirito, la quale non è corollario di filosofia astratta. Ma forse l’esigenza è spinta troppo oltre, sino a disconoscere la funzione della filosofia come controllo metodico dei nostri concetti».
Nell’affermazione dell’Engels è da vedere, sia pure espressa in termini non rigorosi, questa esigenza metodica, che è tanto più viva quanto più il riferimento sottinteso è fatto non per gli intellettuali e per le così dette classi colte, ma per le masse popolari incolte, per le quali è necessaria ancora la conquista della logica formale, della più elementare grammatica del pensiero e della lingua. Potrà sorgere la quistione del posto che una tale tecnica deve occupare nei quadri della scienza filosofica, se essa cioè faccia parte della scienza come tale, già elaborata, o della propedeutica scientifica, del processo di elaborazione come tale. (Così nessuno può negare l’importanza, in chimica, dei corpi catalitici, perché di essi non rimane traccia nel risultato finale). Anche per la dialettica si presenta lo stesso problema: essa è un nuovo modo di pensare, una nuova filosofia, ma è anche perciò una nuova tecnica. Il principio della distinzione, sostenuto dal Croce, e pertanto tutte le sue polemiche con l’attualismo gentiliano, non sono anche quistioni tecniche? Si può staccare il fatto tecnico da quello filosofico? Lo si può però isolare ai fini pratici didascalici. E infatti è da notare l’importanza che ha la tecnica del pensiero nella costruzione dei programmi didattici. Né si può fare il paragone tra la tecnica del pensiero e le vecchie retoriche. Queste né creavano artisti, né creavano il gusto, né davano criteri per apprezzare la bellezza: erano utili solo per creare un «conformismo» culturale, e un linguaggio da conversazione tra letterati. La tecnica del pensiero, elaborata come tale, non creerà certo grandi filosofi, ma darà criteri di giudizio e di controllo e correggerà le storture del modo di pensare del senso comune.
Sarebbe interessante un esame comparativo della tecnica del senso comune, della filosofia dell’uomo della strada, e la tecnica del pensiero riflesso e coerente. Anche in questo riguardo vale l’osservazione del Macaulay sulle debolezze logiche della cultura formatasi per via oratoria e declamatoria.
Tutto questo argomento deve essere ben studiato, dopo aver raccolto tutto il materiale possibile in proposito. È da connettere a questo argomento la quistione, sollevata dai pragmatisti, sul linguaggio come causa di errore: Prezzolini, Pareto, ecc. È da approfondire la quistione dello studio della tecnica del pensiero come propedeutica, come processo di elaborazione, ma occorre esser cauti perché l’immagine di «strumento» tecnico può trarre in errore. Tra «tecnica» e «pensiero in atto» esistono più identità che non esistano nelle scienze sperimentali tra «strumenti materiali» e scienza propriamente detta. Forse un astronomo che non sappia servirsi dei suoi strumenti è concepibile (può avere da altri il materiale di ricerca da elaborare matematicamente) perché i rapporti tra «astronomia» e «strumenti astronomici» sono esteriori e meccanici e anche in astronomia esiste una tecnica del pensiero oltre alla tecnica degli strumenti materiali. Un poeta può non saper leggere e scrivere: in un certo senso anche un pensatore può farsi leggere e scrivere tutto ciò che lo interessa degli altri o egli ha già pensato. Perché il leggere e scrivere si riferiscono alla memoria, sono un aiuto della memoria. La tecnica del pensiero non può essere paragonata a queste operazioni, per cui si possa dire che importa insegnare questa tecnica come importa insegnare a leggere e a scrivere senza che ciò interessi la filosofia come il leggere e lo scrivere non interessa il poeta come tale.
«Gli strumenti mentali e morali di cui l’uomo dispone sono sempre i medesimi (?); l’osservazione, l’esperimento, il ragionamento induttivo e deduttivo, l’abilità manuale (?) e la fantasia inventiva. A seconda del metodo con cui questi mezzi sono usati si ha un indirizzo empirico o scientifico dell’attività umana, con questa differenza fra i due: che il secondo è molto più rapido ed ha un rendimento molto maggiore» (Mario Camis, L’aeronautica e le scienze biologiche, in «Nuova Antologia» del 16 marzo1928).
Esempi di un ragionare semplicisticamente che, secondo l’opinione comune, è il modo di ragionare della grande maggioranza degli uomini (i quali non si controllano e quindi non si accorgono di quanto il sentimento e l’interesse immediato turbino il processo logico). Il ragionamento di Babbitt sulle organizzazioni sindacali (nel romanzo di Sinclair Lewis): «Una buona associazione operaia è una buona cosa perché impedisce i sindacati rivoluzionari che distruggerebbero la proprietà. Però nessuno dovrebbe essere costretto a entrare in una associazione. Tutti gli agitatori laburisti che tentano di costringere chiunque a entrare in una associazione dovrebbero essere impiccati. In breve, sia detto tra noi, bisognerebbe non permettere nessuna associazione; e poiché questa è la maniera migliore di combatterle, ogni uomo d’affari dovrebbe appartenere a una associazione d’imprenditori e alla Camera di Commercio. L’unione fa la forza. Perciò ogni solitario egoista che non fa parte della Camera di Commercio dovrebbe essere costretto ad affiliarsi».
Il ragionamento di don Ferrante è impeccabile formalmente, ma errato nelle premesse di fatto e nella presunzione del ragionatore, onde nasce il senso di umorismo.
Il modo di ragionare di Iliic nella novella di Tolstoi La morte di Iliic («Gli uomini sono mortali, Caio è uomo, Caio è mortale, ma io non sono Caio», ecc.).
Q11 §45 Esperanto filosofico e scientifico. Dal non comprendere la storicità dei linguaggi e quindi delle filosofie, delle ideologie e delle opinioni scientifiche consegue la tendenza, che è propria di tutte le forme di pensiero (anche di quelle idealistico‑storicistiche) a costruire se stesse come un esperanto o volapük della filosofia e della scienza. Si può dire che si sia perpetuato (in forme sempre diverse e più o meno attenuate) lo stato d’animo dei popoli primitivi verso gli altri popoli con cui entravano in rapporto. Ogni popolo primitivo chiamava (o chiama) se stesso con una parola che significa anche «uomo» e gli altri con parole che significano «muti» o «balbettanti» (barbari), in quanto non conoscono la «lingua degli uomini» (ne è venuto il bellissimo paradosso per cui «cannibale» o mangiatore di uomini significa originalmente – etimologicamente – «uomo per eccellenza» o «uomo vero»). Per gli esperantisti della filosofia e della scienza tutto ciò che non è espresso nel loro linguaggio è delirio, è pregiudizio, è superstizione, ecc.; essi (con un processo analogo a quello che si verifica nella mentalità settaria) trasformano in giudizio morale o in diagnosi di ordine psichiatrico quello che dovrebbe essere un mero giudizio storico. Molte tracce di questa tendenza si trovano nel Saggio popolare. L’esperantismo filosofico è specialmente radicato nelle concezioni positivistiche e naturalistiche; la «sociologia» è forse il maggior prodotto di una tale mentalità. Così le tendenze alla «classificazione» astratta, al metodologismo e alla logica formale. La logica e la metodologia generale vengono concepite come esistenti in sé e per sé, come formule matematiche, astratte dal pensiero concreto e dalle concrete scienze particolari (così come si suppone che la lingua esista nel vocabolario e nelle grammatiche, la tecnica fuori del lavoro e dell’attività concreta ecc.). D’altronde non bisogna pensare che la forma di pensiero «antiesperantistico» significhi scetticismo o agnosticismo o ecclettismo. È certo che ogni forma di pensiero deve ritenere se stessa come «esatta» e «vera» e combattere le altre forme di pensiero; ma ciò «criticamente». Dunque la quistione è sulle dosi di «criticismo» e di «storicismo» che sono contenute in ogni forma di pensiero. La filosofia della prassi, riducendo la «speculatività» ai suoi limiti giusti (negando cioè che la «speculatività» come l’intendono anche gli storicisti dell’idealismo sia il carattere essenziale della filosofia) appare essere la metodologia storica più aderente alla realtà e alla verità.
V. Traducibilità dei linguaggi scientifici e filosofici.
Q11 §46 Nel 1921 trattando di quistioni di organizzazione Vilici [Lenin ndc] scrisse e disse (press’a poco) così: non abbiamo saputo «tradurre» nelle lingue europee la nostra lingua.
Q11 §47 È da risolvere il problema: se la traducibilità reciproca dei vari linguaggi filosofici e scientifici sia un elemento «critico» proprio di ogni concezione del mondo o solamente proprio della filosofia della prassi (in modo organico) e solo parzialmente appropriabile da altre filosofie. La traducibilità presuppone che una data fase della civiltà ha una espressione culturale «fondamentalmente» identica, anche se il linguaggio è storicamente diverso, determinato dalla particolare tradizione di ogni cultura nazionale e di ogni sistema filosofico, dal predominio di una attività intellettuale o pratica ecc. Così è da vedere se la traducibilità è possibile tra espressioni di fasi diverse di civiltà, in quanto queste fasi sono momenti di sviluppo una dall’altra, e quindi si integrano a vicenda, o se un’espressione data può essere tradotta coi termini di una fase anteriore di una stessa civiltà, fase anteriore che però è più comprensibile che non il linguaggio dato ecc. Pare si possa dire appunto che solo nella filosofia della prassi la «traduzione» è organica e profonda, mentre da altri punti di vista spesso è un semplice gioco di «schematismi» generici.
Q11 §48 Giovanni Vailati e la traducibilità dei linguaggi scientifici. Passo della Sacra Famiglia in cui si afferma che il linguaggio politico francese del Proudhon corrisponda e possa tradursi nel linguaggio della filosofia classica tedesca. Questa affermazione è molto importante per comprendere alcuni aspetti della filosofia della prassi e per trovare la soluzione di molte apparenti contraddizioni dello sviluppo storico e per rispondere ad alcune superficiali obbiezioni contro questa teoria storiografica (anche utile per combattere alcuni astrattismi meccanicistici).
È da vedere se questo principio critico possa essere avvicinato o confuso con affermazioni analoghe. Nel fascicolo di settembre‑ottobre 1930 dei «Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica», in una lettera aperta di Luigi Einaudi a Rodolfo Benini (Se esista, storicamente, la pretesa repugnanza degli economisti verso il concetto dello Stato produttore) in una nota a p. 303 si legge: «Se io possedessi la meravigliosa facoltà che in sommo grado aveva il compianto amico Vailati di tradurre una qualunque teoria dal linguaggio geometrico in quello algebrico, da quello edonista in quello della morale kantiana, dalla terminologia economica pura normativa in quella applicata precettistica, potrei tentare di ritradurre la pagina dello Spirito nella formalistica tua, ossia economistica classica. Sarebbe un esercizio fecondo, simile a quelli di cui racconta Loria, da lui intrapresi in gioventù, di esporre successivamente una data dimostrazione economica prima in linguaggio di Adamo Smith e poi di Ricardo, e quindi di Marx, di Stuart‑Mill e di Cairnes. Ma sono esercizi che vanno, come faceva Loria, dopo fatti, riposti nel cassetto. Giovano ad insegnare la umiltà ad ognuno di noi, quando per un momento ci illudiamo di aver visto qualcosa di nuovo. Perché se questa novità poteva essere stata detta con le loro parole e inquadrarsi nel pensiero dei vecchi, segno è che quel qualcosa era contenuto in quel pensiero. Ma non possono né devono impedire che ogni generazione usi quel linguaggio che meglio si adatta al modo suo di pensare e d’intendere il mondo. Si riscrive la storia; perché non si dovrebbe riscrivere la scienza economica, prima in termini di costo di produzione e poi di utilità e quindi di equilibrio statico e poi di equilibrio dinamico?»
Lo spunto metodologico‑critico dell’Einaudi è molto circoscritto e si riferisce piuttosto che a linguaggi di culture nazionali, a linguaggi particolari di personalità della scienza. L’Einaudi si riattacca alla corrente rappresentata da alcuni pragmatisti italiani, dal Pareto, dal Prezzolini. Egli si propone con la sua lettera fini critici e metodologici assai limitati: vuole dare una piccola lezione a Ugo Spirito, nel quale, molto spesso, la novità delle idee, dei metodi, dell’impostazione dei problemi, è puramente e semplicemente una quistione verbale, di terminologia, di un «gergo» personale o di gruppo. Tuttavia è da vedere se questo non sia il primo grado del più vasto e profondo problema che è implicito nell’affermazione della Sacra Famiglia.
Come due «scienziati» formatisi nel terreno di una stessa cultura fondamentale, credono di sostenere «verità» diverse solo perché impiegano un diverso linguaggio (e non è detto che tra loro non ci sia una differenza e che essa non abbia il suo significato) scientifico, così due culture nazionali, espressioni di civiltà fondamentalmente simili, credono di essere diverse, opposte, antagonistiche, una superiore all’altra, perché impiegano linguaggi di tradizione diversa, formatisi su attività caratteristiche e particolari a ognuna di esse: linguaggio politico‑giuridico in Francia, filosofico, dottrinario, teorico in Germania. Per lo storico, in realtà, queste civiltà sono traducibili reciprocamente, riducibili l’una all’altra. Questa traducibilità non è «perfetta» certamente, in tutti i particolari, anche importanti (ma quale lingua è esattamente traducibile in un’altra? quale singola parola è traducibile esattamente in un’altra lingua?), ma lo è nel «fondo» essenziale. È anche possibile che una sia realmente superiore all’altra, ma quasi mai in ciò che i loro rappresentanti e i loro chierici fanatici pretendono, e specialmente quasi mai nel loro complesso: il progresso reale della civiltà avviene per la collaborazione di tutti i popoli, per «spinte» nazionali, ma tali spinte quasi sempre riguardano determinate attività culturali o gruppi di problemi.
La filosofia gentiliana è oggi quella che fa più quistioni di «parole», di «terminologia», di «gergo», che dà per «creazioni» nuove quelle che sono espressioni verbali nuove non sempre molto felici e adeguate. La nota dell’Einaudi ha perciò esasperato Ugo Spirito che non riesce però a rispondere nulla di conclusivo. (Vedere tutta la polemica nella rivista citata).
Q11 §49 L’osservazione contenuta nella Sacra Famiglia che il linguaggio politico francese equivale al linguaggio della filosofia classica tedesca è stata espressa «poeticamente» dal Carducci nell’espressione: «decapitaro, Emmanuel Kant, Iddio – Massimiliano Robespierre, il re». A proposito di questo riavvicinamento carducciano tra la politica pratica di M. Robespierre e il pensiero speculativo di E. Kant B. Croce registra una serie di «fonti» filologiche molto interessanti, ma che per il Croce sono di portata puramente filologica e culturale, senza alcun significato teorico o «speculativo». Il Carducci attinse il motivo da Enrico Heine (terzo libro del Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland del 1834). Ma il riavvicinamento di Robespierre a Kant non è originale dello Heine. Il Croce, che ha ricercato l’origine del riavvicinamento, scrive di averne trovato un lontano cenno in una lettera del 21 luglio 1795 dello Hegel allo Schelling (contenuto in Briefe von und an Hegel, Lipsia, 1887, I, 14‑16), svolto poi nelle lezioni che lo stesso Hegel tenne sulla storia della filosofia e sulla filosofia della storia. Nelle prime lezioni di storia della filosofia, Hegel dice che «la filosofia del Kant, del Fichte e dello Schelling contiene in forma di pensiero la rivoluzione», alla quale lo spirito negli ultimi tempi ha progredito in Germania, in una grande epoca cioè della storia universale, a cui «solo due popoli hanno preso parte, i Tedeschi e i Francesi, per opposti che siano tra loro, anzi appunto perché opposti»; sicché, laddove il nuovo principio in Germania «ha fatto irruzione come spirito e concetto» in Francia invece si è esplicato «come realtà effettuale» (cfr Vorles. über die Gesch. d. Philos., 2 ed., Berlino, 1844, III, 485).
Nelle lezioni di filosofia della storia, Hegel spiega che il principio della volontà formale, della libertà astratta, secondo cui «la semplice unità dell’autocoscienza, l’Io, è la libertà assolutamente indipendente e la fonte di tutte le determinazioni universali», «rimase presso i Tedeschi una tranquilla teoria, ma i Francesi vollero eseguirlo praticamente» (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 3 ed., Berlino, 1848, pp. 531‑32). (Questo passo di Hegel è appunto, pare, parafrasato dalla Sacra Famiglia dove si difende un’affermazione di Proudhon contro i Bauer, o, se non la si difende, la si spiega secondo questo canone ermeneutico hegeliano. Ma il passo di Hegel pare assai più importante come «fonte» del pensiero espresso nelle Tesi su Feuerbach che «i filosofi hanno spiegato il mondo e si tratta ora di mutarlo», cioè che la filosofia deve diventare politica per inverarsi, per continuare ad essere filosofia, che la «tranquilla teoria» deve essere «eseguita praticamente», deve farsi «realtà effettuale», come fonte dell’affermazione di Engels che la filosofia classica tedesca ha come erede legittimo il «popolo» tedesco e infine come elemento per la teoria dell’unità di teoria e di pratica.
A. Ravà nel suo libro Introduzione allo studio della filosofia di Fichte (Modena, Formiggini, 1909, pp. 6‑8 n.) fa osservare al Croce che già nel 1791 il Baggesen in una lettera al Reinhold accostava le due rivoluzioni, che lo scritto di Fichte del 1792 sulla rivoluzione francese è animato da questo senso di affinità tra l’opera della filosofia e l’avvenimento politico e che nel 1794 lo Schaumann svolse particolarmente il paragone, notando che la rivoluzione politica di Francia «fa sentire dall’esterno il bisogno di una determinazione fondamentale dei diritti umani» e la riforma filosofica tedesca «mostra dall’interno i mezzi e la via per cui e sulla quale solamente questo bisogno può essere soddisfatto»; anzi che lo stesso paragone dava motivo nel 1797 a una scrittura satirica contro la filosofia kantiana. Il Ravà conclude che il «paragone era nell’aria».
Il paragone venne ripetuto moltissime volte nel corso dell’Ottocento (dal Marx, per es., nella Critica della filosofia del diritto di Hegel) e «dilatato» dallo Heine. In Italia, qualche anno prima del Carducci, lo si ritrova in una lettera di Bertrando Spaventa, dal titolo Paolottismo, positivismo e razionalismo, pubblicata nella «Rivista bolognese» del maggio 1868 e ristampata negli Scritti filosofici (ed. Gentile, p. 301). Il Croce conclude facendo delle riserve sul paragone in quanto «affermazione di un rapporto logico e storico». «Perché se è vero che al Kant giusnaturalista risponde assai bene nel campo dei fatti la rivoluzione francese, è anche vero che quel Kant appartiene alla filosofia del secolo decimottavo, che precesse e informò quel moto politico; laddove il Kant che apre l’avvenire, il Kant della sintesi a priori, è il primo anello di una nuova filosofia, la quale oltrepassa la filosofia che s’incarnò nella rivoluzione francese». Si capisce questa riserva del Croce che però è impropria e incongruente, poiché le stesse citazioni del Croce da Hegel mostrano che non del particolare paragone di Kant col Robespierre si tratta, ma di qualcosa di più esteso e comprensivo, del moto politico francese nel suo complesso e della riforma filosofica tedesca nel suo complesso. Che il Croce sia favorevole alle «tranquille teorie» e non alle «realtà effettuali», che una riforma «in idea» gli sembri la fondamentale e non quella in atto, si capisce: in tal senso la filosofia tedesca ha influito in Italia nel periodo del Risorgimento, col «moderatismo» liberale (nel senso più stretto di «libertà nazionale»), sebbene nel De Sanctis si senta l’insofferenza di questa posizione «intellettualistica» come appare dal suo passaggio alla «Sinistra» e da alcuni scritti, specialmente Scienza e vita, e gli articoli sul verismo, ecc.
Tutta la quistione sarebbe da rivedere, ristudiando i riferimenti dati dal Croce e dal Ravà, cercandone altri, per inquadrarli nella quistione che è argomento della rubrica e cioè che due strutture fondamentalmente simili hanno superstrutture «equivalenti» e reciprocamente traducibili, qualunque sia il linguaggio particolare nazionale. Di questo fatto avevano coscienza i contemporanei della rivoluzione francese e ciò è di sommo interesse. (Le del Croce sul paragone carducciano tra Robespierre e Kant sono pubblicate nella II Serie delle Conversazioni Critiche, pp. 292 sgg.).
VI. Appunti miscellanei.
Q11 §50 Storia della terminologia e delle metafore. L’espressione tradizionale che l’«anatomia» della società è costituita dalla sua «economia» è una semplice metafora ricavata dalle discussioni svoltesi intorno alle scienze naturali e alla classificazione delle specie animali, classificazione entrata nella sua fase «scientifica» quando appunto si partì dall’anatomia e non più da caratteri secondari e accidentali. La metafora era giustificata anche dalla sua «popolarità», cioè dal fatto che offriva anche a un pubblico non intellettualmente raffinato, uno schema di facile comprensione (di questo fatto non si tiene quasi mai il conto debito: che la filosofia della prassi, proponendosi di riformare intellettualmente e moralmente strati sociali culturalmente arretrati, ricorre a metafore talvolta «grossolane e violente» nella loro popolarità). Lo studio dell’origine linguistico‑culturale di una metafora impiegata per indicare un concetto o un rapporto nuovamente scoperto, può aiutare a comprendere meglio il concetto stesso, in quanto esso viene riportato al mondo culturale, storicamente determinato, in cui è sorto, così come è utile per precisare il limite della metafora stessa, cioè ad impedire che essa si materializzi e si meccanicizzi. Le scienze sperimentali e naturali sono state, in una certa epoca, un «modello», un «tipo»; e poiché le scienze sociali (la politica e la storiografia) cercavano di trovare un fondamento obbiettivo e scientificamente adatto a dar loro la stessa sicurezza ed energia delle scienze naturali, è facile comprendere che a queste si sia ricorso per crearne il linguaggio.
D’altronde, da questo punto di vista, occorre distinguere tra i due fondatori della filosofia della prassi, il cui linguaggio non ha la stessa origine culturale e le cui metafore riflettono interessi diversi.
Un altro spunto «linguistico» è legato allo sviluppo delle scienze giuridiche: si dice nell’introduzione alla Critica dell’economia politica che «non si può giudicare un’epoca storica da ciò che essa pensa di se stessa», cioè dal complesso delle sue ideologie. Questo principio è da connettere a quello quasi contemporaneo per cui un giudice non può giudicare l’imputato da ciò che l’imputato pensa di se stesso e dei propri atti od omissioni (sebbene ciò non significhi che la nuova storiografia sia concepita come un’attività tribunalizia), principio che ha portato alla radicale riforma dei metodi processuali, ha contribuito a far abolire la tortura e ha dato all’attività giudiziaria e penale una base moderna.
A questo stesso ordine di osservazioni appartiene l’altra quistione riguardante il fatto che le soprastrutture sono considerate come mere e labili «apparenze». Anche in questo «giudizio» è da vedere più un riflesso delle discussioni nate sul terreno delle scienze naturali (della zoologia e della classificazione delle specie, della scoperta che l’«anatomia» deve essere posta alla base delle classificazioni) che un derivato coerente del materialismo metafisico, per il quale i fatti spirituali sono una mera apparenza, irreale, illusoria, dei fatti corporali. A questa origine storicamente accertabile del «giudizio» si è venuto in parte sovrapponendo e in parte addirittura sostituendo ciò che si può dire un mero «atteggiamento psicologico» senza portata «conoscitiva o filosofica», come non è difficile dimostrare, in cui il contenuto teorico è scarsissimo (o indiretto, e forse si limita a un atto di volontà, che in quanto universale, ha un valore filosofico o conoscitivo implicito) e predomina la immediata passione polemica non solo contro una esagerata e deformata affermazione in senso inverso (che solo lo «spirituale» sia reale) ma contro l’«organizzazione» politica‑culturale di cui tale teoria è espressione. Che l’affermazione dell’«apparenza» delle superstrutture non sia un atto filosofico, di conoscenza, ma solo un atto pratico, di polemica politica, risulta da ciò che essa non è posta come «universale», ma solo per determinate superstrutture. Si può osservare, ponendo la quistione in termini individuali, che chi è scettico per il «disinteresse» degli altri, ma non per il proprio «disinteresse», non è «scettico» filosoficamente, ma fa una quistione di «storia concreta individuale»; lo scetticismo sarebbe tale, cioè un atto filosofico, se lo «scettico» dubitasse di se stesso o della propria capacità filosofica, di conseguenza. E infatti è osservazione ovvia che lo scettico, filosofando per negare la filosofia, in realtà la esalta e la afferma. Nel caso dato, l’affermazione dell’«apparenza» delle superstrutture significa solo l’affermazione che una determinata «struttura» è condannata a perire, deve essere distrutta e il problema che si pone è se questa affermazione sia di pochi o di molti, sia già o sia per diventare una forza storica decisiva o sia puramente l’opinione isolata (o isolabile) di qualche singolare fanatico ossessionato da idee fisse.
L’atteggiamento «psicologico» che sostanzia l’affermazione dell’«apparenza» delle superstrutture, potrebbe essere paragonato all’atteggiamento che si è verificato in certe epoche (anch’esse «materialistiche» e «naturalistiche»!) verso la «donna» e l’«amore». Si vedeva una graziosa giovanetta, fornita di tutti quei pregi fisici che tradizionalmente destano il giudizio di «amabilità». L’uomo «pratico» valutava la sua struttura «scheletrica», l’ampiezza del «bacino», cercava di conoscere sua madre e sua nonna, per vedere quale probabile processo di deformazione ereditaria l’attuale giovinetta avrebbe subito con gli anni, per avere la possibilità di prevedere quale «moglie» egli avrebbe avuto dopo dieci, venti, trenta anni. Il giovanotto «satanico», atteggiandosi al pessimismo ultrarealistico, avrebbe osservato la giovinetta con occhi «stecchettiani»: l’avrebbe giudicata «in realtà» un puro sacco di putredine, l’avrebbe immaginata già morta e sotterrata, con le «occhiaie fetenti e vuote» ecc. ecc. Pare che questo atteggiamento psicologico sia proprio dell’età subito dopo la pubertà, legato alle prime esperienze, alle prime riflessioni, ai primi disinganni, ecc. Tuttavia viene superato dalla vita e una «determinata» donna non susciterà più quei tali pensieri.
Nel giudizio di «apparenza» delle superstrutture c’è un fatto dello stesso genere: un «disinganno», un pseudopessimismo ecc. che scompare di colpo quando si è «conquistato» lo Stato e le superstrutture sono quelle del proprio mondo intellettuale e morale. E infatti queste deviazioni dalla filosofia della prassi sono in gran parte legate a gruppi di intellettuali «vagabondi» socialmente, disincantati ecc., disancorati, ma pronti ad ancorarsi in qualche buon porto.
Q11 §51 Serie di concetti e di posizioni filosofiche da esaminare in una introduzione allo studio della filosofia: trascendenza, teologia, filosofia speculativa, storicismo speculativo. La «speculazione» (in senso idealistico) non ha introdotto una trascendenza di nuovo tipo nella riforma filosofica caratterizzata dalle concezioni immanentistiche? Pare che solo la filosofia della prassi sia la concezione conseguentemente «immanentistica». Sono specialmente da rivedere e criticare tutte le teorie storicistiche di carattere speculativo. Si potrebbe scrivere un nuovo Anti‑Dühring che potrebbe essere un «Anti‑Croce» da questo punto di vista, riassumendo non solo la polemica contro la filosofia speculativa, ma anche quella contro il positivismo e il meccanicismo e le forme deteriori della filosofia della prassi.
Q11 §52 Regolarità e necessità. Come è sorto, nel fondatore della filosofia della prassi, il concetto di regolarità e di necessità nello sviluppo storico? Non pare che possa pensarsi a una derivazione dalle scienze naturali, ma pare invece debba pensarsi a una elaborazione di concetti nati nel terreno dell’economia politica, specialmente nella forma e nella metodologia che la scienza economica ricevette da Davide Ricardo. Concetto e fatto di «mercato determinato», cioè rilevazione scientifica che determinate forze decisive e permanenti sono apparse storicamente, forze il cui operare si presenta con un certo «automatismo» che consente una certa misura di «prevedibilità» e di certezza per il futuro delle iniziative individuali che a tali forze consentono dopo averle intuite o rilevate scientificamente. «Mercato determinato» equivale pertanto a dire «determinato rapporto di forze sociali in una determinata struttura dell’apparato di produzione», rapporto garantito (cioè reso permanente) da una determinata superstruttura politica, morale, giuridica. Dopo aver rilevato queste forze decisive e permanenti e il loro spontaneo automatismo (cioè la loro relativa indipendenza dagli arbitrii individuali e dagli interventi arbitrari governativi) lo scienziato ha, come ipotesi, reso assoluto l’automatismo stesso, ha isolato i fatti meramente economici dalle combinazioni più o meno importanti in cui realmente si presentano, ha stabilito dei rapporti di causa ed effetto, di premessa e conseguenza e così ha dato uno schema astratto di una determinata società economica (a questa costruzione scientifica realistica e concreta si è in seguito venuta sovrapponendo una nuova astrazione più generalizzata dell’«uomo» come tale, «astorico», generico, astrazione che è apparsa la «vera» scienza economica).
Date queste condizioni in cui è nata l’economia classica, perché si possa parlare di una nuova «scienza» o di una nuova impostazione della scienza economica (il che è lo stesso) occorrerebbe aver dimostrato che si sono venuti rilevando nuovi rapporti di forze, nuove condizioni, nuove premesse, che cioè si è «determinato» un nuovo mercato con un suo proprio nuovo «automatismo» e fenomenismo che si presenta come qualcosa di «obbiettivo», paragonabile all’automatismo dei fatti naturali. La economia classica ha dato luogo a una «critica dell’economia politica» ma non pare che finora sia possibile una nuova scienza o una nuova impostazione del problema scientifico. La «critica» dell’economia politica parte dal concetto della storicità del «mercato determinato» e del suo «automatismo» mentre gli economisti puri concepiscono questi elementi come «eterni», «naturali»; la critica analizza realisticamente i rapporti delle forze che determinano il mercato, ne approfondisce le contraddizioni, valuta le modificabilità connesse all’apparire di nuovi elementi e al loro rafforzarsi e presenta la «caducità» e la «sostituibilità» della scienza criticata; la studia come vita ma anche come morte e trova nel suo intimo gli elementi che la dissolveranno e la supereranno immancabilmente, e presenta l’«erede» che sarà presuntivo finché non avrà dato prove manifeste di vitalità ecc. Che nella vita economica moderna l’elemento «arbitrario» sia individuale, sia di consorzi, sia dello Stato abbia assunto un’importanza che prima non aveva e abbia profondamente turbato l’automatismo tradizionale è fatto che non giustifica di per sé l’impostazione di nuovi problemi scientifici, appunto perché questi interventi sono «arbitrari», di misura diversa, imprevedibili. Può giustificare l’affermazione che la vita economica è modificata, che c’è «crisi», ma questo è ovvio; d’altronde non è detto che il vecchio «automatismo» sia sparito, esso si verifica solo su scale più grandi di quelle (di) prima, per i grandi fenomeni economici, mentre i fatti particolari sono «impazziti».
Da queste considerazioni occorre prendere le mosse per stabilire ciò che significa «regolarità», «legge», «automatismo» nei fatti storici. Non si tratta di «scoprire» una legge metafisica di «determinismo» e neppure di stabilire una legge «generale» di causalità. Si tratta di rilevare come nello svolgimento storico si costituiscano delle forze relativamente «permanenti», che operano con una certa regolarità e automatismo. Anche la legge dei grandi numeri, sebbene sia molto utile come termine di paragone, non può essere assunta come la «legge» dei fatti storici. Per stabilire l’origine storica di questo elemento della filosofia della prassi (elemento che è poi, nientemeno, il suo particolare modo di concepire l’«immanenza») occorrerà studiare l’impostazione che delle leggi economiche fu fatta da Davide Ricardo. Si tratta di vedere che il Ricardo non ha avuto importanza nella fondazione della filosofia della prassi solo per il concetto del «valore» in economia, ma ha avuto un’importanza «filosofica», ha suggerito un modo di pensare e d’intuire la vita e la storia. Il metodo del «posto che», della premessa che dà una certa conseguenza, pare debba essere identificato come uno dei punti di partenza (degli stimoli intellettuali) delle esperienze filosofiche dei fondatori della filosofia della prassi. È da vedere se Davide Ricardo sia mai stato studiato da questo punto di vista.
(Così è da vedere il concetto filosofico di «caso» e di «legge», il concetto di una «razionalità» o di una «provvidenza» per cui si finisce nel teleologismo trascendentale se non trascendente e il concetto di «caso», come nel materialismo metafisico «che il mondo a caso pone»).
Appare che il concetto di «necessità» storica è strettamente connesso a quello di «regolarità» e di «razionalità». La «necessità» nel senso «speculativo‑astratto» e nel senso «storico‑concreto». Esiste necessità quando esiste una premessa efficiente e attiva, la cui consapevolezza negli uomini sia diventata operosa ponendo dei fini concreti alla coscienza collettiva e costituendo un complesso di convinzioni e di credenze potentemente agente come le «credenze popolari». Nella premessa devono essere contenute, già sviluppate o in via di sviluppo, le condizioni materiali necessarie e sufficienti per la realizzazione dell’impulso di volontà collettiva, ma è chiaro che da questa premessa «materiale», calcolabile quantitativamente, non può essere disgiunto un certo livello di cultura, un complesso cioè di atti intellettuali e da questi (come loro prodotto e conseguenza) un certo complesso di passioni e sentimenti imperiosi, cioè che abbiano la forza di indurre all’azione «a tutti i costi».
Come si è detto, solo per questa via si può giungere a una concezione storicistica (e non speculativa‑astratta) della «razionalità» nella storia (e quindi dell’«irrazionalità»).
Concetti di «provvidenza» e di «fortuna» nel senso in cui sono adoperati (speculativamente) dai filosofi idealisti italiani e specialmente dal Croce; occorrerà vedere il libro del Croce su G. B. Vico, in cui il concetto di «provvidenza» è tradotto in termini speculativi e in cui si dà inizio all’interpretazione idealistica della filosofia vichiana. Per il significato di «fortuna» nel Machiavelli è da vedere Luigi Russo (nota a p. 23 dell’edizione del Principe). Secondo il Russo, per il Machiavelli «fortuna» ha un duplice significato, obbiettivo e soggettivo. La «fortuna» è la forza naturale delle cose (cioè il nesso causale), la concorrenza propizia degli eventi, quella che sarà la Provvidenza del Vico, oppure è quella potenza trascendente di cui favoleggiava la vecchia dottrina medioevale – cioè dio – e per il Machiavelli ciò non è poi che la virtù stessa dell’individuo e la sua potenza ha radice nella stessa volontà dell’uomo. La virtù del Machiavelli, come dice il Russo, non è più la virtù degli scolastici, la quale ha un carattere etico e ripete la sua forza dal cielo, e nemmeno quella di Tito Livio, che sta a significare per lo più il valore militare, ma la virtù dell’uomo del Rinascimento, che è capacità, abilità, industria, potenza individuale, sensibilità, fiuto delle occasioni e misura delle proprie possibilità.
Il Russo ondeggia in seguito nella sua analisi. Per lui il concetto di fortuna, come forza delle cose, che nel Machiavelli come negli umanisti serba ancora un carattere naturalistico e meccanico troverà il suo inveramento ed approfondimento storico solo nella razionale provvidenza di Vico e di Hegel. Ma è bene avvertire che tali concetti, nel Machiavelli, non hanno mai un carattere metafisico come nei filosofi veri e propri dell’Umanesimo ma sono semplici e profonde intuizioni (quindi filosofia!!) della vita, e come simboli di sentimento vanno intesi e spiegati.
Sulla lenta formazione metafisica di questi concetti, per il periodo premachiavellico, il Russo rimanda al Gentile, Giordano Bruno e il pensiero del Rinascimento (Cap. «Il concetto dell’uomo nel Rinascimento» e l’«Appendice»), Firenze, Vallecchi. (Sugli stessi concetti del Machiavelli cfr F. Ercole, La politica di Machiavelli).
Q11 §53 Filosofia speculativa. Non bisogna nascondersi le difficoltà che presenta la discussione e la critica del carattere «speculativo» di certi sistemi filosofici e la «negazione» teorica della «forma speculativa» delle concezioni filosofiche. Quistioni che nascono: 1) l’elemento «speculativo» è proprio di ogni filosofia, è la forma stessa che deve assumere ogni costruzione teorica in quanto tale cioè «speculazione» è sinonimo di filosofia e di teoria? 2) oppure è da farsi una quistione «storica»: il problema è solo un problema storico e non teorico nel senso che ogni concezione del mondo, in una sua determinata fase storica, assume una forma «speculativa» che ne rappresenta l’apogeo e l’inizio del dissolvimento? Analogia e connessione collo sviluppo dello Stato, che dalla fase «economico‑corporativa» passa alla fase «egemonica» (di consenso attivo). Si può dire cioè che ogni cultura ha il suo momento speculativo o religioso, che coincide col periodo di completa egemonia del gruppo sociale che esprime e forse coincide proprio col momento in cui l’egemonia reale si disgrega alla base, molecolarmente, ma il sistema di pensiero, appunto perciò (per reagire alla disgregazione) si perfeziona dogmaticamente, diventa una «fede» trascendentale: perciò si osserva che ogni epoca così detta di decadenza (in cui avviene una disgregazione del vecchio mondo) è caratterizzata da un pensiero raffinato e altamente «speculativo». La critica pertanto deve risolvere la speculazione nei suoi termini reali di ideologia politica, di strumento d’azione pratica; ma la critica stessa avrà una sua fase speculativa, che ne segnerà l’apogeo. La quistione è questa: se questo apogeo non sia per essere l’inizio di una fase storica di nuovo tipo, in cui necessità‑libertà essendosi compenetrate organicamente non ci saranno più contraddizioni sociali e la sola dialettica sarà quella ideale, dei concetti e non più delle forze storiche.
Q11 §54 Unità della teoria e della pratica. È da ricercare, analizzare e criticare la diversa forma in cui si è presentato nella storia delle idee il concetto di unità della teoria e della pratica, poiché pare indubbio che ogni concezione del mondo e ogni filosofia si è preoccupata di questo problema.
Affermazione di S. Tomaso e della scolastica: «Intellectus speculativus extensione fit practicus», la teoria per semplice estensione si fa pratica, cioè affermazione della necessaria connessione tra l’ordine delle idee e quello dell’azione.
Aforisma del Leibnitz, tanto ripetuto dagli idealisti italiani: «quo magis speculativa, magis practica» detto della scienza.
La proposizione di G. B. Vico «verum ipsum factum» tanto discussa e variamente interpretata (cfr il libro del Croce sul Vico e altri scritti polemici del Croce stesso) e che il Croce svolge nel senso idealistico che il conoscere sia un fare e che si conosce ciò che si fa, in cui «fare» ha un particolare significato, tanto particolare che poi significa niente altro che «conoscere» cioè si risolve in una tautologia (concezione che tuttavia deve essere messa in relazione colla concezione propria della filosofia della prassi).
Q11 §55 Originalità e ordine intellettuale. Una massima di Vauvenargues: «È più facile dire cose nuove che metter d’accordo quelle che sono già state dette». Si può analizzare questa massima nei suoi elementi. È più difficile instaurare un ordine intellettuale collettivo che inventare arbitrariamente dei principi nuovi e originali. Necessità di un ordine intellettuale, accanto all’ordine morale, e all’ordine... pubblico. Per creare un ordine intellettuale, necessità di un «linguaggio comune» (contro neolalismo intellettuale e bohemismo). Originalità «razionale»; anche il filisteo è un originale, così come lo scapigliato. Nella pretesa dell’originalità c’è molta vanità e individualismo, e poco spirito creatore ecc.
Q11 §56 Buon senso e senso comune. Il Manzoni fa distinzione tra senso comune e buon senso (cfr Promessi Sposi, cap. XXXII sulla peste e sugli untori). Parlando del fatto che c’era pur qualcuno che non credeva agli untori, ma non poteva sostenere la sua opinione contro l’opinione volgare diffusa, scrive; «Si vede che era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica; il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune».
Q11 §57 La realtà del mondo esterno. Cfr Tolstoi, I vol. dei Racconti autobiografici (Infanzia‑Adolescenza, ed. «Slavia», Torino, 1930) p. 232 (cap. XIX dell’Adolescenza intitolato proprio «L’Adolescenza»): «Ma da nessuna corrente filosofica fui affascinato come dallo scetticismo, che ad un certo momento mi portò ad uno stato vicino alla follia. Immaginavo che fuori di me nessuno e nulla esistesse in tutto il mondo, che gli oggetti non fossero oggetti, ma immagini, le quali mi apparivano solo quando vi fissavo l’attenzione, e che appena cessavo di pensarci quelle immagini subito svanissero. In una parola mi trovavo d’accordo con Schlegel nel ritenere che esistono non gli oggetti, ma il nostro rapporto con essi. C’erano momenti, quando, sotto l’influenza di questa idea fissa arrivavo a rasentare la follia, al punto che rapidamente mi voltavo dalla parte opposta, sperando di sorprendere il vuoto (le néant) là dov’io non ero».
Q11 §58 Etica. La massima di E. Kant: «Opera in modo che la tua condotta possa diventare una norma per tutti gli uomini, in condizioni simili» è meno semplice e ovvia di ciò che appare a prima vista. Cosa si intende per «condizioni simili»? Le condizioni immediate in cui si opera, o le condizioni generali complesse e organiche, la cui conoscenza richiede una ricerca lunga e criticamente elaborata? (Fondamento sull’etica socratica, in cui la volontà – morale – ha la sua base sull’intelletto, sulla sapienza, per cui il male operare è dovuto all’ignoranza ecc. e la ricerca della conoscenza critica è la base di una superiore morale o della morale senz’altro). La massima kantiana può essere considerata un truismo, poiché è difficile trovare uno che non operi credendo di trovarsi nelle condizioni in cui tutti opererebbero come lui. Chi ruba per fame ritiene che chi ha fame ruberebbe, chi ammazza la moglie infedele ritiene che tutti i mariti traditi dovrebbero ammazzare ecc. Solo i «matti» in senso clinico, operano senza ritenere di essere nel giusto.
La quistione è connessa con altre: 1) ognuno è indulgente con se stesso, perché quando opera non «conformisticamente» conosce il meccanismo delle proprie sensazioni e dei propri giudizi, della catena di cause ed effetti che l’hanno portato ad operare, mentre per gli altri è rigorista, perché non ne conosce la vita interiore; 2) ognuno opera secondo la sua cultura, cioè la cultura del suo ambiente, e «tutti gli uomini» per lui sono il suo ambiente, quelli che la pensano come lui: la massima di Kant presuppone una sola cultura, una sola religione, un conformismo «mondiale». L’obbiezione che non pare esatta è questa, che «condizioni simili» non esistono perché tra le condizioni è compreso chi opera, la sua individualità ecc.
Si può dire che la massima di Kant è connessa al tempo, all’illuminismo cosmopolita, e alla concezione critica dell’autore, cioè è legata alla filosofia degli intellettuali come ceto cosmopolitico. Pertanto chi opera è il portatore delle «condizioni simili», ossia il creatore di esse; cioè egli «deve» operare secondo un «modello» che vorrebbe diffuso tra tutti gli uomini secondo un tipo di civiltà per l’avvento del quale lavora o per la cui conservazione «resiste» contro le forze disgregatrici ecc.
Q11 §59 Cosa è la filosofia? Un’attività puramente ricettiva o tutto al più ordinatrice, oppure una attività assolutamente creativa? Occorre definire cosa s’intende per «ricettivo», «ordinatore», «creativo». «Ricettivo» implica la certezza di un mondo esterno assolutamente immutabile, che esiste «in generale»; obbiettivamente nel senso volgare del termine. «Ordinatore» si avvicina a «ricettivo»: sebbene implichi un’attività nel pensiero, questa attività è limitata e angusta. Ma cosa significa «creativo»? Significherà che il mondo esterno è creato dal pensiero? Ma da qual pensiero e di chi? Si può cadere nel solipsismo e infatti ogni forma di idealismo cade nel solipsismo necessariamente. Per sfuggire al solipsismo e nello stesso tempo alle concezioni meccanicistiche che sono implicite nella concezione del pensiero come attività ricettiva e ordinatrice, occorre porre la quistione «storicisticamente» e nello stesso tempo porre a base della filosofia la «volontà» (in ultima analisi l’attività pratica o politica), ma una volontà razionale, non arbitraria, che si realizza in quanto corrisponde a necessità obbiettive storiche, cioè in quanto è la stessa storia universale nel momento della sua attuazione progressiva; se questa volontà è rappresentata inizialmente da un singolo individuo, la sua razionalità è documentata da ciò che essa viene accolta dal gran numero, e accolta permanentemente, cioè diventa una cultura, un «buon senso», una concezione del mondo con una etica conforme alla sua struttura.
Fino alla filosofia classica tedesca, la filosofia fu concepita come attività ricettiva o al massimo ordinatrice, cioè fu concepita come conoscenza di un meccanismo obbiettivamente funzionante all’infuori dell’uomo. La filosofia classica tedesca introdusse il concetto di «creatività» del pensiero, ma in senso idealistico e speculativo. Pare che solo la filosofia della prassi abbia fatto fare un passo in avanti al pensiero, sulla base della filosofia classica tedesca, evitando ogni tendenza al solipsismo, storicizzando il pensiero in quanto lo assume come concezione del mondo, come «buon senso» diffuso nel gran numero (e tale diffusione non sarebbe appunto pensabile senza la razionalità o storicità) e diffuso in modo tale da convertirsi in norma attiva di condotta. Creativo occorre intenderlo quindi nel senso «relativo», di pensiero che modifica il modo di sentire del maggior numero e quindi della realtà stessa che non può essere pensata senza questo maggior numero. Creativo anche nel senso che insegna come non esista una «realtà» per se stante, in sé e per sé, ma in rapporto storico con gli uomini che la modificano ecc.
Q11 §60 Realtà del mondo esterno. Può la concezione «soggettiva» del Berkeley essere disgiunta dalla religione e in che modo il Berkeley connetteva la sua concezione con le sue credenze religiose? Il Saggio popolare così come il saggio su Teoria e Pratica nel suo semplicismo non riesce a comprendere come possa essere connesso con la religione sia il materialismo meccanico come il soggettivismo più estremo. Né il Berkeley fu un «eretico» in religione: anzi la sua concezione è un modo di concepire il rapporto tra la divinità e il pensiero umano, in fondo una «teologia». Nel saggio su Teoria e Pratica si cita La vida es sueño, senza pensare che si tratta di quistione di linguaggio, perché se tutto è sogno e anche i sogni sono sogni, sogno significa «vita» e «realtà».
Q11 §61 Filosofi‑letterati e filosofi‑scienziati. Ha un qualsiasi valore il fatto che un filosofo abbia preso le mosse da una esperienza scientifica o da una esperienza «letteraria»? Cioè quale filosofia è più «realistica»: quella che muove dalle scienze «esatte» o quella che muove dalla «letteratura», cioè dall’osservazione dell’uomo in quanto intellettualmente attivo e non solo «parte meccanica della natura?»
Q11 §62 Storicità della filosofia della prassi. Che la filosofia della prassi concepisca se stessa storicisticamente, come cioè una fase transitoria del pensiero filosofico, oltre che implicitamente da tutto il suo sistema, appare esplicitamente dalla nota tesi che lo sviluppo storico sarà caratterizzato a un certo punto dal passaggio dal regno della necessità al regno della libertà. Tutte le filosofie (i sistemi filosofici) finora esistite sono state la manifestazione delle intime contraddizioni da cui la società è stata lacerata. Ma ogni sistema filosofico a sé preso non è stato l’espressione cosciente di queste contraddizioni, poiché tale espressione poteva essere data solo dall’insieme dei sistemi in lotta tra loro. Ogni filosofo è e non può non essere convinto di esprimere l’unità dello spirito umano, cioè l’unità della storia e della natura; infatti, se una tale convinzione non fosse, gli uomini non opererebbero, non creerebbero nuova storia, cioè le filosofie non potrebbero diventare «ideologie», non potrebbero nella pratica assumere la granitica compattezza fanatica delle «credenze popolari» che assumono la stessa energia delle «forze materiali».
Hegel rappresenta, nella storia del pensiero filosofico, una parte a sé, poiché, nel suo sistema, in un modo o nell’altro pur nella forma di «romanzo filosofico», si riesce a comprendere cos’è la realtà, cioè si ha, in un solo sistema e in un solo filosofo, quella coscienza delle contraddizioni che prima risultava dall’insieme dei sistemi, dall’insieme dei filosofi, in polemica tra loro, in contraddizione tra loro.
In un certo senso, pertanto, la filosofia della prassi è una riforma e uno sviluppo dello hegelismo, è una filosofia liberata (o che cerca liberarsi) da ogni elemento ideologico unilaterale e fanatico, è la coscienza piena delle contraddizioni, in cui lo stesso filosofo, inteso individualmente o inteso come intero gruppo sociale, non solo comprende le contraddizioni ma pone se stesso come elemento della contraddizione, eleva questo elemento a principio di conoscenza e quindi di azione. L’«uomo in generale», comunque si presenti, viene negato e tutti i concetti dogmaticamente «unitari» vengono dileggiati e distrutti in quanto espressione del concetto di «uomo in generale» o di «natura umana» immanente in ogni uomo.
Ma se anche la filosofia della prassi è una espressione delle contraddizioni storiche, anzi ne è l’espressione più compiuta perché consapevole, significa che essa pure è legata alla «necessità» e non alla «libertà» che non esiste e non può ancora esistere storicamente. Dunque, se si dimostra che le contraddizioni spariranno, si dimostra implicitamente che sparirà, cioè verrà superata, anche la filosofia della prassi: nel regno della «libertà» il pensiero, le idee non potranno più nascere sul terreno delle contraddizioni e della necessità di lotta. Attualmente il filosofo (della prassi) può solo fare questa affermazione generica e non andare più oltre: infatti egli non può evadere dall’attuale terreno delle contraddizioni, non può affermare, più che genericamente, un mondo senza contraddizioni, senza creare immediatamente una utopia.
Ciò non significa che l’utopia non possa avere un valore filosofico, poiché essa ha un valore politico, e ogni politica implicitamente è una filosofia sia pure sconnessa e in abbozzo. In questo senso la religione è la più gigantesca utopia, cioè la più gigantesca «metafisica», apparsa nella storia, poiché essa è il tentativo più grandioso di conciliare in forma mitologica le contraddizioni reali della vita storica: essa afferma, invero, che l’uomo ha la stessa «natura», che esiste l’uomo in generale, in quanto creato da Dio, figlio di Dio, perciò fratello degli altri uomini, uguale agli altri uomini, libero fra gli altri e come gli altri uomini, e che tale egli si può concepire specchiandosi in Dio, «autocoscienza» dell’umanità, ma afferma anche che tutto ciò non è di questo mondo e per questo mondo, ma di un altro (– utopico –). Così le idee di uguaglianza, di fraternità, di libertà fermentano tra gli uomini, in quegli strati di uomini che non si vedono né uguali, né fratelli di altri uomini, né liberi nei loro confronti. Così è avvenuto che in ogni sommovimento radicale delle moltitudini, in un modo o nell’altro, sotto forme e ideologie determinate, siano state poste queste rivendicazioni.
In questo punto si inserisce un elemento proposto dal Vilici [Lenin ncd]: nel programma dell’aprile 1917, nel paragrafo dedicato alla scuola unitaria e precisamente nella nota esplicativa di tale paragrafo (cfr l’edizione di Ginevra del 1918) si ricorda che il chimico e pedagogista Lavoisier, ghigliottinato sotto il Terrore, aveva sostenuto appunto il concetto della scuola unitaria e ciò in rapporto ai sentimenti popolari del tempo, che nel movimento democratico del 1789 vedevano una realtà in isviluppo e non solo una ideologia ‑ strumento di governo e ne traevano conseguenze egualitarie concrete. In Lavoisier si trattava di elemento utopistico (elemento che appare più o meno in tutte le correnti culturali che presuppongono l’unicità di «natura» dell’uomo) tuttavia per il Vilici esso aveva significato dimostrativo‑teorico di un principio politico.
Se la filosofia della prassi afferma teoricamente che ogni «verità» creduta eterna e assoluta ha avuto origini pratiche e ha rappresentato un valore «provvisorio» (storicità di ogni concezione del mondo e della vita), è molto difficile far comprendere «praticamente» che una tale interpretazione è valida anche per la stessa filosofia della prassi, senza scuotere quei convincimenti che sono necessari per l’azione. Questa è, d’altronde, una difficoltà, che si ripresenta per ogni filosofia storicistica: di essa abusano i polemisti a buon mercato (specialmente i cattolici) per contrapporre nello stesso individuo lo «scienziato» al «demagogo», il filosofo all’uomo d’azione, ecc. e per dedurre che lo storicismo conduce necessariamente allo scetticismo morale e alla depravazione. Da questa difficoltà nascono molti «drammi» di coscienza nei piccoli uomini e nei grandi, gli atteggiamenti «olimpici» alla Volfango Goethe.
Ecco perché la proposizione del passaggio dal regno della necessità a quello della libertà deve essere analizzata ed elaborata con molta finezza e delicatezza.
Perciò avviene anche che la stessa filosofia della prassi tende a diventare una ideologia nel senso deteriore, cioè un sistema dogmatico di verità assolute ed eterne; specialmente quando, come nel Saggio popolare, esso è confuso col materialismo volgare, con la metafisica della «materia» che non può non essere eterna e assoluta.
È anche da dire che il passaggio dalla necessità alla libertà avviene per la società degli uomini e non per la natura (sebbene potrà avere conseguenze sull’intuizione della natura, sulle opinioni scientifiche ecc.).
Si può persino giungere ad affermare che mentre tutto il sistema della filosofia della prassi può diventare caduco in un mondo unificato, molte concezioni idealistiche, o almeno alcuni aspetti di esse, che sono utopistiche durante il regno della necessità, potrebbero diventare «verità» dopo il passaggio ecc. Non si può parlare di «Spirito» quando la società è raggruppata, senza necessariamente concludere che si tratti di... spirito di corpo (cosa che è riconosciuta implicitamente quando, come fa il Gentile nel volume sul « modernismo», si dice, sulle tracce di Schopenhauer, che la religione è la filosofia della moltitudine, mentre la filosofia è la religione degli uomini più eletti, cioè dei grandi intellettuali), ma se ne potrà parlare quando sarà avvenuta l’unificazione ecc.
Q11 §63 Concetto di «ideologia». L’«ideologia» è stata un aspetto del «sensismo», ossia del materialismo francese del XVIII secolo. Il suo significato originario era quello di «scienza delle idee» e poiché l’analisi era il solo metodo riconosciuto e applicato dalla scienza, significava «analisi delle idee» cioè «ricerca dell’origine delle idee». Le idee dovevano essere scomposte nei loro «elementi» originari e questi non potevano essere altro che le «sensazioni»: le idee derivano dalle sensazioni. Ma il sensismo poteva associarsi senza troppa difficoltà colla fede religiosa, con le credenze più estreme nella «potenza dello Spirito» e nei suoi «destini immortali» e così avviene che il Manzoni, anche dopo la sua conversione o ritorno al cattolicismo, anche quando scrisse gli Inni Sacri, mantenne la sua adesione di massima al sensismo, finché non conobbe la filosofia del Rosmini.
Il più efficace propagatore letterario dell’ideologia è stato Destutt de Tracy (1754‑1836) per la facilità e popolarità della sua esposizione; altro, il dott. Cabanis col suo Rapport du Physique et du Moral (Condillac, Helvétius ecc. sono più strettamente filosofi). Legame tra cattolicismo e Ideologia: Manzoni, Cabanis, Bourget, Taine (Taine è caposcuola per Maurras e altri di indirizzo cattolico); «romanzo psicologico» (Stendhal fu allievo del de Tracy ecc.). Di Destutt de Tracy l’opera principale è gli Éléments d’Ideologie (Parigi, 1817‑18) che è più completa nella traduzione italiana: Elementi di Ideologia del conte Destutt de Tracy, tradotti da G. Compagnoni, Milano, Stamperia di Giambattista Sonzogno, 1819 (nel testo francese manca una intera sezione, credo quella sull’Amore, che Stendhal conobbe e utilizzò dalla traduzione italiana).
Come il concetto di Ideologia da «scienza delle idee», da «analisi sull’origine delle idee», sia passato a significare un determinato «sistema di idee» è da esaminare storicamente, poiché logicamente il processo è facile da cogliere e comprendere.
Si può affermare che il Freud sia l’ultimo degli Ideologi e che un «ideologo» sia il De Man, per cui appare tanto più strano l’«entusiasmo» per il De Man del Croce e dei crociani, se non ci fosse una giustificazione «pratica» di tale entusiasmo.
È da esaminare come l’autore del Saggio popolare sia rimasto impigliato nell’Ideologia, mentre la filosofia della prassi rappresenta un netto superamento e storicamente si contrapponga appunto all’Ideologia. Lo stesso significato che il termine di «ideologia» ha assunto nella filosofia della prassi contiene implicitamente un giudizio di disvalore ed esclude che per i suoi fondatori l’origine delle idee fosse da ricercare nelle sensazioni e quindi, in ultima analisi, nella fisiologia: questa stessa «ideologia» deve essere analizzata storicamente, secondo la filosofia della prassi, come una superstruttura.
Q11 §64 «Obbiettività» della conoscenza. Per i cattolici «... tutta la teoria idealista riposa sulla negazione dell’obbiettività di ogni nostra conoscenza e sul monismo idealista dello “Spirito” (equivalente, in quanto monismo, a quello positivista della “Materia”) per cui il fondamento stesso della religione, Dio, non esiste obbiettivamente fuori di noi, ma è una creazione dell’intelletto. Pertanto l’idealismo, non meno del materialismo, è radicalmente contrario alla religione». (Cfr articolo del padre Mario Barbera nella «Civiltà Cattolica» del 1° giugno 1929).
La quistione della «obbiettività» della conoscenza secondo la filosofia della prassi può essere elaborata partendo dalla proposizione (contenuta nella prefazione alla Critica dell’economia politica) che «gli uomini diventano consapevoli (del conflitto tra le forze materiali di produzione) nel terreno ideologico» delle forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche, filosofiche. Ma tale consapevolezza è limitata al conflitto tra le forze materiali di produzione e i rapporti di produzione – secondo la lettera del testo – o si riferisce a ogni conoscenza consapevole? Questo è il punto da elaborare e che può esserlo con tutto l’insieme della dottrina filosofica del valore delle superstrutture. Cosa significherà, in tal caso, il termine di «monismo»? Non certo quello materialista né quello idealista, ma identità dei contrari nell’atto storico concreto, cioè attività umana (storia‑spirito) in concreto, connessa indissolubilmente a una certa «materia» organizzata (storicizzata), alla natura trasformata dall’uomo. Filosofia dell’atto (prassi, svolgimento) ma non dell’atto «puro», bensì proprio dell’atto «impuro», reale nel senso più profano e mondano della parola.
Q11 §65 Filosofia‑politica‑economia. Se queste tre attività sono gli elementi costitutivi necessari di una stessa concezione del mondo, necessariamente deve esserci, nei loro principii teorici, convertibilità da una all’altra, traduzione reciproca nel proprio specifico linguaggio di ogni elemento costitutivo: uno è implicito nell’altro, e tutti insieme formano un circolo omogeneo (cfr le precedenti sulla traducibilità reciproca dei linguaggi scientifici). Da queste proposizioni (che devono essere elaborate), conseguono, per lo storico della cultura e delle idee, alcuni criteri d’indagine e canoni critici di grande significato. Può avvenire che una grande personalità esprima il suo pensiero più fecondo non nella sede che apparentemente dovrebbe essere la più «logica», dal punto di vista classificatorio esterno, ma in altra parte che apparentemente può essere giudicata estranea. Un uomo politico scrive di filosofia: può darsi che la sua «vera» filosofia sia invece da ricercarsi negli scritti di politica. In ogni personalità c’è una attività dominante e predominante: è in questa che occorre ricercare il suo pensiero, implicito il più delle volte e talvolta in contraddizione con quello espresso ex professo. È vero che in un tale criterio di giudizio storico sono contenuti molti pericoli di dilettantismo e che nell’applicazione occorre esser molto cauti, ma ciò non toglie che il criterio sia fecondo di verità.
Realmente il «filosofo» occasionale più difficilmente riesce ad astrarre dalle correnti che dominano nel suo tempo, dalle interpretazioni divenute dogmatiche di una certa concezione del mondo ecc.; mentre invece come scienziato della politica si sente libero da questi idola del tempo o del gruppo, affronta più immediatamente e con tutta originalità la stessa concezione, vi penetra nell’intimo e la sviluppa in modo vitale. A questo proposito è ancora utile e fecondo il pensiero espresso dalla Luxemburg sulla impossibilità di affrontare certe quistioni della filosofia della prassi in quanto esse non sono ancora divenute attuali per il corso della storia generale o di un dato aggruppamento sociale. Alla fase economico‑corporativa, alla fase di lotta per l’egemonia nella società civile, alla fase statale corrispondono attività intellettuali determinate che non si possono arbitrariamente improvvisare o anticipare. Nella fase della lotta per l’egemonia si sviluppa la scienza della politica; nella fase statale tutte le superstrutture devono svilupparsi, pena il dissolvimento dello Stato.
Q11 §66 Sorel, Proudhon, De Man. (Cfr p. 78). La «Nuova Antologia» del 1° dicembre 1928 ha pubblicato un lungo (da p. 289 a p. 307) saggio di Giorgio Sorel col titolo Ultime meditazioni (Scritto postumo inedito). Si tratta di uno scritto del 1920, che doveva servire di prefazione a una raccolta di articoli pubblicati dal Sorel in giornali italiani dal 1910 al 1920 (raccolta che è stata pubblicata dalla Casa Ed. «Corbaccio» di Milano, a cura di Mario Missiroli col titolo L’Europa sotto la tormenta, forse con criteri molto diversi da quelli che sarebbero stati applicati nel 1920 quando la prefazione fu scritta: sarebbe utile vedere se nel volume sono riprodotti alcuni articoli come quello dedicato alla Fiat e qualche altro). Il ritardo nella pubblicazione del libro non è indipendente dalle oscillazioni che in Italia ha avuto la rinomanza del Sorel, dovuta a una serie di equivoci più o meno disinteressati, e che oggi è scaduta di molto: esiste già una letteratura antisorelliana.
Il saggio pubblicato dalla Nuova Antologia riassume tutti i pregi e tutte le manchevolezze del Sorel: è tortuoso, saltellante, incoerente, superficiale, sibillino, ecc.; ma dà o suggerisce punti di vista originali, trova nessi impensati eppur veri, obbliga a pensare e ad approfondire.
Qual è il significato di questo saggio? Esso risulta chiaramente da tutto l’articolo, che fu scritto nel 1920, ed è una patente falsificazione la noticina introduttiva della «Nuova Antologia» (dovuta forse allo stesso Missiroli, della cui lealtà intellettuale è bene non fidarsi) che conclude con queste parole: «... uno scrittore, che assegnò all’Italia del dopoguerra il primato intellettuale e politico in Europa». A quale Italia? Qualcosa in proposito potrebbe dire esplicitamente il Missiroli o si potrebbe trovare nelle lettere private del Sorel al Missiroli (lettere che dovrebbero essere pubblicate, secondo che è stato annunziato, ma non lo saranno o lo saranno non integre), ma si può arguire da numerosi articoli del Sorel. Da questo saggio è utile, pro‑memoria, annotare alcuni spunti, ricordando che tutto il saggio è molto importante per comprendere Sorel e il suo atteggiamento nel dopoguerra:
a) Bernstein ha sostenuto (Socialismo teorico e socialdemocrazia pratica, trad. francese, pp. 53‑54) che un rispetto superstizioso per la dialettica hegeliana ha condotto Marx a preferire alle costruzioni degli utopisti tesi rivoluzionarie assai prossime a quelle della tradizione giacobina, babeuvista o blanquista; non si comprende allora, però, come mai nel Manifesto non si parli della letteratura babeuvista che Marx indubbiamente conosceva. L’Andler è del parere (vol. II della sua ediz. del Manifesto, p. 191) che Marx faccia un’allusione piena di disprezzo per la congiura degli Uguali, quando parla dell’ascetismo universale e grossolano che si riscontra nelle più antiche rivendicazioni proletarie dopo la Rivoluzione Francese.
b) Pare che Marx non si sia mai potuto liberare completamente dall’idea hegeliana della storia, secondo la quale diverse ere si succedono nell’umanità, seguendo l’ordine di sviluppo dello spirito, che cerca di raggiungere la perfetta realizzazione della ragione universale. Alla dottrina del suo maestro egli aggiunge quella della lotta di classe: sebbene gli uomini non conoscano che le guerre sociali, nelle quali sono spinti dai loro antagonismi economici, essi cooperano inconsciamente a un’opera che il solo metafisico suppone. Questa ipotesi del Sorel è molto azzardata ed egli non la giustifica: ma evidentemente gli sta molto a cuore, sia per la sua esaltazione della Russia, sia per la sua previsione della funzione civile dell’Italia (è da segnalare, a proposito di questo avvicinamento Russia‑Italia, l’atteggiamento di D’Annunzio, in un tempo quasi coincidente, nei manoscritti fatti circolare nella primavera del 1920; conobbe il Sorel questo atteggiamento dannunziano? Solo il Missiroli potrebbe dare una risposta). Secondo il Sorel «Marx aveva una così grande fiducia nella subordinazione della storia alle leggi dello sviluppo dello Spirito, che ha insegnato che, dopo la caduta del capitalismo, l’evoluzione verso il Comunismo perfetto si produrrebbe senza essere provocata da una lotta di classi (Lettera sul programma di Gotha). Sembra che Marx abbia creduto, come Hegel, che i diversi momenti dell’evoluzione si manifestino in paesi diversi, ciascuno dei quali è specialmente adatto a ciascuno di quei momenti (vedere la prefazione del 21 gennaio 1882 a una traduzione russa del Manifesto). Egli non ha mai fatto una esposizione esplicita della sua dottrina; così molti marxisti sono persuasi che tutte le fasi dell’evoluzione capitalista devono prodursi nella stessa forma, presso tutti i popoli moderni. Questi marxisti sono troppo poco hegeliani».
c) La quistione: prima o dopo il 48? Il Sorel non intende il significato di questo problema, nonostante la letteratura in proposito (sia pure letteratura da bancarella) e accenna al «curioso» (sic) cambiamento che si produsse nello spirito di Marxa alla fine del 1850: nel marzo egli aveva firmato un manifesto dei rivoluzionari rifugiati a Londra, nel quale era tracciato il programma di una agitazione rivoluzionaria. In genere in questo paragrafo i termini «rivoluzione» e «rivoluzionario» sono abbreviati, come pure il termine «proletariato». da intraprendersi in vista di un nuovo prossimo sconvolgimento sociale, che Bernstein trova degno del primo venuto dei rivoluzionari da club (Socialismo teorico ecc. p. 51), mentre poi egli si convinse che la rivoluzione nata dalla crisi del 47 finiva con quella crisi. Ora gli anni dopo il 48 furono di una prosperità senza uguali: mancava dunque per la rivoluzione progettata la prima delle condizioni necessarie: un proletariato ridotto all’ozio e disposto a combattere (cfr Andler, I, pp. 55‑56, ma di quale edizione?) Così sarebbe nata nei marxisti la concezione della miseria crescente, che avrebbe dovuto servire a spaventare gli operai e indurli a combattere in vista di un peggioramento probabile anche in una situazione prospera (spiegazione infantile e contraddetta dai fatti, anche se è vero che della teoria della miseria crescente è stato fatto uno strumento di tal genere, un argomento di immediata persuasione: e del resto si trattò di un arbitrio? Sul tempo in cui nacque la teoria della miseria crescente è da vedere la pubblicazione di Roberto Michels).
d) Su Proudhon: «Proudhon apparteneva a quella parte della borghesia che era più vicina al proletariato; per questo i marxisti hanno potuto accusarlo di essere un borghese, mentre gli scrittori più sagaci lo considerano come un ammirevole prototipo dei nostri (cioè, francesi) contadini e dei nostri artigiani (cfr Daniele Halévy nei “Débats” del 3 gennaio 1913)». Questo giudizio del Sorel si può accettare. Ed ecco come il Sorel spiega la mentalità «giuridica» del Proudhon: «In ragione della modicità delle loro risorse, i contadini, i proprietari delle più piccole fabbriche, i piccoli commercianti sono obbligati a difendere aspramente i loro interessi davanti ai tribunali. Un socialismo che si proponga di proteggere i ceti posti sui gradini più bassi dell’economia, è naturalmente destinato a dare una grande importanza alla sicurezza del diritto; e una tendenza siffatta è particolarmente forte presso quegli scrittori che, come Proudhon, hanno la testa piena di ricordi della vita campagnola». E dà ancora altri spunti per rinforzare questa analisi, che non persuade del tutto: la mentalità giuridica del Proudhon è legata al suo antigiacobinismo, ai ricordi letterari della Rivoluzione francese e dell’antico regime che si suppone abbia portato all’esplosione giacobina proprio per l’arbitrarietà della giustizia: la mentalità giuridica è la sostanza del riformismo piccolo borghese del Proudhon e le sue origini sociali hanno contribuito a formarla per altro e «più alto» nesso di concetti e di sentimenti: in questa analisi il Sorel si confonde con la mentalità degli «ortodossi» da lui tanto spregiati. Lo strano è che il Sorel, avendo una tale convinzione sulla tendenza sociale del Proudhon, lo esalti e talvolta lo proponga a modello o fonte di principii per il proletariato moderno; se la mentalità giuridica del Proudhon ha questa origine perché gli operai dovrebbero occuparsi della quistione di un «nuovo diritto», di una «sicurezza del diritto» ecc.?
A questo punto, si ha l’impressione che il saggio del Sorel sia stato mutilato e che manchi precisamente una parte, riguardante il movimento italiano delle fabbriche: dal testo pubblicato, è possibile immaginare che Sorel abbia trovato nel movimento delle commissioni interne rivolte a controllare i regolamenti di fabbrica e in generale la «legislazione» interna di fabbrica che dipendeva unicamente dall’arbitrio incontrollato degli imprenditori, il corrispettivo delle esigenze che Proudhon rifletteva per i contadini e gli artigiani. Il saggio, così come è pubblicato, è incoerente e incompleto; la sua conclusione, riguardante l’Italia («Molte ragioni mi avevano condotto, da gran tempo, a supporre, che quello che un hegeliano chiamerebbe il Weltgeist, spetta oggi all’Italia. Grazie all’Italia, la luce dei tempi nuovi non si spegnerà») non ha nessuna dimostrazione, sia pure per scorci e accenni, al modo del Sorel. Nell’ultima nota c’è un accenno ai consigli degli operai e contadini in Germania, «che io consideravo conformi allo spirito proudhoniano» e un rimando ai Materiali per una teoria ecc. (pp. 164 e 394). Sarebbe interessante sapere se veramente il saggio è stato mutilato e da chi: se direttamente dal Missiroli o da altri.
Nota I. Non si può comprendere il Sorel come figura di «intellettuale rivoluzionario» se non si pensa alla Francia di dopo il 70, come non si può comprendere il Proudhon senza il «panico antigiacobino» dell’epoca della Restaurazione. Il 70 e il 71 videro in Francia due terribili disfatte, quella nazionale, che pesò sugli intellettuali borghesi e la disfatta popolare della Comune che pesò sugli intellettuali rivoluzionari: la prima creò dei tipi come Clémenceau, quintessenza del giacobinismo nazionalista francese, la seconda creò l’antigiacobino Sorel e il movimento sindacalista «antipolitico». Il curioso antigiacobinismo del Sorel, settario meschino, antistorico, è una conseguenza del salasso popolare del 71 (è da vedere in proposito la Lettre à M. Daniel Halévy nel «Mouvement socialiste», 16 agosto e 15 settembre 1907); da esso viene una curiosa luce per le sue Riflessioni sulla violenza. Il salasso del 71 tagliò il cordone ombelicale tra il «nuovo popolo» e la tradizione del 93: Sorel avrebbe voluto essere il rappresentante di questa rottura tra popolo e giacobinismo storico, ma non gli riuscì.
Nota II. Gli scritti del Sorel del dopoguerra hanno una certa importanza per la storia della cultura occidentale. Il Sorel attribuisce al pensiero di Proudhon tutta una serie di istituzioni e di atteggiamenti ideologici di questo periodo.
Perché il Sorel ha potuto far questo? È assolutamente arbitrario questo suo giudizio? E data l’acutezza del Sorel come storico delle idee, che esclude, almeno in gran parte, una tale arbitrarietà, da quali esperienze culturali è partito il Sorel, e non è tutto ciò importante per un giudizio complessivo dell’opera sorelliana? È certo che occorre ristudiare Sorel, per cogliere al di sotto delle incrostazioni parassitarie deposte sul suo pensiero da ammiratori dilettanti e intellettuali, ciò che in esso è più essenziale e permanente. Occorre tener presente che si è esagerato molto sull’«austerità» e «serietà» morale e intellettuale del Sorel; dall’epistolario col Croce risulta che egli non sempre vinceva gli stimoli della vanità: ciò risulta, per es., dal tono impacciato della lettera in cui vuole spiegare al Croce la sua adesione (titubante e sia pure platonica) al «Circolo Proudhon» di Valois e il suo civettare con gli elementi giovani della tendenza monarchica e clericale. Ancora: c’era molto dilettantismo, molto «non impegnarsi mai a fondo», quindi molta intrinseca irresponsabilità negli atteggiamenti «politici» del Sorel, che non erano mai schiettamente politici, ma «culturali‑politici», «intellettuali‑politici», «au dessus de la mêlée»: anche al Sorel si potrebbero muovere molte accuse simili a quelle contenute nell’opuscolo di un suo discepolo, I misfatti degli intellettuali. Egli stesso era un «puro» intellettuale e perciò bisognerebbe separare, con una analisi accurata, ciò che vi è nelle sue opere di superficiale, di brillante, di accessorio, legato alle contingenze della polemica estemporanea, e ciò che vi è di «polposo» e sostanzioso, per farlo entrare, così definito, nel circolo della cultura moderna.
Nota III. Nel 1929, dopo la pubblicazione di una lettera in cui Sorel parlava di Oberdan, si moltiplicarono gli articoli di protesta per alcune espressioni usate dal Sorel nelle sue lettere al Croce e il Sorel fu «stroncato» (particolarmente violento un articolo di Arturo Stanghellini riportato nell’«Italia Letteraria» di quei giorni). L’epistolario fu interrotto nel numero successivo della «Critica» e ripreso, senza accenno alcuno all’incidente, ma con alcune novità: parecchi nomi furono pubblicati solo con le iniziali e si ebbe l’impressione che alcune lettere non siano state pubblicate o siano state espurgate. Da questo punto incomincia nel giornalismo una valutazione nuova del Sorel e dei suoi rapporti con l’Italia.
Per certi rispetti al Sorel si può accostare il De Man, ma quale differenza tra i due! Il De Man si imbroglia assurdamente nella storia delle idee e si lascia abbagliare dalle superficiali apparenze; se un appunto si può invece muovere al Sorel è proprio in senso contrario, di analizzare troppo minutamente il sostanziale delle idee e di perdere spesso il senso delle proporzioni. Il Sorel trova che una serie di avvenimenti del dopoguerra sono di carattere proudhoniano; il Croce trova che il De Man segna un ritorno al Proudhon, ma il De Man tipicamente non capisce gli avvenimenti del dopoguerra indicati dal Sorel. Per il Sorel è proudhoniano ciò che è «spontanea» creazione del popolo, è «ortodosso» ciò che è di origine burocratica, perché egli ha sempre dinanzi come ossessioni, da una parte la burocrazia dell’organizzazione tedesca e dall’altra il giacobinismo, ambedue fenomeni di centralizzazione meccanica con le leve di comando in mano a una banda di funzionari. Il De Man rimane, in realtà, un esemplare pedantesco della burocrazia laburista belga: tutto è pedantesco in lui, anche l’entusiasmo. Crede di aver fatto scoperte grandiose, perché ripete con un formulario «scientifico» la descrizione di una serie di fatti più o meno individuali: è una tipica manifestazione di positivismo, che raddoppia il fatto, descrivendolo e generalizzandolo in una formula e poi della formulazione del fatto fa la legge del fatto stesso. Per il Sorel, come appare dal saggio pubblicato dalla Nuova Antologia, ciò che conta in Proudhon è l’orientamento psicologico, non già il concreto atteggiamento pratico, sul quale, in verità, il Sorel non si pronunzia esplicitamente: questo orientamento psicologico consiste nel «confondersi» coi sentimenti popolari (contadini e artigiani), che concretamente pullulano dalla situazione reale fatta al popolo dagli ordinamenti economico‑statali, nel «calarsi» in essi per comprenderli ed esprimerli in forma giuridica, razionale; questa o quella interpretazione, o anche l’insieme di esse, possono essere errate, o cervellotiche, o addirittura ridicole, ma l’atteggiamento generale è il più produttivo di conseguenze pregevoli. L’atteggiamento del De Man è invece quello «scientifista»: egli si china verso il popolo non per comprenderlo disinteressatamente, ma per «teorizzare» i suoi sentimenti, per costruire scherni pseudo‑ scientifici; non per mettersi all’unisono ed estrarre principi giuridico‑educativi, ma come lo zoologo osserva un mondo di insetti, come Maeterlinck osserva le api e le termiti.
Il De Man ha la pretesa pedantesca di porre in luce e in primo piano i così detti «valori psicologici ed etici» del movimento operaio; ma può ciò significare, come pretende il De Man, una confutazione perentoria e radicale della filosofia della prassi?. Ciò sarebbe come dire che il porre in luce il fatto che la grande maggioranza degli uomini è ancora alla fase tolemaica, significhi confutare le dottrine copernicane, o che il folclore debba sostituire la scienza. La filosofia della praxis sostiene che gli uomini acquistano coscienza della loro posizione sociale sul terreno delle ideologie; ha forse escluso il popolo da questo modo di prender coscienza di sé? Ma è osservazione ovvia che il mondo delle ideologie è (nel suo complesso) più arretrato che non i rapporti tecnici di produzione: un negro appena giunto dall’Africa può diventare un dipendente di Ford, pur mantenendosi per molto tempo un feticista e pur rimanendo persuaso che l’antropofagia sia un modo di nutrirsi normale e giustificato. Il De Man, fatta un’inchiesta in proposito, quali conclusioni ne potrebbe trarre? Che la filosofia della praxis debba studiare oggettivamente ciò che gli uomini pensano di sé e degli altri in proposito è fuori dubbio, ma deve supinamente accettare come eterno questo modo di pensare? Non sarebbe questo il peggiore dei meccanicismi e dei fatalismi? Compito di ogni iniziativa storica è di modificare le fasi culturali precedenti, di rendere omogenea la cultura a un livello superiore del precedente ecc. In realtà la filosofia della prassi ha sempre lavorato in quel terreno che il De Man crede di aver scoperto, ma vi ha lavorato per innovare, non per conservare supinamente. La «scoperta» del De Man è un luogo comune e la sua confutazione una rimasticatura poco gustosa.
Con questo «conservatorismo» si spiega il discreto successo del De Man, anche in Italia, almeno in certi ambienti (specialmente nell’ambiente crociano‑revisionista e in quello cattolico). Del libro principale del De Man, Croce scrisse un annunzio nella «Critica» del 1928; il De Ruggiero scrisse una recensione nella «Critica» del 1929; la «Civiltà Cattolica» e il «Leonardo» recensioni nel 1929; G. Zibordi vi accennò nel suo libretto su Prampolini; un annunzio librario molto elogiativo ne fece la Casa Laterza per la traduzione Schiavi e lo Schiavi ne parlò come di gran cosa nella sua prefazione; articoli di adesione pubblicò «I problemi del Lavoro» che riprodusse le tesi finali non riportate nella traduzione Schiavi. L’«Italia Letteraria» dell’11 agosto 1929 ne pubblicò una recensione di Umberto Barbaro. Scrive il Barbaro: «... una critica del marxismo che, se si vale delle precedenti “revisioni” di carattere economico, in massima è fondata su di una questione tattica (sic) relativa alla psicologia delle masse operaie». «Dei molti tentativi di andare “au de là” del marxismo (il traduttore, il noto avvocato Alessandro Schiavi, modifica un po’ il titolo, in “superamento” in senso crociano e assai giustificatamente (!) per altro, poiché il De Man stesso considera la sua come una posizione in antitesi necessaria per una sintesi superiore) questo non è certamente dei più poderosi e tanto meno dei più sistematici; anche perché la critica si basa prevalentemente appunto su quella misteriosa e fuggevole, benché certo affascinante, pseudoscienza che è la psicologia. Nei riguardi del “movimento” questo libro è piuttosto disfattista e talvolta fornisce addirittura argomenti alle tendenze che vuole combattere: al fascismo per un gruppo di osservazioni sugli stati affettivi e sui “complessi” (in senso freudiano) degli operai da cui derivano idee di “gioia del lavoro” e di “artigianato” ed al comunismo e fascismo insieme per la scarsa efficacia degli argomenti in difesa della democrazia e del riformismo».
Recensione di Paolo Milano nell’«Italia che scrive» del settembre 1929. Il Milano distingue nell’opera del De Man due apporti: 1° la massa di osservazioni psicologiche sulle fasi di sviluppo, le deviazioni, le reazioni contradditorie del movimento operaio e socialista negli anni recenti, una sagace collezione di dati e documenti sociali, insomma: l’analisi dell’evoluzione riformistica delle masse operaie da un lato e dei gruppi padronali dall’altro, secondo il Milano, è ricca e soddisfacente; 2° e la discussione teorica da cui dovrebbe risultare il «superamento del marxismo» (esattamente, per il De Man, il «ripudio» del marxismo). Per il De Man la filosofia della prassi, nel suo fondo meccanicistica e razionalistica (!), è superata dalle indagini più recenti, che hanno assegnato alla concatenazione razionale soltanto un posto e neppure il più ragguardevole nella serie dei moventi degli atti umani. Alla reazione meccanica (!) della dialettica marxistica la scienza moderna (!) ha vittoriosamente (!) sostituito una reazione psicologica, la cui intensità non è proporzionale (?) alla causa agente. Per il Milano: «È ormai chiaro che qualunque critica alla concezione marxistica della storia porta automaticamente ad impostare il contrasto tra interpretazione materialistica e interpretazione idealistica del mondo e ad assegnare in sostanza una priorità all’essere o al conoscere». Il De Man è sfuggito a questo problema o meglio si è fermato a mezza strada, dichiarandosi per una concezione dei fatti umani come generati da «moventi psicologici» e da «complessi» sociali, cioè il De Man è influenzato dalla psicologia freudiana, soprattutto attraverso le applicazioni alle dottrine sociali, tentatane dall’Adler (forse Max Adler? e in quali scritti?).
Osserva il Milano: «Si sa d’altronde che labile terreno sia la psicologia nelle indagini storiche: tanto più equivoco in ricerche del tipo di queste, di cui si parla. I fenomeni psicologici infatti si prestano ad essere volta a volta indicati come tendenze volitive o come fatti materiali; tra queste opposte interpretazioni oscilla anche il De Man ed evita quindi una presa di posizione sul punto cruciale del contrasto. Davvero psicologica piuttosto un lettore accorto giudicherà che sia l’origine dell’opera del De Man: nata da una crisi di sfiducia e dalla constatazione dell’insufficienza delle dottrine marxistiche integrali a spiegare i fenomeni che all’osservazione dell’autore si erano offerti durante lo spicciolo lavoro politico. Nonostante le ottime intenzioni, il tenore del libro non supera questa documentata e mossa constatazione né riesce ad una confutazione teorica sul piano adeguato e col vigore “necessario”»; e conclude: «La riprova ne dà l’ultimo capitolo, in cui la trattazione vorrebbe conchiudersi col raccomandare un pratico contegno politico. Il De Man, egualmente evitando i due estremi di una tattica di presa del potere e di un apostolato esclusivamente idealistico, consiglia una generica educazione delle masse e con ciò si pone fuori di quel socialismo, di cui pure per tutta l’opera si era dichiarato fedele e illuminato seguace».
Nella «Civiltà Cattolica» del 7 settembre 1929, nell’articolo Per la pace sociale (del p. Brucculeri) che commenta il famoso lodo emesso dalla Congregazione del Concilio nel conflitto tra operai e industriali cattolici della regione Roubaix‑Tourcoing, c’è questo passo: «Il marxismo – come dimostra nelle sue più belle pagine il De Man – è stata una corrente materializzatrice del mondo operaio moderno». Cioè le pagine del De Man sono tutte belle, ma alcune sono più belle ancora. (Dato questo atteggiamento dei cattolici verso la tendenza del De Man, può spiegarsi come Giuseppe Prezzolini, accennando nel «Pégaso» del settembre 1930 al volume del Philip sul Movimento operaio americano, qualifichi il Philip come un «democratico cristiano», sebbene dal libro una tale qualifica non risulti e non sia giustificata).
Nei fascicoli della «Civiltà Cattolica» del 5 ottobre e 16 novembre 1929 è pubblicato un saggio molto diffuso sul libro del De Man. L’opera del De Man è reputata «nonostante le sue deficienze, la più importante e, diciamo pure, geniale, di quante finora ne annoveri la letteratura antimarxista». Verso la fine del saggio c’è questa impressione complessiva: «L’A. (il De Man), benché abbia superato una crisi di pensiero respingendo, con gesto magnanimo, il marxismo, è tuttavia ondeggiante, e la sua intelligenza sitibonda di vero non è a pieno soddisfatta. Egli batte sulle soglie della verità, raccoglie dei raggi, ma non si spinge innanzi per tuffarsi nella luce. Auguriamo al De Man che, compiendo la sua crisi, possa elevarsi, come il gran vescovo di Tagaste, dal divino riflesso che è la legge morale nell’anima, al divino infinito, alla sorgente eternamente splendida di tutto ciò che per l’universo si squaderna».
Q11 §67 Passaggio dal sapere al comprendere, al sentire, e viceversa, dal sentire al comprendere, al sapere. L’elemento popolare «sente», ma non sempre comprende o sa; l’elemento intellettuale «sa», ma non sempre comprende e specialmente «sente». I due estremi sono pertanto la pedanteria e il filisteismo da una parte e la passione cieca e il settarismo dall’altra. Non che il pedante non possa essere appassionato, anzi; la pedanteria appassionata è altrettanto ridicola e pericolosa che il settarismo e la demagogia più sfrenati. L’errore dell’intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere e specialmente senza sentire ed essere appassionato (non solo del sapere in sé, ma per l’oggetto del sapere) cioè che l’intellettuale possa essere tale (e non un puro pedante) se distinto e staccato dal popolo-nazione, cioè senza sentire le passioni elementari del popolo, comprendendole e quindi spiegandole e giustificandole nella determinata situazione storica, e collegandole dialetticamente alle leggi della storia, a una superiore concezione del mondo, scientificamente e coerentemente elaborata, il «sapere»; non si fa politica‑storia senza questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale tra intellettuali e popolo‑nazione. In assenza di tale nesso i rapporti dell’intellettuale col popolo‑nazione sono o si riducono a rapporti di ordine puramente burocratico, formale; gli intellettuali diventano una casta o un sacerdozio (così detto centralismo organico). Se il rapporto tra intellettuali e popolo‑nazione, tra dirigenti e diretti, tra governanti e governati, è dato da una adesione organica in cui il sentimento‑passione diventa comprensione e quindi sapere (non meccanicamente, ma in modo vivente), solo allora il rapporto è di rappresentanza, e avviene lo scambio di elementi individuali tra governati e governanti, tra diretti e dirigenti, cioè si realizza la vita d’insieme che sola è la forza sociale, si crea il «blocco storico». Il De Man «studia» i sentimenti popolari, non con‑sente con essi per guidarli e condurli a una catarsi di civiltà moderna: la sua posizione è quella dello studioso di folclore che ha continuamente paura che la modernità gli distrugga l’oggetto della sua scienza. D’altronde c’è nel suo libro il riflesso pedantesco di una esigenza reale: che i sentimenti popolari siano conosciuti e studiati così come essi si presentano obbiettivamente e non ritenuti qualcosa di trascurabile e di inerte nel movimento storico.
Q11 §68 La «nuova» Scienza. G. A. Borgese e Michele Ardan. Nel romanzo di Jules Verne Dalla terra alla luna, Michele Ardan, nel suo discorso programmatico dice liricamente che «lo spazio non esiste, perché gli astri sono talmente vicini gli uni agli altri che si può pensare l’universo come un tutto solido, le cui reciproche distanze possono paragonarsi alle distanze esistenti fra le molecole del metallo più compatto come l’oro o il platino». Il Borgese, sulle tracce di Eddington, ha capovolto il ragionamento del Verne e sostiene che la «materia solida» non esiste, perché il vuoto nell’atomo è tale che un corpo umano, ridotto alle parti solide, diverrebbe un corpuscolo visibile solo al microscopio. È la «fantasia» di Verne applicata alla Scienza degli scienziati e non più a quella dei ragazzi. (Il Verne immagina che nel momento in cui l’Ardan espone la sua tesi, Maston, una delle figurette con cui rende arguti i suoi libri, nel gridare con entusiasmo: «Sì, le distanze non esistono!» stia per cadere e provare così, sulla sua pelle, se le distanze esistono o no).
Q11 §69 Sorel, Proudhon, De Man (continuazione pagina 70 bis sgg.). Mario Missiroli ha pubblicato nel 1932 presso le «Edizioni Corbaccio» di Milano, l’«annunziata» raccolta di articoli scritti da Giorgio Sorel nei giornali italiani dal 1910 al 1921, col titolo L’Europa sotto la tormenta. Lo scritto del Sorel, pubblicato nella «Nuova Antologia» del 1° dicembre 1928 col titolo Ultime meditazioni (Scritto postumo inedito) non è riprodotto nel volume, sebbene fosse stato annunziato come scritto dal Sorel a modo di prefazione: la scelta degli articoli riprodotti, del resto, non permetteva la stampa di tale prefazione, che col contenuto del libro non ha niente a che vedere. Appare evidente che il Missiroli non si è attenuto alle indicazioni che il Sorel doveva avergli dato per compilare la raccolta, indicazioni che si possono ricavare dalla «prefazione» scartata. La raccolta è stata fatta ad usum delphini, tenendo conto solo di una delle tante direzioni del pensiero sorelliano, che non si può ritenere fosse giudicata dallo scrittore come la più importante, perché altrimenti la «prefazione» sarebbe stata di altra intonazione. Alla raccolta precede invece una prefazione del Missiroli, che è unilaterale ed è in contrasto stridente con la prefazione censurata, della quale, poco lealmente, non si fa neppur cenno.
Q11 §70 Antonio Labriola. Sarebbe di grande utilità un riassunto obbiettivo e sistematico (anche se di tipo scolastico‑analitico) di tutte le pubblicazioni di Antonio Labriola sulla filosofia della prassi per sostituire i volumi esauriti. Un lavoro di tal genere è preliminare per ogni iniziativa rivolta a rimettere in circolazione la posizione filosofica del Labriola che è pochissimo conosciuta all’infuori di una cerchia ristretta. È stupefacente che nelle sue Memorie Leone Bronstein [Trotzky ndc] parli di «dilettantismo» del Labriola (rivedere). Non si capisce questo giudizio (almeno non significasse il distacco tra teoria e pratica nella persona del Labriola, ciò che non pare il caso) se non come un riflesso inconsapevole della pedanteria pseudoscientifica del gruppo intellettuale tedesco che ebbe tanta influenza in Russia. In realtà il Labriola, affermando che la filosofia della prassi è indipendente da ogni altra corrente filosofica, è autosufficiente, è il solo che abbia cercato di costruire scientificamente la filosofia della prassi. La tendenza dominante si è manifestata in due correnti principali:
1) Quella cosidetta ortodossa, rappresentata dal Plekhanov (cfr I Problemi fondamentali) che in realtà nonostante le sue affermazioni in contrario, ricade nel materialismo volgare. Non è stato bene impostato il problema delle «origini» del pensiero del fondatore della filosofia della prassi: uno studio accurato della cultura filosofica del Marx (e dell’ambiente filosofico generale in cui egli si formò direttamente e indirettamente) è certo necessario, ma come premessa allo studio, ben più importante, della sua propria e «originale» filosofia, che non può esaurirsi in alcune «fonti» o nella «cultura sua personale»: occorre, prima di tutto, tener conto della sua attività creatrice e costruttrice. Il modo di porre il problema da parte del Plekhanov è tipicamente proprio del metodo positivistico e mostra le sue scarse facoltà speculative e storiografiche.
2) La tendenza «ortodossa» ha determinato la sua opposta: di collegare la filosofia della prassi al kantismo o ad altre tendenze filosofiche non positivistiche e materialistiche, fino alla conclusione «agnostica» di Otto Bauer che nel suo libretto sulla «Religione» scrive che il marxismo può essere sostenuto e integrato da una qualsiasi filosofia, quindi anche dal tomismo. Questa seconda non è quindi una tendenza in senso stretto, ma un insieme di tutte le tendenze che non accettano la così detta «ortodossia» del pedantismo tedesco, fino a quella freudiana del De Man.
Perché il Labriola e la sua impostazione del problema filosofico, hanno avuto così scarsa fortuna? Si può dire a questo proposito ciò che la Rosa disse a proposito dell’economia critica e dei suoi problemi più alti: nel periodo romantico della lotta, dello Sturm und Drang popolare, tutto l’interesse si appunta sulle armi più immediate, sui problemi di tattica, in politica e sui minori problemi culturali nel campo filosofico. Ma dal momento in cui un gruppo subalterno diventa realmente autonomo ed egemone suscitando un nuovo tipo di Stato, nasce concretamente l’esigenza di costruire un nuovo ordine intellettuale e morale, cioè un nuovo tipo di società e quindi l’esigenza di elaborare i concetti più universali, le armi ideologiche più raffinate e decisive. Ecco la necessità di rimettere in circolazione Antonio Labriola e di far predominare la sua impostazione del problema filosofico. Si può così porre la lotta per una cultura superiore autonoma; la parte positiva della lotta che si manifesta in forma negativa e polemica con gli a‑ privativi e gli anti‑ (anticlericalismo, ateismo, ecc.). Si dà una forma moderna e attuale all’umanesimo laico tradizionale che deve essere la base etica del nuovo tipo di Stato.
La trattazione analitica e sistematica della concezione filosofica di Antonio Labriola potrebbe diventare la sezione filosofica di una rivista del tipo medio «Voce», «Leonardo» («Ordine Nuovo») di cui si parla nella rubrica del giornalismo. Bisognerebbe compilare una bibliografia internazionale sul Labriola («Neue Zeit», ecc.).
QUADERNO 12
APPUNTI E NOTE SPARSE PER UN GRUPPO DI SAGGI SULLA STORIA DEGLI INTELLETTUALI
Q12 §1 Gli intellettuali sono un gruppo sociale autonomo e
indipendente, oppure ogni gruppo sociale ha una sua propria
categoria specializzata di intellettuali? Il problema è
complesso per le varie forme che ha assunto finora il processo
storico reale di formazione delle diverse categorie
intellettuali. Le più importanti di queste forme sono due:
1) Ogni gruppo sociale, nascendo sul terreno originario di una funzione essenziale nel mondo della produzione economica, si crea insieme, organicamente, uno o più ceti di intellettuali che gli danno omogeneità e consapevolezza della propria funzione non solo nel campo economico, ma anche in quello sociale e politico: l’imprenditore capitalistico crea con sé il tecnico dell’industria, lo scienziato dell’economia politica, l’organizzatore di una nuova cultura, di un nuovo diritto, ecc. ecc. Occorre notare il fatto che l’imprenditore rappresenta una elaborazione sociale superiore, già caratterizzata da una certa capacità dirigente e tecnica (cioè intellettuale): egli deve avere una certa capacità tecnica, oltre che nella sfera circoscritta della sua attività e della sua iniziativa, anche in altre sfere, almeno in quelle più vicine alla produzione economica (deve essere un organizzatore di masse d’uomini, deve essere un organizzatore della «fiducia» dei risparmiatori nella sua azienda, dei compratori della sua merce ecc.).
Se non tutti gli imprenditori, almeno una élite di essi deve avere una capacità di organizzatore della società in generale, in tutto il suo complesso organismo di servizi, fino all’organismo statale, per la necessità di creare le condizioni più favorevoli all’espansione della propria classe; o deve possedere per lo meno la capacità di scegliere i «commessi» (impiegati specializzati) cui affidare questa attività organizzatrice dei rapporti generali esterni all’azienda.
Si può osservare che gli intellettuali «organici» che ogni nuova classe crea con se stessa ed elabora nel suo sviluppo progressivo, sono per lo più «specializzazioni» di aspetti parziali dell’attività primitiva del tipo sociale nuovo che la nuova classe ha messo in luce. (Anche i signori feudali erano detentori di una particolare capacità tecnica, quella militare, ed è appunto dal momento in cui l’aristocrazia perde il monopolio della capacità tecnico‑militare che si inizia la crisi del feudalismo. Ma la formazione degli intellettuali nel mondo feudale e nel precedente mondo classico è una quistione da esaminare a parte: questa formazione ed elaborazione segue vie e modi che occorre studiare concretamente. Così è da notare che la massa dei contadini, quantunque svolga una funzione essenziale nel mondo della produzione, non elabora proprii intellettuali «organici» e non «assimila» nessun ceto di intellettuali «tradizionali», quantunque dalla massa dei contadini altri gruppi sociali tolgano molti dei loro intellettuali e gran parte degli intellettuali tradizionali siano di origine contadina).
2) Ma ogni gruppo sociale «essenziale» emergendo alla storia dalla precedente struttura economica e come espressione di un suo sviluppo (di questa struttura), ha trovato, almeno nella storia finora svoltasi, categorie sociali preesistenti e che anzi apparivano come rappresentanti una continuità storica ininterrotta anche dai più complicati e radicali mutamenti delle forme sociali e politiche. La più tipica di queste categorie intellettuali è quella degli ecclesiastici, monopolizzatori per lungo tempo (per un’intera fase storica che anzi da questo monopolio è in parte caratterizzata) di alcuni servizi importanti: l’ideologia religiosa cioè la filosofia e la scienza dell’epoca, con la scuola, l’istruzione, la morale, la giustizia, la beneficenza, l’assistenza ecc.
La categoria degli ecclesiastici può essere considerata essere la categoria intellettuale organicamente legata all’aristocrazia fondiaria: era equiparata giuridicamente all’aristocrazia, con cui divideva l’esercizio della proprietà feudale della terra e l’uso dei privilegi‑statali legati alla proprietà. Ma il monopolio delle superstrutture da parte degli ecclesiastici (da esso è nata l’accezione generale di «intellettuale» – o di «specialista» – della parola «chierico», in molte lingue di origine neolatina o influenzate fortemente, attraverso il latino chiesastico, dalle lingue neolatine, col suo correlativo di «laico» nel senso di profano – non specialista) non è stato esercitato senza lotta e limitazioni, e quindi si è avuto il nascere, in varie forme (da ricercare e studiare concretamente) di altre categorie, favorite e ingrandite dal rafforzarsi del potere centrale del monarca, fino all’assolutismo. Così si viene formando l’aristocrazia della toga, con suoi propri privilegi; un ceto di amministratori ecc., scienziati, teorici, filosofi non ecclesiastici ecc.
Siccome queste varie categorie di intellettuali tradizionali sentono con «spirito di corpo» la loro ininterrotta continuità storica e la loro «qualifica», così essi pongono se stessi come autonomi e indipendenti dal gruppo sociale dominante; questa auto‑posizione non è senza conseguenze nel campo ideologico e politico, conseguenze di vasta portata (tutta la filosofia idealista si può facilmente connettere con questa posizione assunta dal complesso sociale degli intellettuali e si può definire l’espressione di questa utopia sociale per cui gli intellettuali si credono «indipendenti», autonomi, rivestiti di caratteri loro proprii ecc. Da notare però che se il papa e l’alta gerarchia della Chiesa si credono più legati a Cristo e agli apostoli di quanto non siano ai senatori Agnelli e Benni, lo stesso non è per Gentile e Croce, per esempio; il Croce, specialmente, si sente legato fortemente ad Aristotile e a Platone, ma egli non nasconde, anzi, di essere legato ai senatori Agnelli e Benni e in ciò appunto è da ricercare il carattere più rilevato della filosofia del Croce).
(Questa ricerca sulla storia degli intellettuali non sarà di carattere «sociologico», ma darà luogo a una serie di saggi di «storia della cultura» (Kulturgeschichte) e di storia della scienza politica. Tuttavia sarà difficile evitare alcune forme schematiche e astratte che ricordano quelle della «sociologia»: occorrerà pertanto trovare la forma letteraria più adatta perché l’esposizione sia «non‑sociologica». La prima parte della ricerca potrebbe essere una critica metodica delle opere già esistenti sugli intellettuali, che quasi tutte sono di carattere sociologico. Raccogliere la bibliografia sull’argomento è pertanto indispensabile).
Quali sono i limiti «massimi» dell’accezione di «intellettuale»? Si può trovare un criterio unitario per caratterizzare ugualmente tutte le diverse e disparate attività intellettuali e per distinguere queste nello stesso tempo e in modo essenziale dalle attività degli altri raggruppamenti sociali? L’errore metodico più diffuso mi pare quello di aver cercato questo criterio di distinzione nell’intrinseco delle attività intellettuali e non invece nell’insieme del sistema di rapporti in cui esse (e quindi i gruppi che le impersonano) vengono a trovarsi nel complesso generale dei rapporti sociali. E invero l’operaio o proletario, per esempio, non è specificamente caratterizzato dal lavoro manuale o strumentale (a parte la considerazione che non esiste lavoro puramente fisico e che anche l’espressione del Taylor di «gorilla ammaestrato» è una metafora per indicare un limite in una certa direzione: in qualsiasi lavoro fisico, anche il più meccanico e degradato, esiste un minimo di qualifica tecnica, cioè un minimo di attività intellettuale creatrice), ma da questo lavoro in determinate condizioni e in determinati rapporti sociali. Ed è stato già osservato che l’imprenditore, per la sua stessa funzione, deve avere in una certa misura un certo numero di qualifiche di carattere intellettuale, sebbene la sua figura sociale sia determinata non da esse ma dai rapporti generali sociali che appunto caratterizzano la posizione dell’imprenditore nell’industria.
Tutti gli uomini sono intellettuali, si potrebbe dire perciò; ma non tutti gli uomini hanno nella società la funzione di intellettuali (così, perché può capitare che ognuno in qualche momento si frigga due uova o si cucisca uno strappo della giacca, non si dirà che tutti sono cuochi e sarti). Si formano così storicamente delle categorie specializzate per l’esercizio della funzione intellettuale, si formano in connessione con tutti i gruppi sociali ma specialmente in connessione coi gruppi sociali più importanti e subiscono elaborazioni più estese e complesse in connessione col gruppo sociale dominante.
Una delle caratteristiche più rilevanti di ogni gruppo che si sviluppa verso il dominio è la sua lotta per l’assimilazione e la conquista «ideologica» degli intellettuali tradizionali, assimilazione e conquista che è tanto più rapida ed efficace quanto più il gruppo dato elabora simultaneamente i propri intellettuali organici. L’enorme sviluppo preso dall’attività e dall’organizzazione scolastica (in senso largo) nelle società sorte dal mondo medioevale indica quale importanza abbiano assunto nel mondo moderno le categorie e le funzioni intellettuali: come si è cercato di approfondire e dilatare l’«intellettualità» di ogni individuo, così si è anche cercato di moltiplicare le specializzazioni e di affinarle. Ciò risulta dalle istituzioni scolastiche di diverso grado, fino agli organismi per promuovere la così detta «alta cultura», in ogni campo della scienza e della tecnica.
(La scuola è lo strumento per elaborare gli intellettuali di vario grado. La complessità della funzione intellettuale nei diversi Stati si può misurare obbiettivamente dalla quantità delle scuole specializzate e dalla loro gerarchizzazione: quanto più estesa è l’«area» scolastica e quanto più numerosi i «gradi» «verticali» della scuola, tanto è più complesso il mondo culturale, la civiltà, di un determinato Stato. Si può avere un termine di paragone nella sfera della tecnica industriale: l’industrializzazione di un paese si misura dalla sua attrezzatura nella costruzione di macchine per costruire macchine e nella fabbricazione di strumenti sempre più precisi per costruire macchine e strumenti per costruire macchine ecc. Il paese che ha la migliore attrezzatura per costruire strumenti per i gabinetti sperimentali degli scienziati e per costruire strumenti per collaudare questi strumenti, si può dire il più complesso nel campo tecnico‑industriale, il più civile ecc. Così è nella preparazione degli intellettuali e nelle scuole dedicate a questa preparazione: scuole e istituti di alta cultura sono assimilabili). (Anche in questo campo la quantità non può scindersi dalla qualità. Alla più raffinata specializzazione tecnico‑culturale non può non corrispondere la maggiore estensione possibile della diffusione dell’istruzione primaria e la maggiore sollecitudine per favorire i gradi intermedi al più gran numero. Naturalmente questa necessità di creare la più larga base possibile per la selezione e l’elaborazione delle più alte qualifiche intellettuali – di dare cioè all’alta cultura e alla tecnica superiore una struttura democratica – non è senza inconvenienti: si crea così la possibilità di vaste crisi di disoccupazione degli strati medi intellettuali, come avviene di fatto in tutte le società moderne).
Da notare che l’elaborazione dei ceti intellettuali nella realtà concreta non avviene su un terreno democratico astratto, ma secondo processi storici tradizionali molto concreti. Si sono formati dei ceti che tradizionalmente «producono» intellettuali e sono quelli stessi che di solito sono specializzati nel «risparmio», cioè la piccola e media borghesia terriera e alcuni strati della piccola e media borghesia cittadina. La diversa distribuzione dei diversi tipi di scuole (classiche e professionali) nel territorio «economico» e le diverse aspirazioni delle varie categorie di questi ceti determinano o danno forma alla produzione dei diversi rami di specializzazione intellettuale. Così in Italia la borghesia rurale produce specialmente funzionari statali e professionali liberi, mentre la borghesia cittadina produce tecnici per l’industria: e perciò l’Italia settentrionale produce specialmente tecnici e l’Italia meridionale specialmente funzionari e professionisti.
Il rapporto tra gli intellettuali e il mondo della produzione non è immediato, come avviene per i gruppi sociali fondamentali, ma è mediato, in diverso grado, da tutto il tessuto sociale, dal complesso delle superstrutture, di cui appunti gli intellettuali sono i «funzionari». Si potrebbe misurare l’«organicità» dei diversi strati intellettuali, la loro più o meno stretta connessione con un gruppo sociale fondamentale, fissando una gradazione delle funzioni e delle soprastrutture dal basso in alto (dalla base strutturale in su).
Si possono, per ora, fissare due grandi «piani» superstrutturali, quello che si può chiamare della «società civile», cioè dell’insieme di organismi volgarmente detti «privati» e quello della «società politica o Stato» e che corrispondono alla funzione di «egemonia» che il gruppo dominante esercita in tutta la società e a quello di «dominio diretto» o di comando che si esprime nello Stato e nel governo «giuridico». Queste funzioni sono precisamente organizzative e connettive.
Gli intellettuali sono i «commessi» del gruppo dominante per l’esercizio delle funzioni subalterne dell’egemonia sociale e del governo politico, cioè: 1) del consenso «spontaneo» dato dalle grandi masse della popolazione all’indirizzo impresso alla vita sociale dal gruppo fondamentale dominante, consenso che nasce «storicamente» dal prestigio (e quindi dalla fiducia) derivante al gruppo dominante dalla sua posizione e dalla sua funzione nel mondo della produzione; 2) dell’apparato di coercizione statale che assicura «legalmente» la disciplina di quei gruppi che non «consentono» né attivamente né passivamente, ma è costituito per tutta la società in previsione dei momenti di crisi nel comando e nella direzione in cui il consenso spontaneo vien meno.
Questa impostazione del problema dà come risultato un’estensione molto grande del concetto di intellettuale, ma solo così è possibile giungere a una approssimazione concreta della realtà. Questo modo di impostare la questione urta contro preconcetti di casta: è vero che la stessa funzione organizzativa dell’egemonia sociale e del dominio statale dà luogo a una certa divisione del lavoro e quindi a tutta una gradazione di qualifiche, in alcune delle quali non appare più alcuna attribuzione direttiva e organizzativa: nell’apparato di direzione sociale e statale esiste tutta una serie di impieghi di carattere manuale e strumentale (di ordine e non di concetto, di agente e non di ufficiale o funzionario ecc.), ma evidentemente occorre fare questa distinzione, come occorrerà farne anche qualche altra. Infatti l’attività intellettuale deve essere distinta in gradi anche dal punto di vista intrinseco, gradi che nei momenti di estrema opposizione danno una vera e propria differenza qualitativa: nel più alto gradino saranno da porre i creatori delle varie scienze, della filosofia, dell’arte, ecc.; nel più basso i più umili «amministratori» e divulgatori della ricchezza intellettuale già esistente, tradizionale, accumulata. L’organismo militare, anche in questo caso, offre un modello di queste complesse graduazioni: ufficiali subalterni, ufficiali superiori, Stato maggiore; e non bisogna dimenticare i graduati di truppa, la cui importanza reale è superiore a quanto di solito si pensi. È interessante notare che tutte queste parti si sentono solidali e anzi che gli strati inferiori manifestano un più appariscente spirito di corpo e traggono da esso una «boria» che spesso li espone ai frizzi e ai motteggi.
Nel mondo moderno, la categoria degli intellettuali, così intesa, si è ampliata in modo inaudito. Sono state elaborate dal sistema sociale democratico‑burocratico masse imponenti, non tutte giustificate dalle necessità sociali della produzione, anche se giustificate dalle necessità politiche del gruppo fondamentale dominante. Quindi la concezione loriana del «lavoratore» improduttivo (ma improduttivo per riferimento a chi e a quale modo di produzione?), che potrebbe in parte giustificarsi se si tiene conto che queste masse sfruttano la loro posizione per farsi assegnare taglie ingenti sul reddito nazionale. La formazione di massa ha standardizzato gli individui e come qualifica individuale e come psicologia, determinando gli stessi fenomeni che in tutte le altre masse standardizzate: concorrenza che pone la necessità dell’organizzazione professionale di difesa, disoccupazione, superproduzione scolastica, emigrazione ecc.
Diversa posizione degli intellettuali di tipo urbano e di tipo rurale. Gli intellettuali di tipo urbano sono concresciuti con l’industria e sono legati alle sue fortune. La loro funzione può essere paragonata a quella degli ufficiali subalterni nell’esercito: non hanno nessuna iniziativa autonoma nel costruire i piani di costruzione; mettono in rapporto, articolandola, la massa strumentale con l’imprenditore, elaborano l’esecuzione immediata del piano di produzione stabilito dallo stato maggiore dell’industria, controllandone le fasi lavorative elementari. Nella loro media generale gli intellettuali urbani sono molto standardizzati; gli alti intellettuali urbani si confondono sempre più col vero e proprio stato maggiore industriale.
Gli intellettuali di tipo rurale sono in gran parte «tradizionali», cioè legati alla massa sociale campagnola e piccolo borghese, di città (specialmente dei centri minori), non ancora elaborata e messa in movimento dal sistema capitalistico: questo tipo di intellettuale mette a contatto la massa contadina con l’amministrazione statale o locale (avvocati, notai ecc.) e per questa stessa funzione ha una grande funzione politico‑sociale, perché la mediazione professionale è difficilmente scindibile dalla mediazione politica. Inoltre: nella campagna l’intellettuale (prete, avvocato, maestro, notaio, medico ecc.) ha un medio tenore di vita superiore o almeno diverso da quello del medio contadino e perciò rappresenta per questo un modello sociale nell’aspirazione a uscire dalla sua condizione e a migliorarla. Il contadino pensa sempre che almeno un suo figliolo potrebbe diventare intellettuale (specialmente prete), cioè diventare un signore, elevando il grado sociale della famiglia e facilitandone la vita economica con le aderenze che non potrà non avere tra gli altri signori. L’atteggiamento del contadino verso l’intellettuale è duplice e pare contradditorio: egli ammira la posizione sociale dell’intellettuale e in generale dell’impiegato statale, ma finge talvolta di disprezzarla, cioè la sua ammirazione è intrisa istintivamente da elementi di invidia e di rabbia appassionata. Non si comprende nulla della vita collettiva dei contadini e dei germi e fermenti di sviluppo che vi esistono se non si prende in considerazione, non si studia in concreto e non si approfondisce, questa subordinazione effettiva agli intellettuali: ogni sviluppo organico delle masse contadine, fino a un certo punto, è legato ai movimenti degli intellettuali e ne dipende.
Altro è il caso per gli intellettuali urbani: i tecnici di fabbrica non esplicano nessuna funzione politica sulle loro masse strumentali, o almeno è questa una fase già superata; talvolta avviene proprio il contrario, che le masse strumentali, almeno attraverso i loro propri intellettuali organici, esercitano un influsso politico sui tecnici.
Il punto centrale della quistione rimane la distinzione tra intellettuali, categoria organica di ogni gruppo sociale fondamentale e intellettuali, come categoria tradizionale; distinzione da cui scaturisce tutta una serie di problemi e di possibili ricerche storiche. Il problema più interessante è quello che riguarda, se considerato da questo punto di vista, il partito politico moderno, le sue origini reali, i suoi sviluppi, le sue forme. Cosa diventa il partito politico in ordine al problema degli intellettuali?
Occorre fare alcune distinzioni: 1) per alcuni gruppi sociali il partito politico è niente altro che il modo proprio di elaborare la propria categoria di intellettuali organici, che si formano così e non possono non formarsi, dati i caratteri generali e le condizioni di formazione, di vita e di sviluppo del gruppo sociale dato, direttamente nel campo politico e filosofico e non già nel campo della tecnica produttiva (nel campo della tecnica produttiva si formano quegli strati che si può dire corrispondono ai «graduati di truppa» nell’esercito, cioè gli operai qualificati e specializzati in città e in modo più complesso i mezzadri e coloni in campagna, poiché il mezzadro e il colono in generale corrisponde piuttosto al tipo artigiano, che è l’operaio qualificato di una economia medioevale); 2) il partito politico, per tutti i gruppi, è appunto il meccanismo che nella società civile compie la stessa funzione che compie lo Stato in misura più vasta e più sinteticamente, nella società politica, cioè procura la saldatura tra intellettuali organici di un dato gruppo, quello dominante, e intellettuali tradizionali, e questa funzione il partito compie appunto in dipendenza della sua funzione fondamentale che è quella di elaborare i proprii componenti, elementi di un gruppo sociale nato e sviluppatosi come «economico», fino a farli diventare intellettuali politici qualificati, dirigenti, organizzatori di tutte le attività e le funzioni inerenti all’organico sviluppo di una società integrale, civile e politica.
Si può dire anzi che nel suo ambito il partito politico compia la sua funzione molto più compiutamente e organicamente di quanto lo Stato compia la sua in ambito più vasto: un intellettuale che entra a far parte del partito politico di un determinato gruppo sociale, si confonde con gli intellettuali organici del gruppo stesso, si lega strettamente al gruppo, ciò che non avviene attraverso la partecipazione alla vita statale che mediocremente e talvolta affatto. Anzi avviene che molti intellettuali pensino di essere lo Stato, credenza, che, data la massa imponente della categoria, ha talvolta conseguenze voli e porta a complicazioni spiacevoli per il gruppo fondamentale economico che realmente è lo Stato.
Che tutti i membri di un partito politico debbano essere considerati come intellettuali, ecco un’affermazione che può prestarsi allo scherzo e alla caricatura; pure, se si riflette, niente di più esatto. Sarà da fare distinzione di gradi, un partito potrà avere una maggiore o minore composizione del grado più alto o di quello più basso, non è ciò che importa: importa la funzione che è direttiva e organizzativa, cioè educativa, cioè intellettuale. Un commerciante non entra a far parte di un partito politico per fare del commercio, né un industriale per produrre di più e a costi diminuiti, né un contadino per apprendere nuovi metodi di coltivare la terra, anche se alcuni aspetti di queste esigenze del commerciante, dell’industriale, del contadino possono trovare soddisfazione nel partito politico (l’opinione generale contraddice a ciò, affermando che il commerciante, l’industriale, il contadino «politicanti» perdono invece di guadagnare, e sono i peggiori della loro categoria, ciò che può essere discusso). Per questi scopi, entro certi limiti, esiste il sindacato professionale in cui l’attività economico‑corporativa del commerciante, dell’industriale, del contadino, trova il suo quadro più adatto.
Nel partito politico gli elementi di un gruppo sociale economico superano questo momento del loro sviluppo storico e diventano agenti di attività generali, di carattere nazionale e internazionale. Questa funzione del partito politico dovrebbe apparire molto più chiara da un’analisi storica concreta del come si sono sviluppate le categorie organiche degli intellettuali e quelle tradizionali sia nel terreno delle varie storie nazionali sia in quello dello sviluppo dei vari gruppi sociali più importanti nel quadro delle diverse nazioni, specialmente di quei gruppi la cui attività economica è stata prevalentemente strumentale.
La formazione degli intellettuali tradizionali è il problema storico più interessante. Esso è certamente legato alla schiavitù del mondo classico e alla posizione dei liberti di origine greca e orientale nell’organizzazione sociale dell’Impero romano. Questo distacco non solo sociale ma nazionale, di razza, tra masse voli di intellettuali e la classe dominante dell’Impero romano si riproduce dopo la caduta dell’Impero tra guerrieri germanici e intellettuali di origine romanizzati, continuatori della categoria dei liberti. Si intreccia con questi fenomeni il nascere e lo svilupparsi del cattolicismo e dell’organizzazione ecclesiastica che per molti secoli assorbe la maggior parte delle attività intellettuali ed esercita il monopolio della direzione culturale, con sanzioni penali per chi vuole opporsi o anche eludere il monopolio. In Italia si verifica il fenomeno, più o meno intenso secondo i tempi, della funzione cosmopolita degli intellettuali della penisola. Accennerò le differenze che saltano subito agli occhi nello sviluppo degli intellettuali in tutta una serie di paesi, almeno le più voli, con l’avvertenza che queste osservazioni dovranno essere controllate e approfondite (d’altronde, tutte queste devono essere considerate semplicemente come spunti e motivi per la memoria, che devono essere controllati e approfonditi):
Per l’Italia il fatto centrale è appunto la funzione internazionale e cosmopolita dei suoi intellettuali che è causa ed effetto dello stato di disgregazione in cui rimane la penisola dalla caduta dell’Impero Romano al 1870.
La Francia dà un tipo compiuto di sviluppo armonico di tutte le energie nazionali e specialmente delle categorie intellettuali; quando nel 1789 un nuovo raggruppamento sociale affiora politicamente alla storia, esso è completamente attrezzato per tutte le sue funzioni sociali e perciò lotta per il dominio totale della nazione, senza venire a compromessi essenziali con le vecchie classi, ma invece subordinandole ai propri fini. Le prime cellule intellettuali del nuovo tipo nascono con le prime cellule economiche: la stessa organizzazione ecclesiastica ne è influenzata (gallicanismo, lotte molto precoci tra Chiesa e Stato). Questa massiccia costruzione intellettuale spiega la funzione della cultura francese nei secoli XVIII e XIX, funzione di irradiazione internazionale e cosmopolita e di espansione a carattere imperialistico ed egemonico in modo organico, quindi ben diversa da quella italiana, a carattere immigratorio personale e disgregato, che non refluisce sulla base nazionale per potenziarla ma invece concorre a rendere impossibile il costituirsi di una salda base nazionale.
In Russia diversi spunti: l’organizzazione politica ed economico‑commerciale è creata dai Normanni (Varieghi), quella religiosa dai greci bizantini; in un secondo tempo i tedeschi e i francesi portano l’esperienza europea in Russia e danno un primo scheletro consistente alla gelatina storica russa. Le forze nazionali sono inerti, passive e ricettive, ma forse appunto perciò assimilano completamente le influenze straniere e gli stessi stranieri, russificandoli. Nel periodo storico più recente avviene il fenomeno inverso: una élite di persone tra le più attive, energiche, intraprendenti e disciplinate, emigra all’estero, assimila la cultura e le esperienze storiche dei paesi più progrediti dell’Occidente, senza perciò perdere i caratteri più essenziali della propria nazionalità, senza cioè rompere i legami sentimentali e storici col proprio popolo; fatto così il suo garzonato intellettuale, rientra nel paese, costringendo il popolo ad un forzato risveglio, ad una marcia in avanti accelerata, bruciando le tappe. La differenza tra questa élite e quella tedesca importata (da Pietro il Grande, per esempio) consiste nel suo carattere essenziale nazionale‑popolare: non può essere assimilata dalla passività inerte del popolo russo, perché è essa stessa una energica reazione russa alla propria inerzia storica.
In un altro terreno e in ben diverse condizioni di tempo e di luogo, questo fenomeno russo può essere paragonato alla nascita della nazione americana (Stati Uniti): gl’immigrati anglosassoni sono anch’essi un’élite intellettuale, ma specialmente morale. Si vuol parlare naturalmente dei primi immigrati, dei pionieri, protagonisti delle lotte religiose e politiche inglesi, sconfitti, ma non umiliati né depressi nella loro patria d’origine. Essi importano in America, con se stessi, oltre l’energia morale e volitiva, un certo grado di civiltà, una certa fase dell’evoluzione storica europea, che trapiantata nel suolo vergine americano da tali agenti, continua a sviluppare le forze implicite nella sua natura ma con un ritmo incomparabilmente più rapido che nella vecchia Europa, dove esiste tutta una serie di freni (morali intellettuali politici economici, incorporati in determinati gruppi della popolazione, reliquie dei passati regimi che non vogliono sparire) che si oppongono a un processo celere ed equilibrano nella mediocrità ogni iniziativa, diluendola nel tempo e nello spazio.
In Inghilterra lo sviluppo è molto diverso che in Francia. Il nuovo raggruppamento sociale nato sulla base dell’industrialismo moderno, ha un sorprendente sviluppo economico‑corporativo, ma procede a tastoni nel campo intellettuale‑politico. Molto vasta la categoria degli intellettuali organici, nati cioè sullo stesso terreno industriale col gruppo economico, ma nella sfera più elevata troviamo conservata la posizione di quasi monopolio della vecchia classe terriera, che perde la supremazia economica ma conserva a lungo una supremazia politico‑intellettuale e viene assimilata come «intellettuali tradizionali» e strato dirigente dal nuovo gruppo al potere. La vecchia aristocrazia terriera si unisce agli industriali con un tipo di sutura che in altri paesi è appunto quello che unisce gli intellettuali tradizionali alle nuove classi dominanti.
Il fenomeno inglese si è presentato anche in Germania complicato da altri elementi storici e tradizionali. La Germania, come l’Italia, è stata la sede di una istituzione e di una ideologia universalistica, supernazionale (Sacro Romano Impero della Nazione tedesca) e ha dato una certa quantità di personale alla cosmopoli medioevale, depauperando le proprie energie interne e suscitando lotte che distoglievano dai problemi di organizzazione nazionale e mantenevano la disgregazione territoriale del Medio Evo. Lo sviluppo industriale è avvenuto sotto un involucro semifeudale durato fino al novembre 1918 e gli junker hanno mantenuto una supremazia politico‑intellettuale ben maggiore di quella dello stesso gruppo inglese. Essi sono stati gli intellettuali tradizionali degli industriali tedeschi, ma con speciali privilegi e con una forte coscienza di essere un gruppo sociale indipendente, basata sul fatto che detenevano un notevole potere economico sulla terra, «produttiva» più che in Inghilterra.
Gli junker prussiani rassomigliano a una casta sacerdotale‑militare, che ha un quasi monopolio delle funzioni direttive‑organizzative nella società politica, ma ha nello stesso tempo una base economica propria e non dipende esclusivamente dalla liberalità del gruppo economico dominante. Inoltre, a differenza dei nobili terrieri inglesi, gli junker costituivano l’ufficialità di un grande esercito stanziale, ciò che dava loro dei quadri organizzativi solidi, favorevoli alla conservazione dello spirito di corpo e del monopolio politico (nel libro Parlamento e governo nel nuovo ordinamento della Germania di Max Weber si possono trovare molti elementi per vedere come il monopolio politico dei nobili abbia impedito l’elaborazione di un personale politico borghese vasto e sperimentato e sia alla base delle continue crisi parlamentari e della disgregazione dei partiti liberali e democratici; quindi l’importanza del Centro Cattolico e della Socialdemocrazia, che nel periodo imperiale riuscirono a elaborare un proprio strato parlamentare e direttivo abbastanza notevole).
Negli Stati Uniti è da notare l’assenza, in una certa misura, degli intellettuali tradizionali e quindi il diverso equilibrio degli intellettuali in generale. Si è avuta una formazione massiccia sulla base industriale di tutte le superstrutture moderne. La necessità di un equilibrio non è data dal fatto che occorre fondere gli intellettuali organici con quelli tradizionali che non esistono come categoria cristallizzata e misoneista, ma dal fatto che occorre fondere in un unico crogiolo nazionale di cultura unitaria tipi di culture diverse portati dagli immigrati di varie origini nazionali. La mancanza di una vasta sedimentazione di intellettuali tradizionali, come si è verificata nei paesi di antica civiltà, spiega in parte, sia l’esistenza di due soli grandi partiti politici, che si potrebbero in realtà facilmente ridurre a uno solo (cfr con la Francia non solo del dopoguerra, quando la moltiplicazione dei partiti è diventata fenomeno generale) e all’opposto la moltiplicazione illimitata delle sette religiose (mi pare ne siano state catalogate più di 200; cfr con la Francia e con le lotte accanite sostenute per mantenere l’unità religiosa e morale del popolo francese).
Una manifestazione interessante è ancora da studiare negli Stati Uniti ed è il formarsi di un numero sorprendente di intellettuali negri, che assorbono la cultura e la tecnica americana. Si può pensare all’influsso indiretto che questi intellettuali negri possono esercitare sulle masse arretrate dell’Africa e a quello diretto se si verificasse una di queste ipotesi: 1) che l’espansionismo americano si serva come di suoi agenti dei negri nazionali per conquistare i mercati africani e estendervi il proprio tipo di civiltà (qualcosa di simile è già avvenuto, ma ignoro in qual misura); 2) che le lotte per l’unificazione del popolo americano si inaspriscano in tal misura da determinare l’esodo dei negri e il ritorno in Africa degli elementi intellettuali più indipendenti ed energici e quindi meno propensi ad assoggettarsi a una possibile legislazione ancora più umiliante del costume attualmente diffuso. Nascerebbero due quistioni fondamentali: 1) della lingua, cioè l’inglese potrebbe diventare la lingua colta dell’Africa, unificatrice dell’esistente pulviscolo di dialetti? 2) se questo strato intellettuale possa avere la capacità assimilatrice e organizzatrice in tal misura da far diventare «nazionale» l’attuale primitivo sentimento di razza disprezzata, innalzando il continente africano al mito e alla funzione di patria comune di tutti i negri. Mi pare che, per ora, i negri d’America debbano avere uno spirito di razza e nazionale più negativo che positivo, suscitato cioè dalla lotta che i bianchi conducono per isolarli e deprimerli: ma non è stato questo il caso degli ebrei fino a tutto il 1700? La Liberia già americanizzata e con lingua ufficiale inglese potrebbe diventare la Sion dei negri americani, con la tendenza a porsi come il Piemonte africano.
Nell’America meridionale e centrale la quistione degli intellettuali mi pare sia da esaminare tenendo conto di queste condizioni fondamentali: anche nell’America meridionale e centrale non esiste una vasta categoria di intellettuali tradizionali, ma la cosa non si presenta negli stessi termini degli Stati Uniti. Troviamo infatti alla base dello sviluppo di questi paesi i quadri della civiltà spagnola e portoghese del 500 e del 600, caratterizzata dalla Controriforma e dal militarismo parassitario. Le cristallizzazioni resistenti ancora oggi in questi paesi sono il clero e una casta militare, due categorie di intellettuali tradizionali fossilizzate nella forma della madre patria europea. La base industriale è molto ristretta e non ha sviluppato soprastrutture complicate: la maggior quantità di intellettuali è di tipo rurale e poiché domina il latifondo, con estese proprietà ecclesiastiche, questi intellettuali sono legati al clero e ai grandi proprietari. La composizione nazionale è molto squilibrata anche fra i bianchi, ma si complica per le masse voli di indii che in alcuni paesi sono la maggioranza della popolazione. Si può dire in generale che in queste regioni america ne esiste ancora una situazione da Kulturkampf e da processo Dreyfus, cioè una situazione in cui l’elemento laico e borghese non ha ancora raggiunto la fase della subordinazione alla politica laica dello Stato moderno degli interessi e dell’influenza clericale e militaresca. Avviene così che per opposizione algesuitismo abbia ancora molta influenza la Massoneria e il tipo di organizzazione culturale come la «Chiesa positivista». Gli avvenimenti di questi ultimi tempi (novembre 1930), dal Kulturkampf di Calles nel Messico alle insurrezioni militari‑popolari in Argentina, nel Brasile, nel Perù, nel Cile, in Bolivia, dimostrano appunto la esattezza di queste osservazioni.
Altri tipi di formazione delle categorie intellettuali e dei loro rapporti con le forze nazionali si possono trovare in India, in Cina, nel Giappone. Nel Giappone abbiamo una formazione del tipo inglese e tedesco, cioè di una civiltà industriale che si sviluppa entro un involucro feudale‑burocratico con caratteri propri inconfondibili.
In Cina c’è il fenomeno della scrittura, espressione della completa separazione degli intellettuali dal popolo. In India e in Cina l’enorme distanza tra gli intellettuali e il popolo si manifesta poi nel campo religioso. Il problema delle diverse credenze e del modo diverso di concepire e praticare la stessa religione tra i diversi strati della società ma specialmente tra clero e intellettuali e popolo dovrebbe essere studiato in generale, perché si manifesta da per tutto in una certa misura, sebbene nei paesi dell’Asia orientale abbia le manifestazioni più estreme. Nei paesi protestanti la differenza è relativamente piccola (la moltiplicazione delle sette è legata all’esigenza di una sutura completa tra intellettuali e popolo, ciò che riproduce nella sfera dell’organizzazione superiore tutte le scabrosità della concezione reale delle masse popolari). È molto notevole nei paesi cattolici, ma con gradi diversi: meno grande nella Germania cattolica e in Francia, più grande in Italia, specialmente nel Mezzogiorno e nelle Isole; grandissima nella penisola iberica e nei paesi dell’America latina. Il fenomeno aumenta di portata nei paesi ortodossi ove bisogna parlare di tre gradi della stessa religione: quello dell’alto clero e dei monaci, quello del clero secolare e quello del popolo. Diventa assurdo nell’Asia orientale, dove la religione del popolo spesso non ha nulla a che fare con quella dei libri, sebbene alle due si dia lo stesso nome.
Aspetti diversi della quistione degli intellettuali, oltre quelli sopra accennati. Occorre farne un prospetto organico, sistematico e ragionato. Registro delle attività di carattere prevalentemente intellettuale. Istituzioni legate all’attività culturale. Metodo e problemi di metodo del lavoro intellettuale e culturale, sia creativo che divulgativo. Scuola, accademia, circoli di diverso tipo come istituzioni di elaborazione collegiale della vita culturale. Riviste e giornali come mezzi per organizzare e diffondere determinati tipi di cultura.
Si può osservare in generale che nella civiltà moderna tutte le attività pratiche sono diventate così complesse e le scienze si sono talmente intrecciate alla vita che ogni attività pratica tende a creare una scuola per i propri dirigenti e specialisti e quindi a creare un gruppo di intellettuali specialisti di grado più elevato, che insegnino in queste scuole. Così accanto al tipo di scuola che si potrebbe chiamare «umanistica», ed è quello tradizionale più antico, e che era rivolta a sviluppare in ogni individuo umano la cultura generale ancora indifferenziata, la potenza fondamentale di pensare e di sapersi dirigere nella vita, si è andato creando tutto un sistema di scuole particolari di vario grado, per intere branche professionali o per professioni già specializzate e indicate con precisa individuazione.
Si può anzi dire che la crisi scolastica che oggi imperversa è appunto legata al fatto che questo processo di differenziazione e particolarizzazione avviene caoticamente, senza principii chiari e precisi, senza un piano bene studiato e consapevolmente fissato: la crisi del programma e dell’organizzazione scolastica, cioè dell’indirizzo generale di una politica di formazione dei moderni quadri intellettuali, è in gran parte un aspetto e una complicazione della crisi organica più comprensiva e generale. La divisione fondamentale della scuola in classica e professionale era uno schema razionale: la scuola professionale per le classi strumentali, quella classica per le classi dominanti e per gli intellettuali. Lo sviluppo della base industriale sia in città che in campagna aveva un crescente bisogno del nuovo tipo di intellettuale urbano: si sviluppò accanto alla scuola classica quella tecnica (professionale ma non manuale), ciò che mise in discussione il principio stesso dell’indirizzo concreto di cultura generale, dell’indirizzo umanistico della cultura generale fondata sulla tradizione greco‑romana. Questo indirizzo, una volta messo in discussione, può dirsi spacciato, perché la sua capacità formativa era in gran parte basata sul prestigio generale e tradizionalmente indiscusso, di una determinata forma di civiltà.
Oggi la tendenza è di abolire ogni tipo di scuola «disinteressata» (non immediatamente interessata) e «formativa» o di lasciarne solo un esemplare ridotto per una piccola élite di signori e di donne che non devono pensare a prepararsi un avvenire professionale e di diffondere sempre più le scuole professionali specializzate in cui il destino dell’allievo e la sua futura attività sono predeterminate. La crisi avrà una soluzione che razionalmente dovrebbe seguire questa linea: scuola unica iniziale di cultura generale, umanistica, formativa, che contemperi giustamente lo sviluppo della capacità di lavorare manualmente (tecnicamente, industrialmente) e lo sviluppo delle capacità del lavoro intellettuale. Da questo tipo di scuola unica, attraverso esperienze ripetute di orientamento professionale, si passerà a una delle scuole specializzate o al lavoro produttivo.
È da tener presente la tendenza in isviluppo per cui ogni attività pratica tende a crearsi una sua scuola specializzata, così come ogni attività intellettuale tende a crearsi propri circoli di cultura, che assumono la funzione di istituzioni postscolastiche specializzate nell’organizzare le condizioni in cui sia possibile tenersi al corrente dei progressi che si verificano nel proprio ramo scientifico. Si può anche osservare che sempre più gli organi deliberanti tendono a distinguere la loro attività in due aspetti «organici», quella deliberativa che è loro essenziale e quella tecnico‑culturale per cui le quistioni su cui occorre prendere risoluzioni sono prima esaminate da esperti ed analizzate scientificamente. Questa attività ha creato già tutto un corpo burocratico di una nuova struttura, poiché oltre agli uffici specializzati di competenti che preparano il materiale tecnico per i corpi deliberanti, si crea un secondo corpo di funzionati, più o meno «volontari» e disinteressati, scelti volta a volta nell’industria, nella banca, nella finanza. È questo uno dei meccanismi attraverso cui la burocrazia di carriera aveva finito col controllare i regimi democratici e i parlamenti; ora il meccanismo si va estendendo organicamente ed assorbe nel suo circolo i grandi specialisti dell’attività pratica privata, che così controlla e regimi e burocrazia.
Poiché si tratta di uno sviluppo organico necessario che tende a integrare il personale specializzato nella tecnica politica con personale specializzato nelle quistioni concrete di amministrazione delle attività pratiche essenziali delle grandi e complesse società nazionali moderne, ogni tentativo di esorcizzare queste tendenze dall’esterno, non produce altro risultato che prediche moralistiche e gemiti retorici. Si pone la quistione di modificare la preparazione del personale tecnico politico, integrando la sua cultura secondo le nuove necessità e di elaborare nuovi tipi di funzionari specializzati che collegialmente integrino l’attività deliberante.
Il tipo tradizionale del «dirigente» politico, preparato solo per le attività giuridico‑formali, diventa anacronistico e rappresenta un pericolo per la vita statale: il dirigente deve avere quel minimo di coltura generale tecnica che gli permetta, se non di «creare» autonomamente la soluzione giusta, di saper giudicare tra le soluzioni prospettate dagli esperti e scegliere quindi quella giusta dal punto di vista «sintetico» della tecnica politica. Un tipo di collegio deliberante che cerca di incorporarsi la competenza tecnica necessaria per operare realisticamente è stato descritto in altro luogo, dove si parla di ciò che avviene in certe redazioni di riviste, che funzionano nello stesso tempo come redazioni e come circoli di coltura. Il circolo critica collegialmente e contribuisce così ad elaborare i lavori dei singoli redattori, la cui operosità è organizzata secondo un piano e una divisione del lavoro razionalmente predisposta. Attraverso la discussione e la critica collegiale (fatta di suggerimenti, consigli, indicazioni metodiche, critica costruttiva e rivolta alla educazione reciproca) per cui ognuno funziona da specialista nella sua materia per integrare la competenza collettiva, in realtà si riesce ad elevare il livello medio dei singoli redattori, a raggiungere l’altezza o la capacità del più preparato, assicurando alla rivista una collaborazione sempre più scelta ed organica, non solo, ma creando le condizioni per il sorgere di un gruppo omogeneo di intellettuali preparato a produrre una regolare e metodica attività «libraria» (non solo di pubblicazioni d’occasione e di saggi parziali, ma di lavori organici di insieme). Indubbiamente, in questa specie di attività collettive, ogni lavoro produce nuove capacità e possibilità di lavoro, poiché crea sempre più organiche condizioni di lavoro: schedari, spogli bibliografici, raccolta di opere fondamentali specializzate ecc.
Si domanda una lotta rigorosa contro le abitudini al dilettantismo, all’improvvisazione, alle soluzioni «oratorie» e declamatorie. Il lavoro deve essere fatto specialmente per iscritto, così come per iscritto devono essere le critiche, in stringate e succinte, ciò che si può ottenere distribuendo a tempo il materiale ecc.; lo scrivere le e le critiche è principio didattico reso necessario dal bisogno di combattere le abitudini alla prolissità, alla declamazione e al paralogismo create dall’oratoria. Questo tipo di lavoro intellettuale è necessario per fare acquistare agli autodidatti la disciplina degli studi che procura una carriera scolastica regolare, per taylorizzare il lavoro intellettuale. Così è utile il principio degli «anziani di Santa Zita» di cui parla il De Sanctis nei suoi ricordi sulla scuola napoletana di Basilio Puoti: cioè è utile una certa «stratificazione» delle capacità ed attitudini e la formazione di gruppi di lavoro sotto la guida dei più esperti e sviluppati, che accelerino la preparazione dei più arretrati e grezzi.
Un punto importante nello studio dell’organizzazione pratica della scuola unitaria è quello riguardante la carriera scolastica nei suoi vari gradi conformi all’età e allo sviluppo intellettuale‑morale degli allievi e ai fini che la scuola stessa vuole raggiungere. La scuola unitaria o di formazione umanistica (inteso questo termine di umanismo in senso largo e non solo nel senso tradizionale) o di cultura generale, dovrebbe proporsi di immettere nell’attività sociale i giovani dopo averli portati a un certo grado di maturità e capacità alla creazione intellettuale e pratica e di autonomia nell’orientamento e nell’iniziativa. La fissazione dell’età scolastica obbligatoria dipende dalle condizioni economiche generali, poiché queste possono costringere a domandare ai giovani e ai ragazzi un certo apporto produttivo immediato.
La scuola unitaria domanda che lo Stato possa assumersi le spese che oggi sono a carico della famiglia per il mantenimento degli scolari, cioè trasforma il bilancio del dicastero dell’educazione nazionale da cima a fondo, estendendolo in modo inaudito e complicandolo: la intera funzione dell’educazione e formazione delle nuove generazioni diventa da privata, pubblica, poiché solo così essa può coinvolgere tutte le generazioni senza divisioni di gruppi o caste. Ma questa trasformazione dell’attività scolastica domanda un allargamento inaudito dell’organizzazione pratica della scuola, cioè degli edifizi, del materiale scientifico, del corpo insegnante ecc. Il corpo insegnante specialmente dovrebbe essere aumentato, perché la efficenza della scuola è tanto maggiore e intensa quanto più piccolo è il rapporto tra maestro e allievi, ciò che prospetta altri problemi non di facile e rapida soluzione. Anche la quistione degli edifizi non è semplice, perché questo tipo di scuola dovrebbe essere una scuola‑collegio, con dormitori, refettori, biblioteche specializzate, sale adatte per il lavoro di seminario ecc. Perciò inizialmente il nuovo tipo di scuola dovrà e non potrà non essere che propria di gruppi ristretti, di giovani scelti per concorso o indicati sotto la loro responsabilità da istituzioni idonee.
La scuola unitaria dovrebbe corrispondere al periodo rappresentato oggi dalle elementari e dalle medie, riorganizzate non solo per il contenuto e il metodo di insegnamento, ma anche per la disposizione dei vari gradi della carriera scolastica. Il primo grado elementare non dovrebbe essere di più che 3‑4 anni e accanto all’insegnamento delle prime nozioni «strumentali» dell’istruzione – leggere, scrivere, far di conto, geografia, storia – dovrebbe specialmente svolgere la parte che oggi è trascurata dei «diritti e doveri», cioè le prime nozioni dello Stato e della società, come elementi primordiali di una nuova concezione del mondo che entra in lotta contro le concezioni date dai diversi ambienti sociali tradizionali, cioè le concezioni che si possono chiamare folcloristiche.
Il problema didattico da risolvere è quello di temperare e fecondare l’indirizzo dogmatico che non può non essere proprio di questi primi anni. Il resto del corso non dovrebbe durare più di sei anni, in modo che a 15‑16 anni si dovrebbe poter compiere tutti i gradi della scuola unitaria. Si può obbiettare che un tale corso è troppo faticoso per la sua rapidità, se si vogliono raggiungere effettivamente i risultati che l’attuale organizzazione della scuola classica si propone ma non raggiunge. Si può dire però che il complesso della nuova organizzazione dovrà contenere in se stessa gli elementi generali per cui oggi, per una parte degli allievi almeno, il corso è invece troppo lento. Quali sono questi elementi?
In una serie di famiglie, specialmente dei ceti intellettuali, i ragazzi trovano nella vita famigliare una preparazione, un prolungamento e un’integrazione della vita scolastica, assorbono, come si dice, dall’«aria» tutta una quantità di nozioni e di attitudini che facilitano la carriera scolastica propriamente detta: essi conoscono già e sviluppano la conoscenza della lingua letteraria, cioè il mezzo di espressione e di conoscenza, tecnicamente superiore ai mezzi posseduti dalla media della popolazione scolastica dai 6 ai 12 anni. Così gli allievi della città, per il solo fatto di vivere in città, hanno assorbito già prima dei 6 anni una quantità di nozioni e di attitudini che rendono più facile, più proficua e più rapida la carriera scolastica. Nell’organizzazione intima della scuola unitaria devono essere create almeno le principali di queste condizioni, oltre al fatto, che è da supporre, che parallelamente alla scuola unitaria si sviluppi una rete di asili d’infanzia e altre istituzioni in cui, anche prima dell’età scolastica, i bambini siano abituati a una certa disciplina collettiva ed acquistino nozioni e attitudini prescolastiche. Infatti, la scuola unitaria dovrebbe essere organizzata come collegio, con vita collettiva diurna e notturna, liberata dalle attuali forme di disciplina ipocrita e meccanica, e lo studio dovrebbe essere fatto collettivamente, con l’assistenza dei maestri e dei migliori allievi, anche nelle ore di applicazione così detta individuale ecc.
Il problema fondamentale si pone per quella fase dell’attuale carriera scolastica che oggi è rappresentata dal liceo e che oggi non si differenzia per nulla, come tipo d’insegnamento, dalle classi precedenti, altro che per la supposizione astratta di una maggiore maturità intellettuale e morale dell’allievo conforme all’età maggiore e all’esperienza precedentemente accumulata. Di fatto tra liceo e università e cioè tra la scuola vera e propria e la vita c’è un salto, una vera soluzione di continuità, non un passaggio razionale dalla quantità (età) alla qualità (maturità intellettuale e morale). Dall’insegnamento quasi puramente dogmatico, in cui la memoria ha una grande parte, si passa alla fase creativa o di lavoro autonomo e indipendente; dalla scuola con disciplina dello studio imposta e controllata autoritativamente si passa a una fase di studio o di lavoro professionale in cui l’autodisciplina intellettuale e l’autonomia morale è teoricamente illimitata. E ciò avviene subito dopo la crisi della pubertà, quando la foga delle passioni istintive ed elementari non ha ancora finito di lottare coi freni del carattere e della coscienza morale in formazione. In Italia poi, dove nelle Università non è diffuso il principio del lavoro di «seminario», il passaggio è ancora più brusco e meccanico.
Ecco dunque che nella scuola unitaria la fase ultima deve essere concepita e organata come la fase decisiva in cui si tende a creare i valori fondamentali dell’«umanesimo», l’autodisciplina intellettuale e l’autonomia morale necessarie per l’ulteriore specializzazione sia essa di carattere scientifico (studi universitari) sia di carattere immediatamente pratico‑produttivo (industria, burocrazia, organizzazione degli scambi, ecc.). Lo studio e l’apprendimento dei metodi creativi nella scienza e nella vita deve cominciare in questa ultima fase della scuola e non essere più un monopolio dell’Università o essere lasciato al caso della vita pratica: questa fase scolastica deve già contribuire a sviluppare l’elemento della responsabilità autonoma negli individui, essere una scuola creativa (occorre distinguere tra scuola creativa e scuola attiva, anche nella forma data dal metodo Dalton.
Tutta la scuola unitaria è scuola attiva, sebbene occorra porre dei limiti alle ideologie libertarie in questo campo e rivendicare con una certa energia il dovere delle generazioni adulte, cioè dello Stato, di «conformare» le nuove generazioni. Si è ancora nella fase romantica della scuola attiva, in cui gli elementi della lotta contro la scuola meccanica e gesuitica si sono dilatati morbosamente per ragioni di contrasto e di polemica: occorre entrare nella fase «classica», razionale, trovare nei fini da raggiungere la sorgente naturale per elaborare i metodi e le forme. La scuola creativa è il coronamento della scuola attiva: nella prima fase si tende a disciplinare, quindi anche a livellare, a ottenere una certa specie di «conformismo» che si può chiamare «dinamico»; nella fase creativa, sul fondamento raggiunto di «collettivizzazione» del tipo sociale, si tende a espandere la personalità, divenuta autonoma e responsabile, ma con una coscienza morale e sociale solida e omogenea.
Così scuola creativa non significa scuola di «inventori e scopritori»; si indica una fase e un metodo di ricerca e di conoscenza, e non un «programma» predeterminato con l’obbligo dell’originalità e dell’innovazione a tutti i costi. Indica che l’apprendimento avviene specialmente per uno sforzo spontaneo e autonomo del discente, e in cui il maestro esercita solo una funzione di guida amichevole come avviene o dovrebbe avvenire nell’Università. Scoprire da se stessi, senza suggerimenti e aiuti esterni, una verità è creazione, anche se la verità è vecchia, e dimostra il possesso del metodo; indica che in ogni modo si è entrati nella fase di maturità intellettuale in cui si possono scoprire verità nuove. Perciò in questa fase l’attività scolastica fondamentale si svolgerà nei seminari, nelle biblioteche, nei laboratori sperimentali; in essa si raccoglieranno le indicazioni organiche per l’orientamento professionale).
L’avvento della scuola unitaria significa l’inizio di nuovi rapporti tra lavoro intellettuale e lavoro industriale non solo nella scuola, ma in tutta la vita sociale. Il principio unitario si rifletterà perciò in tutti gli organismi di cultura, trasformandoli e dando loro un nuovo contenuto. Problema della nuova funzione che potranno assumere le Università e le Accademie. Oggi queste due istituzioni sono indipendenti l’una dall’altra e le Accademie sono il simbolo, spesso a ragione deriso, del distacco esistente tra l’alta cultura e la vita, tra gli intellettuali e il popolo (perciò quella certa fortuna che ebbero i futuristi nel loro primo periodo di Sturm und Drang antiaccademico, antitradizionalista ecc.).
In una nuova situazione di rapporti tra vita e cultura, tra lavoro intellettuale e lavoro industriale, le accademie dovrebbero diventare l’organizzazione culturale (di sistemazione, espansione e creazione intellettuale) di quegli elementi che dopo la scuola unitaria passeranno al lavoro professionale, e un terreno d’incontro tra essi e gli universitari. Gli elementi sociali impiegati nel lavoro professionale non devono cadere nella passività intellettuale, ma devono avere a loro disposizione (per iniziativa collettiva e non di singoli, come funzione sociale organica riconosciuta di pubblica necessità ed utilità) istituti specializzati in tutte le branche di ricerca e di lavoro scientifico, ai quali potranno collaborare e in cui troveranno tutti i sussidi necessari per ogni forma di attività culturale che intendano intraprendere. L’organizzazione accademica (dovrà essere) riorganizzata e vivificata da cima a fondo. Territorialmente avrà una centralizzazione di competenze e di specializzazione: centri nazionali che si aggregheranno le grandi istituzioni esistenti, sezioni regionali e provinciali e circoli locali urbani e rurali. Si sezionerà per competenze scientifico‑culturali, che saranno tutte rappresentate nei centri superiori ma solo parzialmente nei circoli locali.
Unificare i vari tipi di organizzazione culturale esistenti: Accademie, Istituti di cultura, circoli filologici ecc., integrando il lavoro accademico tradizionale, che si esplica prevalentemente nella sistemazione del sapere passato o nel cercare di fissare una media del pensiero nazionale come guida dell’attività intellettuale, con attività collegate alla vita collettiva, al mondo della produzione e del lavoro. Si controlleranno le conferenze industriali, l’attività dell’organizzazione scientifica del lavoro, i gabinetti sperimentali di fabbrica ecc. Si costruirà un meccanismo per selezionare e fare avanzare le capacità individuali della massa popolare, che oggi sono sacrificate e si smarriscono in errori e tentativi senza uscita. Ogni circolo locale dovrebbe avere necessariamente la sezione di scienze morali e politiche, e mano a mano organizzerà le altre sezioni speciali per discutere gli aspetti tecnici dei problemi industriali, agrari, di organizzazione e razionalizzazione del lavoro, di fabbrica, agricolo, burocratico ecc. Congressi periodici di diverso grado faranno conoscere i più capaci.
Sarebbe utile avere l’elenco completo delle Accademie e delle altre organizzazioni culturali oggi esistenti e degli argomenti che sono prevalentemente trattati nei loro lavori e pubblicati nei loro Atti: in gran parte si tratta di cimiteri della cultura, pure esse hanno una funzione nella psicologia della classe dirigente.
La collaborazione tra questi organismi e le Università dovrebbe essere stretta, così come con tutte le scuole superiori specializzate di ogni genere (militari, navali, ecc.). Lo scopo è di ottenere una centralizzazione e un impulso della cultura nazionale che sarebbero superiori a quelli della Chiesa Cattolica.
(Questo schema di organizzazione del lavoro culturale secondo i principi generali della scuola unitaria, dovrebbe essere sviluppato in tutte le sue parti accuratamente e servire di guida nella costituzione anche del più elementare e primitivo centro di cultura, che dovrebbe essere concepito come un embrione e una molecola di tutta la più massiccia struttura. Anche le iniziative che si sanno transitorie e di esperimento dovrebbero essere concepite come capaci di essere assorbite nello schema generale e nello stesso tempo come elementi vitali che tendono a creare tutto lo schema. Studiare con attenzione l’organizzazione e lo sviluppo del Rotary Club).
Q12 §2 Osservazioni sulla scuola: per la ricerca del principio educativo. La frattura determinata dalla riforma Gentile tra la scuola elementare e media da una parte e quella superiore dall’altra. Prima della riforma una frattura simile esisteva solo in modo molto marcato tra la scuola professionale da una parte e le scuole medie e superiori dall’altra: la scuola elementare era posta in una specie di limbo, per alcuni suoi caratteri particolari.
Nelle scuole elementari due elementi si prestavano all’educazione e alla formazione dei bambini: le prime nozioni di scienze naturali e le nozioni di diritti e doveri del cittadino. Le nozioni scientifiche dovevano servire a introdurre il bambino nella «societas rerum», i diritti e doveri nella vita statale e nella società civile. Le nozioni scientifiche entravano in lotta con la concezione magica del mondo e della natura che il bambino assorbe dall’ambiente impregnato di folclore, come le nozioni di diritti e doveri entrano in lotta con le tendenze alla barbarie individualistica e localistica, che è anch’essa un aspetto del folclore.
La scuola col suo insegnamento lotta contro il folclore, con tutte le sedimentazioni tradizionali di concezioni del mondo per diffondere una concezione più moderna, i cui elementi primitivi e fondamentali sono dati dall’apprendimento dell’esistenza delle leggi della natura come qualcosa di oggettivo e di ribelle a cui occorre adattarsi per dominarle, e delle leggi civili e statali che sono un prodotto di un’attività umana, che sono stabilite dall’uomo e possono essere dall’uomo mutate per i fini del suo sviluppo collettivo; la legge civile e statale ordina gli uomini nel modo storicamente più conforme a dominare le leggi della natura, cioè a facilitare il loro lavoro, che è il modo proprio dell’uomo di partecipare attivamente alla vita della natura per trasformarla e socializzarla sempre più profondamente ed estesamente.
Si può dire perciò che il principio educativo che fondava le scuole elementari era il concetto di lavoro, che non può realizzarsi in tutta la sua potenza di espansione e di produttività senza una conoscenza esatta e realistica delle leggi naturali e senza un ordine legale che regoli organicamente la vita degli uomini tra di loro, ordine che deve essere rispettato per convinzione spontanea e non solo per imposizione esterna, per necessità riconosciuta e proposta a se stessi come libertà e non per mera coercizione. Il concetto e il fatto del lavoro (dell’attività teorico‑pratica) è il principio educativo immanente nella scuola elementare, poiché l’ordine sociale e statale (diritti e doveri) è dal lavoro introdotto e identificato nell’ordine naturale. Il concetto dell’equilibrio tra ordine sociale e ordine naturale sul fondamento del lavoro, dell’attività teorico‑pratica dell’uomo, crea i primi elementi di una intuizione del mondo, liberata da ogni magia e stregoneria, e dà l’appiglio allo sviluppo ulteriore di una concezione storica, dialettica, del mondo, a comprendere il movimento e il divenire, a valutare la somma di sforzi e di sacrifizi che è costato il presente al passato e che l’avvenire costa al presente, a concepire l’attualità come sintesi del passato, di tutte le generazioni passate, che si proietta nel futuro. Questo è il fondamento della scuola elementare; che esso abbia dato tutti i suoi frutti, che nel corpo dei maestri ci sia stata la consapevolezza del loro compito e del contenuto filosofico del loro compito, è altra quistione, connessa alla critica del grado di coscienza civile di tutta la nazione, di cui il corpo magistrale era solo un’espressione, immeschinita ancora, e non certo un’avanguardia.
Non è completamente esatto che l’istruzione non sia anche educazione: l’aver insistito troppo in questa distinzione è stato grave errore della pedagogia idealistica e se ne vedono già gli effetti nella scuola riorganizzata da questa pedagogia. Perché l’istruzione non fosse anche educazione bisognerebbe che il discente fosse una mera passività, un «meccanico recipiente» di nozioni astratte, ciò che è assurdo e del resto viene «astrattamente» negato dai sostenitori della pura educatività appunto contro la mera istruzione meccanicistica. Il «certo» diventa «vero» nella coscienza del fanciullo.
Ma la coscienza del fanciullo non è alcunché di «individuale» (e tanto meno di individuato), è il riflesso della frazione di società civile cui il fanciullo partecipa, dei rapporti sociali quali si annodano nella famiglia, nel vicinato, nel villaggio ecc. La coscienza individuale della stragrande maggioranza dei fanciulli riflette rapporti civili e culturali diversi e antagonistici con quelli che sono rappresentati dai programmi scolastici: il «certo» di una cultura progredita, diventa «vero» nei quadri di una cultura fossilizzata e anacronistica, non c’è unità tra scuola e vita, e perciò non c’è unità tra istruzione e educazione.
Perciò si può dire che nella scuola il nesso istruzione‑educazione può solo essere rappresentato dal lavoro vivente del maestro, in quanto il maestro è consapevole dei contrasti tra il tipo di società e di cultura che egli rappresenta e il tipo di società e di cultura rappresentato dagli allievi ed è consapevole del suo compito che consiste nell’accelerare e nel disciplinare la formazione del fanciullo conforme al tipo superiore in lotta col tipo inferiore. Se il corpo magistrale è deficiente e il nesso istruzione‑educazione viene sciolto per risolvere la quistione dell’insegnamento secondo schemi cartacei in cui l’educatività è esaltata, l’opera del maestro risulterà ancor più deficiente: si avrà una scuola retorica, senza serietà, perché mancherà la corposità materiale del certo, e il vero sarà vero di parole, appunto retorica.
La degenerazione si vede ancor meglio nella scuola media, per i corsi di letteratura e filosofia. Prima gli allievi, per lo meno, si formavano un certo «bagaglio» o «corredo» (secondo i gusti) di nozioni concrete: ora che il maestro deve essere specialmente un filosofo e un esteta, l’allievo trascura le nozioni concrete e si «riempie la testa» di formule e parole che per lui non hanno senso, il più delle volte, e che vengono subito dimenticate. La lotta contro la vecchia scuola era giusta, ma la riforma non era cosa così semplice come pareva, non si trattava di schemi programmatici, ma di uomini, e non degli uomini che immediatamente sono maestri, ma di tutto il complesso sociale di cui gli uomini sono espressione. In realtà un mediocre insegnante può riuscire a ottenere che gli allievi diventino più istruiti, non riuscirà ad ottenere che siano più colti; egli svolgerà con scrupolo e coscienza burocratica la parte meccanica della scuola e l’allievo, se è un cervello attivo, ordinerà per conto suo, e con l’aiuto del suo ambiente sociale, il «bagaglio» accumulato. Coi nuovi programmi, che coincidono con un abbassamento generale del livello del corpo insegnante, non vi sarà «bagaglio» del tutto da ordinare. I nuovi programmi avrebbero dovuto abolire completamente gli esami; dare un esame, ora, dev’essere terribilmente più «gioco d’azzardo» d’una volta. Una data è sempre una data, qualsiasi professore esamini, e una «definizione» è sempre una definizione; ma un giudizio, un’analisi estetica o filosofica?
L’efficacia educativa della vecchia scuola media italiana, quale l’aveva organizzata la vecchia legge Casati, non era da ricercare (o da negare) nella volontà espressa di essere o no scuola educativa, ma nel fatto che il suo organamento e i suoi programmi erano l’espressione di un modo tradizionale di vita intellettuale e morale, di un clima culturale diffuso in tutta la società italiana per antichissima tradizione. Che un tale clima e un tal modo di vivere siano entrati in agonia e che la scuola si sia staccata dalla vita, ha determinato la crisi della scuola. Criticare i programmi e l’organamento disciplinare della scuola, vuol dire meno che niente, se non si tiene conto di tali condizioni. Così si ritorna alla partecipazione realmente attiva dell’allievo alla scuola, che può esistere solo se la scuola è legata alla vita. I nuovi programmi, quanto più affermano e teorizzano l’attività del discente, e la sua collaborazione operosa col lavoro del docente, e tanto più sono disposti come se il discente fosse una mera passività.
Nella vecchia scuola lo studio grammaticale delle lingue latina e greca, unito allo studio delle letterature e storie politiche rispettive, era un principio educativo in quanto l’ideale umanistico, che si impersona in Atene e Roma, era diffuso in tutta la società, era un elemento essenziale della vita e della cultura nazionale. Anche la meccanicità dello studio grammaticale era avviata dalla prospettiva culturale. Le singole nozioni non venivano apprese per uno scopo immediato pratico‑professionale: esso appariva disinteressato, perché l’interesse era lo sviluppo interiore della personalità, la formazione del carattere attraverso l’assorbimento e l’assimilazione di tutto il passato culturale della moderna civiltà europea. Non si imparava il latino e il greco per parlarli, per fare i camerieri, gli interpreti, i corrispondenti commerciali. Si imparava per conoscere direttamente la civiltà dei due popoli, presupposto necessario della civiltà moderna, cioè per essere se stessi e conoscere se stessi consapevolmente. La lingua latina e greca si imparava secondo grammatica, meccanicamente; ma c’è molta ingiustizia e improprietà nell’accusa di meccanicità e di aridità. Si ha che fare con ragazzetti, ai quali occorre far contrarre certe abitudini di diligenza, di esattezza, di compostezza anche fisica, di concentrazione psichica su determinati soggetti che non si possono acquistare senza una ripetizione meccanica di atti disciplinati e metodici.
Uno studioso di quarant’anni sarebbe capace di stare a tavolino sedici ore di seguito, se da bambino non avesse coattivamente, per coercizione meccanica, assunto le abitudini psicofisiche appropriate? Se si vuole selezionare dei grandi scienziati, occorre ancora incominciare da quel punto e occorre premere su tutta l’area scolastica per riuscire a far emergere quelle migliaia o centinaia o anche solo dozzine di studiosi di gran nerbo, di cui ogni civiltà ha bisogno (se pure si può molto migliorare in questo campo, con l’aiuto dei sussidi scientifici adeguati, senza tornare ai metodi scolastici dei gesuiti).
Si impara il latino (o meglio, si studia il latino), lo si analizza fin nei suoi membretti più elementari, si analizza come una cosa morta, è vero, ma ogni analisi fatta da un fanciullo non può essere che su cose morte; d’altronde non bisogna dimenticare che dove questo studio avviene, in queste forme, la vita dei Romani è un mito che in una certa misura ha già interessato il fanciullo e lo interessa, sicché nel morto è sempre presente un più grande vivente. Eppoi: la lingua è morta, è analizzata come una cosa inerte, come un cadavere sul tavolo anatomico, ma rivive continuamente negli esempi, nelle narrazioni. Si potrebbe fare lo stesso studio con l’italiano? Impossibile: nessuna lingua viva potrebbe essere studiata come il latino: sarebbe e sembrerebbe assurdo. Nessuno dei fanciulli conosce il latino quando ne inizia lo studio con quel tal metodo analitico. Una lingua viva potrebbe esser conosciuta e basterebbe che un solo fanciullo la conoscesse, per rompere l’incanto: tutti andrebbero alla scuola Berlitz, immediatamente.
Il latino si presenta (così come il greco) alla fantasia come un mito, anche per l’insegnante. Il latino non si studia per imparare il latino; il latino, da molto tempo, per una tradizione culturale‑scolastica di cui si potrebbe ricercare l’origine e lo sviluppo, si studia come elemento di un ideale programma scolastico, elemento che riassume e soddisfa tutta una serie di esigenze pedagogiche e psicologiche; si studia per abituare i fanciulli a studiare in un determinato modo, ad analizzare un corpo storico che si può trattare come un cadavere che continuamente si ricompone in vita, per abituarli a ragionare, ad astrarre schematicamente pur essendo capaci dall’astrazione a ricalarsi nella vita reale immediata, per vedere in ogni fatto o dato ciò che ha di generale e ciò che di particolare, il concetto e l’individuo. E cosa non significa, educativamente, il continuo paragone tra il latino e la lingua che si parla?
La distinzione e l’identificazione delle parole e dei concetti, tutta la logica formale, con le contraddizioni degli opposti e l’analisi dei distinti, col movimento storico dell’insieme linguistico, che si modifica nel tempo, che ha un divenire e non è solo una staticità. Negli otto anni di ginnasio-liceo si studia tutta la lingua storicamente reale, dopo averla vista fotografata in un istante astratto, in forma di grammatica: si studia da Ennio (e anzi dalle parole dei frammenti delle dodici tavole) a Fedro e ai cristiano‑latini: un processo storico è analizzato dal suo sorgere alla sua morte nel tempo, morte apparente, perché si sa che l’italiano, con cui il latino è continuamente confrontato, è latino moderno, Si studia la grammatica di una certa epoca, un’astrazione, il vocabolario di un periodo determinato, ma si studia (per comparazione) la grammatica e il vocabolario di ogni autore determinato, e il significato di ogni termine in ogni «periodo» stilistico determinato: si scopre così che la grammatica e il vocabolario di Fedro non sono quelli di Cicerone, né quelli di Plauto, o di Lattanzio e Tertulliano, che uno stesso nesso di suoni non ha lo stesso significato nei diversi tempi, nei diversi scrittori.
Si paragona continuamente il latino e l’italiano: ma ogni parola è un concetto, una immagine, che assume sfumature diverse nei tempi, nelle persone, in ognuna delle due lingue comparate. Si studia la storia letteraria, dei libri scritti in quella lingua, la storia politica, le gesta degli uomini che hanno parlato quella lingua. Da tutto questo complesso organico è determinata l’educazione del giovinetto, dal fatto che anche solo materialmente ha percorso tutto quell’itinerario, con quelle tappe ecc. Si è tuffato nella storia, ha acquistato una intuizione storicistica del mondo e della vita, che diventa una seconda natura, quasi una spontaneità, perché non pedantescamente inculcata per «volontà» estrinsecamente educativa. Questo studio educava senza averne la volontà espressamente dichiarata, col minimo intervento «educativo» dell’insegnante: educava perché istruiva. Esperienze logiche, artistiche, psicologiche erano fatte senza «rifletterci su», senza guardarsi continuamente allo specchio, ed era fatta specialmente una grande esperienza «sintetica», filosofica, di sviluppo storico‑reale.
Ciò non vuol dire (e sarebbe inetto pensarlo) che il latino e il greco, come tali, abbiano qualità intrinsecamente taumaturgigiche nel campo educativo. È tutta la tradizione culturale, che vive anche e specialmente fuori della scuola, che in un dato ambiente produce tali conseguenze. Si vede, d’altronde, come, mutata la tradizionale intuizione della cultura, la scuola sia entrata in crisi e sia entrato in crisi lo studio del latino e del greco.
Bisognerà sostituire il latino e il greco come fulcro della scuola formativa e lo si sostituirà, ma non sarà agevole disporre la nuova materia o la nuova serie di materie in un ordine didattico che dia risultati equivalenti di educazione e formazione generale della personalità, partendo dal fanciullo fino alla soglia della scelta professionale. In questo periodo infatti lo studio o la parte maggiore dello studio deve essere (o apparire ai discenti) disinteressato, non avere cioè scopi pratici immediati o troppo immediati, deve essere formativo, anche se «istruttivo», cioè ricco di nozioni concrete.
Nella scuola attuale, per la crisi profonda della tradizione culturale e della concezione della vita e dell’uomo, si verifica un processo di progressiva degenerazione: le scuole di tipo professionale, cioè preoccupate di soddisfare interessi pratici immediati, prendono il sopravvento sulla scuola formativa, immediatamente disinteressata. L’aspetto più paradossale è che questo nuovo tipo di scuola appare e viene predicata come democratica, mentre invece essa non solo è destinata a perpetuare le differenze sociali, ma a cristallizzarle in forme cinesi.
La scuola tradizionale è stata oligarchica perché destinata alla nuova generazione dei gruppi dirigenti, destinata a sua volta a diventare dirigente: ma non era oligarchica per il modo del suo insegnamento. Non è l’acquisto di capacità direttive, non è la tendenza a formare uomini superiori che dà l’impronta sociale a un tipo di scuola. L’impronta sociale è data dal fatto che ogni gruppo sociale ha un proprio tipo di scuola, destinato a perpetuare in questi strati una determinata funzione tradizionale, direttiva o strumentale. Se si vuole spezzare questa trama, occorre dunque non moltiplicare e graduare i tipi di scuola professionale, ma creare un tipo unico di scuola preparatoria (elementare‑media) che conduca il giovinetto fino alla soglia della scelta professionale, formandolo nel frattempo come persona capace di pensare, di studiare, di dirigere o di controllare chi dirige.
Il moltiplicarsi di tipi di scuola professionale tende dunque a eternare le differenze tradizionali, ma siccome, in queste differenze, tende a suscitare stratificazioni interne, ecco che fa nascere l’impressione di una sua tendenza democratica. Manovale e operaio qualificato, per esempio; contadino e geometra o piccolo agronomo ecc. Ma la tendenza democratica, intrinsecamente, non può solo significare che un operaio manovale diventa qualificato, ma che ogni «cittadino» può diventare «governante» e che la società lo pone, sia pure «astrattamente», nelle condizioni generali di poterlo diventare; la democrazia politica tende a far coincidere governanti e governati (nel senso del governo col consenso dei governati), assicurando a ogni governato l’apprendimento gratuito della capacità e della preparazione tecnica generale necessarie al fine. Ma il tipo di scuola che si sviluppa come scuola per il popolo non tende neanche più a mantenere l’illusione, poiché essa si organizza sempre più in modo da restringere la base del ceto governante tecnicamente preparato, in un ambiente sociale politico che restringe ancor più l’«iniziativa privata» nel senso di dare questa capacità e preparazione tecnico‑politica, in modo che si ritorna in realtà alle divisioni di «ordini» giuridicamente fissati e cristallizzati più che al superamento delle divisioni in gruppi: il moltiplicarsi delle scuole professionali sempre più specializzate fin dall’inizio della carriera degli studi è una delle manifestazioni più vistose di questa tendenza.
A proposito del dogmatismo e del criticismo‑storicismo nella scuola elementare e media è da osservare che la nuova pedagogia ha voluto battere in breccia il dogmatismo proprio nel campo dell’istruzione, dell’apprendimento delle nozioni concrete, cioè proprio nel campo in cui un certo dogmatismo è praticamente imprescindibile e può venire riassorbito e disciolto solo nel ciclo intero del corso scolastico (non si può insegnare la grammatica storica nelle elementari e nel ginnasio), ma è costretta poi a veder introdotto il dogmatismo per eccellenza nel campo del pensiero religioso e implicitamente a veder descritta tutta la storia della filosofia come un succedersi di follie e di delirii.
Nell’insegnamento della filosofia il nuovo corso pedagogico (almeno per quegli alunni, e sono la stragrande maggioranza, che non ricevono aiuti intellettuali fuori della scuola, in famiglia o nell’ambiente famigliare, e devono formarsi solo con le indicazioni che ricevono in classe) impoverisce l’insegnamento, e ne abbassa il livello, praticamente, nonostante che razionalmente sembri bellissimo, di un bellissimo utopistico. La filosofia descrittiva tradizionale, rafforzata da un corso di storia della filosofia e dalla lettura di un certo numero di filosofi, praticamente sembra la miglior cosa. La filosofia descrittiva e definitrice sarà un’astrazione dogmatica, come la grammatica e la matematica, ma è una necessità pedagogica e didattica. 1 = 1 è un’astrazione, ma nessuno è perciò condotto a pensare che 1 mosca è uguale a 1 elefante. Anche le regole della logica formale sono astrazioni dello stesso genere, sono come la grammatica del pensare normale eppure occorre studiarle, perché non sono qualcosa di innato, ma devono essere acquisite col lavoro e con la riflessione. Il nuovo corso presuppone che la logica formale sia qualcosa che già si possiede quando si pensa, ma non spiega come la si debba acquisire, sì che praticamente è come se la supponesse innata.
La logica formale è come la grammatica: viene assimilata in modo «vivente» anche se l’apprendimento necessariamente sia stato schematico e astratto, poiché il discente non è un disco di grammofono, non è un recipiente passivamente meccanico, anche se la convenzionalità liturgica degli esami così lo fa apparire talvolta. Il rapporto di questi schemi educativi collo spirito infantile è sempre attivo e creativo, come attivo e creativo è il rapporto tra l’operaio e i suoi utensili di lavoro: un calibro è un insieme di astrazioni, anch’esso, eppure non si producono oggetti reali senza la calibratura, oggetti reali che sono rapporti sociali e contengono implicite delle idee. Il fanciullo che si arrabbatta coi barbara, baralipton, si affatica, certo, e bisogna cercare che egli debba fare la fatica indispensabile e non più, ma è anche certo che dovrà sempre faticare per imparare a costringere se stesso a privazioni e limitazioni di movimento fisico, cioè sottostare a un tirocinio psico‑fisico.
Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare‑nervoso: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. La partecipazione di più larghe masse alla scuola media porta con sé la tendenza a rallentare la disciplina dello studio, a domandare «facilitazioni». Molti pensano addirittura che le difficoltà siano artificiose, perché sono abituati a considerare lavoro e fatica solo il lavoro manuale. La quistione è complessa.
Certo il fanciullo di una famiglia tradizionale di intellettuali supera più facilmente il processo di adattamento psico‑fisico; entrando già la prima volta in classe ha parecchi punti di vantaggio sui suoi compagni, ha un’orientazione già acquisita per le abitudini famigliari: si concentra nell’attenzione con più facilità, perché ha l’abito del contegno fisico ecc. Allo stesso modo il figlio di un operaio di città soffre meno entrando in fabbrica di un ragazzo di contadini o di un giovane contadino già sviluppato per la vita rurale. Anche il regime alimentare ha un’importanza ecc. ecc. Ecco perché molti del popolo pensano che nella difficoltà dello studio ci sia un «trucco» a loro danno (quando non pensano di essere stupidi per natura): vedono il signore (e per molti, nelle campagne specialmente, signore vuol dire intellettuale) compiere con scioltezza e apparente facilità il lavoro che ai loro figli costa lacrime e sangue, e pensano ci sia un «trucco». In una nuova situazione, queste quistioni possono diventare asprissime e occorrerà resistere alla tendenza di render facile ciò che non può esserlo senza essere snaturato. Se si vorrà creare un nuovo strato di intellettuali, fino alle più grandi specializzazioni, da un gruppo sociale che tradizionalmente non ha sviluppato le attitudini conformi, si avranno da superare difficoltà inaudite.
Q12 §3 Quando si distingue tra intellettuali e non‑intellettuali in realtà ci si riferisce solo alla immediata funzione sociale della categoria professionale degli intellettuali, cioè si tiene conto della direzione in cui grava il peso maggiore della attività specifica professionale, se nell’elaborazione intellettuale o nello sforzo muscolare‑nervoso. Ciò significa che se si può parlare di intellettuali, non si può parlare di non-intellettuali, perché non‑intellettuali non esistono. Ma lo stesso rapporto tra sforzo di elaborazione intellettuale‑cerebrale e sforzo muscolare‑nervoso non è sempre uguale, quindi si hanno diversi gradi di attività specifica intellettuale.
Non c’è attività umana da cui si possa escludere ogni intervento intellettuale, non si può separare l’homo faber dall’homo sapiens. Ogni uomo infine, all’infuori della sua professione esplica una qualche attività intellettuale, è cioè un «filosofo», un artista, un uomo di gusto, partecipa di una concezione del mondo, ha una consapevole linea di condotta morale, quindi contribuisce a sostenere o a modificare una concezione del mondo, cioè a suscitare nuovi modi di pensare.
Il problema della creazione di un nuovo ceto intellettuale consiste pertanto nell’elaborare criticamente l’attività intellettuale che in ognuno esiste in un certo grado di sviluppo, modificando il suo rapporto con lo sforzo muscolare-nervoso verso un nuovo equilibrio e ottenendo che lo stesso sforzo muscolare‑nervoso, in quanto elemento di un’attività pratica generale, che innova perpetuamente il mondo fisico e sociale, diventi il fondamento di una nuova e integrale concezione del mondo.
Il tipo tradizionale e volgarizzato dell’intellettuale è dato dal letterato, dal filosofo, dall’artista. Perciò i giornalisti, che ritengono di essere letterati, filosofi, artisti, ritengono anche di essere i «veri» intellettuali.
Nel mondo moderno l’educazione tecnica, strettamente legata al lavoro industriale anche il più primitivo o squalificato, deve formare la base del nuovo tipo di intellettuale. Su questa base ha lavorato l’«Ordine Nuovo» settimanale per sviluppare certe forme di nuovo intellettualismo e per determinarne i nuovi concetti, e questa non è stata una delle minori ragioni del suo successo, perché una tale impostazione corrispondeva ad aspirazioni latenti e era conforme allo sviluppo delle forme reali di vita.
Il modo di essere del nuovo intellettuale non può più consistere nell’eloquenza, motrice esteriore e momentanea degli affetti e delle passioni, ma nel mescolarsi attivamente alla vita pratica, come costruttore, organizzatore, «persuasore permanentemente» perché non puro oratore – e tuttavia superiore allo spirito astratto matematico; dalla tecnica‑lavoro giunge alla tecnica‑scienza e alla concezione umanistica storica, senza la quale si rimane «specialista» e non si diventa «dirigente» (specialista + politico).
QUADERNO 13
NOTARELLE SULLA POLITICA DEL MACHIAVELLI
Q13 §1 Il carattere fondamentale del Principe è quello di non
essere una trattazione sistematica ma un libro «vivente», in cui
l’ideologia politica e la scienza politica si fondono nella
forma drammatica del «mito». Tra l’utopia e il trattato
scolastico, le forme in cui la scienza politica si configurava
fino al Machiavelli, questi dette alla sua concezione la forma
fantastica e artistica, per cui l’elemento dottrinale e
razionale si impersona in un condottiero, che rappresenta
plasticamente e «antropomorficamente» il simbolo della «volontà
collettiva». Il processo di formazione di una determinata
volontà collettiva, per un determinato fine politico, viene
rappresentato non attraverso disquisizioni e classificazioni
pedantesche di principii e criteri di un metodo d’azione, ma
come qualità, tratti caratteristici, doveri, necessità di una
concreta persona, ciò che fa operare la fantasia artistica di
chi si vuol convincere e dà una più concreta forma alle passioni
politiche. (Sarà da cercare negli scrittori politici precedenti
al Machiavelli se esistono scritture configurate come il
Principe. Anche la chiusa del Principe è legata a questo
carattere «mitico» del libro: dopo aver rappresentato il
condottiero ideale, il Machiavelli con un passaggio di grande
efficacia artistica, invoca il condottiero reale che
storicamente lo impersoni: questa invocazione appassionata si
riflette su tutto il libro conferendogli appunto il carattere
drammatico. Nei Prolegomeni di L. Russo il Machiavelli è detto
l’artista della politica e una volta si trova anche
l’espressione «mito», ma non precisamente nel senso su
indicato).
Il Principe del Machiavelli potrebbe essere studiato come una esemplificazione storica del «mito» sorelliano, cioè di una ideologia politica che si presenta non come fredda utopia né come dottrinario raziocinio, ma come una creazione di fantasia concreta che opera su un popolo disperso e polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collettiva. Il carattere utopistico del Principe è nel fatto che il «principe» non esisteva nella realtà storica, non si presentava al popolo italiano con caratteri di immediatezza obbiettiva, ma era una pura astrazione dottrinaria, il simbolo del capo, del condottiero ideale; ma gli elementi passionali, mitici, contenuti nell’intero volumetto, con mossa drammatica di grande effetto, si riassumono e diventano vivi nella conclusione, nell’invocazione di un principe, «realmente esistente». Nell’intero volumetto Machiavelli tratta di come deve essere il Principe per condurre un popolo alla fondazione del nuovo Stato, e la trattazione è condotta con rigore logico, con distacco scientifico: nella conclusione il Machiavelli stesso si fa popolo, si confonde col popolo, ma non con un popolo «genericamente» inteso, ma col popolo che il Machiavelli ha convinto con la sua trattazione precedente, di cui egli diventa e si sente coscienza ed espressione, si sente medesimezza: pare che tutto il lavoro «logico» non sia che un’autoriflessione del popolo, un ragionamento interno, che si fa nella coscienza popolare e che ha la sua conclusione in un grido appassionato, immediato. La passione, da ragionamento su se stessa, ridiventa «affetto», febbre, fanatismo d’azione. Ecco perché l’epilogo del Principe non è qualcosa di estrinseco, di «appiccicato» dall’esterno, di retorico, ma deve essere spiegato come elemento necessario dell’opera, anzi come quell’elemento che riverbera la sua vera luce su tutta l’opera e ne fa come un «manifesto politico».
Si può studiare come il Sorel, dalla concezione dell’ideologia‑mito non sia giunto alla comprensione del partito politico, ma si sia arrestato alla concezione del sindacato professionale. È vero che per il Sorel il «mito» non trovava la sua espressione maggiore nel sindacato, come organizzazione di una volontà collettiva, ma nell’azione pratica del sindacato e di una volontà collettiva già operante, azione pratica, la cui realizzazione massima avrebbe dovuto essere lo sciopero generale, cioè un’«attività passiva» per così dire, di carattere cioè negativo e preliminare (il carattere positivo è dato solo dall’accordo raggiunto nelle volontà associate) di una attività che non prevede una propria fase «attiva e costruttiva». Nel Sorel dunque si combattevano due necessità: quella del mito e quella della critica del mito in quanto «ogni piano prestabilito è utopistico e reazionario». La soluzione era abbandonata all’impulso dell’irrazionale, dell’«arbitrario» (nel senso bergsoniano di «impulso vitale») ossia della «spontaneità». (Sarebbe da notare qui una contraddizione implicita nel modo con cui il Croce pone il suo problema di storia e antistoria con altri modi di pensare del Croce: la sua avversione dei «partiti politici» e il suo modo di porre la quistione della «prevedibilità» dei fatti sociali, cfr Conversazioni Critiche, Serie prima, pp. 150‑52, recensione del libro di Ludovico Limentani, La previsione dei fatti sociali, Torino, Bocca, 1907; se i fatti sociali sono imprevedibili e lo stesso concetto di previsione è un puro suono, l’irrazionale non può non dominare e ogni organizzazione di uomini è antistoria, è un «pregiudizio»: non resta che risolvere volta per volta, e con criteri immediati, i singoli problemi pratici posti dallo svolgimento storico – cfr articolo di Croce, Il partito come giudizio e come pregiudizio in Cultura e Vita morale – e l’opportunismo è la sola linea politica possibile). Può un mito però essere «non‑costruttivo», può immaginarsi, nell’ordine di intuizioni del Sorel, che sia produttivo di effettualità uno strumento che lascia la volontà collettiva nella sua fase primitiva ed elementare del suo mero formarsi, per distinzione (per «scissione») sia pure con violenza, cioè distruggendo i rapporti morali e giuridici esistenti? Ma questa volontà collettiva, così formata elementarmente, non cesserà subito di esistere, sparpagliandosi in una infinità di volontà singole che per la fase positiva seguono direzioni diverse e contrastanti? Oltre alla quistione che non può esistere distruzione, negazione senza una implicita costruzione, affermazione, e non in senso «metafisico», ma praticamente, cioè politicamente, come programma di partito. In questo caso si vede che si suppone dietro la spontaneità un puro meccanicismo, dietro la libertà (arbitrio ‑ slancio vitale) un massimo di determinismo, dietro l’idealismo un materialismo assoluto.
Il moderno principe, il mito‑principe non può essere una persona reale, un individuo concreto, può essere solo un organismo; un elemento di società complesso nel quale già abbia inizio il concretarsi di una volontà collettiva riconosciuta e affermatasi parzialmente nell’azione. Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico ed è il partito politico, la prima cellula in cui si riassumono dei germi di volontà collettiva che tendono a divenire universali e totali. Nel mondo moderno solo un’azione storico‑politica immediata e imminente, caratterizzata dalla necessità di un procedimento rapido e fulmineo, può incarnarsi miticamente in un individuo concreto: la rapidità non può essere resa necessaria che da un grande pericolo imminente, grande pericolo che appunto crea fulmineamente l’arroventarsi delle passioni e del fanatismo, annichilendo il senso critico e la corrosività ironica che possono distruggere il carattere «carismatico» del condottiero (ciò che è avvenuto nell’avventura di Boulanger). Ma un’azione immediata di tal genere, per la sua stessa natura, non può essere di vasto respiro e di carattere organico: sarà quasi sempre del tipo restaurazione e riorganizzazione e non del tipo proprio alla fondazione di nuovi Stati e nuove strutture nazionali (come era il caso nel Principe del Machiavelli, in cui l’aspetto di restaurazione era solo un elemento retorico, cioè legato al concetto letterario dell’Italia discendente di Roma e che doveva restaurare l’ordine e la potenza di Roma), di tipo «difensivo» e non creativo originale, in cui, cioè, si suppone che una volontà collettiva, già esistente, si sia snervata, dispersa, abbia subito un collasso pericoloso e minaccioso ma non decisivo e catastrofico e occorra riconcentrarla e irrobustirla, e non già che una volontà collettiva sia da creare ex novo, originalmente e da indirizzare verso mete concrete sì e razionali, ma di una concretezza e razionalità non ancora verificate e criticate da una esperienza storica effettuale e universalmente conosciuta.
Il carattere «astratto» della concezione sorelliana del «mito» appare dall’avversione (che assume la forma passionale di una repugnanza etica) per i giacobini che certamente furono una «incarnazione categorica» del Principe di Machiavelli. Il moderno Principe deve avere una parte dedicata al giacobinismo (nel significato integrale che questa nozione ha avuto storicamente e deve avere concettualmente), come esemplificazione di come si sia formata in concreto e abbia operato una volontà collettiva che almeno per alcuni aspetti fu creazione ex novo, originale. E occorre che sia definita la volontà collettiva e la volontà politica in generale nel senso moderno, la volontà come coscienza operosa della necessità storica, come protagonista di un reale ed effettuale dramma storico.
Una delle prime parti dovrebbe appunto essere dedicata alla «volontà collettiva», impostando così la quistione: quando si può dire che esistano le condizioni perché possa suscitarsi e svilupparsi una volontà collettiva nazionale‑popolare? Quindi un’analisi storica (economica) della struttura sociale del paese dato e una rappresentazione «drammatica» dei tentativi fatti attraverso i secoli per suscitare questa volontà e le ragioni dei successivi fallimenti. Perché in Italia non si ebbe la monarchia assoluta al tempo di Machiavelli? Bisogna risalire fino all’Impero Romano (questione della lingua, degli intellettuali ecc.), comprendere la funzione dei Comuni medioevali, il significato del Cattolicismo ecc.: occorre insomma fare uno schizzo di tutta la storia italiana, sintetico ma esatto.
La ragione dei successivi fallimenti dei tentativi di creare una volontà collettiva nazionale‑popolare è da ricercarsi nell’esistenza di determinati gruppi sociali, che si formano dalla dissoluzione della borghesia comunale, nel particolare carattere di altri gruppi che riflettono la funzione internazionale dell’Italia come sede della Chiesa e depositaria del Sacro Romano Impero ecc. Questa funzione e la posizione conseguente determina una situazione interna che si può chiamare «economico‑corporativa», cioè, politicamente, la peggiore delle forme di società feudale, la forma meno progressiva e più stagnante: mancò sempre, e non poteva costituirsi, una forza giacobina efficiente, la forza appunto che nelle altre nazioni ha suscitato e organizzato la volontà collettiva nazionale‑popolare e ha fondato gli Stati moderni. Esistono finalmente le condizioni per questa volontà, ossia quale è il rapporto attuale tra queste condizioni e le forze opposte? Tradizionalmente le forze opposte sono state l’aristocrazia terriera e più generalmente
la proprietà terriera nel suo complesso, col suo tratto caratteristico italiano che è una speciale «borghesia rurale», eredità di parassitismo lasciata ai tempi moderni dallo sfacelo, come classe, della borghesia comunale (le cento città, le città del silenzio). Le condizioni positive sono da ricercare nell’esistenza di gruppi sociali urbani, convenientemente sviluppati nel campo della produzione industriale e che abbiano raggiunto un determinato livello di cultura storico‑politica. Ogni formazione di volontà collettiva nazionale‑popolare è impossibile se le grandi masse dei contadini coltivatori non irrompono simultaneamente nella vita politica. Ciò intendeva il Machiavelli attraverso la riforma della milizia, ciò fecero i giacobini nella Rivoluzione francese, in questa comprensione è da identificare un giacobinismo precoce del Machiavelli, il germe (più o meno fecondo) della sua concezione della rivoluzione nazionale. Tutta la storia dal 1815 in poi mostra lo sforzo delle classi tradizionali per impedire la formazione di una volontà collettiva di questo genere, per mantenere il potere «economico‑corporativo» in un sistema internazionale di equilibrio passivo.
Una parte importante del moderno Principe dovrà essere dedicata alla quistione di una riforma intellettuale e morale, cioè alla quistione religiosa o di una concezione del mondo. Anche in questo campo troviamo nella tradizione assenza di giacobinismo e paura del giacobinismo (l’ultima espressione filosofica di tale paura è l’atteggiamento maltusiano di B. Croce verso la religione). Il moderno Principe deve e non può non essere il banditore e l’organizzatore di una riforma intellettuale e morale, ciò che poi significa creare il terreno per un ulteriore sviluppo della volontà collettiva nazionale popolare verso il compimento di una forma superiore e totale di civiltà moderna.
Questi due punti fondamentali – formazione di una volontà collettiva nazionale‑popolare di cui il moderno Principe è nello stesso tempo l’organizzatore e l’espressione attiva e operante, e riforma intellettuale e morale – dovrebbero costituire la struttura del lavoro. I punti concreti di programma devono essere incorporati nella prima parte, cioè dovrebbero «drammaticamente», risultare dal discorso, non essere una fredda e pedantesca esposizione di raziocini.
Può esserci riforma culturale e cioè elevamento civile degli strati depressi della società, senza una precedente riforma economica e un mutamento nella posizione sociale e nel mondo economico? Perciò una riforma intellettuale e morale non può non essere legata a un programma di riforma economica, anzi il programma di riforma economica è appunto il modo concreto con cui si presenta ogni riforma intellettuale e morale. Il moderno Principe, sviluppandosi, sconvolge tutto il sistema di rapporti intellettuali e morali in quanto il suo svilupparsi significa appunto che ogni atto viene concepito come utile o dannoso, come virtuoso o scellerato, solo in quanto ha come punto di riferimento il moderno Principe stesso e serve a incrementare il suo potere o a contrastarlo. Il Principe prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume.
Q13 §2 Le scritte a proposito dello studio delle
situazioni e di ciò che occorre intendere per «rapporti di
forza». Lo studio di come occorre analizzare le «situazioni»,
cioè di come occorre stabilire i diversi gradi di rapporto di
forze può prestarsi a una esposizione elementare di scienza ed
arte politica, intesa come un insieme di canoni pratici di
ricerca e di osservazioni particolari utili per risvegliare
l’interesse per la realtà effettuale e suscitare intuizioni
politiche più rigorose e vigorose. Insieme è da porre
l’esposizione di ciò che occorre intendere in politica per
strategia e tattica, per «piano» strategico, per propaganda e
agitazione, per organica, o scienza dell’organizzazione e
dell’amministrazione in politica. Gli elementi di osservazione
empirica che di solito sono esposti alla rinfusa nei trattati di
scienza politica (si può prendere come esemplare l’opera di G.
Mosca: Elementi di scienza politica) dovrebbero, in quanto non
sono quistioni astratte o campate in aria, trovar posto nei vari
gradi del rapporto di forze, a cominciare dai rapporti delle
forze internazionali (in cui troverebbero posto le scritte
su ciò che è una grande potenza, sugli aggruppamenti di Stati in
sistemi egemonici e quindi sul concetto di indipendenza e
sovranità per ciò che riguarda le potenze piccole e medie) per
passare ai rapporti obbiettivi sociali, cioè al grado di
sviluppo delle forze produttive, ai rapporti di forza politica e
di partito (sistemi egemonici nell’interno dello Stato) e ai
rapporti politici immediati (ossia potenzialmente militari).
I rapporti internazionali precedono o seguono (logicamente) i rapporti sociali fondamentali? Seguono indubbiamente. Ogni innovazione organica nella struttura modifica organicamente i rapporti assoluti e relativi nel campo internazionale, attraverso le sue espressioni tecnico‑militari. Anche la posizione geografica di uno Stato nazionale non precede ma segue (logicamente) le innovazioni strutturali, pur reagendo su di esse in una certa misura (nella misura appunto in cui le superstrutture reagiscono sulla struttura, la politica sull’economia ecc.). D’altronde i rapporti internazionali reagiscono passivamente e attivamente sui rapporti politici (di egemonia dei partiti). Quanto più la vita economica immediata di una nazione è subordinata ai rapporti internazionali, tanto più un determinato partito rappresenta questa situazione e la sfrutta per impedire il sopravvento dei partiti avversari (ricordare il famoso discorso di Nitti sulla rivoluzione italiana tecnicamente impossibile!). Da questa serie di fatti si può giungere alla conclusione che spesso il così detto «partito dello straniero» non è proprio quello che come tale viene volgarmente indicato, ma proprio il partito più nazionalistico, che, in realtà, più che rappresentare le forze vitali del proprio paese, ne rappresenta la subordinazione e l’asservimento economico alle nazioni o a un gruppo di nazioni egemoniche (un accenno a questo elemento internazionale «repressivo» delle energie interne si trova negli articoli pubblicati da G. Volpe nel «Corriere della Sera» del 22 e 23 marzo 1932).
Q13 §3 Oltre che dal modello esemplare delle grandi monarchie e assolute di Francia e Spagna, il Machiavelli fu mosso alla sua concezione politica della necessità di uno Stato unitario italiano dal ricordo del passato di Roma. Occorre far risaltare però che non perciò il Machiavelli è da confondere con la tradizione letteraria‑retorica. Intanto perché questo elemento non è esclusivo e neanche dominante, e la necessità di un grande Stato nazionale non è dedotta da esso, e poi anche perché lo stesso richiamo a Roma è meno astratto di quanto paia, se collocato puntualmente nel clima dell’Umanesimo e del Rinascimento. Nel libro VII dell’Arte della guerra si legge: «questa provincia (l’Italia) pare nata per risuscitare le cose morte, come si è visto della poesia, della pittura e della scultura», perché dunque non ritroverebbe la virtù militare? ecc. Saranno da raggruppare gli altri accenni del genere per stabilirne l’esatto carattere.
Q13 §4 Prendendo le mosse dall’affermazione del Foscolo, nei Sepolcri, che il Machiavelli «temprando lo scettro ai regnatori, gli allor ne sfronda, ed alle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue», si potrebbe fare una raccolta di tutte le massime «universali» di prudenza politica contenute negli scritti del Machiavelli e ordinarle con un commento opportuno (forse una raccolta di tal genere esiste già).
Q13 §5 Grande politica (alta politica) ‑ piccola politica (politica del giorno per giorno, politica parlamentare, di corridoio, d’intrigo). La grande politica comprende le quistioni connesse con la fondazione di nuovi Stati, con la lotta per la distruzione, la difesa, la conservazione di determinate strutture organiche economico‑sociali. La piccola politica le quistioni parziali e quotidiane che si pongono nell’interno di una struttura già stabilita per le lotte di preminenza tra le diverse frazioni di una stessa classe politica. È pertanto grande politica il tentare di escludere la grande politica dall’ambito interno della vita statale e di ridurre tutto a piccola politica (Giolitti, abbassando il livello delle lotte interne faceva della grande politica; ma i suoi succubi, erano oggetto di grande politica, ma facevano essi della piccola politica). È invece da dilettanti porre le quistioni in modo tale che ogni elemento di piccola politica debba necessariamente diventare quistione di grande politica, di radicale riorganizzazione dello Stato. Gli stessi termini si ripresentano nella politica internazionale: 1) la grande politica nelle quistioni che riguardano la statura relativa dei singoli Stati nei confronti reciproci; 2) la piccola politica nelle quistioni diplomatiche che nascono nell’interno di un equilibrio già costituito e che non tentano di superare l’equilibrio stesso per creare nuovi rapporti.
Il Machiavelli esamina specialmente le quistioni di grande politica: creazione di nuovi Stati, conservazione e difesa di strutture organiche nel complesso; quistioni di dittatura e di egemonia su vasta scala, cioè su tutta l’area statale. Il Russo nei Prolegomeni fa del Principe il trattato della dittatura (momento dell’autorità e dell’individuo) e dei Discorsi quello dell’egemonia (momento dell’universale e della libertà). L’osservazione del Russo è esatta, sebbene anche nel Principe non manchino gli accenni al momento dell’egemonia o del consenso accanto a quelli dell’autorità o della forza. Così è giusta l’osservazione che non c’è opposizione di principio tra principato e repubblica, ma si tratti piuttosto della ipostasi dei due momenti di autorità e universalità.
Q13 §6 La quistione della classe politica, come è presentata nelle opere di Gaetano Mosca, è diventata un puzzle. Non si capisce esattamente cosa il Mosca intenda precisamente per classe politica, tanto la nozione è elastica ed ondeggiante. Talvolta pare che per classe politica si intenda la classe media, altre volte l’insieme delle classi possidenti, altre volte ciò che si chiama la «parte colta» della società, o il «personale politico» (ceto parlamentare) dello Stato: talvolta pare che la burocrazia, anche nel suo strato superiore, sia esclusa dalla classe politica in quanto deve appunto essere controllata e guidata dalla classe politica. La deficienza della trattazione del Mosca appare nel fatto che egli non affronta nel suo complesso il problema del «partito politico» e ciò si capisce, dato il carattere dei libri del Mosca e specialmente degli Elementi di scienza politica: l’interesse del Mosca infatti ondeggia tra una posizione «obbiettiva» e disinteressata di scienziato e una posizione appassionata di immediato uomo di parte che vede svolgersi avvenimenti che lo angustiano e ai quali vorrebbe reagire. D’altronde il Mosca inconsapevolmente riflette le discussioni suscitate dal materialismo storico, ma le riflette come il provinciale che «sente nell’aria» le discussioni che avvengono nella capitale e non ha il mezzo di procurarsene i documenti e i testi fondamentali: nel caso del Mosca «non avere i mezzi» di procurarsi i testi e i documenti del problema che tuttavia tratta significa che il Mosca appartiene a quella parte di universitari che mentre ritengono loro dovere fare sfoggio di tutte le cautele del metodo storico quando studiano le ideuzze di un pubblicista medioevale di terzo ordine, non ritengono o non ritenevano degne «del metodo» le dottrine del materialismo storico, non ritenevano necessario risalire alle fonti e si accontentavano di orecchiare articolucci di giornale e opuscoletti popolari.
Q13 §7 Quistione dell’«uomo collettivo» o del «conformismo sociale». Compito educativo e formativo dello Stato, che ha sempre il fine di creare nuovi e più alti tipi di civiltà, di adeguare la «civiltà» e la moralità delle più vaste masse popolari alle necessità del continuo sviluppo dell’apparato economico di produzione, quindi di elaborare anche fisicamente dei tipi nuovi d’umanità. Ma come ogni singolo individuo riuscirà a incorporarsi nell’uomo collettivo e come avverrà la pressione educativa sui singoli ottenendone il consenso e la collaborazione, facendo diventare «libertà» la necessità e la coercizione? Quistione del «diritto», il cui concetto dovrà essere esteso, comprendendovi anche quelle attività che oggi cadono sotto la formula di «indifferente giuridico» e che sono di dominio della società civile che opera senza «sanzioni» e senza «obbligazioni» tassative, ma non per tanto esercita una pressione collettiva e ottiene risultati obbiettivi di elaborazione nei costumi, nei modi di pensare e di operare, nella moralità ecc.
Concetto politico della così detta «rivoluzione permanente» sorto prima del 1848, come espressione scientificamente elaborata delle esperienze giacobine dal 1789 al Termidoro. La formula è propria di un periodo storico in cui non esistevano ancora i grandi partiti politici di massa e i grandi sindacati economici e la società era ancora, per dir così, allo stato di fluidità sotto molti aspetti: maggiore arretratezza della campagna e monopolio quasi completo dell’efficienza politico‑statale in poche città o addirittura in una sola (Parigi per la Francia), apparato statale relativamente poco sviluppato e maggiore autonomia della società civile dall’attività statale, determinato sistema delle forze militari e dell’armamento nazionale, maggiore autonomia delle economie nazionali dai rapporti economici del mercato mondiale ecc. Nel periodo dopo il 1870, con l’espansione coloniale europea, tutti questi elementi mutano, i rapporti organizzativi interni e internazionali dello Stato diventano più complessi e massicci e la formula quarantottesca della «rivoluzione permanente» viene elaborata e superata nella scienza politica nella formula di «egemonia civile». Avviene nell’arte politica ciò che avviene nell’arte militare: la guerra di movimento diventa sempre più guerra di posizione e si può dire che uno Stato vince una guerra in quanto la prepara minutamente e tecnicamente nel tempo di pace. La struttura massiccia delle democrazie moderne, sia come organizzazioni statali che come complesso di associazioni nella vita civile costituiscono per l’arte politica come le «trincee» e le fortificazioni permanenti del fronte nella guerra di posizione: essi rendono solo «parziale» l’elemento del movimento che prima era «tutta» la guerra ecc.
La quistione si pone per gli Stati moderni, non per i paesi arretrati e per le colonie, dove vigono ancora le forme che altrove sono superate e divenute anacronistiche. Anche la quistione del valore delle ideologie (come si può trarre dalla polemica Malagodi‑Croce) – con le osservazioni del Croce sul «mito» soreliano, che si possono ritorcere contro la «passione» deve essere studiata in un trattato di scienza politica.
Q13 §8 La concezione del Croce, della politica‑passione, esclude i partiti, perché non si può pensare a una «passione» organizzata e permanente: la passione permanente è una condizione di orgasmo e di spasimo, che determina inettitudine all’operare. Esclude i partiti ed esclude ogni «piano» d’azione concertato preventivamente. Tuttavia i partiti esistono e piani d’azione vengono elaborati, applicati, e spesso realizzati in misura volissima; c’è adunque nella concezione del Croce un «vizio». Né vale dire che se i partiti esistono, ciò non ha grande importanza «teorica», perché al momento dell’azione il «partito» che opera non è la stessa cosa del partito che esisteva prima; in parte ciò può esser vero, tuttavia tra i due «partiti» le coincidenze sono tante che in realtà si può dire trattarsi dello stesso organismo. Ma la concezione, per esser valida, dovrebbe potersi applicare anche alla «guerra» e quindi spiegare il fatto degli eserciti permanenti, delle accademie militari, dei corpi di ufficiali. Anche la guerra in atto è «passione», la più intensa e febbrile, è un momento della vita politica, è la continuazione, in altre forme, di una determinata politica; bisogna dunque spiegare come la «passione» possa diventare «dovere» morale e non dovere di morale politica, ma di etica.
Sui «piani politici» che sono connessi ai partiti come formazioni permanenti, ricordare ciò che Moltke diceva dei piani militari; che essi non possono essere elaborati e fissati in precedenza in tutti i loro dettagli, ma solo nel loto nucleo e disegno centrale, perché le particolarità dell’azione dipendono in una certa misura dalle mosse dell’avversario. La passione si manifesta appunto nei particolari, ma non pare che il principio di Moltke sia tale da giustificare la concezione del Croce: rimarrebbe in ogni caso da spiegare il genere di «passione» dello Stato Maggiore che ha elaborato il piano a mente fredda e «spassionatamente».
Q13 §9 Lo Schopenhauer avvicina l’insegnamento di scienza politica del Machiavelli a quello impartito dal maestro di scherma che insegna l’arte di ammazzare (ma anche di non farsi ammazzare) ma non perciò insegna a diventare sicari e assassini. (Trovare il riferimento esatto).
Q13 §10 La quistione iniziale da porre e da risolvere in una trattazione sul Machiavelli è la quistione della politica come scienza autonoma, cioè del posto che la scienza politica occupa o deve occupare in una concezione del mondo sistematica (coerente e conseguente) – in una filosofia della praxis –. Il progresso fatto fare dal Croce, a questo proposito, agli studi sul Machiavelli e sulla scienza politica, consiste precipuamente (come in altri campi dell’attività critica crociana) nella dissoluzione di una serie di problemi falsi, inesistenti o male impostati. Il Croce si è fondato sulla sua distinzione dei momenti dello Spirito e sull’affermazione di un momento della pratica, di uno spirito pratico, autonomo e indipendente, sebbene legato circolarmente all’intera realtà per la dialettica dei distinti. In una filosofia della prassi la distinzione non sarà certo tra i momenti dello Spirito assoluto, ma tra i gradi della soprastruttura e si tratterà pertanto di stabilire la posizione dialettica dell’attività politica (e della scienza corrispondente) come determinato grado superstrutturale: si potrà dire, come primo accenno e approssimazione, che l’attività politica è appunto il primo momento o primo grado, il momento in cui la superstruttura è ancora nella fase immediata di mera affermazione volontaria, indistinta ed elementare.
In che senso si può identificare la politica e la storia e quindi tutta la vita e la politica. Come perciò tutto il sistema delle superstrutture possa concepirsi come distinzioni della politica e quindi si giustifichi l’introduzione del concetto di distinzione in una filosofia della prassi. Ma si può parlare di dialettica dei distinti e come si può intendere il concetto di circolo fra i gradi della superstruttura? Concetto di «blocco storico», cioè unità tra la natura e lo spirito (struttura e superstruttura) unità dei contrari e dei distinti.
Il criterio di distinzione si può introdurre anche nella struttura? Come sarà da intendere la struttura: come nel sistema dei rapporti sociali si potrà distinguere l’elemento «tecnica», «lavoro», «classe» ecc. intesi storicamente e non «metafisicamente». Critica della posizione del Croce per cui, ai fini della polemica, la struttura diventa un «dio ascoso», un «noumeno» in contrapposizione alle «apparenze» della superstruttura. «Apparenze» in senso metaforico e in senso positivo. Perché «storicamente» e come linguaggio si è parlato di «apparenze».
È interessante fissare come il Croce, da questa concezione generale, abbia tratto la sua particolare dottrina dell’errore e della origine pratica dell’errore. Per il Croce l’errore ha origine in una «passione» immediata, cioè di carattere individuale o di gruppo; ma che cosa produrrà la «passione» di portata storica più vasta, la passione come «categoria»? La passione interesse immediato che è origine dell’«errore» è il momento che nelle Glosse al Feuerbach viene chiamato «schmutzig‑jüdisch»: ma come la passione-interesse «schmutzig‑jüdisch» determina l’errore immediato, così la passione del più vasto gruppo sociale determina l’«errore» filosofico (intermedio l’errore‑ideologia, di cui il Croce tratta a parte): l’importante in questa serie: egoismo (errore immediato) ‑ ideologia ‑ filosofia è il termine comune «errore» legato ai diversi gradi di passione, e che sarà da intendere non nel significato moralistico o dottrinario ma nel senso puramente «storico» e dialettico di «ciò che è storicamente caduco e degno di cadere», nel senso della «non definitività» di ogni filosofia, della «morte‑vita», «essere ‑ non essere», cioè del termine dialettico da superare nello svolgimento.
Il termine di «apparente», «apparenza», significa proprio questo e niente altro che questo ed è da giustificare contro il dogmatismo: è l’affermazione della caducità di ogni sistema ideologico, accanto all’affermazione di una validità storica di ogni sistema, e di una necessità di esso («nel terreno ideologico l’uomo acquista coscienza dei rapporti sociali»: dire ciò non è affermare la necessità e la validità delle «apparenze»?)
Q13 §11 Una concezione del diritto che deve essere essenzialmente rinnovatrice. Essa non può essere trovata, integralmente, in nessuna dottrina preesistente (neanche nella dottrina della così detta scuola positiva, e particolarmente nella dottrina del Ferri). Se ogni Stato tende a creare e a mantenere un certo tipo di civiltà e di cittadino (e quindi di connivenza e di rapporti individuali), tende a far sparire certi costumi e attitudini e a diffonderne altri, il diritto sarà lo strumento per questo fine (accanto alla scuola ed altre istituzioni ed attività) e deve essere elaborato affinché sia conforme al fine, sia massimamente efficace e produttivo di risultati positivi. La concezione del diritto dovrà essere liberata da ogni residuo di trascendenza e di assoluto, praticamente di ogni fanatismo moralistico, tuttavia mi pare non possa partire dal punto di vista che lo Stato non «punisce» (se questo termine è ridotto al suo significato umano) ma lotta solo contro la «pericolosità» sociale. In realtà lo Stato deve essere concepito come «educatore» in quanto tende appunto a creare un nuovo tipo o livello di civiltà. Per il fatto che si opera essenzialmente sulle forze economiche, che si riorganizza e si sviluppa l’apparato di produzione economica, che si innova la struttura, non deve trarsi la conseguenza che i fatti di soprastruttura debbano abbandonarsi a se stessi, al loro sviluppo spontaneo, a una germinazione casuale e sporadica. Lo Stato, anche in questo campo, è uno strumento di «razionalizzazione», di accelerazione e di taylorizzazione, opera secondo un piano, preme, incita, sollecita, e «punisce», poiché, create le condizioni in cui un determinato modo di vita è «possibile», l’«azione o l’omissione criminale» devono avere una sanzione punitiva, di portata morale, e non solo un giudizio di pericolosità generica. Il diritto è l’aspetto repressivo e negativo di tutta l’attività positiva di incivilimento svolta dallo Stato. Nella concezione del diritto dovrebbero essere incorporate anche le attività «premiatrici» di individui, di gruppi ecc.; si premia l’attività lodevole e meritoria, come si punisce l’attività criminale (e si punisce in modi originali, facendo intervenire l’«opinione pubblica», come sanzionatrice).
Q13 §12 Bacone ha chiamato «Re Magi» i tre re che operano più energicamente per la fondazione delle monarchie assolute: Luigi XI di Francia, Ferdinando il Cattolico in Spagna, Enrico VII in Inghilterra.
Filippo di Commynes (1447‑1511), al servizio di Carlo il Temerario fino al 1472; nel 1472 passa al servizio di Luigi XI ed è lo strumento della politica di questo re. Scrive la Chronique de Louis XI, pubblicata la prima volta nel 1524. (Una mercantessa di Tours che mosse causa al di Commynes quando fu in disgrazia, sostenendo di essere stata strozzata in un contratto stipulato sotto Luigi XI, scrisse nella sua memoria giuridica: «le sieur d’Argenton qui pour lors était roy»). Studiare i possibili rapporti del Machiavelli col di Commynes: il Machiavelli come apprezzava l’attività e la funzione del di Commynes sotto Luigi XI e in seguito?
Q13 §13 Accanto ai meriti della moderna «machiavellistica» derivata dal Croce, occorre segnalare anche le «esagerazioni» e le deviazioni cui ha dato luogo. Si è formata l’abitudine di considerare troppo il Machiavelli come il «politico in generale», come lo «scienziato della politica», attuale in tutti i tempi. Bisogna considerare maggiormente il Machiavelli come espressione necessaria del suo tempo e come strettamente legato alle condizioni e alle esigenze del tempo suo che risultano: 1) dalle lotte interne della repubblica fiorentina e dalla particolare struttura dello Stato che non sapeva liberarsi dai residui comunali‑municipali, cioè da una forma divenuta inceppante di feudalismo; 2) dalle lotte tra gli Stati italiani per un equilibrio nell’ambito italiano, che era ostacolato dall’esistenza del papato e dagli altri residui feudali, municipalistici della forma statale cittadina e non territoriale; 3) dalle lotte degli Stati italiani più o meno solidali per un equilibrio europeo, ossia dalle contraddizioni tra le necessità di un equilibrio interno italiano e le esigenze degli Stati europei in lotta per l’egemonia. Su Machiavelli opera l’esempio della Francia e della Spagna che hanno raggiunto una forte unità statale territoriale; il Machiavelli fa un «paragone ellittico» (per usare l’espressione crociana) e desume le regole per uno Stato forte in generale e italiano in particolare. Machiavelli è uomo tutto della sua epoca e la sua scienza politica rappresenta la filosofia del tempo che tende all’organizzazione delle monarchie nazionali assolute, la forma politica che permette e facilita un ulteriore sviluppo delle forze produttive borghesi. In Machiavelli si può scoprire in nuce la separazione dei poteri e il parlamentarismo (il regime rappresentativo): la sua «ferocia» è rivolta contro i residui del mondo feudale, non contro le classi progressive. Il Principe deve porre termine all’anarchia feudale e ciò fa il Valentino in Romagna, appoggiandosi sulle classi produttive, mercanti e contadini. Dato il carattere militare‑dittatoriale del capo dello Stato, come si richiede in un periodo di lotta per la fondazione e il consolidamento di un nuovo generale statale: se le classi urbane vogliono porre fine al disordine interno e all’anarchia esterna devono appoggiarsi sui contadini come massa, costituendo una forza armata sicura e fedele di tipo assolutamente diverso dalle compagnie di ventura. Si può dire che la concezione essenzialmente politica è così dominante nel Machiavelli che gli fa commettere gli errori di carattere militare: egli pensa specialmente alle fanterie, le cui masse possono essere arruolate con un’azione politica e perciò misconosce il significato dell’artiglieria. il Russo (nei Prolegomeni a Machiavelli) nota giustamente che l’Arte della guerra integra il Principe, ma non trae tutte le conclusioni della sua osservazione. Anche nell’Arte della guerra il Machiavelli deve essere considerato come un politico che deve occuparsi di arte militare; il suo unilateralismo (con altre «curiosità» come la teoria della falange, che danno luogo a facili spiritosaggini come quella più diffusa ricavata dal Bandello) è dipendente dal fatto che non nella quistione tecnico‑militare è il centro del suo interesse e del suo pensiero, ma egli ne tratta solo in quanto è necessario per la sua costruzione politica.
Ma non solo l’Arte della guerra deve essere connessa al Principe, sibbene anche le Istorie fiorentine, che devono servire appunto come un’analisi delle condizioni reali italiane ed europee da cui scaturiscono le esigenze immediate contenute nel Principe.
Da una concezione del Machiavelli più aderente ai tempi deriva subordinatamente una valutazione più storicistica dei così detti «antimachiavellici», o almeno dei più «ingenui» tra essi. Non si tratta, in realtà, di antimachiavellici, ma di politici che esprimono esigenze del tempo loro o di condizioni diverse da quelle che operavano sul Machiavelli; la forma polemica è pura accidentalità letteraria. L’esempio tipico di questi «antimachiavellici» mi pare da ricercare in Jean Bodin (1530‑96) che fu deputato agli Stati Generali di Blois del 1576 e vi fece rifiutare dal Terzo Stato i sussidi domandati per la guerra civile. (Opere del Bodin: Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566) dove indica l’influenza del clima sulla forma degli Stati, accenna a un’idea di progresso ecc.; La Republique (1576) dove esprime le opinioni del Terzo Stato sulla monarchia assoluta e i suoi rapporti col popolo; Hentaplomores (inedito fino all’epoca moderna) in cui confronta tutte le religioni e le giustifica come espressioni diverse della religione naturale, sola ragionevole, e tutte egualmente degne di rispetto e di tolleranza.
Durante le guerre civili in Francia, il Bodin è l’esponente del terzo partito, detto dei «politici», che si pone dal punto di vista dell’interesse nazionale, cioè di un equilibrio interno delle classi in cui l’egemonia appartiene al Terzo Stato attraverso il Monarca. Mi pare evidente che classificare il Bodin fra gli «antimachiavellici» sia quistione assolutamente estrinseca e superficiale. Il Bodin fonda la scienza politica in Francia in un terreno molto più avanzato e complesso di quello che l’Italia aveva offerto al Machiavelli. Per il Bodin non si tratta di fondare lo Stato unitario‑ territoriale (nazionale) cioè di ritornare all’epoca di Luigi XI, ma di equilibrare le forze sociali in lotta nell’interno di questo Stato già forte e radicato; non il momento della forza interessa il Bodin, ma quello del consenso. Col Bodin si tende a sviluppare la monarchia assoluta: il Terzo Stato è talmente cosciente della sua forza e della sua dignità, conosce così bene che la fortuna della Monarchia assoluta è legata alla propria fortuna e al proprio sviluppo, che pone delle condizioni per il suo consenso, presenta delle esigenze, tende a limitare l’assolutismo. In Francia il Machiavelli serviva già alla reazione, perché poteva servire a giustificare che si mantenesse perpetuamente il mondo in «culla» (secondo l’espressione di Bertrando Spaventa), quindi bisognava essere «polemicamente» antiMachiavellici. È da notare che nell’Italia studiata dal Machiavelli non esistevano istituzioni rappresentative già sviluppate e significative per la vita nazionale come quelle degli Stati Generali in Francia. Quando modernamente si osserva tendenziosamente che le istituzioni parlamentari in Italia sono state importate dall’estero, non si tiene conto che ciò riflette solo una condizione di arretratezza e di stagnazione della storia italiana politica sociale dal 500 al 700, condizione che era dovuta in gran parte alla preponderanza dei rapporti internazionali su quelli interni, paralizzati e assiderati. Che la struttura statale italiana, per le preponderanzeNel ms una variante interlineare: «suzeraineté». straniere, sia rimasta alla fase semifeudale di un oggetto di «suzeraineté» straniera, è forse «originalità» nazionale distrutta dall’importazione delle forme parlamentari che invece danno una forma al processo di liberazione nazionale? e al passaggio allo Stato territoriale moderno (indipendente e nazionale)? Del resto istituzioni rappresentative sono esistite, specialmente nel Mezzogiorno e in Sicilia, ma con carattere molto più ristretto che in Francia, per il poco sviluppo in queste regioni del Terzo Stato, cosa per cui i Parlamenti erano strumenti per mantenere l’anarchia dei baroni contro i tentativi innovatori della monarchia, che doveva appoggiarsi ai «lazzari» in assenza di una borghesia. Ricordare lo studio di Antonio Panella sugli Antimachiavellici pubblicato nel «Marzocco» del 1927 (o anche 26? in undici articoli): vedere come vi è giudicato il Bodin in confronto al Machiavelli e come è posto in generale il problema dell’antimachiavellismo.
Che il programma o la tendenza di collegare la città alla campagna potesse avere nel Machiavelli solo un’espressione militare si capisce riflettendo che il giacobinismo francese sarebbe inesplicabile senza il presupposto della cultura fisiocratica, con la sua dimostrazione dell’importanza economica e sociale del coltivatore diretto. Le teorie economiche del Machiavelli sono state studiate da Gino Arias (negli «Annali d’Economia» dell’Università Bocconi) ma è da domandarsi se il Machiavelli abbia avuto teorie economiche: si tratterà di vedere se il linguaggio essenzialmente politico del Machiavelli può tradursi in termini economici e a quale sistema economico possa ridursi. Vedere se il Machiavelli che viveva nel periodo mercantilista abbia politicamente preceduto i tempi e anticipato qualche esigenza che ha poi trovato espressione nei fisiocratici.
Anche Rousseau sarebbe stato possibile senza la cultura fisiocratica? Non mi pare giusto affermare che i fisiocratici abbiano rappresentato meri interessi agricoli e che solo con l’economia classica si affermino gli interessi del capitalismo urbano? I fisiocratici rappresentano la rottura col mercantilismo e col regime delle corporazioni e sono una fase per giungere all’economia classica, ma mi pare appunto per ciò che essi rappresentino una società avvenire ben più complessa di quella contro cui combattono e anche di quella che risulta immediatamente dalle loro affermazioni: il loro linguaggio è troppo legato al tempo ed esprime il contrasto immediato tra città e campagna, ma lascia prevedere un allargamento del capitalismo all’agricoltura. La formula del lasciar fare lasciar passare, cioè della libertà industriale e d’iniziativa, non è certo legata a interessi agrari.
Q13 §14 Altro punto da fissare e da svolgere è quello della «doppia prospettiva» nell’azione politica e nella vita statale. Vari gradi in cui può presentarsi la doppia prospettiva, dai più elementari ai più complessi, ma che possono ridursi teoricamente a due gradi fondamentali, corrispondenti alla doppia natura del Centauro machiavellico, ferina ed umana, della forza e del consenso, dell’autorità e dell’egemonia, della violenza e della civiltà, del momento individuale e di quello universale (della «Chiesa» e dello «Stato»), dell’agitazione e della propaganda, della tattica e della strategia ecc. Alcuni hanno ridotto la teoria della «doppia prospettiva» a qualcosa di meschino e di banale, a niente altro cioè che a due forme di «immediatezza» che si succedono meccanicamente nel tempo con maggiore o minore «prossimità». Può invece avvenire che quanto più la prima «prospettiva» è «immediatissima», elementarissima, tanto più la seconda debba essere «lontana» (non nel tempo, ma come rapporto dialettico) complessa, elevata, cioè può avvenire come nella vita umana, che quanto più un individuo è costretto a difendere la propria esistenza fisica immediata, tanto più sostiene e si pone dal punto di vista di tutti i complessi e più elevati valori della civiltà e dell’umanità.
Q13 §15 Nella nozione di grande potenza è da considerare anche l’elemento «tranquillità interna» cioè il grado e l’intensità della funzione egemonica del gruppo sociale dirigente; (questo elemento è da ricercare nella valutazione della potenza di ogni Stato, ma acquista maggiore importanza nella considerazione delle grandi potenze. Né vale ricordare la storia dell’antica Roma e delle lotte interne che non impedirono l’espansione vittoriosa ecc.; oltre agli altri elementi differenziali, basta considerare questo, che Roma era la sola grande potenza dell’epoca, e che non aveva da temere la concorrenza di rivali potenti, dopo la distruzione di Cartagine). Si potrebbe perciò dire che quanto più forte è l’apparato di polizia, tanto più debole è l’esercito e quanto più debole (cioè relativamente inutile) la polizia, tanto più forte è l’esercito (di fronte alla prospettiva di una lotta internazionale).
Q13 §16 Il «troppo» (e quindi superficiale e meccanico) realismo politico porta spesso ad affermare che l’uomo di Stato deve operare solo nell’ambito della «realtà effettuale», non interessarsi del «dover essere», ma solo dell’«essere». Ciò significherebbe che l’uomo di Stato non deve avere prospettive oltre la lunghezza del proprio naso. Questo errore ha condotto Paolo Treves a trovare nel Guicciardini e non nel Machiavelli il «vero politico». Bisogna distinguere oltre che tra «diplomatico» e «politico», anche tra scienziato della politica e politico in atto. Il diplomatico non può non muoversi solo nella realtà effettuale, perché la sua attività specifica non è quella di creare nuovi equilibri, ma di conservare entro certi quadri giuridici un equilibrio esistente. Così anche lo scienziato deve muoversi solo nella realtà effettuale in quanto mero scienziato. Ma il Machiavelli non è un mero scienziato; egli è un uomo di parte, di passioni poderose, un politico in atto, che vuol creare nuovi rapporti di forze e perciò non può non occuparsi del «dover essere», certo non inteso in senso moralistico. La quistione non è quindi da porre in questi termini, è più complessa: si tratta cioè di vedere se il «dover essere» è un atto arbitrario o necessario, è volontà concreta, o velleità, desiderio, amore con le nuvole. Il politico in atto è un creatore, un suscitatore, ma né crea dal nulla, né si muove nel vuoto torbido dei suoi desideri e sogni. Si fonda sulla realtà effettuale, ma cos’è questa realtà effettuale? È forse qualcosa di statico e immobile o non piuttosto un rapporto di forze in continuo movimento e mutamento di equilibrio? Applicare la volontà alla creazione di un nuovo equilibrio delle forze realmente esistenti ed operanti, fondandosi su quella determinata forza che si ritiene progressiva, e potenziandola per farla trionfare è sempre muoversi nel terreno della realtà effettuale ma per dominarla e superarla (o contribuire a ciò). Il «dover essere» è quindi concretezza, anzi è la sola interpretazione realistica e storicistica della realtà, è sola storia in atto e filosofia in atto, sola politica. L’opposizione Savonarola‑Machiavelli non è l’opposizione tra essere e dover essere (tutto il paragrafo del Russo su questo punto è pura belletristica) ma tra due dover essere, quello astratto e fumoso del Savonarola e quello realistico del Machiavelli, realistico anche se non diventato realtà immediata, poiché non si può attendere che un individuo o un libro mutino la realtà ma solo la interpretino e indichino la linea possibile dell’azione. Il limite e l’angustia del Machiavelli consistono solo nell’essere egli stato una «persona privata», uno scrittore e non il capo di uno Stato o di un esercito, che è pure una singola persona, ma avente a sua disposizione le forze di uno Stato o di un esercito e non solo eserciti di parole. Né perciò si può dire che il Machiavelli sia stato anche egli un «profeta disarmato»: sarebbe fare dello spirito a troppo buon mercato. Il Machiavelli non dice mai di pensare o di proporsi egli stesso di mutare la realtà, ma solo e concretamente di mostrare come avrebbero dovuto operare le forze storiche per essere efficienti.
Q13 §17 Analisi delle situazioni: rapporti di forza. È il problema dei rapporti tra struttura e superstrutture che bisogna impostare esattamente e risolvere per giungere a una giusta analisi delle forze che operano nella storia di un determinato periodo e determinare il loro rapporto. Occorre muoversi nell’ambito di due principii: 1) quello che nessuna società si pone dei compiti per la cui soluzione non esistano già le condizioni necessarie e sufficienti o esse non siano almeno in via di apparizione e di sviluppo; 2) e quello che nessuna società si dissolve e può essere sostituita se prima non ha svolto tutte le forme di vita che sono implicite nei suoi rapporti (controllare l’esatta enunciazione di questi principii).
«Una formazione sociale non perisce, prima che non siano sviluppate tutte le forze produttive per le quali essa è ancora sufficiente e nuovi più alti rapporti di produzione non ne abbiano preso il posto, prima che le condizioni materiali di esistenza di questi ultimi siano state covate nel seno stesso della vecchia società. Perciò l’umanità si pone sempre solo quei compiti che essa può risolvere; se si osserva con più accuratezza si troverà sempre che il compito stesso sorge solo dove le condizioni materiali della sua risoluzione esistono già o almeno sono nel processo del loro divenire» (Introduzione a Critica dell’Economia Politica).
Dalla riflessione su questi due canoni si può giungere allo svolgimento di tutta una serie di altri principii di metodologia storica. Intanto nello studio di una struttura occorre distinguere i movimenti organici (relativamente permanenti) da i movimenti che si possono chiamare di congiuntura (e si presentano come occasionali, immediati, quasi accidentali). I fenomeni di congiuntura sono certo dipendenti anch’essi da movimenti organici, ma il loro significato non è di vasta portata storica: essi danno luogo a una critica politica spicciola, del giorno per giorno, che investe i piccoli gruppi dirigenti e le personalità responsabili immediatamente del potere. I fenomeni organici danno luogo alla critica storico‑sociale, che investe i grandi aggruppamenti, di là dalle persone immediatamente responsabili e di là dal personale dirigente. Nello studiare un periodo storico appare la grande importanza di questa distinzione. Si verifica una crisi, che talvolta si prolunga per decine di anni. Questa durata eccezionale significa che nella struttura si sono rivelate (sono venute a maturità) contraddizioni insanabili e che le forze politiche operanti positivamente alla conservazione e difesa della struttura stessa si sforzano tuttavia di sanare entro certi limiti e di superare. Questi sforzi incessanti e perseveranti (poiché nessuna forma sociale vorrà mai confessare di essere superata) formano il terreno dell’«occasionale» sul quale si organizzano le forze antagonistiche che tendono a dimostrare (dimostrazione che in ultima analisi riesce solo ed è «vera» se diventa nuova realtà, se le forze antagonistiche trionfano, ma immediatamente si svolge in una serie di polemiche ideologiche, religiose, filosofiche, politiche, giuridiche ecc., la cui concretezza è valutabile dalla misura in cui riescono convincenti e spostano il preesistente schieramento delle forze sociali) che esistono già le condizioni necessarie e sufficienti perché determinati compiti possano e quindi debbano essere risolti storicamente (debbano, perché ogni venir meno al dovere storico aumenta il disordine necessario e prepara più gravi catastrofi).
L’errore in cui si cade spesso nelle analisi storico‑politiche consiste nel non saper trovare il giusto rapporto tra ciò che è organico e ciò che è occasionale: si riesce così o ad esporre come immediatamente operanti cause che invece sono operanti mediatamente, o ad affermare che le cause immediate sono le sole cause efficienti; nell’un caso si ha l’eccesso di «economismo» o di dottrinarismo pedantesco, dall’altro l’eccesso di «ideologismo», nell’un caso si sopravalutano le cause meccaniche; nell’altro si esalta l’elemento volontaristico e individuale. (La distinzione tra «movimenti» e fatti organici e movimenti e fatti di «congiuntura» o occasionali deve essere applicata a tutti i tipi di situazione, non solo a quelle in cui si verifica uno svolgimento regressivo o di crisi acuta, ma a quelle in cui si verifica uno svolgimento progressivo o di prosperità e a quelle in cui si verifica una stagnazione delle forze produttive). Il nesso dialettico tra i due ordini di movimento e quindi di ricerca difficilmente viene stabilito esattamente e se l’errore è grave nella storiografia, ancor più grave diventa nell’arte politica, quando si tratta non di ricostruire la storia passata ma di costruire quella presente e avvenire: i proprii desideri e le proprie passioni deteriori e immediate sono la causa dell’errore, in quanto essi sostituiscono l’analisi obbiettiva e imparziale e ciò avviene non come «mezzo» consapevole per stimolare all’azione ma come autoinganno. La biscia, anche in questo caso, morde il ciarlatano ossia il demagogo è la prima vittima della sua demagogia.
Il non aver considerato il momento immediato dei «rapporti di forza» è connesso a residui della concezione liberale volgare, di cui il sindacalismo è una manifestazione che credeva di essere più avanzata in quanto faceva realmente un passo indietro. Infatti la concezione liberale volgare dando importanza al rapporto delle forze politiche organizzate nelle diverse forme di partito (lettori di giornali, elezioni parlamentari e locali, organizzazione di massa dei partiti e dei sindacati in senso stretto) era più avanzata del sindacalismo che dava importanza primordiale al rapporto fondamentale economico‑sociale e solo a questo. La concezione liberale volgare teneva conto implicito anche di tale rapporto (come appare da tanti segni) ma insisteva di più sul rapporto delle forze politiche che era un’espressione dell’altro e in realtà lo conteneva. Questi residui della concezione liberale volgare si possono rintracciare in tutta una serie di trattazioni che si dicono connesse alla filosofia della prassi e hanno dato luogo a forme infantili di ottimismo e di scempiaggine.
Questi criteri metodologici possono acquistare visibilmente e didatticamente tutto il loro significato se applicati all’esame di fatti storici concreti. Si potrebbe farlo utilmente per gli avvenimenti che si svolsero in Francia dal 1789 al 1870. Mi pare che per maggior chiarezza dell’esposizione sia proprio necessario abbracciare tutto questo periodo. Infatti solo nel 1870‑71, col tentativo comunalistico si esauriscono storicamente tutti i germi nati nel 1789 cioè non solo la nuova classe che lotta per il potere sconfigge i rappresentanti della vecchia società che non vuole confessarsi decisamente superata, ma sconfigge anche i gruppi nuovissimi che sostengono già superata la nuova struttura sorta dal rivolgimento iniziatosi nel 1789 e dimostra così di essere vitale e in confronto al vecchio e in confronto al nuovissimo. Inoltre, col 1870‑71, perde efficacia l’insieme di principii di strategia e tattica politica nati praticamente nel 1789 e sviluppati ideologicamente intorno al 48 (quelli che si riassumono nella formula della «rivoluzione permanente»: sarebbe interessante studiare quanto di tale formula è passata nella strategia mazziniana – per es. per l’insurrezione di Milano del 1853 – e se è avvenuto consapevolmente o meno). Un elemento che mostra la giustezza di questo punto di vista è il fatto che gli storici non sono per nulla concordi (ed è impossibile che lo siano) nel fissare i limiti di quel gruppo di avvenimenti che costituisce la rivoluzione francese. Per alcuni (per es. il Salvemini) la rivoluzione è compiuta a Valmy: la Francia ha creato un nuovo Stato e ha saputo organizzare la forza politico‑militare che ne afferma e ne difende la sovranità territoriale. Per altri la Rivoluzione continua fino al Termidoro, anzi essi parlano di più rivoluzioni (il 10 agosto sarebbe una rivoluzione a sé ecc.; cfr la Rivoluzione francese di A. Mathiez nella collezione Colin). Il modo di interpretare il Termidoro e l’opera di Napoleone offre le più aspre contradizioni: si tratta di rivoluzione o di controrivoluzione? ecc. Per altri la storia della Rivoluzione continua fino al 1830, 1848, 1870 e persino fino alla guerra mondiale del 1914.
In tutti questi modi di vedere c’è una parte di verità. Realmente le contraddizioni interne della struttura sociale francese che si sviluppano dopo il 1789 trovano una loro relativa composizione solo con la terza repubblica e la Francia ha 60 anni di vita politica equilibrata dopo 80 anni di rivolgimenti a ondate sempre più lunghe: 89‑94‑99‑1804-1815‑1830‑1848‑1870. È appunto lo studio di queste «ondate» a diversa oscillazione che permette di ricostruire i rapporti tra struttura e superstruttura da una parte e dall’altra tra lo svolgersi del movimento organico e quello del movimento di congiuntura della struttura. Si può dire intanto che la mediazione dialettica tra i due principii metodologici enunziati all’inizio di questa nota si può trovare nella formula politico‑storica di rivoluzione permanente.
Un aspetto dello stesso problema è la quistione così detta dei rapporti di forza. Si legge spesso nelle narrazioni storiche l’espressione generica: rapporti di forza favorevoli, sfavorevoli a questa o a quella tendenza. Così, astrattamente, questa formulazione non spiega nulla o quasi nulla, perché non si fa che ripetere il fatto che si deve spiegare presentandolo una volta come fatto e una volta come legge astratta e come spiegazione. L’errore teorico consiste dunque nel dare un canone di ricerca e di interpretazione come «causa storica».
Intanto nel «rapporto di forza» occorre distinguere diversi momenti o gradi, che fondamentalmente sono questi:
1) Un rapporto di forze sociali strettamente legato alla struttura, obbiettivo, indipendente dalla volontà degli uomini, che può essere misurato coi sistemi delle scienze esatte o fisiche. Sulla base del grado di sviluppo delle forze materiali di produzione si hanno i raggruppamenti sociali, ognuno dei quali rappresenta una funzione e ha una posizione data nella produzione stessa. Questo rapporto è quello che è, una realtà ribelle: nessuno può modificare il numero delle aziende e dei suoi addetti, il numero delle città con la data popolazione urbana ecc. Questo schieramento fondamentale permette di studiare se nella società esistono le condizioni necessarie e sufficienti per una sua trasformazione, permette cioè di controllare il grado di realismo e di attuabilità delle diverse ideologie che sono nate nel suo stesso terreno, nel terreno delle contraddizioni che esso ha generato durante il suo sviluppo.
2) Un momento successivo è il rapporto delle forze politiche, cioè la valutazione del grado di omogeneità, di autocoscienza e di organizzazione raggiunto dai vari gruppi sociali. Questo momento può essere a sua volta analizzato e distinto in vari gradi, che corrispondono ai diversi momenti della coscienza politica collettiva, così come si sono manifestati finora nella storia. Il primo e più elementare è quello economico‑corporativo: un commerciante sente di dover essere solidale con un altro commerciante, un fabbricante con un altro fabbricante, ecc., ma il commerciante non si sente ancora solidale col fabbricante; è cioè sentita l’unità omogenea, e il dovere di organizzarla, del gruppo professionale, ma non ancora del gruppo sociale più vasto. Un secondo momento è quello in cui si raggiunge la coscienza della solidarietà di interessi fra tutti i membri del gruppo sociale, ma ancora nel campo meramente economico. Già in questo momento si pone la quistione dello Stato, ma solo nel terreno di raggiungere una eguaglianza politico‑giuridica coi gruppi dominanti, poiché si rivendica il diritto di partecipare alla legislazione e all’amministrazione e magari di modificarle, di riformarle, ma nei quadri fondamentali esistenti. Un terzo momento è quello in cui si raggiunge la coscienza che i propri interessi corporativi, nel loro sviluppo attuale e avvenire, superano la cerchia corporativa, di gruppo meramente economico, e possono e debbono divenire gli interessi di altri gruppi subordinati. Questa è la fase più schiettamente politica, che segna il netto passaggio dalla struttura alla sfera delle superstrutture complesse, è la fase in cui le ideologie germinate precedentemente diventano «partito», vengono a confronto ed entrano in lotta fino a che una sola di esse o almeno una sola combinazione di esse, tende a prevalere, a imporsi, a diffondersi su tutta l’area sociale, determinando oltre che l’unicità dei fini economici e politici, anche l’unità intellettuale e morale, ponendo tutte le quistioni intorno a cui ferve la lotta non sul piano corporativo ma su un piano «universale» e creando così l’egemonia di un gruppo sociale fondamentale su una serie di gruppi subordinati. Lo Stato è concepito sì come organismo proprio di un gruppo, destinato a creare le condizioni favorevoli alla massima espansione del gruppo stesso, ma questo sviluppo e questa espansione sono concepiti e presentati come la forza motrice di una espansione universale, di uno sviluppo di tutte le energie «nazionali», cioè il gruppo dominante viene coordinato concretamente con gli interessi generali dei gruppi subordinati e la vita statale viene concepita come un continuo formarsi e superarsi di equilibri instabili (nell’ambito della legge) tra gli interessi del gruppo fondamentale e quelli dei gruppi subordinati, equilibrii in cui gli interessi del gruppo dominante prevalgono ma fino a un certo punto, non cioè fino al gretto interesse economico‑corporativo. Nella storia reale questi momenti si implicano reciprocamente, per così dire orizzontalmente e verticalmente, cioè secondo le attività economico‑ sociali (orizzontali) e secondo i territori (verticalmente), combinandosi e scindendosi variamente: ognuna di queste combinazioni può essere rappresentata da una propria espressione organizzata economica e politica. Ancora bisogna tener conto che a questi rapporti interni di uno Stato‑nazione si intrecciano i rapporti internazionali, creando nuove combinazioni originali e storicamente concrete. Una ideologia, nata in un paese più sviluppato, si diffonde in paesi meno sviluppati, incidendo nel gioco locale delle combinazioni. (La religione, per es., è sempre stata una fonte di tali combinazioni ideologico‑politiche nazionali e internazionali, e con la religione le altre formazioni internazionali, la massoneria, il Rotary Club, gli ebrei, la diplomazia di carriera che suggeriscono espedienti politici di origine storica diversa e li fanno trionfare in determinati paesi, funzionando come partito politico internazionale che opera in ogni nazione con tutte le sue forze internazionali concentrate; ma religione, massoneria, Rotary, ebrei ecc., possono rientrare nella categoria sociale degli «intellettuali», la cui funzione, su scala internazionale, è quella di mediare gli estremi, di «socializzare» i ritrovati tecnici che fanno funzionare ogni attività di direzione, di escogitare compromessi e vie d’uscita tra le soluzioni estreme). Questo rapporto tra forze internazionali e forze nazionali è ancora complicato dall’esistenza nell’interno di ogni Stato di parecchie sezioni territoriali di diversa struttura e di diverso rapporto di forza in tutti i gradi (così la Vandea era alleata con le forze internazionali reazionarie e le rappresentava nel seno dell’unità territoriale francese; così Lione nella Rivoluzione Francese rappresentava un nodo particolare di rapporti ecc.).
3) Il terzo momento è quello del rapporto delle forze militari, immediatamente decisivo volta per volta. (Lo sviluppo storico oscilla continuamente tra il primo e il terzo momento, con la mediazione del secondo). Ma anche esso non è qualcosa di indistinto e di identificabile immediatamente in forma schematica; si possono anche in esso distinguere due gradi: quello militare in senso stretto o tecnico‑militare e il grado che si può chiamare politico‑militare. Nello sviluppo della storia questi due gradi si sono presentati in una grande varietà di combinazioni. Un esempio tipico che può servire come dimostrazione‑limite, è quello del rapporto di oppressione militare di uno Stato su una nazione che cerca di raggiungere la sua indipendenza statale. Il rapporto non è puramente militare, ma politico‑militare e infatti un tale tipo di oppressione sarebbe inspiegabile senza lo stato di disgregazione sociale del popolo oppresso e la passività della sua maggioranza; pertanto l’indipendenza non potrà essere raggiunta con forze puramente militari, ma militari e politico‑militari. Se la nazione oppressa, infatti, per iniziare la lotta d’indipendenza, dovesse attendere che lo Stato egemone le permetta di organizzare un proprio esercito nel senso stretto e tecnico della parola, avrebbe da attendere un pezzo (può avvenire che la rivendicazione di avere un proprio esercito sia soddisfatta dalla nazione egemone, ma ciò significa che già una gran parte della lotta è stata combattuta e vinta sul terreno politico‑militare). La nazione oppressa opporrà dunque inizialmente alla forza militare egemone una forza che è solo «politico‑militare», cioè opporrà una forma di azione politica che abbia la virtù di determinare riflessi di carattere militare nel senso: 1) che abbia efficacia di disgregare intimamente l’efficienza bellica della nazione egemone; 2) che costringa la forza militare egemone a diluirsi e disperdersi in un grande territorio, annullandone gran parte dell’efficienza bellica. Nel Risorgimento italiano si può notare l’assenza disastrosa di una direzione politico-militare specialmente nel Partito d’Azione (per congenita incapacità), ma anche nel partito piemontese‑moderato sia prima che dopo il 1848 non certo per incapacità ma per «maltusianismo economico‑politico», cioè perché non si volle neanche accennare alla possibilità di una riforma agraria e perché non si voleva la convocazione di una assemblea nazionale costituente, ma si tendeva solo a che la monarchia piemontese, senza condizioni o limitazioni di origine popolare, si estendesse a tutta Italia, con la pura sanzione di plebisciti regionali.
Altra quistione connessa alle precedenti è quella di vedere se le crisi storiche fondamentali sono determinate immediatamente dalle crisi economiche. La risposta alla quistione è contenuta implicitamente nei paragrafi precedenti, dove sono trattate quistioni che sono un altro modo di presentare quella ora trattata, tuttavia è sempre necessario, per ragioni didattiche, dato il pubblico particolare, esaminare ogni modo di presentarsi di una stessa quistione come fosse un problema indipendente e nuovo. Si può escludere che, di per se stesse, le crisi economiche immediate producano eventi fondamentali; solo possono creare un terreno più favorevole alla diffusione di certi modi di pensare, di impostare e risolvere le quistioni che coinvolgono tutto l’ulteriore sviluppo della vita statale. Del resto, tutte le affermazioni che riguardano i periodi di crisi o di prosperità possono dar luogo a giudizi unilaterali. Nel suo compendio di storia della Rivoluzione francese (ed. Colin) il Mathiez, opponendosi alla storia volgare tradizionale, che aprioristicamente «trova» una crisi in coincidenza con le grandi rotture di equilibri sociali, afferma che verso il 1789 la situazione economica era piuttosto buona immediatamente, per cui non si può dire che la catastrofe dello Stato assoluto sia dovuta a una crisi di immiserimento (cfr l’affermazione esatta del Mathiez). Occorre osservare che lo Stato era in preda a una mortale crisi finanziaria e si poneva la quistione su quale dei tre ordini sociali privilegiati dovevano cadere i sacrifizi e i pesi per rimettere in sesto le finanze statali e regali. Inoltre: se la posizione economica della borghesia era florida, certamente non era buona la situazione delle classi popolari delle città e delle campagne, specialmente di queste, tormentate da miseria endemica. In ogni caso, la rottura dell’equilibrio delle forze non avvenne per cause meccaniche immediate di immiserimento del gruppo sociale che aveva interesse a rompere l’equilibrio e di fatto lo ruppe, ma avvenne nel quadro di conflitti superiori al mondo economico immediato, connessi al «prestigio» di classe (interessi economici avvenire), ad una esasperazione del sentimento di indipendenza, di autonomia e di potere. La quistione particolare del malessere o benessere economico come causa di nuove realtà storiche è un aspetto parziale della quistione dei rapporti di forza nei loro vari gradi. Possono prodursi novità sia perché una situazione di benessere è minacciata dal gretto egoismo di un gruppo avversario, come perché il malessere è diventato intollerabile e non si vede nella vecchia società nessuna forza che sia capace di mitigarlo e di ristabilire una normalità con mezzi legali. Si può dire pertanto che tutti questi elementi sono la manifestazione concreta delle fluttuazioni di congiuntura dell’insieme dei rapporti sociali di forza, nel cui terreno avviene il passaggio di questi a rapporti politici di forza per culminare nel rapporto militare decisivo. Se manca questo processo di sviluppo da un momento all’altro, ed esso è essenzialmente un processo che ha per attori gli uomini e la volontà e capacità degli uomini, la situazione rimane inoperosa, e possono darsi conclusioni contradditorie: la vecchia società resiste e si assicura un periodo di «respiro», sterminando fisicamente l’élite avversaria e terrorizzando le masse di riserva, oppure anche la distruzione reciproca delle forze in conflitto con l’instaurazione della pace dei cimiteri, magari sotto la vigilanza di una sentinella straniera.
Ma l’osservazione più importante da fare a proposito di ogni analisi concreta dei rapporti di forza è questa: che tali analisi non possono e non debbono essere fine a se stesse (a meno che non si scriva un capitolo di storia del passato) ma acquistano un significato solo se servono a giustificare una attività pratica, una iniziativa di volontà.
Esse mostrano quali sono i punti di minore resistenza, dove la forza della volontà può essere applicata più fruttuosamente, suggeriscono le operazioni tattiche immediate, indicano come si può meglio impostare una campagna di agitazione politica, quale linguaggio sarà meglio compreso dalle moltitudini ecc. L’elemento decisivo di ogni situazione è la forza permanentemente organizzata e predisposta di lunga mano che si può fare avanzare quando si giudica che una situazione è favorevole (ed è favorevole solo in quanto una tale forza esista e sia piena di ardore combattivo); perciò il compito essenziale è quello di attendere sistematicamente e pazientemente a formare, sviluppare, rendere sempre più omogenea, compatta, consapevole di se stessa questa forza. Ciò si vede nella storia militare e nella cura con cui in ogni tempo sono stati predisposti gli eserciti ad iniziare una guerra in qualsiasi momento. I grandi Stati sono stati grandi Stati appunto perché erano in ogni momento preparati a inserirsi efficacemente nelle congiunture internazionali favorevoli e queste erano tali perché c’era la possibilità concreta di inserirsi efficacemente in esse.
Q13 §18 Alcuni aspetti teorici e pratici dell’«economismo». Economismo ‑ movimento teorico per il libero scambio ‑ sindacalismo teorico. È da vedere in che misura il sindacalismo teorico abbia avuto origine dalla filosofia della praxis e in quanto dalle dottrine economiche del libero scambio, cioè, in ultima analisi, dal liberalismo. E perciò è da vedere se l’economismo, nella sua forma più compiuta, non sia una filiazione diretta del liberalismo e abbia avuto, anche alle origini, ben pochi rapporti colla filosofia della praxis, rapporti in ogni modo solo estrinseci e puramente verbali. Da questo punto di vista è da vedere la polemica Einaudi‑Croce, determinata dalla prefazione nuova (del 1917) al volume sul Materialismo storico: la esigenza, prospettata dall’Einaudi, di tener conto della letteratura di storia economica suscitata dall’economia classica inglese, può essere soddisfatta in questo senso, che una tale letteratura, per una contaminazione superficiale con la filosofia della praxis, ha originato l’economismo; perciò quando l’Einaudi critica (in modo, a dir vero, impreciso) alcune degenerazioni economistiche, non fa altro che tirare sassi in piccionaia. Il nesso tra ideologie libero‑scambiste e sindacalismo teorico è specialmente evidente in Italia, dove sono l’ammirazione per Pareto dei sindacalisti come Lanzillo e C. Il significato di queste due tendenze è però molto diverso: il primo è proprio di un gruppo sociale dominante e dirigente, il secondo di un gruppo ancora subalterno, che non ha ancora acquistato coscienza della sua forza e delle sue possibilità e modi di sviluppo e non sa perciò uscire dalla fase di primitivismo. L’impostazione del movimento del libero scambio si basa su un errore teorico di cui non è difficile identificare l’origine pratica: sulla distinzione cioè tra società politica e società civile, che da distinzione metodica viene fatta diventare ed è presentata come distinzione organica. Così si afferma che l’attività economica è propria della società civile e che lo Stato non deve intervenire nella sua regolamentazione. Ma siccome nella realtà effettuale società civile e Stato si identificano, è da fissare che anche il liberismo è una «regolamentazione» di carattere statale, introdotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva: è un fatto di volontà consapevole dei propri fini e non l’espressione spontanea, automatica del fatto economico. Pertanto il liberismo è un programma politico, destinato a mutare, in quanto trionfa, il personale dirigente di uno Stato e il programma economico dello Stato stesso, cioè a mutare la distribuzione del reddito nazionale. Diverso è il caso del sindacalismo teorico, in quanto si riferisce a un gruppo subalterno, al quale con questa teoria si impedisce di diventare mai dominante, di svilupparsi oltre la fase economico‑corporativa per elevarsi alla fase di egemonia etico‑politica nella società civile e dominante nello Stato. Per ciò che riguarda il liberismo si ha il caso di una frazione del gruppo dirigente che vuole modificare non la struttura dello Stato, ma solo l’indirizzo di governo, che vuole riformare la legislazione commerciale e solo indirettamente industriale (poiché è innegabile che il protezionismo, specialmente nei paesi a mercato povero e ristretto, limita la libertà di iniziativa industriale e favorisce morbosamente il nascere dei monopoli): si tratta di rotazione dei partiti dirigenti al governo, non di fondazione e organizzazione di una nuova società politica e tanto meno di un nuovo tipo di società civile. Nel movimento del sindacalismo teorico la quistione si presenta più complessa: è innegabile che in esso l’indipendenza e l’autonomia del gruppo subalterno che si dice di esprimere sono invece sacrificate all’egemonia intellettuale del gruppo dominante, poiché appunto il sindacalismo teorico non è che un aspetto del liberismo, giustificato con alcune affermazioni mutilate, e pertanto banalizzate, della filosofia della praxis. Perché e come avviene questo «sacrifizio»? Si esclude la trasformazione del gruppo subordinato in dominante, o perché il problema non è neppure prospettato (fabianesimo, De Man, parte notevole del laburismo) o perché è presentato in forme incongrue e inefficienti (tendenze socialdemocratiche in generale) o perché si afferma il salto immediato dal regime dei gruppi a quello della perfetta eguaglianza e dell’econornia sindacale.
È per lo meno strano l’atteggiamento dell’economismo verso le espressioni di volontà, di azione e di iniziativa politica e intellettuale, come se queste non fossero una emanazione organica di necessità economiche e anzi la sola espressione efficiente dell’economia; così è incongruo che l’impostazione concreta della quistione egemonica sia interpretata come un fatto che subordina il gruppo egemone. Il fatto dell’egemonia presuppone indubbiamente che sia tenuto conto degli interessi e delle tendenze dei gruppi sui quali l’egemonia verrà esercitata, che si formi un certo equilibrio di compromesso, che cioè il gruppo dirigente faccia dei sacrifizi di ordine economico‑corporativo, ma è anche indubbio che tali sacrifizi e tale compromesso non possono riguardare l’essenziale, poiché se l’egemonia è etico‑politica, non può non essere anche economica, non può non avere il suo fondamento nella funzione decisiva che il gruppo dirigente esercita nel nucleo decisivo dell’attività economica.
L’economismo si presenta sotto molte altre forme oltre che il liberismo e il sindacalismo teorico. Gli appartengono tutte le forme di astensionismo elettorale (esempio tipico l’astensionismo dei clericali italiani dopo il 1870, dopo il 1900 sempre più attenuato, fino al 1919 e alla formazione del Partito popolare: la distinzione organica che i clericali facevano tra Italia reale e Italia legale era una riproduzione della distinzione tra mondo economico e mondo politico‑legale), che sono molte, nel senso che può esserci semi‑astensionismo, un quarto ecc. All’astensionismo è legata la formula del «tanto peggio, tanto meglio» e anche la formula della così detta «intransigenza» parlamentare di alcune frazioni di deputati. Non sempre l’economismo è contrario all’azione politica e al partito politico, che viene però considerato mero organismo educativo di tipo sindacale.
Un punto di riferimento per lo studio dell’economismo e per comprendere i rapporti tra struttura e superstrutture è quel passaggio della Miseria della Filosofia dove si dice che una fase importante nello sviluppo di un gruppo sociale è quella in cui i singoli componenti di un sindacato non lottano solo più per i loro interessi economici, ma per la difesa e lo sviluppo dell’organizzazione stessa (vedere la affermazione esatta; la Miseria della Filosofia è un momento essenziale nella formazione della filosofia della praxis; essa può essere considerata come lo svolgimento delle Tesi su Feuerbach, mentre la Sacra Famiglia è una fase intermedia indistinta e di origine occasionale, come appare dai brani dedicati al Proudhon e specialmente al materialismo francese. Il brano sul materialismo francese è più che altro un capitolo di storia della cultura e non un brano teoretico, come spesso viene interpretato, e come storia della cultura è ammirevole. Ricordare l’osservazione che la critica contenuta nella Miseria della Filosofia contro Proudhon e la sua interpretazione della dialettica hegeliana può essere estesa al Gioberti e allo hegelismo dei liberali moderati italiani in genere. Il parallelo Proudhon‑Gioberti, nonostante rappresentino fasi storico‑politiche non omogenee, anzi appunto per questo, può essere interessante e fecondo). È da ricordare insieme l’affermazione di Engels che l’economia solo in «ultima analisi» è la molla della storia (nelle due lettere sulla filosofia della praxis pubblicate anche in italiano) da collegarsi direttamente al passo della prefazione della Critica dell’Economia politica, dove si dice che gli uomini diventano consapevoli dei conflitti che si verificano nel mondo economico sul terreno delle ideologie.
In varie occasioni è affermato in queste che la filosofia della praxis è molto più diffusa di quanto non si voglia concedere. L’affermazione è esatta se si intende che è diffuso l’economismo storico, come il prof. Loria chiama ora le sue concezioni più o meno sgangherate, e che pertanto l’ambiente culturale è completamente mutato dal tempo in cui la filosofia della praxis iniziò le sue lotte; si potrebbe dire, con terminologia crociana, che la più grande eresia sorta nel seno della «religione della libertà» ha anch’essa, come la religione ortodossa, subito una degenerazione, si è diffusa come «superstizione» cioè è entrata in combinazione col liberismo e ha prodotto l’economismo. È da vedere però se, mentre la religione ortodossa si è ormai imbozzacchita, la superstizione eretica non abbia sempre mantenuto un fermento che la farà rinascere come religione superiore, se cioè le scorie di superstizione non siano facilmente liquidabili.
Alcuni punti caratteristici dell’economismo storico: 1) nella ricerca dei nessi storici non si distingue ciò che è «relativamente permanente» da ciò che è fluttuazione occasionale e si intende per fatto economico l’interesse personale e di piccolo gruppo, in senso immediato e «sordidamente giudaico». Non si tiene conto cioè delle formazioni di classe economica, con tutti i rapporti inerenti, ma si assume l’interesse gretto e usurario, specialmente quando coincide con forme delittuose contemplate dai codici criminali; 2) la dottrina per cui lo svolgimento economico viene ridotto al susseguirsi dei cangiamenti tecnici negli strumenti di lavoro. Il prof. Loria ha fatto un’esposizione brillantissima di questa dottrina applicata nell’articolo sull’influsso sociale dell’aeroplano, pubblicato nella «Rassegna contemporanea» del 1912; 3) la dottrina per cui lo svolgimento economico e storico viene fatto dipendere immediatamente dai mutamenti di un qualche elemento importante della produzione, la scoperta di una nuova materia prima, di un nuovo combustibile ecc., che portano con sé l’applicazione di nuovi metodi nella costruzione e nell’azionamento delle macchine. In questi ultimi tempi c’è tutta una letteratura sul petrolio: si può vedere come tipico un articolo di Antonino Laviosa nella Nuova Antologia del 1929. La scoperta di nuovi combustibili e di nuove energie motrici, come di nuove materie prime da trasformare, hanno certo grande importanza, perché può mutare la posizione dei singoli Stati, ma non determina il moto storico ecc.
Avviene spesso che si combatte l’economismo storico, credendo di combattere il materialismo storico. È questo il caso, per esempio, di un articolo dell’«Avenir» di Parigi del 10 ottobre 1930 (riportato nella «Rassegna Settimanale della Stampa Estera» del 21 ottobre 1930, pp. 2303‑4) e che si riporta come tipico: «Ci si dice da molto tempo, ma sopratutto dopo la guerra, che le quistioni d’interesse dominano i popoli e portano avanti il mondo. Sono i marxisti che hanno inventato questa tesi, sotto l’appellativo un po’ dottrinario di “materialismo storico”. Nel marxismo puro, gli uomini presi in massa non obbediscono alle passioni, ma alle necessità economiche. La politica è una passione. La Patria è una passione. Queste due idee esigenti non godono nella storia che una funzione di apparenza perché in realtà la vita dei popoli, nel corso dei secoli, si spiega con un gioco cangiante e sempre rinnovato di cause di ordine materiale. L’economia è tutto. Molti filosofi ed economisti “borghesi” hanno ripreso questo ritornello. Essi assumono una certa aria da spiegarci col corso del grano, dei petroli o del caucciù, la grande politica internazionale. Essi si ingegnano a dimostrarci che tutta la diplomazia è comandata da quistioni di tariffe doganali e di prezzi di costo. Queste spiegazioni sono molto in auge. Esse hanno una piccola apparenza scientifica e procedono da una specie di scetticismo superiore che vorrebbe passare per una eleganza suprema. La passione in politica estera? Il sentimento in materia nazionale? Suvvia! Questa roba è buona per la gente comune. I grandi spiriti, gli iniziati sanno che tutto è dominato dal dare e dall’avere. Ora questa è una pseudo‑verità assoluta. È completamente falso che i popoli non si lasciano guidare che da considerazioni di interesse ed è completamente vero che essi obbediscono più che mai al sentimento. Il materialismo storico è una buona scemenza. Le nazioni obbediscono sopratutto a delle considerazioni dettate da un desiderio e da una fede ardente di prestigio. Chi non comprende questo non comprende nulla». La continuazione dell’articolo (intitolato La mania del prestigio) esemplifica con la politica tedesca e italiana, che sarebbe di «prestigio» e non dettata da interessi materiali. L’articolo racchiude in breve una gran parte degli spunti più banali di polemica contro la filosofia della praxis, ma in realtà la polemica è contro l’economismo sgangherato di tipo loriano. D’altronde lo scrittore non è molto ferrato in argomento anche per altri rispetti: egli non capisce che le «passioni» possono essere niente altro che un sinonimo degli interessi economici e che è difficile sostenere essere l’attività politica uno stato permanente di esasperazione passionale e di spasimo; proprio la politica francese è presentata come una «razionalità» sistematica e coerente, cioè depurata di ogni elemento passionale ecc.
Nella sua forma più diffusa di superstizione economistica, la filosofia della praxis perde una gran parte della sua espansività culturale nella sfera superiore del gruppo intellettuale, per quanta ne acquista tra le masse popolari e tra gli intellettuali di mezza tacca, che non intendono affaticarsi il cervello ma vogliono apparire furbissimi ecc. Come scrisse Engels, fa molto comodo a molti credere di poter avere, a poco prezzo e con nessuna fatica, in saccoccia, tutta la storia e tutta la sapienza politica e filosofica concentrata in qualche formuletta. Avendo dimenticato che la tesi secondo cui gli uomini acquistano coscienza dei conflitti fondamentali nel terreno delle ideologie non è di carattere psicologico o moralistico, ma ha un carattere organico gnoseologico, si è creata la forma mentis di considerare la politica e quindi la storia come un continuo marché de dupes, un gioco di illusionismi e di prestidigitazione. L’attività «critica» si è ridotta a svelare trucchi, a suscitare scandali, a fare i conti in tasca agli uomini rappresentativi.
Si è così dimenticato che essendo o presumendo di essere anche l’«economismo» un canone obbiettivo di interpretazione (obbiettivo‑scientifico), la ricerca nel senso degli interessi immediati dovrebbe esser valida per tutti gli aspetti della storia, per gli uomini che rappresentano la «tesi» come per quelli che rappresentano l’«antitesi». Si è dimenticato inoltre un’altra proposizione della filosofia della praxis: quella che le «credenze popolari» o le credenze del tipo delle credenze popolari hanno la validità delle forze materiali.
Gli errori di interpretazione nel senso delle ricerche degli interessi «sordidamente giudaici» sono stati talvolta grossolani e comici e hanno così reagito negativamente sul prestigio della dottrina originaria. Occorre perciò combattere l’economismo non solo nella teoria della storiografia, ma anche e specialmente nella teoria e nella pratica politica. In questo campo la lotta può e deve essere condotta sviluppando il concetto di egemonia, così come è stata condotta praticamente nello sviluppo della teoria del partito politico e nello sviluppo pratico della vita di determinati partiti politici (la lotta contro la teoria della così detta rivoluzione permanente, cui si contrapponeva il concetto di dittatura democratico‑rivoluzionaria, importanza avuta dal sostegno dato alle ideologie costituentiste ecc.). Si potrebbe fare una ricerca sui giudizi emessi a mano a mano che si sviluppavano certi movimenti politici, prendendo come tipo il movimento boulangista (dal 1886 al 1890 circa), o il processo Dreyfus o addirittura il colpo di Stato del 2 dicembre (un’analisi del libro classico sul 2 dicembre, per studiare quale importanza relativa vi si dà al fattore economico immediato e quale posto invece vi abbia lo studio concreto delle «ideologie»). Di fronte a questo evento, l’economismo si pone la domanda: a chi giova immediatamente l’iniziativa in quistione? e risponde con un ragionamento tanto semplicistico quanto paralogistico. Giova immediatamente a una certa frazione del gruppo dominante e per non sbagliare questa scelta cade su quella frazione che evidentemente ha una funzione progressiva e di controllo sull’insieme delle forze economiche. Si può esser sicuri di non sbagliare, perché necessariamente, se il movimento preso in esame andrà al potere, prima o poi la frazione progressiva del gruppo dominante finirà col controllare il nuovo governo e col farsene uno strumento per rivolgere a proprio benefizio l’apparato statale. Si tratta adunque di una infallibilità molto a buon mercato e che non solo non ha significato teorico, ma ha scarsissima portata politica ed efficacia pratica: in generale non produce altro che prediche moralistiche e quistioni personali interminabili.
Quando un movimento di tipo boulangista si produce, l’analisi dovrebbe realisticamente essere condotta secondo questa linea: 1) contenuto sociale della massa che aderisce al movimento; 2) questa massa che funzione aveva nell’equilibrio di forze che va trasformandosi come il nuovo movimento dimostra col suo stesso nascere? 3) le rivendicazioni che i dirigenti presentano e che trovano consenso quale significato hanno politicamente e socialmente? a quali esigenze effettive corrispondono? 4) esame della conformità dei mezzi al fine proposto; 5) solo in ultima analisi e presentata in forma politica e non moralistica si prospetta l’ipotesi che tale movimento necessariamente verrà snaturato e servirà a ben altri fini da quelli che le moltitudini seguaci se ne attendono. Invece questa ipotesi viene affermata preventivamente, quando nessun elemento concreto (che cioè appaia tale con l’evidenza del senso comune e non per una analisi «scientifica» esoterica) esiste ancora per suffragarla, così che essa appare come un’accusa moralistica di doppiezza e di malafede o di poca furberia, di stupidaggine (per i seguaci). La lotta politica così diventa una serie di fatti personali tra chi la sa lunga, avendo il diavolo nell’ampolla, e chi è preso in giro dai propri dirigenti e non vuole convincersene per la sua inguaribile buaggine.
D’altronde, finché questi movimenti non hanno raggiunto il potere, si può sempre pensare che essi falliscano e alcuni infatti sono falliti (il boulangismo stesso, che è fallito come tale ed è poi stato schiacciato definitivamente col movimento dreyfusardo, il movimento di Giorgio Valois, quello del Generale Gayda); la ricerca deve quindi dirigersi all’identificazione degli elementi di forza, ma anche degli elementi di debolezza che essi contengono nel loro intimo: l’ipotesi «economistica» afferma un elemento immediato di forza, cioè la disponibilità di un certo apporto finanziario diretto o indiretto (un grande giornale che appoggi il movimento è anche esso un apporto finanziario indiretto) e basta. Troppo poco.
Anche in questo caso l’analisi dei diversi gradi di rapporto delle forze non può culminare che nella sfera dell’egemonia e dei rapporti etico‑politici.
Q13 §19 Elementi per calcolare la gerarchia di potenza fra gli Stati: 1) estensione del territorio, 2) forza economica, 3) forza militare. Il modo in cui si esprime l’essere grande potenza è dato dalla possibilità di imprimere alla attività statale una direzione autonoma, di cui gli altri Stati devono subire l’influsso e la ripercussione: la grande potenza è potenza egemone, capo e guida di un sistema di alleanze e di intese di maggiore o minore estensione. La forza militare riassume il valore dell’estensione territoriale (con popolazione adeguata, naturalmente) e del potenziale economico. Nell’elemento territoriale è da considerare in concreto la posizione geografica. Nella forza economica è da distinguere la capacità industriale e agricola (forze produttive) dalla capacità finanziaria. Un elemento «imponderabile» è la posizione «ideologica» che un paese occupa nel mondo in ogni momento dato, in quanto ritenuto rappresentante delle forze progressive della storia (esempio della Francia durante la Rivoluzione del 1789 e il periodo napoleonico).
Questi elementi sono calcolati nella prospettiva di una guerra. Avere tutti gli elementi che, nei limiti del prevedibile, danno sicurezza di vittoria, significa avere un potenziale di pressione diplomatica da grande potenza, cioè significa ottenere una parte dei risultati di una guerra vittoriosa senza bisogno di combattere.
Q13 §20 Charles Benoist nella prefazione al Le Machiavélisme, Prima parte: Avant Machiavel (Parigi, Plon, 1907) scrive: «C’è machiavellismo e machiavellismo: c’è un machiavellismo vero e un machiavellismo falso; vi è un machiavellismo che è di Machiavelli e un machiavellismo che è qualche volta dei discepoli, più spesso dei nemici di Machiavelli; sono già due, anzi tre machiavellismi, quello di Machiavelli, quello dei machiavellisti, e quello degli antimachiavellisti; ma eccone un quarto: quello di coloro che non han mai letto una riga di Machiavelli e che si servono a sproposito dei verbi (!), dei sostantivi e degli aggettivi derivati dal suo nome. Machiavelli perciò non dovrebbe essere tenuto responsabile di quel che dopo di lui il primo o l’ultimo venuto si sono compiaciuti di fargli dire» Un po’ allumacato, il signor Carlo Benoist.
La innovazione fondamentale introdotta dalla filosofia della praxis nella scienza della politica e della storia è la dimostrazione che non esiste una astratta «natura umana» fissa e immutabile (concetto che deriva certo dal pensiero religioso e dalla trascendenza) ma che la natura umana è l’insieme dei rapporti sociali storicamente determinati, cioè un fatto storico accertabile, entro certi limiti, coi metodi della filologia e della critica. Pertanto la scienza politica deve essere concepita nel suo contenuto concreto (e anche nella sua formulazione logica) come un organismo in sviluppo. È da osservare tuttavia che l’impostazione data dal Machiavelli alla quistione della politica (e cioè l’affermazione implicita nei suoi scritti che la politica è una attività autonoma che ha suoi principii e leggi diversi da quelli della morale e della religione, proposizione che ha una grande portata filosofica perché implicitamente innova la concezione della morale e della religione, cioè innova tutta la concezione del mondo) è ancora discussa e contraddetta oggi, non è riuscita a diventare «senso comune». Cosa significa ciò? Significa solo che la rivoluzione intellettuale e morale i cui elementi sono contenuti in nuce nel pensiero del Machiavelli non si è ancora attuata, non è diventata forma pubblica e manifesta della cultura nazionale? Oppure ha un mero significato politico attuale, serve a indicare il distacco esistente tra governanti e governati, a indicare che esistono due colture, quella dei governanti e quella dei governati, e che la classe dirigente, come la Chiesa, ha un suo atteggiamento verso i semplici dettato dalla necessità di non staccarsi da loro da una parte, e dall’altra di mantenerli nella convinzione che il Machiavelli è niente altro che un’apparizione diabolica? Si pone così il problema del significato che il Machiavelli ha avuto nel tempo suo e dei fini che egli si proponeva scrivendo i suoi libri e specialmente il Principe. La dottrina del Machiavelli non era, al tempo suo, una cosa puramente «libresca», un monopolio di pensatori isolati, un libro segreto che circola tra iniziati. Lo stile del Machiavelli non è quello di un trattatista sistematico, come ne avevano e il Medio Evo e l’Umanesimo, tutt’altro: è stile di uomo d’azione, di chi vuole spingere all’azione, è stile da «manifesto» di partito. L’interpretazione «moralistica» data dal Foscolo è certo sbagliata, tuttavia è vero che il Machiavelli ha svelato qualcosa e non solo teorizzato il reale; ma quale era il fine dello svelare? Un fine moralistico o politico? Si suol dire che le norme del Machiavelli per l’attività politica «si applicano, ma non si dicono»; i grandi politici, si dice, cominciano con maledire Machiavelli, col dichiararsi antimachiavellici, appunto per poterne applicare le norme «santamente». Non sarebbe stato il Machiavelli poco machiavellico, uno di quelli che «sanno il gioco» e stoltamente lo insegnano, mentre il machiavellismo volgare insegna a fare il contrario? L’affermazione del Croce che essendo il machiavellismo una scienza, serve tanto ai reazionari quanto ai democratici, come l’arte della scherma serve ai gentiluomini e ai briganti, a difendersi e ad assassinare, e che in tal senso occorre intendere il giudizio del Foscolo, è vera astrattamente. Il Machiavelli stesso nota che le cose che egli scrive sono applicate e sono sempre state applicate dai più grandi uomini della storia; non pare perciò che egli voglia suggerire a chi già sa, né il suo stile è quello di una disinteressata attività scientifica (cfr in una delle pagine precedenti quanto è scritto a proposito del significato dell’invocazione finale del Principe e dell’ufficio che essa può compiere per riguardo all’intera operetta), né può pensarsi che egli sia giunto alle sue tesi di scienza politica per via di speculazione filosofica, ciò che in questa materia particolare avrebbe un po’ del miracoloso al tempo suo, se anche oggi trova tanto contrasto e opposizione. Si può quindi supporre che il Machiavelli abbia in vista «chi non sa», che egli intenda fare l’educazione politica di «chi non sa», educazione politica non negativa, di odiatori di tiranni, come parrebbe intendere il Foscolo, ma positiva, di chi deve riconoscere necessari determinati mezzi, anche se propri dei tiranni, perché vuole determinati fini. Chi è nato nella tradizione degli uomini di governo, per tutto il complesso dell’educazione che assorbe dall’ambiente famigliare, in cui predominano gli interessi dinastici o patrimoniali, acquista quasi automaticamente i caratteri del politico realista. Chi dunque «non sa»? La classe rivoluzionaria del tempo, il «popolo» e la «nazione» italiana, la democrazia cittadina che esprime dal suo seno i Savonarola e i Pier Soderini e non i Castruccio e i Valentino. Si ritenere che il Machiavelli voglia persuadere queste forze della necessità di avere un «capo» che sappia ciò che vuole e come ottenere ciò che vuole, e di accettarlo con entusiasmo anche se le sue azioni possono essere o parere in contrasto con l’ideologia diffusa del tempo, la religione.
Questa posizione della politica del Machiavelli si ripete per la filosofia della praxis: si ripete la necessità di essere «antimachiavellici», sviluppando una teoria e una tecnica della politica che possono servire alle due parti in lotta, quantunque esse si pensa finiranno col servire specialmente alla parte che «non sapeva», perché in essa è ritenuta esistere la forza progressiva della storia e infatti si ottiene subito un risultato: di spezzare l’unità basata sull’ideologia tradizionale, senza la cui rottura la forza nuova non potrebbe acquistare coscienza della propria personalità indipendente. Il machiavellismo è servito a migliorare la tecnica politica tradizionale dei gruppi dirigenti conservatori, così come la politica della filosofia della praxis; ciò non deve mascherare il suo carattere essenzialmente rivoluzionario, che è sentito anche oggi e spiega tutto l’antimachiavellismo, da quello dei gesuiti a quello pietistico di P. Villari.
Q13 §21 Continua del «Nuovo Principe». Si è detto che protagonista del Nuovo Principe non potrebbe essere nell’epoca moderna un eroe personale, ma il partito politico, cioè volta per volta e nei diversi rapporti interni delle diverse nazioni, quel determinato partito che intende (ed è razionalmente e storicamente fondato a questo fine) fondare un nuovo tipo di Stato. È da osservare come nei regimi che si pongono come totalitari, la funzione tradizionale dell’istituto della corona è in realtà assunta dal partito determinato, che anzi è totalitario appunto perché assolve a tale funzione. Sebbene ogni partito sia espressione di un gruppo sociale, e di un solo gruppo sociale, tuttavia determinati partiti appunto rappresentano un solo gruppo sociale, in certe condizioni date, in quanto esercitano una funzione di equilibrio e di arbitrato tra gli interessi del proprio gruppo e gli altri gruppi, e procurano che lo sviluppo del gruppo rappresentato avvenga col consenso e con l’aiuto dei gruppi alleati, se non addirittura dei gruppi decisamente avversari. La formula costituzionale del re o del presidente di repubblica che «regna e non governa» è la formula giuridica che esprime questa funzione di arbitrato; la preoccupazione dei partiti costituzionali di non «scoprire» la corona o il presidente, le formule sulla non responsabilità, per gli atti governativi, del capo dello Stato, ma sulla responsabilità ministeriale, sono la casistica del principio generale di tutela della concezione dell’unità statale, del consenso dei governati all’azione statale, qualunque sia il personale immediato di governo e il suo partito.
Col partito totalitario queste formule perdono di significato e sono quindi diminuite le istituzioni che funzionavano nel senso di tali formule; ma la funzione stessa è incorporata dal partito, che esalterà il concetto astratto di «Stato» e cercherà con vari modi di dare l’impressione che la funzione «di forza imparziale» è attiva ed efficace.
Q13 §22 Bibliografia. In una recensione di Giuseppe Tarozzi del I° volume della Costituzione russa di Mario Sertoli (Firenze, Le Monnier, 1928, in 8°, pp. 435, L. 50) pubblicata dall’«Italia che scrive», è citato un libro del Vorländer, Von Machiavelli bis Lenin, senz’altra indicazione. (Sarà da vedere la rassegna sulla letteratura machiavellica più recente pubblicata nel 1929 dai «Nuovi Studi»).
Q13 §23 Osservazioni su alcuni aspetti della struttura dei partiti politici nei periodi di crisi organica (da connettere con le sulle situazioni e i rapporti di forza). A un certo punto della loro vita storica i gruppi sociali si staccano dai loro partiti tradizionali, cioè i partiti tradizionali in quella data forma organizzativa, con quei determinati uomini che li costituiscono, li rappresentano e li dirigono non sono più riconosciuti come loro espressione dalla loro classe o frazione di classe. Quando queste crisi si verificano, la situazione immediata diventa delicata e pericola, perché il campo è aperto alle soluzioni di forza, all’attività di potenze oscure rappresentate dagli uomini provvidenziali o carismatici. Come si formano queste situazioni di contrasto tra rappresentanti e rappresentati, che dal terreno dei partiti (organizzazioni di partito in senso stretto, campo elettorale‑parlamentare, organizzazione giornalistica) si riflette in tutto l’organismo statale, rafforzando la posizione relativa del potere della burocrazia (civile e militare), dell’alta finanza, della Chiesa e in generale di tutti gli organismi relativamente indipendenti dalle fluttuazioni dell’opinione pubblica? In ogni paese il processo è diverso, sebbene il contenuto sia lo stesso. E il contenuto è la crisi di egemonia della classe dirigente, che avviene o perché la classe dirigente ha fallito in qualche sua grande impresa politica per cui ha domandato o imposto con la forza il consenso delle grandi masse (come la guerra) o perché vaste masse (specialmente di contadini e di piccoli borghesi intellettuali) sono passati di colpo dalla passività politica a una certa attività e pongono rivendicazioni che nel loro complesso disorganico costituiscono una rivoluzione. Si parla di «crisi di autorità» e ciò appunto è la crisi di egemonia, o crisi dello Stato nel suo complesso.
La crisi crea situazioni immediate pericolose, perché i diversi strati della popolazione non possiedono la stessa capacità di orientarsi rapidamente e di riorganizzarsi con lo stesso ritmo. La classe tradizionale dirigente, che ha un numeroso personale addestrato, muta uomini e programmi e riassorbe il controllo che le andava sfuggendo con una celerità maggiore di quanto avvenga nelle classi subalterne; fa magari dei sacrifizi, si espone a un avvenire oscuro con promesse demagogiche, ma mantiene il potere, lo rafforza per il momento e se ne serve per schiacciare l’avversario e disperderne il personale di direzione, che non può essere molto numeroso e molto addestrato. Il passaggio delle truppe di molti partiti sotto la bandiera di un partito unico che meglio rappresenta e riassume i bisogni dell’intera classe è un fenomeno organico e normale, anche se il suo ritmo sia rapidissimo e quasi fulmineo in confronto di tempi tranquilli: rappresenta la fusione di un intero gruppo sociale sotto un’unica direzione ritenuta sola capace di risolvere un problema dominante esistenziale e allontanare un pericolo mortale. Quando la crisi non trova questa soluzione organica, ma quella del capo carismatico, significa che esiste un equilibrio statico (i cui fattori possono essere disparati, ma in cui prevale l’immaturità delle forze progressive) che nessun gruppo, né quello conservativo né quello progressivo, ha la forza necessaria alla vittoria e che anche il gruppo conservativo ha bisogno di un padrone (cfr Il 18 brumaio di Luigi Napoleone).
Questo ordine di fenomeni è connesso a una delle quistioni più importanti che riguardano il partito politico, e cioè alla capacità del partito di reagire contro lo spirito di consuetudine, contro le tendenze a mummificarsi e a diventare anacronistico. I partiti nascono e si costituiscono in organizzazione per dirigere la situazione in momenti storicamente vitali per le loro classi; ma non sempre essi sanno adattarsi ai nuovi compiti e alle nuove epoche, non sempre sanno svilupparsi secondo che si sviluppano i rapporti complessivi di forza (e quindi posizione relativa delle loro classi) nel paese determinato o nel campo internazionale. Nell’analizzare questi sviluppi dei partiti occorre distinguere: il gruppo sociale; la massa di partito; la burocrazia e lo stato maggiore del partito. La burocrazia è la forza consuetudinaria e conservatrice più pericolosa; se essa finisce col costituire un corpo solidale, che sta a sé e si sente indipendente dalla massa, il partito finisce col diventare anacronistico, e nei momenti di crisi acuta viene svuotato del suo contenuto sociale e rimane come campato in aria. Si può vedere cosa avviene a una serie di partiti tedeschi per l’espansione dell’hitlerismo. 1 partiti francesi sono un campo ricco per tali ricerche: essi sono tutti mummificati e anacronistici, documenti storico‑politici delle diverse fasi della storia passata francese, di cui ripetono la terminologia invecchiata: la loro crisi può diventare ancora più catastrofica di quella dei partiti tedeschi.
Nell’esaminare questo ordine di avvenimenti di solito si trascura di fare un giusto posto all’elemento burocratico, civile e militare, e non si tiene presente, inoltre, che in tali analisi non devono rientrare solo gli elementi militari e burocratici in atto, ma gli strati sociali da cui, nei complessi statali dati, la burocrazia è tradizionalmente reclutata. Un movimento politico può essere di carattere militare anche se l’esercito come tale non vi partecipa apertamente; un governo può essere di carattere militare anche se l’esercito come tale non partecipa al governo. In determinate situazioni può avvenire che convenga non «scoprire» l’esercito, non farlo uscire dalla costituzionalità, non portare la politica tra i soldati, come si dice, per mantenere l’omogeneità tra ufficiali e soldati in un terreno di apparente neutralità e superiorità sulle fazioni; eppure è l’esercito, cioè lo Stato Maggiore e l’ufficialità, che determina la nuova situazione e la domina. D’altronde non è vero che l’esercito, secondo le costituzioni, non deve mai fare della politica; l’esercito dovrebbe appunto difendere la costituzione, cioè la forma legale dello Stato, con le istituzioni connesse; perciò la così detta neutralità significa solo appoggio alla parte retriva, ma occorre, in tali situazioni, porre così la quistione per impedire che nell’esercito si riproduca il dissenso del paese e quindi sparisca il potere determinante dello Stato Maggiore per la disgregazione dello strumento militare. Tutti questi elementi di osservazione non sono certo assoluti, nei diversi momenti storici e nei vari paesi essi hanno pesi molto diversi.
La prima ricerca da fare è questa: esiste in un determinato paese uno strato sociale diffuso per il quale la carriera burocratica, civile e militare, sia elemento molto importante di vita economica e di affermazione politica (partecipazione effettiva al potere, sia pure indirettamente, per «ricatto»)? Nell’Europa moderna questo strato si può identificare nella borghesia rurale media e piccola che è più o meno diffusa nei diversi paesi a seconda dello sviluppo delle forze industriali da una parte e della riforma agraria dall’altra. Certo la carriera burocratica (civile e militare) non è un monopolio di questo strato sociale, tuttavia essa gli è particolarmente adatta per la funzione sociale che questo strato svolge e per le tendenze psicologiche che la funzione determina o favorisce; questi due elementi danno all’insieme del gruppo sociale una certa omogeneità ed energia di direttive, e quindi un valore politico e una funzione spesso decisiva nell’insieme dell’organismo sociale. Gli elementi di questo gruppo sono abituati a comandare direttamente nuclei di uomini sia pure esigui e a comandare «politicameme», non «economicamente»; cioè nella loro arte di comando non c’è attitudine a ordinare le «cose», a ordinare «uomini e cose» in un tutto organico, come avviene nella produzione industriale, perché questo gruppo non ha funzioni economiche nel senso moderno della parola. Esso ha un reddito perché giuridicamente è proprietario di una parte del suolo nazionale e la sua funzione consiste nel contendere «politicamente» al contadino coltivatore di migliorare la propria esistenza, perché ogni miglioramento della posizione relativa del contadino sarebbe catastrofica per la sua posizione sociale. La miseria cronica e il lavoro prolungato del contadino, col conseguente abbrutimento, sono per esso una necessità primordiale. Perciò spiega la massima energia nella resistenza e nel contrattacco a ogni minimo tentativo di organizzazione autonoma del lavoro contadino e a ogni movimento culturale contadino che esca dai limiti della religione ufficiale. Questo gruppo sociale trova i suoi limiti e le ragioni della sua intima debolezza nella sua dispersione territoriale e nella «inomogeneità» che è intimamente connessa a tale dispersione; ciò spiega anche altre caratteristiche: la volubilità, la molteplicità dei sistemi ideologici seguiti, la stessa stranezza delle ideologie talvolta seguite. La volontà è decisa verso un fine, ma essa è tarda e ha bisogno, di solito, di un lungo processo per centralizzarsi organizzativamente e politicamente. Il processo si accelera quando la «volontà» specifica di questo gruppo coincide con la volontà e gli interessi immediati della classe alta; non solo il processo si accelera, ma si manifesta subito la «forza militare» di questo strato, che talvolta, organizzatosi, detta legge alla classe alta, almeno per ciò che riguarda la «forma» della soluzione, se non per il contenuto. Si vedono qui funzionare le stesse leggi che sono state notate per i rapporti città‑campagna nei riguardi delle classi subalterne: la forza della città automaticamente diventa forza della campagna, ma poiché in campagna i conflitti assumono subito una forma acuta e «personale», per l’assenza di margini economici e per la normalmente più pesante compressione esercitata dall’alto in basso, così in campagna i contrattacchi devono essere più rapidi e decisi. Questo gruppo capisce e vede che l’origine dei suoi guai è nelle città, nella forza delle città e perciò capisce di «dover» dettare la soluzione alle classi alte urbane, affinché il focolaio principale sia spento, anche se ciò alle classi alte urbane non conviene immediatamente o perché troppo dispendioso o perché pericoloso a lungo andare (queste classi vedono cicli più ampi di sviluppo, in cui è possibile manovrare e non solo l’interesse «fisico» immediato). In questo senso deve intendersi la funzione direttiva di questo strato e non in senso assoluto; tuttavia non è piccola cosa.
Un riflesso di questo gruppo si vede nell’attività ideologica degli intellettuali conservatori, di destra. Il libro di Gaetano Mosca Teorica dei governi e governo parlamentare (II ed. del 1925, I ed. del 1883) è esemplare per questo rispetto; fin dal 1883 il Mosca era terrorizzato da un possibile contatto tra città e campagna. Il Mosca, per la sua posizione difensiva (di contrattacco) comprendeva meglio nel 1883 la tecnica della politica delle classi subalterne di quanto non la comprendessero, anche parecchi decenni dopo, i rappresentanti di queste forze subalterne anche urbane.
(È da notare come questo carattere «militare» del gruppo sociale in quistione, che era tradizionalmente un riflesso spontaneo di certe condizioni di esistenza, viene ora consapevolmente educato e predisposto organicamente. In questo movimento consapevole rientrano gli sforzi sistematici per far sorgere e per mantenere stabilmente associazioni varie di militari in congedo e di ex‑combattenti dei vari corpi ed armi, specialmente di ufficiali, che sono legate agli Stati Maggiori e possono essere mobilitate all’occorrenza senza bisogno di mobilitare l’esercito di leva, che manterrebbe così il suo carattere di riserva allarmata, rafforzata e immunizzata dalla decomposizione politica da queste forze «private» che non potranno non influire sul suo «morale», sostenendolo e irrobustendolo. Si può dire che si verifica un movimento del tipo «cosacco», non in formazioni scaglionate lungo i confini di nazionalità, come avveniva per i cosacchi zaristi, ma lungo i «confini» di gruppo sociale).
In tutta una serie di paesi, pertanto, influenza dell’elemento militare nella vita statale non significa solo influenza e peso dell’elemento tecnico militare, ma influenza e peso dello strato sociale da cui l’elemento tecnico militare (specialmente gli ufficiali subalterni) trae specialmente origine. Questa serie di osservazioni sono indispensabili per analizzare l’aspetto più intimo di quella determinata forma politica che si suole chiamare cesarismo o bonapartismo, per distinguerla da altre forme in cui l’elemento tecnico militare, come tale, predomina, in forme forse ancor più appariscenti ed esclusive. La Spagna e la Grecia offrono due esempi tipici, con tratti simili e dissimili. Nella Spagna occorre tener conto di alcuni particolari: grandezza e scarsa densità della popolazione contadina. Tra il nobile latifondista e il contadino non esiste una numerosa borghesia rurale, quindi scarsa importanza dell’ufficialità subalterna come forza a sé (aveva invece una certa importanza antagonistica l’ufficialità delle armi dotte, artiglieria e genio, di origine borghese urbana, che si opponeva ai generali e tentava di avere una politica propria). I governi militari sono pertanto governi di «grandi» generali. Passività delle masse contadine come cittadinanza e come truppa. Se nell’esercito si verifica disgregazione politica, è in senso verticale, non orizzontale, per la concorrenza delle cricche dirigenti: la truppa si scinde per seguire i capi in lotta tra loro. Il governo militare è una parentesi tra due governi costituzionali; l’elemento militare è la riserva permanente dell’ordine e della conservazione, è una forza politica operante in «modo pubblico» quando la «legalità» è in pericolo. Lo stesso avviene in Grecia con la differenza che il territorio greco è sparpagliato in un sistema di isole e che una parte della popolazione più energica e attiva è sempre sul mare, ciò che rende più facile l’intrigo e il complotto militare; il contadino greco è passivo come quello spagnuolo, ma nel quadro della popolazione totale, il greco più energico ed attivo essendo marinaio e quasi sempre lontano dal suo centro di vita politica, la passività generale deve essere analizzata diversamente e la soluzione del problema non può essere la stessa (le fucilazioni avvenute in Grecia anni fa dei membri di un governo rovesciato, probabilmente sono da spiegarsi con uno scatto di collera di questo elemento energico e attivo che volle dare una sanguinosa lezione). Ciò che è specialmente da osservare è che in Grecia e in Ispagna l’esperienza del governo militare non ha creato una ideologia politica e sociale permanente e formalmente organica, come avviene invece nei paesi potenzialmente bonapartisti per così dire. Ma le condizioni storiche generali dei due tipi sono le stesse: equilibrio dei gruppi urbani in lotta, che impedisce il gioco della democrazia «normale», il parlamentarismo; è diverso però l’influsso della campagna in questo equilibrio. Nei paesi come la Spagna, la campagna, completamente passiva, permette ai generali della nobiltà terriera di servirsi politicamente dell’esercito per ristabilire l’equilibrio pericolante, cioè il sopravvento dei gruppi alti. In altri paesi la campagna non è passiva, ma il suo movimento non è politicamente coordinato a quello urbano: l’esercito deve rimanere neutrale poiché è possibile che altrimenti esso si disgreghi orizzontalmente (rimarrà neutrale fino ad un certo punto, s’intende), ed entra invece in azione la classe militare‑burocratica che con mezzi militari soffoca il movimento in campagna (immediatamente più pericoloso), in questa lotta trova una certa unificazione politica e ideologica, trova alleati nelle classi medie urbane (medie in senso italiano) rafforzate dagli studenti di origine rurale che stanno in città, impone i suoi metodi politici alle classi alte, che devono farle molte concessioni e permettere una determinata legislazione favorevole; insomma riesce a permeare lo Stato dei suoi interessi fino ad un certo punto e a sostituire una parte del personale dirigente, continuando a mantenersi armata nel disarmo generale e prospettando il pericolo di una guerra civile tra i propri armati e l’esercito di leva se la classe alta mostra troppe velleità di resistenza.
Queste osservazioni non devono essere concepite come schemi rigidi, ma solo come criteri pratici di interpretazione storica e politica. Nelle concrete analisi di avvenimenti reali le forme storiche sono individuate e quasi «uniche». Cesare rappresenta una combinazione di circostanze reali molto diversa da quella rappresentata da Napoleone I, come Primo De Rivera da quella di Zivkovic ecc.
Nell’analisi del terzo grado o momento del sistema dei rapporti di forza esistenti in una determinata situazione, si può ricorrere utilmente al concetto che nella scienza militare è chiamato della «congiuntura strategica» ossia, con più precisione, del grado di preparazione strategica del teatro della lotta, uno dei cui principali elementi è dato dalle condizioni qualitative del personale dirigente e delle forze attive che si possono chiamare di prima linea (comprese in queste quelle d’assalto). Il grado di preparazione strategica può dare la vittoria a forze «apparentemente» (cioè quantitativamente) inferiori a quelle dell’avversario. Si può dire che la preparazione strategica tende a ridurre a zero i così detti «fattori imponderabili», cioè le reazioni immediate, di sorpresa, da parte, in un momento dato, delle forze tradizionalmente inerti e passive. Tra gli elementi della preparazione di una favorevole congiuntura strategica sono da porre appunto quelli considerati nelle osservazioni su l’esistenza e l’organizzazione di un ceto militare accanto all’organismo tecnico dell’esercito nazionale.
Altri elementi si possono elaborare da questo brano del discorso tenuto al Senato il 19 maggio 1932 dal ministro della guerra generale Gazzera (cfr «Corriere della Sera» del 20 maggio): «Il regime di disciplina del nostro Esercito per virtù del Fascismo appare oggi una norma direttiva che ha valore per tutta la Nazione. Altri eserciti hanno avuto e tuttora conservano una disciplina formale e rigida. Noi teniamo sempre presente il principio che l’Esercito è fatto per la guerra e che a quella deve prepararsi; la disciplina di pace deve essere quindi la stessa del tempo di guerra, che nel tempo di pace deve trovare il suo fondamento spirituale. La nostra disciplina si basa su uno spirito di coesione tra i capi e i gregari che è frutto spontaneo del sistema seguito. Questo sistema ha resistito magnificamente durante una lunga e durissima guerra fino alla vittoria; è merito del Regime fascista di avere esteso a tutto il popolo italiano una tradizione disciplinare così insigne. Dalla disciplina dei singoli dipende l’esito della concezione strategica e delle operazioni tattiche. La guerra ha insegnato molte cose, e anche che vi è un distacco profondo tra la preparazione di pace e la realtà della guerra. Certo è che, qualunque sia la preparazione, le operazioni iniziali della campagna pongono i belligeranti innanzi a problemi nuovi che danno luogo a sorprese da una parte e dall’altra. Non bisogna trarne però la conseguenza che non sia utile avere una concezione a priori e che nessun insegnamento possa derivarsi dalla guerra passata. Se ne può ricavare una dottrina di guerra che deve essere intesa con disciplina intellettuale e come mezzo per promuovere modi di ragionamento non discordi e uniformità di linguaggio tale da permettere a tutti di comprendere e di farsi comprendere. Se, talvolta, l’unità di dottrina ha minacciato di degenerare in schematismo, si è subito reagito prontamente, imprimendo alla tattica, anche per i progressi della tecnica, una rapida rinnovazione. Tale regolamentazione quindi non è statica, non è tradizionale, come taluno crede. La tradizione è considerata solo come forza e i regolamenti sono sempre in corso di revisione non per desiderio di cambiamento, ma per poterli adeguare alla realtà». (Una esemplificazione di «preparazione della congiuntura strategica» si può trovare nelle Memorie di Churchill, dove parla della battaglia dello Yütland).
Un elemento da aggiungere al paragrafo dell’economismo, come esemplificazione delle teorie così dette dell’intransigenza, è quello della rigida avversione di principio ai così detti compromessi, che ha come manifestazione subordinata quella che si può chiamare la «paura dei pericoli». Che l’avversione di principio ai compromessi sia strettamente legata all’economismo è chiaro in quanto la concezione su cui si fonda questa avversione non può essere altro che la convinzione ferrea che esistano per lo sviluppo storico leggi obbiettive dello stesso carattere delle leggi naturali, con in più la persuasione di un finalismo fatalistico di carattere simile a quello religioso: poiché le condizioni favorevoli dovranno fatalmente verificarsi e da esse saranno determinati, in modo alquanto misterioso, avvenimenti palingenetici, risulta l’inutilità non solo, ma il danno di ogni iniziativa volontaria tendente a predisporre queste situazioni secondo un piano. Accanto a queste convinzioni fatalistiche sta tuttavia la tendenza ad affidarsi «in seguito» ciecamente e scriteriatamente alla virtù regolatrice delle armi, ciò che però non è completamente senza una logica e una coerenza, poiché si pensa che l’intervento della volontà è utile per la distruzione, non per la ricostruzione (già in atto nel momento stesso della distruzione). La distruzione viene concepita meccanicamente non come distruzione‑ricostruzione. In tali modi di pensare non si tiene conto del fattore «Tempo» e non si tiene conto, in ultima analisi, della stessa «economia» nel senso che non si capisce come i fatti ideologici di massa sono sempre in arretrato sui fenomeni economici di massa e come pertanto in certi momenti la spinta automatica dovuta al fattore economico è rallentata, impastoiata o anche spezzata momentaneamente da elementi ideologici tradizionali, che perciò deve esserci lotta cosciente e predisposta per far «comprendere» le esigenze della posizione economica di massa che possono essere in contrasto con le direttive dei capi tradizionali. Una iniziativa politica appropriata è sempre necessaria per liberare la spinta economica dalle pastoie della politica tradizionale, per mutare cioè la direzione politica di certe forze che è necessario assorbire per realizzare un nuovo, omogeneo, senza contraddizioni interne, blocco storico economico‑politico, e poiché due forze «simili» non possono fondersi in organismo nuovo che attraverso una serie di compromessi o con la forza delle armi, alleandole su un piano di alleanza o subordinando l’una all’altra con la coercizione, la quistione è se si ha questa forza e se sia «produttivo» impiegarla. Se l’unione di due forze è necessaria per vincere un terza, il ricorso alle armi e alla coercizione (dato che se ne abbia la disponibilità) è una pura ipotesi metodica e l’unica possibilità concreta è il compromesso, poiché la forza può essere impiegata contro i nemici, non contro una parte di se stessi che si vuole rapidamente assimilare e di cui occorre la «buona volontà» e l’entusiasmo.
(A proposito del «ceto militare» è interessante ciò che scrive T. Tittoni nei Ricordi personali di politica interna, «Nuova Antologia», 1° aprile ‑ 16 aprile 1929. Racconta il Tittoni di aver meditato sul fatto che per riunire la forza pubblica necessaria a fronteggiare i tumulti scoppiati in una località, occorreva sguarnire altre regioni: durante la settimana rossa del giugno 1914, per reprimere i moti di Ancona si era sguarnita Ravenna, dove poi il prefetto, privato della forza pubblica, dovette chiudersi nella Prefettura abbandonando la città ai rivoltosi. «Più volte io ebbi a domandarmi, che cosa avrebbe potuto fare il Governo se un movimento di rivolta fosse scoppiato contemporaneamente in tutta la penisola». Tittoni propose al Governo l’arruolamento dei «volontari dell’ordine», ex‑combattenti inquadrati da ufficiali in congedo. Il progetto di Tittoni parve degno di considerazione, ma non ebbe seguito).
Cfr Quaderno 4 (XIII), p. 39; Quaderno 7 (VII), p. 41bis; Quaderno 4 (XIII), pp. 36 - 38 bis; Quaderno 9 (XIV), pp. 30, 21‑22, 30‑31.
Q13 §24 A proposito dei confronti tra i concetti di guerra manovrata e guerra di posizione nell’arte militare e i concetti relativi nell’arte politica è da ricordare il libretto della Rosa tradotto in italiano nel 1919 da C. Alessandri (tradotto dal francese). Nel libretto si teorizzano un po’ affrettatamente e anche superficialmente le esperienze storiche del 1905: la Rosa infatti trascurò gli elementi «volontari» e organizzativi che in quegli avvenimenti furono molto più diffusi ed efficienti di quanto la Rosa fosse portata a credere per un certo suo pregiudizio «economistico» e spontaneista. Tuttavia questo libretto (e altri saggi dello stesso autore) è uno dei documenti più significativi della teorizzazione della guerra manovrata applicata all’arte politica. L’elemento economico immediato (crisi, ecc.) è considerato come l’artiglieria campale che in guerra apriva il varco nella difesa nemica, varco sufficiente perché le proprie truppe facciano irruzione e ottengano un successo definitivo (strategico) o almeno un successo importante nella direttrice della linea strategica. Naturalmente nella scienza storica l’efficacia dell’elemento economico immediato è ritenuta molto più complessa di quella dell’artiglieria pesante nella guerra di manovra, perché questo elemento era concepito come avente un doppio effetto: 1) di aprire il varco nella difesa nemica dopo aver scompaginato e fatto perdere la fiducia in sé e nelle sue forze e nel suo avvenire al nemico stesso; 2) di organizzare fulmincamente le proprie truppe, di creare i quadri, o almeno di porre i quadri esistenti (elaborati fino allora dal processo storico generale) fulmineamente al loro posto di inquadramento delle truppe disseminate; 3) di creare fulmineamente la concentrazione ideologica dell’identità di fine da raggiungere. Era una forma di ferreo determinismo economistico, con l’aggravante che gli effetti erano concepiti come rapidissimi nel tempo e nello spazio; perciò era un vero e proprio misticismo storico, l’aspettazione di una specie di fulgurazione miracolosa.
L’osservazione del generale Krasnov (nel suo romanzo) che l’Intesa (che non voleva una vittoria della Russia imperiale, perché non fosse risolta definitivamente a favore dello zarismo la quistione orientale) impose allo Stato Maggiore russo la guerra di trincea (assurda dato l’enorme sviluppo del fronte dal Baltico al mar Nero, con grandi zone paludose e boscose) mentre unica possibile era la guerra manovrata, è una mera scempiaggine. In realtà l’esercito russo tentò la guerra di manovra e di sfondamento, specialmente nel settore austriaco (ma anche nella Prussia orientale) ed ebbe successi brillantissimi, per quanto effimeri. La verità è che non si può scegliere la forma di guerra che si vuole, a meno di avere subito una superiorità schiacciante sul nemico, ed è noto quante perdite abbia costato l’ostinazione degli Stati
Maggiori nel non voler riconoscere che la guerra di posizione era «imposta» dai rapporti generali delle forze in contrasto. La guerra di posizione non è infatti solo costituita dalle trincee vere e proprie, ma da tutto il sistema organizzativo e industriale del territorio che è alle spalle dell’esercito schierato, ed è imposta specialmente dal tiro rapido dei cannoni delle mitragliatrici dei moschetti, dalla concentrazione delle armi in un determinato punto, oltre che dall’abbondanza del rifornimento che permette di sostituire rapidamente il materiale perduto dopo uno sfondamento e un arretramento. Un altro elemento è la grande massa d’uomini che partecipano allo schieramento, di valore molto diseguale e che appunto possono operare solo come massa. Si vide come nel fronte orientale altra cosa era fare irruzione nel settore tedesco e altra nel settore austriaco e come anche nel settore austriaco, rinforzato da truppe scelte tedesche e comandato da tedeschi, la tattica irruenta finì nel disastro. Lo stesso si vide nella guerra polacca del 1920, quando l’avanzata che sembrava irresistibile fu fermata dinanzi a Varsavia dal generale Weygand sulla linea comandata da ufficiali francesi. Gli stessi tecnici militari che ormai si sono fissati sulla guerra di posizione come prima lo erano su quella manovrata, non sostengono certo che il tipo precedente debba essere considerato come espunto dalla scienza; ma nelle guerre tra gli Stati più avanzati industrialmente e civilmente esso deve considerarsi ridotto a funzione tattica più che strategica, deve considerarsi nella stessa posizione in cui era prima la guerra d’assedio in confronto a quella manovrata. La stessa riduzione deve avvenire nell’arte e nella scienza politica, almeno per ciò che riguarda gli Stati più avanzati, dove la «società civile» è diventata una struttura molto complessa e resistente alle «irruzioni» catastrofiche dell’elemento economico immediato (crisi, depressioni ecc.); le superstrutture della società civile sono come il sistema delle trincee nella guerra moderna. Come in questa avveniva che un accanito attacco d’artiglieria sembrava aver distrutto tutto il sistema difensivo avversario ma ne aveva solo invece distrutto la superficie esterna e al momento dell’attacco e dell’avanzata gli assalitori si trovavano di fronte una linea difensiva ancora efficiente, così avviene nella politica durante le grandi crisi economiche; né le truppe assalitrici, per effetto della crisi, si organizzano fulmineamente nel tempo e nello spazio, né tanto meno acquistano uno spirito aggressivo; per reciproca, gli assaliti non si demoralizzano né abbandonano le difese, pur tra le macerie, né perdono la fiducia nella propria forza e nel proprio avvenire. Le cose certo non rimangono tali e quali, ma è certo che viene a mancare l’elemento della rapidità, del tempo accelerato, della marcia progressiva definitiva come si aspetterebbero gli strateghi del cadornismo politico. L’ultimo fatto del genere nella storia della politica sono stati gli avvenimenti del 1917. Essi hanno segnato una svolta decisiva nella storia dell’arte e della scienza della politica. Si tratta dunque di studiare con «profondità» quali sono gli elementi della società civile che corrispondono ai sistemi di difesa nella guerra di posizione. Si dice con «profondità» a disegno, perché essi sono stati studiati, ma da punti di vista superficiali e banali, come certi storici del costume studiano le stranezze della moda femminile, o da un punto di vista «razionalistico» cioè con la persuasione che certi fenomeni sono distrutti appena spiegati «realisticamente», come se fossero superstizioni popolari (che del resto anch’esse non si distruggono con lo spiegarle).
A questo nesso di problemi è da riattaccare la quistione dello scarso successo ottenuto da nuove correnti nel movimento sindacale.
Un tentativo di iniziare una revisione dei metodi tattici avrebbe dovuto essere quello esposto da L. Davidovic Bronstein [Trotzky ndc] alla quarta riunione quando fece un confronto tra il fronte orientale e quello occidentale, quello cadde subito ma fu seguito da lotte inaudite: in questo le lotte si verificherebbero «prima». Si tratterebbe cioè se la società civile resiste prima o dopo l’assalto, dove questo avviene ecc. La quistione però è stata esposta solo in forma letteraria brillante, ma senza indicazioni di carattere pratico1.
Q13 §25 «Doppiezza» e «ingenuità» del Machiavelli. Cfr articolo di Adolfo Oxilia Machiavelli nel teatro («Cultura» dell’ottobre‑dicembre 1933). Interpretazione romantico‑liberale del Machiavelli (Rousseau nel Contratto Sociale, III, 6; Foscolo nei Sepolcri; Mazzini nel breve saggio sul Machiavelli). Mazzini scrive: «Ecco ciò che i vostri principi, deboli e vili quanti sono, faranno per dominarvi: or pensateci». Rousseau vede nel Machiavelli un «gran republicano», il quale fu costretto dai tempi – senza che ne derivi alcuna menomazione della sua dignità morale – a «déguiser son amour pour la liberté» e a fingere di dare lezioni ai re per darne «des grandes aux peuples». Filippo Burzio ha notato che una tale interpretazione, invece di giustificare moralmente il machiavellismo, in realtà prospetta un «machiavellismo al quadrato»: giacché l’autore del Principe non solo darebbe consigli di frode bensì anche con frode, a rovina di coloro stessi cui sono rivolti.
Questa interpretazione «democratica» del Machiavelli risalirebbe al Cardinale Polo e ad Alberico Gentile (sarà da vedere il libro del Villari e quello del Tommasini nella parte che riguarda la fortuna del Machiavelli). A me pare che il brano di Traiano Boccalini nei Ragguagli del Parnaso sia molto più significativo di tutte le impostazioni dei «grandi studiosi di politica» e che tutto si riduca a un’applicazione del proverbio volgare «chi sa il gioco non l’insegni». La corrente «antimachiavellica» non è che la manifestazione teorica di questo principio di arte politica elementare: che certe cose si fanno ma non si dicono.
Proprio da questo pare nasca il problema più interessante: perché il Machiavelli ha scritto il Principe, non come una «memoria» segreta o riservata, come «istruzioni» di un consigliere a un principe, ma come un libro che avrebbe dovuto andare nelle mani di tutti? Per scrivere un’opera di «scienza» disinteressata, come potrebbe arguirsi dagli accenni del Croce? Pare ciò sia contro lo spirito dei tempi, sia una concezione anacronistica. Per «ingenuità», dato che il Machiavelli è visto come un teorico e non come uomo d’azione? Non pare accettabile l’ipotesi dell’«ingenuità» vanitosa e «chiacchierona». Bisogna ricostruire i tempi, e le esigenze che il Machiavelli vedeva in essi. In realtà, pare si possa dire, nonostante che il Principe abbia una destinazione precisa, che il libro non è scritto per nessuno e per tutti: è scritto per un ipotetico «uomo della provvidenza» che potrebbe manifestarsi così come si era manifestato il Valentino o altri condottieri, dal nulla, senza tradizione dinastica, per le sue qualità militari eccezionali. La conclusione del Principe giustifica tutto il libro anche verso le masse popolari che realmente dimenticano i mezzi impiegati per raggiungere un fine se questo fine è storicamente progressivo, cioè risolve i problemi essenziali dell’epoca e stabilisce un ordine in cui sia possibile muoversi, operare, lavorare tranquillamente. Nell’interpretare il Machiavelli si dimentica che la monarchia assoluta era in quei tempi una forma di reggimento popolare e che essa si appoggiava sui borghesi contro i nobili e anche contro il clero. (L’Oxilia accenna all’ipotesi che l’interpretazione democratica del Machiavelli nel periodo 700‑800 sia stata rafforzata e resa più ovvia dal Giorno del Parini, «satirico istitutore del giovin signore, come il Machiavelli – in altri tempi, con altre nature e misure d’uomini – sarebbe stato il tragico istitutore del principe»)
Q13 §26 Egemonia politico‑cullurale. È ancora possibile, nel mondo moderno, l’egemonia culturale di una nazione sulle altre? Oppure il mondo è già talmente unificato nella sua struttura economico‑ sociale, che un paese, se può avere «cronologicamente» l’iniziativa di una innovazione, non ne può però conservare il «monopolio politico» e quindi servirsi di tale monopolio come base di egemonia? Quale significato quindi può avere oggi il nazionalismo? Non è esso possibile come «imperialismo» economico‑finanziario ma non più come «primato» civile o egemonia politico‑intellettuale?
Q13 §27 Il cesarismo. Cesare, Napoleone I, Napoleone III, Cromwell, ecc. Compilare un catalogo degli eventi storici che hanno culminato in una grande personalità «eroica». Si può dire che il cesarismo esprime una situazione in cui le forze in lotta si equilibrano in modo catastrofico, cioè si equilibrano in modo che la continuazione della lotta non può concludersi che con la distruzione reciproca. Quando la forza progressiva A lotta con la forza regressiva B, può avvenire non solo che A vinca B o B vinca A, può avvenire anche che non vinca né A né B, ma si svenino reciprocamente e una terza forza C intervenga dall’esterno assoggettando ciò che resta di A e di B. Nell’Italia dopo la morte del Magnifico è appunto successo questo, come era successo nel mondo antico con le invasioni barbariche.
Ma il cesarismo, se esprime sempre la soluzione «arbitrale», affidata a una grande personalità, di una situazione storico‑politica caratterizzata da un equilibrio di forze a prospettiva catastrofica, non ha sempre lo stesso significato storico. Ci può essere un cesarismo progressivo e uno regressivo e il significato esatto di ogni forma di cesarismo, in ultima analisi, può essere ricostruito dalla storia concreta e non da uno schema sociologico. È progressivo il cesarismo, quando il suo intervento aiuta la forza progressiva a trionfare sia pure con certi compromessi e temperamenti limitativi della vittoria; è regressivo quando il suo intervento aiuta a trionfare la forza regressiva, anche in questo caso con certi compromessi e limitazioni, che però hanno un valore, una portata e un significato diversi che non nel caso precedente. Cesare e Napoleone I sono esempi di cesarismo progressivo. Napoleone III e Bismark di cesarismo regressivo. Si tratta di vedere se nella dialettica «rivoluzione‑restaurazione» è l’elemento rivoluzione o quello restaurazione che prevale, poiché è certo che nel movimento storico non si torna mai indietro e non esistono restaurazioni «in toto». Del resto il cesarismo è una formula polemica‑ideologica e non un canone di interpretazione storica. Si può avere soluzione cesarista anche senza un Cesare, senza una grande personalità «eroica» e rappresentativa. Il sistema parlamentare ha dato anch’esso un meccanismo per tali soluzioni di compromesso. I governi «laburisti» di Mac Donald erano soluzioni di tale specie in un certo grado, il grado di cesarismo si intensificò quando fu formato il governo con Mac Donald presidente e la maggioranza conservatrice. Così in Italia nell’ottobre 1922, fino al distacco dei popolari e poi gradatamente fino al 3 gennaio 1925 e ancora fino all’8 novembre 1926 si ebbe un moto politico‑storico in cui diverse gradazioni di cesarismo si succedettero fino a una forma più pura e permanente, sebbene anch’essa non immobile e statica. Ogni governo di coalizione è un grado iniziale di cesarismo, che può e non può svilupparsi fino ai gradi più significativi (naturalmente l’opinione volgare è invece che i governi di coalizione siano il più «solido baluardo» contro il cesarismo).
Nel mondo moderno, con le sue grandi coalizioni di carattere economico‑ sindacale e politico di partito, il meccanismo del fenomeno cesarista è molto diverso da quello che fu fino a Napoleone III. Nel periodo fino a Napoleone III le forze militari regolari o di linea erano un elemento decisivo per l’avvento del cesarismo, che si verificava con colpi di Stato ben precisi, con azioni militari ecc. Nel mondo moderno, le forze sindacali e politiche, coi mezzi finanziari incalcolabili di cui possono disporre piccoli gruppi di cittadini, complicano il problema. I funzionari dei partiti e dei sindacati economici possono essere corrotti o terrorizzati, senza bisogno di azione militare in grande stile, tipo Cesare o 18 brumaio. Si riproduce in questo campo la stessa situazione esaminata a proposito della formula giacobina‑quarantottesca della così detta «rivoluzione permanente». La tecnica politica moderna è completamente mutata dopo il 48, dopo l’espansione del parlamentarismo, del regime associativo sindacale e di partito, del formarsi di vaste burocrazie statali e «private» (politico‑private, di partiti e sindacali) e le trasformazioni avvenute nell’organizzazione della polizia in senso largo, cioè non solo del servizio statale destinato alla repressione della delinquenza, ma dell’insieme delle forze organizzate dallo Stato e dai privati per tutelare il dominio politico ed economico delle classi dirigenti. In questo senso, interi partiti «politici» e altre organizzazioni economiche o di altro genere devono essere considerati organismi di polizia politica, di carattere investigativo e preventivo.
Lo schema generico delle forze A e B in lotta con prospettiva catastrofica, cioè con la prospettiva che non vinca né A né B nella lotta per costituire (o ricostituire un equilibrio organico, da cui nasce (può nascere) il cesarismo, è appunto un’ipotesi generica, uno schema sociologico (di comodo per l’arte politica). L’ipotesi può essere resa sempre più concreta, portata a un grado sempre maggiore di approssimazione alla realtà storica concreta e ciò può ottenersi precisando alcuni elementi fondamentali. Così, parlando di A e di B si è solo detto che esse sono una forza genericamente progressi va e una forza genericamente regressiva: si può precisare di quale tipo di forze progressive e regressive si tratta e ottenere così maggiori approssimazioni. Nel caso di Cesare e di Napoleone I si può dire che A e B, pur essendo distinte e contrastanti, non erano però tali da non poter venire «assolutamente» ad una fusione ed assimilazione reciproca dopo un processo molecolare, ciò che infatti avvenne, almeno in una certa misura (sufficiente tuttavia ai fini storico‑politici della cessazione della lotta organica fondamentale e quindi del superamento della fase catastrofica). Questo è un elemento di maggiore approssimazione. Un altro elemento è il seguente: la fase catastrofica può emergere per una deficienza politica «momentanea» della forza dominante tradizionale e non già per una deficienza organica necessariamente insuperabile. Ciò si è verificato nel caso di Napoleone III. La forza dominante in Francia dal 1815 al 1848 si era scissa politicamente (faziosamente) in quattro frazioni: quella legittimista, quella orleanista, quella bonapartista, quella giacobino‑repubblicana. Le lotte interne di fazione erano tali da rendere possibile l’avanzata della forza antagonista B (progressista) in forma «precoce»; tuttavia la forma sociale esistente non aveva ancora esaurito le sue possibilità di sviluppo, come la storia successiva dimostrò abbondantemente. Napoleone III rappresentò (a suo modo, secondo la statura dell’uomo, che non era grande) queste possibilità latenti e immanenti: il suo cesarismo dunque ha un colore particolare. È obbiettivamente progressivo sebbene non come quello di Cesare e di Napoleone I. Il cesarismo di Cesare e di Napoleone I è stato, per così dire, di carattere quantitativo‑qualitativo, ha cioè rappresentato la fase storica di passaggio da un tipo di Stato a un altro tipo, un passaggio in cui le innovazioni furono tante e tali da rappresentare un completo rivolgimento. Il cesarismo di Napoleone III fu solo e limitatamente quantitativo, non ci fu passaggio da un tipo di Stato ad un altro tipo, ma solo «evoluzione» dello stesso tipo, secondo una linea ininterrotta.
Nel mondo moderno i fenomeni di cesarismo sono del tutto diversi, sia da quelli del tipo progressivo Cesare‑Napoleone I, come anche da quelli del tipo Napoleone III, sebbene si avvicinino a quest’ultimo. Nel mondo moderno l’equilibrio a prospettive catastrofiche non si verifica tra forze che in ultima analisi potrebbero fondersi e unificarsi, sia pure dopo un processo faticoso e sanguinoso, ma tra forze il cui contrasto è insanabile storicamente e anzi si approfondisce specialmente coll’avvento di forme cesaree. Tuttavia il cesarismo ha anche nel mondo moderno un certo margine, più o meno grande, a seconda dei paesi e del loro peso relativo nella struttura mondiale, perché una forma sociale ha «sempre» possibilità marginali di ulteriore sviluppo e sistemazione organizzativa e specialmente può contare sulla debolezza relativa della forza progressiva antagonistica, per la natura e il modo di vita peculiare di essa, debolezza che occorre mantenere: perciò si è detto che il cesarismo moderno più che militare è poliziesco.
Q13 §28 Sullo sviluppo della tecnica militare. Il tratto più caratteristico e significativo dello stadio attuale della tecnica militare e quindi anche dell’indirizzo delle ricerche scientifiche in quanto sono connesse con lo sviluppo della tecnica militare (o tendono a questo fine) pare sia da ricercare in ciò, che la tecnica militare in alcuni suoi aspetti tende a rendersi indipendente dal complesso della tecnica generale e a diventare un’attività a parte, autonoma. Fino alla guerra mondiale la tecnica militare era una semplice applicazione specializzata della tecnica generale e pertanto la potenza militare di uno Stato o di un gruppo di Stati (alleati per integrarsi a vicenda) poteva essere calcolata con esattezza quasi matematica sulla base della potenza economica (industriale, agricola, finanziaria, tecnico‑culturale). Dalla guerra mondiale in poi questo calcolo non è più possibile, almeno con pari esattezza o approssimazione, e ciò costituisce la più formidabile incognita dell’attuale situazione politico-militare. Come punto di riferimento basta accennare ad alcuni elementi: il sottomarino, l’aeroplano da bombardamento, il gas e i mezzi chimici e batteriologici applicati alla guerra. Ponendo la questione nei suoi termini limite, per assurdo, si può dire che Andorra può produrre mezzi bellici in gas e bacteri da sterminare l’intera Francia.
Questa situazione della tecnica militare è uno degli elementi più «silenziosamente» operanti di quella trasformazione dell’arte politica che ha portato al passaggio, anche in politica, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione o di assedio.
Q13 §29 Volontarismo e masse sociali. In tutta una serie di quistioni, sia di ricostruzione della storia passata, sia di analisi storico‑politica del presente, non si tiene conto di questo elemento; che occorre distinguere e valutare diversamente le imprese e le organizzazioni di volontari, dalle imprese e dalle organizzazioni di blocchi sociali omogenei (è evidente che per volontari non si deve intendere l’élite quando essa è espressione organica della massa sociale, ma del volontario staccato dalla massa per spinta individuale arbitraria e in contrasto spesso con la massa o indifferente per essa). Questo elemento ha importanza specialmente per l’Italia: 1) per l’apoliticismo e la passività tradizionali nelle grandi masse popolari che hanno come reazione naturale una relativa facilità al «reclutamento di volontari»; 2) per la costituzione sociale italiana, uno dei cui elementi è la malsana quantità di borghesi rurali o di tipo rurale, medi e piccoli, da cui si formano molti intellettuali irrequieti e quindi facili «volontari» per ogni iniziativa anche la più bizzarra, che sia vagamente sovversiva (a destra o a sinistra); 3) la massa di salariati rurali e di lumpenproletariat, che pittorescamente in Italia è chiamata la classe dei «morti di fame». Nell’analisi dei partiti politici italiani si può vedere che essi sono sempre stati di «volontari», in un certo senso di spostati, e mai o quasi mai di blocchi sociali omogenei. Un’eccezione è stata la destra storica cavourriana e quindi la sua superiorità organica e permanente sul così detto Partito d'Azione mazziniano e garibaldino, che è stato il prototipo di tutti i partiti italiani di «massa» successivi, che non furono tali in realtà (cioè non ordinarono gruppi omogenei sociali) ma furono attendamenti zingareschi e nomadi della politica. Si può trovare una sola analisi di tal genere (ma imprecisa e gelatinosa, da un punto di vista solo «statistico‑sociologico») nel volume di Roberto Michels su Borghesia e proletariato.
La posizione del Gottlieb fu appunto simile a quella del Partito d’Azione, cioè zingaresca e nomade: l’interesse sindacale era molto superficiale e di origine polemica, non sistematico, non organico e conseguente, non di ricerca di omogeneità sociale, ma paternalistico e formalistico.
Q13 §30 Il numero e la qualità nei regimi rappresentativi. Uno dei luoghi comuni più banali che si vanno ripetendo contro il sistema elettivo di formazione degli organi statali è questo, che il «numero sia in esso legge suprema» e che la «opinione di un qualsiasi imbecille che sappia scrivere (e anche di un analfabeta, in certi paesi), valga, agli effetti di determinare il corso politico dello Stato, esattamente quanto quella di chi allo Stato e alla Nazione dedichi le sue migliori forze» ecc. (le formulazioni sono molte, alcune anche più felici di questa riportata, che è di Mario da Silva, nella «Critica Fascista» del 15 agosto 1932, ma il contenuto è sempre uguale). Ma il fatto è che non è vero, in nessun modo, che il numero sia «legge suprema», né che il peso dell’opinione di ogni elettore sia «esattamente» uguale.
I numeri, anche in questo caso, sono un semplice valore strumentale, che danno una misura e un rapporto e niente di più. E che cosa poi si misura? Si misura proprio l’efficacia e la capacità di espansione e di persuasione delle opinioni di pochi, delle minoranze attive, delle élites, delle avanguardie ecc. ecc. cioè la loro razionalità o storicità o funzionalità concreta. Ciò vuol dire che non è vero che il peso delle opinioni dei singoli sia «esattamente» uguale. Le idee e le opinioni non «nascono» spontaneamente nel cervello di ogni singolo: hanno avuto un centro di formazione, di irradiazione, di diffusione, di persuasione, un gruppo di uomini o anche una singola individualità che le ha elaborate e presentate nella forma politica d’attualità. La numerazione dei «voti» è la manifestazione terminale di un lungo processo in cui l’influsso massimo appartiene proprio a quelli che «dedicano allo Stato e alla Nazione le loro migliori forze» (quando lo sono). Se questo presunto gruppo di ottimati, nonostante le forze materiali sterminate che possiede, non ha il consenso della maggioranza, sarà da giudicare o inetto o non rappresentante gli interessi «nazionali» che non possono non essere prevalenti nell’indurre la volontà nazionale in un senso piuttosto che in un altro. «Disgraziatamente» ognuno è portato a confondere il proprio «particulare» con l’interesse nazionale e quindi a trovare «orribile» ecc. che sia la «legge del numero» a decidere; è certo miglior cosa diventare élite per decreto. Non si tratta pertanto di chi «ha molto» intellettualmente che si sente ridotto al livello dell’ultimo analfabeta, ma di chi presume di aver molto e che vuole togliere all’uomo «qualunque» anche quella frazione infinitesima di potere che egli possiede nel decidere sul corso della vita statale.
Dalla critica (di origine oligarchica e non di élite) al regime parlamentaristico (è strano che esso non sia criticato perché la razionalità storicistica del consenso numerico è sistematicamente falsificata dall’influsso della ricchezza), queste affermazioni banali sono state estese a ogni sistema rappresentativo, anche non parlamentaristico, e non foggiato secondo i canoni della democrazia formale. Tanto meno queste affermazioni sono esatte. In questi altri regimi il consenso non ha nel momento del voto una fase terminale, tutt’altre. Il consenso è supposto permanentemente attivo, fino al punto che i consenzienti potrebbero essere considerati come «funzionari» dello Stato e le elezioni un modo di arruolamento volontario di funzionari statali di un certo tipo, che in un certo senso potrebbe ricollegarsi (in piani diversi) al self‑government. Le elezioni avvenendo non su programmi generici e vaghi, ma di lavoro concreto immediato, chi consente si impegna a fare qualcosa di più del comune cittadino legale, per realizzarli, a essere cioè una avanguardia di lavoro attivo e responsabile. L’elemento «volontariato» nell’iniziativa non potrebbe essere stimolato in altro modo per le più larghe moltitudini, e quando queste non siano formate di cittadini amorfi, ma di elementi produttivi qualificati, si può intendere l’importanza che la manifestazione del voto può avere. (Queste osservazioni potrebbero essere svolte più ampiamente e organicamente, mettendo in rilievo anche altre differenze tra i diversi tipi di elezionismo, a seconda che mutano i rapporti generali sociali e politici: rapporto tra funzionari elettivi e funzionari di carriera ecc.).
Q13 §31 Il teorema delle proporzioni definite. Questo teorema può essere impiegato utilmente per tendere più chiari e di uno schematismo più evidente molti ragionamenti riguardanti la scienza dell’organizzazione (lo studio dell’apparato amministrativo, della composizione demografica ecc.) e anche la politica generale (nelle analisi delle situazioni, dei rapporti di forza, nel problema degli intellettuali ecc.). S’intende che occorre sempre ricordare come il ricorso al teorema delle proporzioni definite ha un valore schematico e metaforico, cioè non può essere applicato meccanicamente, poiché negli aggregati umani l’elemento qualitativo (o di capacità tecnica e intellettuale dei singoli componenti) ha una funzione predominante, mentre non può essere misurato matematicamente. Perciò si può dire che ogni aggregato umano ha un suo particolare principio ottimo di proporzioni definite. Specialmente la scienza dell’organizzazione può ricorrere utilmente a questo teorema e ciò appare con chiarezza nell’esercito. Ma ogni forma di società ha un suo tipo di esercito e ogni tipo di esercito ha un suo principio di proporzioni definite, che del resto cambia anche per le diverse armi o specialità. C’è un determinato rapporto tra uomini di truppa, graduati, sottufficiali, ufficiali subalterni, ufficiali superiori, stati maggiori, stato maggiore generale ecc. C’è un rapporto tra le varie armi e specialità tra loro ecc. Ogni mutamento in una parte determina la necessità di un nuovo equilibrio col tutto ecc. Politicamente il teorema si può vedere applicato nei partiti, nei sindacati, nelle fabbriche e vedere come ogni gruppo sociale ha una propria legge di proporzioni definite, che varia a seconda del livello di cultura, di indipendenza mentale, di spirito d’iniziativa e di senso della responsabilità e della disciplina dei suoi membri più arretrati e periferici.
La legge delle proporzioni definite è così riassunta dal Pantaleoni nei Principii di Economia pura: «... I corpi si combinano chimicamente soltanto in proporzioni definite e ogni quantità di un elemento che superi la quantità richiesta per una combinazione con altri elementi, presenti in quantità definite, resta libera; se la quantità di un elemento è deficiente per rapporto alla quantità di altri elementi presenti, la combinazione non avviene che nella misura in cui è sufficiente la quantità dell’elemento che è presente in quantità minore degli altri». Si potrebbe servirsi metaforicamente di questa legge per comprendere come un «movimento» o tendenza di opinioni, diventa partito, cioè forza politica efficiente dal punto di vista dell’esercizio del potere governativo; nella misura appunto in cui possiede (ha elaborato nel suo interno) dirigenti di vario grado e nella misura in cui essi dirigenti hanno acquisito determinate capacità. L’«automatismo» storico di certe premesse (l’esistenza di certe condizioni obbiettive) viene potenziato politicamente dai partiti e dagli uomini capaci: la loro assenza o deficienza (quantitativa e qualitativa) rende sterile l’«automatismo» stesso (che pertanto non è automatismo): ci sono astrattamente le premesse, ma le conseguenze non si realizzano perché il fattore umano manca. Perciò si può dire che i partiti hanno il compito di elaborare dirigenti capaci, sono la funzione di massa che seleziona, sviluppa, moltiplica i dirigenti necessari perché un gruppo sociale definito (che è una quantità «fissa», in quanto si può stabilire quanti sono i componenti di ogni gruppo sociale) si articoli e da caos tumultuoso diventi esercito politico organicamente predisposto. Quando in elezioni successive dello stesso grado o di grado diverso (per esempio nella Germania prima di Hitler: elezioni per il presidente della repubblica, per il Reichstag, per le diete dei Länder, per i consigli comunali e giù giù fino ai comitati d’azienda) un partito oscilla nella sua massa di suffragi da massimi a minimi che sembrano strani e arbitrari, si può dedurre che i quadri di esso sono deficienti per quantità e per qualità, o per quantità e non per qualità (relativamente) o per qualità e non per quantità. Un partito che ha molti voti nelle elezioni locali e meno in quelle di più alta importanza politica, è certo deficiente qualitativamente nella sua direzione centrale: possiede molti subalterni o almeno in numero sufficiente, ma non possiede uno stato maggiore adeguato al paese e alla sua posizione nel mondo, ecc. Analisi di questo genere sono accennate in altri paragrafi.
Q13 §32 Sul concetto di grande potenza. La misura decisiva per stabilire cosa deve intendersi per grande potenza è data dalla guerra. Il concetto di grande potenza è strettamente legato alle guerre. È grande potenza quello Stato che entrato in un sistema di alleanze per una guerra – (e oggi ogni guerra presuppone dei sistemi di forze antagonistiche) al momento della pace è riuscito a conservare un tale rapporto di forze con gli alleati da essere in grado di far mantenere i patti e le promesse fatte all’inizio della campagna. Ma uno Stato che per entrare in guerra ha bisogno di grossi prestiti, ha bisogno continuo di armi e munizioni per i suoi soldati, di vettovaglie per l’esercito e per la popolazione civile, di navi per i trasporti, che cioè non può far la guerra senza l’aiuto continuo dei suoi alleati e che per qualche tempo anche dopo la pace ha ancora bisogno di aiuti, specialmente di vettovaglie, di prestiti o altre forme di sussidi finanziari, come può essere uguale ai suoi alleati e imporsi perché mantengano i patti? Un simile Stato è considerato grande potenza solo nelle carte diplomatiche, ma nella realtà è considerato come un probabile fornitore di uomini per la coalizione che ha i mezzi non solo di sostenere le proprie forze militari ma anche per finanziare quelle degli altri alleati.
Nella politica estera: «Così la politica estera italiana, mirando sempre alla stessa meta, è stata sempre rettilinea, e le sue pretese oscillazioni sono state in realtà determinate soltanto dalle incertezze e dalle contraddizioni altrui, com’è inevitabile nel campo internazionale dove infiniti sono gli elementi in contrasto» (Aldo Valori, «Corriere della Sera» del 12 maggio 1932). Che siano infiniti gli elementi di equilibrio di un sistema politico internazionale, è verissimo, ma appunto per ciò il sistema deve essere stabilito in modo che nonostante le fluttuazioni esterne, la propria linea non oscilli (è poi difficile definire cosa s’intende in tal caso per oscillazione – che non può essere intesa meccanicamente al modo dei farmacisti di villaggio e di una mera coerenza formale). La linea di uno Stato egemonico (cioè di una grande potenza) non oscilla, perché esso stesso determina la volontà altrui e non ne è determinato, perché la linea politica è fondata su ciò che vi è di permanente e non di casuale e immediato e nei propri interessi e in quelli delle altre forze che concorrono in modo decisivo a formare un sistema e un equilibrio.
Q13 §33 Sul concetto di partito politico. Quando si vuol scrivere la storia di un partito politico, in realtà occorre affrontare tutta una serie di problemi molto meno semplici di quanto creda, per es., Roberto Michels che pure è ritenuto uno specialista in materia. Cosa sarà la storia di un partito? Sarà la mera narrazione della vita interna di una organizzazione politica? come essa nasce, i primi gruppi che la costituiscono, le polemiche ideologiche attraverso cui si forma il suo programma e la sua concezione del mondo e della vita? Si tratterebbe in tal caso, della storia di ristretti gruppi intellettuali e talvolta della biografia politica di una singola individualità. La cornice del quadro dovrà, adunque, essere più vasta e comprensiva. Si dovrà fare la storia di una determinata massa di uomini che avrà seguito i promotori, li avrà sorretti con la sua fiducia, con la sua lealtà, con la sua disciplina o li avrà criticati «realisticamente» disperdendosi o rimanendo passiva di fronte a talune iniziative. Ma questa massa sarà costituita solo dagli aderenti al partito? Sarà sufficiente seguire i congressi, le votazioni, ecc., cioè tutto l’insieme di attività e di modi di esistenza con cui una massa di partito manifesta la sua volontà? Evidentemente occorrerà tener conto del gruppo sociale di cui il partito dato è espressione e parte più avanzata: la storia di un partito, cioè, non potrà non essere la storia di un determinato gruppo sociale. Ma questo gruppo non è isolato; ha amici, affini, avversari, nemici. Solo dal complesso quadro di tutto l’insieme sociale e statale (e spesso anche con interferenze internazionali) risulterà la storia di un determinato partito, per cui si può dire che scrivere la storia di un partito significa niente altro che scrivere la storia generale di un paese da un punto di vista monografico, per porne in risalto un aspetto caratteristico. Un partito avrà avuto maggiore o minore significato e peso, nella misura appunto in cui la sua particolare attività avrà pesato più o meno nella determinazione della storia di un paese.
Ecco quindi che dal modo di scrivere la storia di un partito risulta quale concetto si abbia di ciò che è un partito o debba essere. Il settario si esalterà nei fatterelli interni, che avranno per lui un significato esoterico e lo riempiranno di mistico entusiasmo; lo storico, pur dando a ogni cosa l’importanza che ha nel quadro generale, poserà l’accento soprattutto sull’efficienza reale del partito, sulla sua forza determinante, positiva e negativa, nell’aver contribuito a creare un evento e anche nell’aver impedito che altri eventi si compissero.
Q13 §34 Sull’origine delle guerre. Come si può dire che le guerre tra gli Stati possono avere la loro origine nelle lotte dei gruppi nell’interno di ogni singola nazione? È certo che in ogni nazione deve esistere una certa (e specifica per ogni nazione) espressione della legge delle proporzioni definite nella composizione sociale: i vari gruppi cioè devono trovarsi in certi rapporti di equilibrio, il cui turbamento radicale potrebbe condurre a una catastrofe sociale. Questi rapporti variano a seconda che un paese è prevalentemente agricolo o industriale e a seconda dei diversi gradi di sviluppo delle forze produttive materiali e del tenore di vita. Il gruppo dirigente tenderà a mantenere l’equilibrio migliore per il suo permanere, non solo, ma per il suo permanere in condizioni determinate di floridezza, e anzi a incrementare tali condizioni. Ma siccome l’area sociale di ogni paese è limitata, sarà portato a estenderla nelle zone coloniali e d’influenza e quindi a entrare in conflitto con altri gruppi dirigenti che aspirano allo stesso fine o ai cui danni l’espansione di esso dovrebbe necessariamente avvenire, poiché anche il globo terrestre è limitato. Ogni gruppo dirigente tende in astratto ad allargare la base della società lavoratrice da cui prelevare plusvalore, ma la tendenza astratta diventa concreta e immediata quando il prelevamento di plusvalore nella sua base storica è diventato difficile o pericoloso oltre certi limiti che sono tuttavia insufficienti.
Q13 §35 Arte politica e arte militare. Lo scrittore ita liano di cose militari generale De Cristoforis nel suo libro Che cosa sia la guerra dice che per «distruzione dell’esercito nemico» (fine strategico) non si intende «la morte dei soldati, ma lo scioglimento del loro legame come massa organica». La formula è felice e può essere impiegata anche nel la terminologia politica. Si tratta di identificare quale sia nella vita politica il legame organico essenziale, che non può consistere solo nei rapporti giuridici (libertà di associazione e riunione ecc., con la sequela dei partiti e dei sindacati ecc.) ma si radica nei più profondi rapporti economici, cioè nella funzione sociale nel mondo produttivo (forme di proprietà e di direzione ecc.)
Q13 §36 Sulla burocrazia. 1) Il fatto che nello svolgimento storico delle forme politiche ed economiche si sia venuto formando il tipo del funzionario «di carriera», tecnicamente addestrato al lavoro burocratico (civile e militare) ha un significato primordiale nella scienza politica e nella storia delle forme statali. Si è trattato di una necessità o di una degenerazione in confronto dell’autogoverno (self‑government) come pretendono i liberisti «puri»? È certo che ogni forma sociale e statale ha avuto un suo problema dei funzionari, un suo modo di impostarlo e risolverlo, un suo sistema di selezione, un suo tipo di funzionario da educare. Ricostruire lo svolgimento di tutti questi elementi è di importanza capitale. Il problema dei funzionari coincide in parte col problema degli intellettuali. Ma se è vero che ogni nuova forma sociale e statale ha avuto bisogno di un nuovo tipo di funzionario, è vero anche che i nuovi gruppi dirigenti non hanno mai potuto prescindere, almeno per un certo tempo, dalla tradizione e dagli interessi costituiti, cioè dalle formazioni di funzionari già esistenti e precostituiti al loro avvento (ciò specialmente nella sfera ecclesiastica e in quella militare). L’unità del lavoro manuale e intellettuale e un legame più stretto tra il potere legislativo e quello esecutivo (per cui i funzionari eletti, oltre che del controllo, si interessino dell’esecuzione degli affari di Stato) possono essere motivi ispiratori sia per un indirizzo nuovo nella soluzione del problema degli intellettuali che di quello dei funzionari.
2) Connessa con la quistione della burocrazia e della sua organizzazione «ottima» è la discussione sui cosidetti «centralismo organico» e «centralismo democratico» (che d’altronde non ha niente a che fare con la democrazia astratta, tanto che la Rivoluzione francese e la terza Repubblica hanno sviluppato delle forme di centralismo organico che non avevano conosciuto né la monarchia assoluta né Napoleone I). Saranno da ricercare ed esaminare i reali rapporti economici e politici che trovano la loro forma organizzativa, la loro articolazione e la loro funzionalità nelle diverse manifestazioni di centralismo organico e democratico in tutti i campi: nella vita statale (unitarismo, federazione, unione di Stati federati, federazione di Stati o Stato federale ecc.), nella vita interstatale (alleanza, forme varie di «costellazione» politica internazionale), nella vita delle associazioni politiche e culturali (massoneria, Rotary Club, Chiesa cattolica), sindacali economiche (cartelli, trusts), in uno stesso paese, in diversi paesi ecc.
Polemiche sorte nel passato (prima del 1914) a proposito del predominio tedesco nella vita dell’alta cultura e di alcune forze politiche internazionali: era poi reale questo predominio o in che cosa realmente consisteva? Si può dire: a) che nessun nesso organico e disciplinare stabiliva una tale supremazia, che pertanto era un mero fenomeno di influsso culturale astratto e di prestigio molto labile; b) che tale influsso culturale non toccava per nulla l’attività effettuale, che viceversa era disgregata, localistica, senza indirizzo d’insieme. Non si può parlare perciò di nessun centralismo, né organico né democratico né d’altro genere o misto. L’influsso era sentito e subito da scarsi gruppi intellettuali, senza legame con le masse popolari e appunto questa assenza di legame caratterizzava la situazione. Tuttavia un tale stato di cose è degno di esame perché giova a spiegare il processo che ha condotto a formulare le teorie del centralismo organico, che sono state appunto una critica unilaterale e da intellettuali di quel disordine e di quella dispersione di forze.
Occorre intanto distinguere nelle teorie del centralismo organico tra quelle che velano un preciso programma di predominio reale di una parte sul tutto (sia la parte costituita da un ceto come quello degli intellettuali, sia costituita da un gruppo territoriale «privilegiato») e quelle che sono una pura posizione unilaterale di settari e fanatici, e che pur potendo nascondere un programma di predominio (di solito di una singola individualità, come quella del papa infallibile per cui il cattolicismo si è trasformato in una specie di culto del pontefice), immediatamente non pare nascondere un tale programma come fatto politico consapevole. Il nome più esatto sarebbe quello di centralismo burocratico. L’«organicità» non può essere che del centralismo democratico il quale è un «centralismo» in movimento, per così dire, cioè una continua adeguazione dell’organizzazione al movimento reale, un contemperare le spinte dal basso con il comando dall’alto, un inserimento continuo degli elementi che sbocciano dal profondo della massa nella cornice solida dell’apparato di direzione che assicura la continuità e l’accumularsi regolare delle esperienze: esso è «organico» perché tiene conto del movimento, che è il modo organico di rivelarsi della realtà storica e non si irrigidisce meccanicamente nella burocrazia, e nello stesso tempo tiene conto di ciò che è relativamente stabile e permanente o che per lo meno si muove in una direzione facile a prevedersi ecc. Questo elemento di stabilità nello Stato si incarna nello sviluppo organico del nucleo centrale del gruppo dirigente così come avviene in più ristretta scala nella vita dei partiti. Il prevalere del centralismo burocratico nello Stato indica che il gruppo dirigente è saturato diventando una consorteria angusta che tende a perpetrare i suoi gretti privilegi regolando o anche soffocando il nascere di forze contrastanti, anche se queste forze sono omogenee agli interessi dominanti fondamentali (per es. nei sistemi protezionistici a oltranza in lotta col liberismo economico). Nei partiti che rappresentano gruppi socialmente subalterni l’elemento di stabilità è necessario per assicurare l’egemonia non a gruppi privilegiati ma agli elementi progressivi, organicamente progressivi in confronto di altre forze affini e alleate ma composite e oscillanti.
In ogni caso occorre rilevare che le manifestazioni morbose di centralismo burocratico sono avvenute per deficienza di iniziativa e responsabilità nel basso, cioè per la primitività politica delle forze periferiche, anche quando esse sono omogenee con il gruppo territoriale egemone (fenomeno del piemontesismo nei primi decenni dell’unità italiana). Il formarsi di tali situazioni può essere estremamente dannoso e pericoloso negli organismi internazionali (Società delle Nazioni).
Il centralismo democratico offre una formula elastica, che si presta a molte incarnazioni; essa vive in quanto è interpretata e adattata continuamente alle necessità: essa consiste nella ricerca critica di ciò che è uguale nell’apparente disformità e invece distinto e anche opposto nell’apparente uniformità per organare e connettere strettamente ciò che è simile, ma in modo che l’organamento e la connessione appaiano una necessità pratica e «induttiva», sperimentale e non il risultato di un processo razionalistico, deduttivo, astrattistico, cioè proprio degli intellettuali puri (o puri asini). Questo lavorio continuo per sceverare l’elemento «internazionale» e «unitario» nella realtà nazionale e localistica è in realtà l’azione politica concreta, l’attività sola produttiva di progresso storico. Esso richiede una organica unità tra teoria e pratica, tra ceti intellettuali e masse popolari, tra governanti e governati. Le formule di unità e federazione perdono gran parte del loro significato da questo punto di vista, mentre conservano il loro veleno nella concezione burocratica, per la quale finisce col non esistere unità ma palude stagnante, superficialmente calma e «muta» e non federazione ma «sacco di patate», cioè giustapposizione meccanica di singole «unità» senza nesso tra loro.
Q13 §37 sulla vita nazionale francese. Il partito monarchico in regime repubblicano, come il partito repubblicano in regime monarchico, o il partito nazionale in regime di soggezione del paese a uno Stato straniero, non possono non essere partiti sui generis: devono essere, cioè, se vogliono ottenere successi relativamente rapidi, le centrali di federazioni di partiti, più che partiti caratterizzati in tutti i punti particolari dei loro programmi di governo; partiti di un sistema generale di governo e non di governi particolari (in questa stessa serie spetta un posto a parte ai partiti confessionali, come il Centro tedesco o i diversi partiti cristiano‑sociali o popolari). Il partito monarchico si fonda in Francia sui residui ancora tenaci della vecchia nobiltà terriera e su una parte della piccola borghesia e degli intellettuali. Su che sperano i monarchici per diventare capaci di assumere il potere e restaurare la monarchia? Sperano sul collasso del regime parlamentare‑borghese e sulla incapacità di qualsiasi altra forza organizzata esistente ad essere il nucleo politico di una dittatura militare prevedibile o da loro stessi preordinata; in nessun altro modo le loro forze sociali sarebbero in grado di conquistare il potere. In attesa, il centro dirigente dell’Action Française svolge sistematicamente una serie di attività: un’azione organizzativa politico‑militare (militare nel senso di partito e nel senso di avere cellule attive fra gli ufficiali dell’esercito) per raggruppare nel modo più efficiente l’angusta base sociale su cui storicamente il movimento s’appoggia. Essendo questa base costituita di elementi in generale più scelti per intelligenza, cultura, ricchezza, pratica di amministrazione ecc. che qualsiasi altro movimento, è possibile avere un partito notevole, imponente persino, ma che però si esaurisce in se stesso, che non ha, cioè, riserve da gettare nella lotta in una crisi risolutiva. Il partito è notevole, pertanto, solo nei tempi normali, quando gli elementi attivi nella lotta politica si contano a decine di migliaia, ma diventerà insignificante (numericamente) nei periodi di crisi, quando gli attivi si conteranno a centinaia di migliaia e forse a milioni.
Lo sviluppo del giacobinismo (di contenuto) e della formula della rivoluzione permanente attuata nella fase attiva della Rivoluzione francese ha trovato il suo «perfezionamento» giuridico‑costituzionale nel regime parlamentare, che realizza, nel periodo più ricco di energie «private» nella società, l’egemonia permanente della classe urbana su tutta la popolazione, nella forma hegeliana del governo col consenso permanentemente organizzato (ma l’organizzazione del consenso è lasciata all’iniziativa privata, è quindi di carattere morale o etico, perché consenso «volontariamente» dato in un modo o nell’altro). Il «limite» trovato dai giacobini nella legge Chapelier e in quella del maximum, viene superato e respinto più lontano progressivamente attraverso un processo completo, in cui si alternano l’attività propagandistica e quella pratica (economica, politico‑giuridica): la base economica, per lo sviluppo industriale e commerciale, viene continuamente allargata e approfondita, dalle classi inferiori si innalzano fino alle classi dirigenti gli elementi sociali più ricchi di energia e di spirito d’intrapresa, la società intera è in continuo processo di formazione e di dissoluzione seguita da formazioni più complesse e ricche di possibilità; ciò dura, in linea generale, fino all’epoca dell’imperialismo e culmina nella guerra mondiale. In questo processo si alternano tentativi di insurrezione e repressioni spietate, allargamento e restrizioni del suffragio politico, libertà di associazione e restrizioni o annullamenti di questa libertà, libertà nel campo sindacale ma non in quello politico, forme diverse di suffragio, scrutinio di lista o circoscrizioni uninominali, sistema proporzionale o individuale, con le varie combinazioni che ne risultano – sistema delle due camere o di una sola camera elettiva, con vari modi di elezione per ognuna (camera vitalizia ed ereditaria, Senato a termine, ma con elezione dei Senatori diversa da quella dei deputati ecc.) –, vario equilibrio dei poteri, per cui la magistratura può essere un potere indipendente o solo un ordine, controllato e diretto dalle circolari ministeriali, diverse attribuzioni del capo del governo e dello Stato, diverso equilibrio interno degli organismi territoriali (centralismo o decentramento, maggiori o minori poteri dei prefetti, dei Consigli provinciali, dei Comuni, ecc.), diverso equilibrio tra le forze armate di leva e quelle professionali (polizia, gendarmeria), con la dipendenza di questi corpi professionali dall’uno o dall’altro organo statale (dalla magistratura, dal ministero dell’interno o dallo Stato maggiore); la maggiore o minore parte lasciata alla consuetudine o alla legge scritta, per cui si sviluppano forme consuetudinarie che possono ad un certo punto essere abolite in virtù delle leggi scritte (in alcuni paesi «pareva» si fossero costituiti regimi democratici, ma essi si erano costituiti solo formalmente, senza lotta, senza sanzione costituzionale e fu facile disgregarli senza lotta, o quasi, perché privi di sussidi giuridico‑morali e militari, ripristinando la legge scritta o dando della legge scritta interpretazioni reazionarie); il distacco più o meno grande tra le leggi fondamentali e i regolamenti d’esecuzione che annullano le prime o ne danno un’interpretazione restrittiva; l’impiego più o meno esteso dei decreti‑legge che tendono a sostituire la legislazione ordinaria e la modificano in certe occasioni, «forzando la pazienza» del parlamento fino a giungere a un vero e proprio «ricatto della guerra civile». A questo processo contribuiscono i teorici‑filosofi, i pubblicisti, i partiti politici ecc. per lo sviluppo della parte formale e i movimenti o le pressioni di massa per la parte sostanziale, con azioni e reazioni reciproche, con iniziative «preventive» prima che un fenomeno si manifesti pericolosamente e con repressioni quando le prevenzioni sono mancate o sono state tardive e inefficaci.
L’esercizio «normale» dell’egemonia nel terreno divenuto classico del regime parlamentare, è caratterizzato dalla combinazione della forza e del consenso che si equilibrano variamente, senza che la forza soverchi di troppo il consenso, anzi cercando di ottenere che la forza appaia appoggiata sul consenso della maggioranza, espresso dai così detti organi dell’opinione pubblica – giornali e associazioni – i quali, perciò, in certe situazioni, vengono moltiplicati artificiosamente. Tra il consenso e la forza sta la corruzione‑frode (che è caratteristica di certe situazioni di difficile esercizio della funzione egemonica, presentando l’impiego della forza troppi pericoli) cioè lo snervamento e la paralisi procurati all’antagonista o agli antagonisti con l’accaparrarne i dirigenti sia copertamente sia in caso di pericolo emergente, apertamente, per gettare lo scompiglio e il disordine nelle file antagoniste,
Nel periodo del dopoguerra, l’apparato egemonico si screpola e l’esercizio dell’egemonia diviene permanentemente difficile e aleatorio. Il fenomeno viene presentato e trattato con vari nomi e in aspetti secondari e derivati. I più triviali sono: «crisi del principio d’autorità» e «dissoluzione del regime parlamentare». Naturalmente del fenomeno si descrivono solo le manifestazioni «teatrali» sul terreno parlamentare e del governo politico ed esse appunto si spiegano col fallimento di alcuni «principii» (parlamentare, democratico, ecc.) e con la «crisi» del principio d’autorità (del fallimento di questo principio parleranno altri non meno superficiali e superstiziosi). La crisi si presenta praticamente nella sempre crescente difficoltà di formare i governi e nella sempre crescente instabilità dei governi stessi: essa ha la sua origine immediata nella moltiplicazione dei partiti parlamentari, e nelle crisi interne permanenti di ognuno di questi partiti (si verifica cioè nell’interno di ogni partito ciò che si verifica nell’intero parlamento: difficoltà di governo e instabilità di direzione). Le forme di questo fenomeno sono anche, in una certa misura, di corruzione e dissoluzione morale: ogni frazione di partito crede di avere la ricetta infallibile per arrestare l’indebolimento dell’intero partito, e ricorre a ogni mezzo per averne la direzione o almeno per partecipare alla direzione, così come nel parlamento il partito crede di essere il solo a dover formare il governo per salvare il paese o almeno pretende, per dare l’appoggio al governo, di doverci partecipare il più largamente possibile; quindi contrattazioni cavillose e minuziose, che non possono non essere personalistiche in modo da apparire scandalose, e che spesso sono infide e perfide. Forse, nella realtà, la corruzione personale è minore di quanto appare, perché tutto l’organismo politico è corrotto dallo sfacelo della funzione egemonica. Che gli interessati a che la crisi si risolva dal loro punto di vista, fingano di credere e proclamino a gran voce che si tratta della «corruzione» e della «dissoluzione» di una serie di «principii» (immortali o no), potrebbe anche essere giustificato: ognuno è il giudice migliore nella scelta delle armi ideologiche che sono più appropriate ai fini che vuol raggiungere e la demagogia può essere ritenuta arma eccellente. Ma la cosa diventa comica quando il demagogo non sa di esserlo ed opera praticamente come fosse vero nella realtà effettuale che l’abito è il monaco e il berretto il cervello. Machiavelli diventa così Stenterello.
La crisi in Francia. Sua grande lentezza di sviluppi. I partiti politici francesi: essi erano molto numerosi anche prima del 1914. La loro molteplicità formale dipende dalla ricchezza di eventi rivoluzionari e politici in Francia dal 1789 all’Affare Dreyfus: ognuno di questi eventi ha lasciato sedimenti e strascichi che si sono consolidati in partiti, ma le differenze essendo molto meno importanti delle coincidenze, in realtà ha sempre regnato nel Parlamento il regime dei due partiti, liberali‑democratici (varie gamme del radicalismo) e conservatori. Si può anzi dire che la molteplicità dei partiti, date le circostanze particolari della formazione politico‑nazionale francese è stata molto utile nel passato: ha permesso una vasta opera di selezioni individuali e ha creato il gran numero di abili uomini di governo che è caratteristica francese. Attraverso questo meccanismo molto snodato e articolato, ogni movimento dell’opinione pubblica trovava un immediato riflesso e una composizione. L’egemonia borghese è molto forte e ha molte riserve. Gli intellettuali sono molto concentrati (Istituto di Francia, Università, grandi giornali e riviste di Parigi) e quantunque numerosissimi sono in fondo molto disciplinati ai centri nazionali di cultura. La burocrazia militare e civile ha una grande tradizione e ha raggiunto un alto grado di omogeneità attiva.
La debolezza interna più pericolosa per l’apparato statale (militare e civile) consisteva nell’alleanza del clericalismo e del monarchismo. Ma la massa popolare, se pure cattolica, non era clericale. Nell’affare Dreyfus è culminata la lotta per paralizzare l’influsso clericale‑monarchico nell’apparato statale e per dare all’elemento laico la netta prevalenza. La guerra non ha indebolito ma rafforzato l’egemonia; non si è avuto il tempo di pensare: lo Stato è entrato in guerra e quasi subito il territorio è stato invaso. Il passaggio dalla disciplina di pace a quella di guerra non ha domandato una crisi troppo grande: i vecchi quadri militari erano abbastanza vasti ed elastici; gli ufficiali subalterni e i sottufficiali erano forse i più selezionati del mondo e i meglio allenati alle funzioni di comando immediato sulle truppe. Confronto con altri paesi. La quistione degli arditi e del volontarismo; la crisi dei quadri, determinata dal sopravvento degli ufficiali di complemento, che altrove avevano una mentalità antitetica con gli ufficiali di carriera. Gli arditi, in altri paesi, hanno rappresentato un nuovo esercito di volontari, una selezione militare, che ebbe una funzione tattica primordiale. Il contatto col nemico fu cercato solo attraverso gli arditi, che formavano come un velo tra il nemico e l’esercito di leva (funzione delle stecche nel busto). La fanteria francese era formata in grandissima maggioranza di coltivatori diretti, cioè di uomini forniti di una riserva muscolare e nervosa molto ricca che rese più difficile il collasso fisico procurato dalla lunga vita di trincea (il consumo medio di un cittadino francese è di circa 1 500 000 calorie annue, mentre quello italiano è minore di 1 000 000); in Francia il bracciantato agricolo è minimo, il contadino senza terra è servo di fattoria cioè vive la stessa vita dei padroni e non conosce l’inedia della disoccupazione neanche stagionale; il vero bracciantato si confonde con la mala vita rurale ed è formato di elementi irrequieti che viaggiano da un angolo all’altro del paese per piccoli lavori marginali. Il vitto in trincea era migliore che in altri paesi e il passato democratico, ricco di lotte e di ammaestramenti reciproci, aveva creato il tipo diffuso del cittadino moderno anche nelle classi subalterne, cittadino nel doppio senso, che l’uomo del popolo si sentiva qualche cosa non solo, ma era ritenuto qualche cosa anche dai superiori, dalle classi dirigenti, cioè non era sfottuto e bistrattato per bazzecole. Non si formarono così, durante la guerra, quei sedimenti di rabbia avvelenata e sorniona che si formarono altrove. Le lotte interne del dopoguerra mancarono perciò di grande asprezza e specialmente, non si verificò l’inaudita oscillazione delle masse rurali verificatasi altrove.
La crisi endemica del parlamentarismo francese indica che c’è un malessere diffuso nel paese ma questo malessere non ha avuto finora un carattere radicale, non ha posto in gioco quistioni intangibili. C’è stato un allargamento della base industriale e quindi un accresciuto urbanesimo. Masse di rurali si sono riversate in città, ma non perché ci fosse in campagna disoccupazione o fame insoddisfatta di terra; perché in città si sta meglio, ci sono più soddisfazioni ecc. (il prezzo della terra è bassissimo e molte terre buone sono abbandonate agli Italiani). La crisi parlamentare riflette (finora) piuttosto uno spostamento normale di masse (non dovuto ad acuta crisi economica), con una ricerca laboriosa di nuovi equilibri di rappresentanza e di partiti e un malessere vago che è solo premonitore di una possibile grande crisi politica. La stessa sensibilità dell’organismo politico porta ad esagerare formalmente i sintomi del malessere. Finora si è trattato di una serie di lotte per la divisione dei carichi e dei benefici statali, più che altro, perciò crisi dei partiti medi e di quello radicale in primo luogo, che rappresenta le città medie e piccole e i contadini più avanzati. Le forze politiche si preparano alle grandi lotte future e cercano un migliore assestamento; le forze extrastatali fanno sentire più sensibilmente il loro peso e impongono i loro uomini in modo più brutale.
Il punto culminante della crisi parlamentare francese fu raggiunto nel 1925 e dall’atteggiamento verso quegli avvenimenti, ritenuti decisivi, occorre partire per dare un giudizio sulla consistenza politica e ideologica dell’Action Française. Maurras gridò allo sfacelo del regime repubblicano e il suo gruppo si preparò alla presa del potere. Maurras è spesso esaltato come un grande statista e come un grandissimo Realpolitiker: in realtà egli è solo un giacobino alla rovescia. I giacobini impiegavano un certo linguaggio, erano convinti fautori di una determinata ideologia; nel tempo e nelle circostanze date, quel linguaggio e quella ideologia erano ultrarealistici, perché ottenevano di mettere in moto le energie politiche necessarie ai fini della Rivoluzione e a consolidare permanentemente l’andata al potere della classe rivoluzionaria; furono poi staccati, come avviene quasi sempre, dalle condizioni di luogo e di tempo e ridotti in formule e divennero una cosa diversa, una larva, parole vacue e inerti. Il comico consiste nel fatto che il Maurras capovolse banalmente quelle formule, creandone altre che sistemò in un ordine logico‑letterario impeccabile, le quali non potevano anche esse che rappresentare il riflesso del più puro e triviale illuminismo. In realtà è proprio Maurras il più rappresentativo campione dello «stupido secolo XIX», la concentrazione di tutti i luoghi comuni massonici meccanicamente rovesciati: la sua relativa fortuna dipende appunto da ciò che il suo metodo piace perché è quello della ragione ragionante da cui è nato l’enciclopedismo, e tutta la tradizione culturale massonica francese. L’illuminismo creò una serie di miti popolari, che erano solo la proiezione nel futuro delle più profonde e millenarie aspirazioni delle grandi masse, aspirazioni legate al cristianesimo e alla filosofia del senso comune, miti semplicistici quanto si vuole, ma che avevano un’origine realmente radicata nei sentimenti e che, in ogni caso, non potevano essere controllati sperimentalmente (storicamente); Maurras ha creato il mito «semplicistico» di un passato monarchico francese fantastico; ma questo mito è stato «storia» e le deformazioni intellettualistiche di essa possono essere facilmente corrette: tutta la istruzione pubblica francese è una implicita rettifica del mito monarchico, che in tal modo diventa un «mito» difensivo più che creatore di passioni. Una delle formule fondamentali di Maurras è «Politique d’abord», ma egli è il primo a non seguirla. Per lui, prima della politica c’è sempre l’«astrazione politica», l’accoglimento integrale di una concezione del mondo «minuziosissima», che prevede tutti i particolari, come l’anno le utopie dei letterati, che domanda una determinata concezione della storia, ma della storia concreta di Francia e d’Europa, cioè una determinata e fossilizzata ermeneutica.
Léon Daudet ha scritto che la grande forza dell’Action Française è stata la incrollabile omogeneità e unità del suo gruppo dirigente: sempre d’accordo, sempre solidali politicamente e ideologicamente. Certo l’unità e omogeneità del gruppo dirigente è una grande forza, ma di carattere settario e massonico, non di un grande partito di governo. Il linguaggio politico è diventato un gergo, si è formata l’atmosfera di una conventicola: a forza di ripetere sempre le stesse formule, di maneggiare gli stessi schemi mentali irrigiditi, si finisce, è vero, col pensare allo stesso modo, perché si finisce col non pensare più. Maurras a Parigi e Daudet a Bruxelles pronunziano la stessa frase, senza accordo, sullo stesso avvenimento perché l’accordo c’era già prima, perché si tratta di due macchinette di frasi, montate da venti anni per dire le stesse frasi nello stesso momento.
Il gruppo dirigente dell’Action Française si è formato per cooptazione: in principio c’era Maurras col suo verbo, poi si unì Vaugeois, poi Daudet, poi Pujo, ecc. ecc. Ogni volta che dal gruppo si staccò qualcuno, fu una catastrofe di polemiche e di accuse interminabili e perfide e si capisce: Maurras è come un papa infallibile e che da lui si stacchi uno dei più prossimi ha un significato veramente catastrofico.
Dal punto di vista dell’organizzazione l’Action Française è molto interessante e meriterebbe uno studio approfondito. La sua forza relativa è costituita specialmente da ciò che i suoi elementi di base sono tipi sociali intellettualmente selezionati, la cui «radunata» militare è estremamente facile come sarebbe quella di un esercito costituito di soli ufficiali. La selezione intellettuale è relativa, si capisce, poiché è stupefacente come gli aderenti all’Action Française siano facili a ripetere pappagallescamente le formule del leader (se pure non si tratti di una necessità di guerra, sentita come tale) e anzi a trarne profitto «snobistico». In una repubblica può essere segno di distinzione l’essere monarchico, in una democrazia parlamentare l’essere reazionario conseguente. Il gruppo, per la sua composizione, possiede (a parte le sovvenzioni di certi gruppi industriali) molti fondi, tanti da permettere iniziative molteplici che danno l’apparenza di una certa vitalità e attività. La posizione sociale di molti aderenti palesi ed occulti permette al giornale e al centro dirigente di avere una massa di informazioni e documenti riservati che permettono una molteplicità di polemiche personali. Nel passato, ma più limitatamente anche ora, il Vaticano doveva essere una fonte di prim’ordine d’informazioni (la Segreteria di Stato e l’alto clero francese). Molte campagne personalistiche devono essere a chiave o a mezza chiave: si pubblica una parte di vero per far capire che si sa tutto, o si fanno allusioni furbesche comprensibili agli interessati. Queste campagne violente personalistiche hanno per l’Action Française vari significati: galvanizzano gli aderenti perché lo sfoggio della conoscenza delle cose più segrete dà l’impressione di gran capacità a penetrare nel campo avversario e di una forte organizzazione cui nulla sfugge, mostrano il regime repubblicano come un’associazione a delinquere paralizzano una serie di avversari con la minaccia di disonorarli e di alcuni fanno dei fautori segreti. La concezione empirica che si può ricavare da tutta l’attività dell’Action Française è questa: il regime parlamentare repubblicano si dissolverà ineluttabilmente perché esso è un «monstrum» storico‑razionale, che non corrisponde alle leggi «naturali» della società francese rigidamente stabilite dal Maurras. I nazionalisti integrali devono pertanto: 1) appartarsi dalla vita reale della politica francese, non riconoscendone la «legalità» storico‑razionale (astensionismo, ecc.) e combattendola in blocco; 2) creare un antigoverno, sempre pronto a insediarsi nei «palazzi tradizionali» con un colpo di mano: questo antigoverno si presenta già oggi con tutti gli uffici embrionali, che corrispondono alle grandi attività nazionali.
Nella realtà furono fatti molti strappi a tanto rigore; nel 19 furono presentate alcune candidature, e riuscì eletto per miracolo il Daudet. Nelle altre elezioni l’Action Française appoggiò quei candidati di destra che accettavano alcuni suoi principii marginali (questa attività pare sia stata imposta al Maurras dai suoi collaboratori più esperti di politica reale, ciò che dimostra che l’unità non è senza crepe). Per uscire dall’isolamento fu progettata la pubblicazione di un grande giornale d’informazione, ma finora non se ne fece nulla (esiste solo la «Revue Universelle» e lo «Charivari» che compiono ufficio di divulgazione indiretta tra il grande pubblico). L’acre polemica col Vaticano e la riorganizzazione del clero e delle associazioni cattoliche che ne fu una conseguenza, ha rotto il solo legame che l’Action Française aveva con le grandi masse nazionali, legame che era anch’esso piuttosto aleatorio. Il suffragio universale che è stato introdotto in Francia da tanto tempo ha già determinato il fatto che le masse, formalmente cattoliche, politicamente aderiscano ai partiti repubblicani di centro, sebbene questi siano anticlericali e laicisti: il sentimento nazionale, organizzato intorno al concetto di patria, è altrettanto forte, e in certi casi è indubbiamente più forte, del sentimento religioso‑cattolico, che del resto ha caratteristiche proprie. La formula che «la religione è una quistione privata» si è radicata come forma popolare del concetto di separazione della Chiesa dallo Stato. Inoltre, il complesso di associazioni che costituiscono l’Azione Cattolica è in mano all’aristocrazia terriera (ne è capo, o era, il generale Castelnau), senza che il basso clero eserciti quella funzione di guida spirituale‑sociale che esercitava in Italia (in quella settentrionale). Il contadino francese, nella quasi totalità, rassomiglia piuttosto al nostro contadino meridionale, che dice volentieri: «il prete è prete sull’altare, ma fuori è un uomo come tutti gli altri» (in Sicilia: «monaci e parrini, sienticci la missa e stoccacci li rini»). L’Action Française attraverso lo strato dirigente cattolico pensava di poter dominare, nel momento decisivo, tutto l’apparato di massa del cattolicismo francese. In questo calcolo c’era un po’ di verità e molta illusione: in epoche di grandi crisi politico‑morali, il sentimento religioso, rilassato in tempi normali, può diventare vigoroso e assorbente; ma se l’avvenire appare pieno di nubi tempestose, anche la solidarietà nazionale, espressa nel concetto di patria, diventa assorbente in Francia, dove la crisi non può non assumere il carattere di crisi internazionale e allora la «Marsigliese» è più forte dei Salmi penitenziali. In ogni caso, anche la speranza in questa riserva possibile è svanita per Maurras. Il Vaticano non vuole più astenersi dagli affari interni francesi e ritiene che il ricatto di una possibile restaurazione monarchica sia divenuto inoperante: il Vaticano è più realista di Maurras, e concepisce meglio la formula «politique d’abord». Finché il contadino francese dovrà scegliere tra Herriot e un Hobereau, sceglierà Herriot: bisogna perciò creare il tipo del «radicale cattolico» cioè del «popolare», bisogna accettare senza riserve la repubblica e la democrazia e su questo terreno organizzare le masse contadine, superando il dissidio tra religione e politica, facendo del prete non solo la guida spirituale (nel campo individuale‑privato) ma anche la guida sociale nel campo economico‑politico. La sconfitta di Maurras è certa (come quella di Hugenberg in Germania). È la concezione di Maurras che è falsa per troppa perfezione logica: questa sconfitta, d’altronde, fu sentita dallo stesso Maurras proprio all’inizio della polemica col Vaticano, che coincise con la crisi parlamentare francese del 1925 (non certo per caso). Quando i ministeri si succedevano a rotazione, l’Action Française pubblicò di essere pronta ad assumere il potere e apparve un articolo in cui si giunse ad invitare Caillaux a collaborare, Caillaux per il quale si annunziava continuamente il plotone d’esecuzione. L’episodio è classico: la politica irrigidita e razionalistica del Maurras, dell’astensionismo aprioristico, delle leggi naturali «siderali» che reggono la società francese, era condannata al marasma, al crollo, all’abdicazione nel momento risolutivo. Nel momento risolutivo si vede che le grandi masse di energie entrate in movimento per la crisi non si riversano affatto nei serbatoi creati artificialmente, ma seguono le vie realmente tracciate dalla politica reale precedente, si spostano secondo i partiti che sono sempre stati attivi, o perfino che sono nati come funghi sul terreno stesso della crisi. A parte la stoltezza di credere che nel 1925 potesse avvenire il crollo del regime repubblicano per una crisi parlamentare (l’intellettualismo antiparlamentarista porta a simili allucinazioni monomaniache) se ci fu crollo fu quello morale del Maurras, che magari non si sarà scosso dal suo stato di illuminazione apocalittica, e del suo gruppo, che si sentì isolato e dovette fare appello a Caillaux e C.
Nella concezione di Maurras esistono molti tratti simili a quelli di certe teorie formalmente catastrofiche di certo economismo e sindacalismo. È spesso avvenuta questa trasposizione nel campo politico e parlamentare di concezioni nate sul terreno economico e sindacale. Ogni astensionismo politico in generale e non solo quello parlamentare si basa su una simile concezione meccanicamente catastrofica: la forza dell’avversario crollerà matematicamente se con metodo rigorosamente intransigente lo si boicotterà nel campo governativo (allo sciopero economico si accoppia lo sciopero e il boicottaggio politico). L’esempio classico è quello italiano dei clericali dopo il 70, che imitarono e generalizzarono alcuni episodi della lotta dei patrioti contro il dominio austriaco verificatisi specialmente a Milano.
L’affermazione, spesso ripetuta da Jacques Bainville nei suoi saggi storici, che il suffragio universale e il plebiscito potevano (avrebbero potuto) e potranno quindi servire anche al legittimismo come servirono ad altre correnti politiche (specialmente ai Bonaparte) è molto ingenua, perché legata a un ingenuo e astrattamente scemo sociologismo: il suffragio universale e il plebiscito sono concepiti come schemi astratti dalle condizioni di tempo e di luogo. Occorre notare: 1) che ogni sanzione data dal suffragio universale e dalplebiscito è avvenuta dopo che la classe fondamentale si era concentrata fortemente o nel campo politico o più ancora nel campo politico‑militare intorno a una personalità «cesarista», o dopo una guerra che aveva creato una situazione di emergenza nazionale; 2) che nella realtà della storia francese ci sono stati diversi tipi di «suffragio universale», a mano a mano che mutarono storicamente i rapporti economico-politici. Le crisi del suffragio universale sono state determinate dai rapporti tra Parigi e la provincia, ossia tra la città e la campagna, tra le forze urbane e quelle contadinesche. Durante la Rivoluzione, il blocco urbano parigino guida in modo quasi assoluto la provincia e si forma così il mito del suffragio universale che dovrebbe sempre dar ragione alla democrazia radicale parigina. Perciò Parigi vuole il suffragio universale nel 1848, ma esso esprime un parlamento reazionario‑clericale che permette a Napoleone III la sua carriera. Nel 1871 Parigi ha fatto un gran passo in avanti, perché si ribella all’Assemblea Nazionale di Versailles, formata dal suffragio universale, cioè implicitamente «capisce» che tra «progresso» e suffragio può esserci conflitto; ma questa esperienza storica, di valore inestimabile, è perduta immediatamente perché i portatori di essa vengono immediatamente soppressi. D’altronde dopo il 71 Parigi perde in gran parte la sua egemonia politico‑democratica sulla restante Francia per diverse ragioni: 1) perché si diffonde in tutta la Francia il capitalismo urbano e si crea il movimento radicale socialista in tutto il territorio; 2) perché Parigi perde definitivamente la sua unità rivoluzionaria e la sua democrazia si scinde in gruppi sociali e partiti antagonistici. Lo sviluppo del suffragio universale e della democrazia coincide sempre più con l’affermarsi in tutta la Francia del partito radicale e della lotta anticlericale, affermazione resa più facile e anzi favorita dallo sviluppo del così detto sindacalismo rivoluzionario. In realtà l’astensionismo elettorale e l’economismo dei sindacalisti sono l’apparenza «intransigente» dell’abdicazione di Parigi al suo ruolo di testa rivoluzionaria della Francia, sono l’espressione di un piatto opportunismo seguito al salasso del 1871. Il radicalismo unifica così in un piano intermedio, della mediocrità piccolo‑borghese, l’aristocrazia operaia di città e il contadino agiato di campagna. Dopo la guerra c’è una ripresa dello sviluppo storico troncato col ferro e col fuoco nel 1871, ma esso è incerto, informe, oscillante, e specialmente privo di cervelli pensanti.
La «Rivista d’Italia» del 15 gennaio 1927 riassume un articolo di J. Vialatoux pubblicato nella «Chronique Sociale de France» di qualche settimana prima; il Vialatoux respinge la tesi sostenuta da Jacques Maritain, in Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques (Parigi, Plon, 1926) secondo cui tra la filosofia e la morale pagane di Maurras e la sua politica non vi sarebbe che un rapporto contingente, di modo che se si prende la dottrina politica, astraendo dalla filosofia, si può andare incontro a qualche pericolo, come in ogni movimento umano, ma non vi ha nulla di condannabile. Per il Vialatoux, giustamente, la dottrina politica scaturisce (o per lo meno è inscindibilmente legata – g.) dalla concezione pagana del mondo (su questo paganesimo occorre distinguere e chiarire, tra la veste letteraria piena di riferimenti e metafore pagane e il nocciolo essenziale che è poi il positivismo naturalistico, preso da Comte e mediatamente dal sansimonismo, ciò che rientra nel paganesimo solo per il gergo e la nomenclatura ecclesiastica – g.). Lo Stato è il fine ultimo dell’uomo: esso realizza l’ordine umano con le sole forze della natura (cioè «umane», in contrapposizione a «soprannaturali»). Maurras è definibile per i suoi odii ancor più che per i suoi amori. Odia il cristianesimo primitivo (la concezione del mondo contenuta negli Evangeli, nei primi apologisti ecc., il cristianesimo all’editto di Milano, insomma, la cui credenza fondamentale era che la venuta di Cristo avesse annunziato la fine del mondo e che perciò determinava la dissoluzione dell’ordine politico romano in una anarchia morale corrosiva di ogni valore civile e statale) che per lui è una concezione giudaica. In questo senso Maurras vuole scristianizzare la società moderna. Per Maurras la Chiesa cattolica è stata e sarà sempre più lo strumento di questa scristianizzazione. Egli distingue tra cristianesimo e cattolicismo ed esalta quest’ultimo come la reazione dell’ordine romano all’anarchia giudaica. Il culto cattolico, le sue devozioni superstiziose, le sue feste, le sue pompe, le sue solennità, la sua liturgia, le sue immagini, le sue formule, i suoi riti sacramentali, la sua gerarchia imponente, sono come un incantesimo salutare per domare l’anarchia cristiana, per immunizzare il veleno giudaico del cristianesimo autentico. Secondo il Vialatoux il nazionalismo dell’Action Française non è che un episodio della storia religiosa del nostro tempo (in questo senso ogni movimento politico non controllato dal Vaticano è un episodio della storia religiosa, ossia tutta la storia è storia religiosa. In ogni modo occorre aggiungere che l’odio di Maurras contro tutto ciò che sa di protestante ed è di origine anglo‑germanica – Romanticismo, Rivoluzione francese, capitalismo ecc. – non è che un aspetto di questo odio contro il cristianesimo primitivo. Occorrerebbe cercare in Augusto Comte le origini di questo atteggiamento generale verso il cattolicismo, che non è indipendente dalla rinascita libresca del tomismo e dell’aristotelismo).
Q13 §38 Maurras e il «centralismo organico». Il cosidetto «centralismo organico» si fonda sul principio che un gruppo politico viene selezionato per «cooptazione» intorno a un «portatore infallibile della verità», a un «illuminato dalla ragione» che ha trovato le leggi naturali infallibili dell’evoluzione storica, infallibili anche se a lunga portata e se gli eventi immediati «sembrano» dar loro torto. L’applicazione delle leggi della meccanica e della matematica ai fatti sociali, ciò che non dovrebbe avere che un valore metaforico, diventa il solo e allucinante motore intellettuale (a vuoto). Il nesso tra il centralismo organico e le dottrine di Maurras è evidente.
La battaglia dello Jütland. È da rivedere la descrizione della battaglia dello Jütland fatta da Winston Churchill nelle sue memorie di guerra. Appare da essa come il piano e la direzione strategica della battaglia da parte del comando inglese e di quello tedesco siano in contrasto con la raffigurazione tradizionale del carattere dei due popoli. Il comando inglese aveva centralizzato «organicamente» l’esecuzione del piano nella nave ammiraglia: le unità della flotta dovevano «attendere ordini» volta per volta. Il comando tedesco invece aveva spiegato a tutti i comandi subalterni il piano strategico generale e aveva lasciato alle singole unità quella certa libertà di manovra che le circostanze potevano richiedere. La flotta tedesca si comportò molto bene. La flotta inglese invece fu impacciata, corse molti rischi, ebbe gravi perdite, e nonostante la sua superiorità, non poté conseguire fini strategici positivi: a un certo punto l’ammiraglio perdette le comunicazioni con le unità combattenti e queste commisero errori su errori. (Sulla battaglia dello Jütland ha scritto un libro Epicarmo Corbino).
Q13 §39 Italo Chittaro, La capacità di comando, Casa Editrice De Alberti, Roma. Da una recensione di V. Varanini nella «Fiera Letteraria» del 4 novembre 1928 pare che nel libro del Chittaro sono contenuti spunti molto interessanti anche per la scienza politica. Necessità degli studi storici per la preparazione professionale degli ufficiali. Per comandare non basta il semplice buon senso: questo, se mai, è il frutto di un profondo sapere e di un lungo esercizio. La capacità di comando è specialmente importante per la fanteria: se nelle altre armi si diventa specialisti di compiti particolari, nella fanteria si diventa specialisti nel comando, cioè del compito di insieme: necessità quindi che tutti gli ufficiali destinati a gradi elevati abbiano tenuto comandi di fanteria (cioè prima di essere capaci a ordinare le «cose» occorre essere capaci a ordinare e guidare gli uomini). Considera infine la necessità della formazione di uno Stato Maggiore numeroso, valido, popolare tra le truppe.
Q13 §40 G. Gentile e la filosofia della politica. Cfr l’articolo pubblicato da G. Gentile nello «Spectator» del 3 novembre 1928 e ristampato nell’«Educazione Fascista». «Filosofia che non si pensa (!?), ma che si fa, e perciò si enuncia ed afferma non con le formule ma con l’azione». Poiché da quando esiste l’uomo, si è sempre «fatto», è sempre esistita l’«azione», questa filosofia è sempre esistita, è stata pertanto la filosofia di… Nitti e di Giolitti. Ogni Stato ha «due filosofie»: quella che si enuncia per formule ed è una semplice arte di governo, e quella che si afferma con l’azione ed è la filosofia reale, cioè la storia. Il problema è di vedere in che misura queste due filosofie coincidono, divergono, sono in contrasto, sono coerenti intimamente e tra loro. La «formula» gentiliana non è, in realtà, che la mascheratura sofistica della «filosofia» politica più nota col nome di «opportunismo» ed empirismo. Se Bouvard e Pécuchet avessero conosciuto Gentile, avrebbero trovato nella sua filosofia la giusta interpretazione della loro attività rinnovatrice e rivoluzionaria (nel senso non corrotto della parola, come si dice).
QUADERNO 14
Q14 §1 Letteratura popolare (cfr paragrafo successivo). È giusto che lo studio della funzione non è sufficiente, pur essendo necessario, per creare la bellezza: intanto sulla stessa «funzione» nascono discordie, cioè anche l’idea e il fatto di funzione è individuale o dà luogo a interpretazioni individuali. Non è poi detto che la «decorazione» non sia «funzionale» e si intende «decorazione» in senso largo, per tutto ciò che non è strettamente «funzionale» come la matematica. Intanto la «razionalità» porta alla «semplificazione», ciò che è già molto. (Lotta contro il secentismo estetico che appunto è caratterizzato dal prevalere dell’elemento esternamente decorativo su quello «funzionale» sia pure in senso largo, cioè di funzione in cui sia compresa la «funzione estetica»). È molto che si sia giunti ad ammettere che l’«architettura è l’interpretazione di ciò che è pratico». Forse questo potrebbe dirsi di tutte le arti che sono una «determinata interpretazione di ciò che è pratico», dato che all’espressione «pratico» si tolga ogni significato «deteriore, giudaico» (o piattamente borghese: è da notare che «borghese» in molti linguaggi significa solo «piatto, mediocre, interessato», cioè ha assunto il significato che una volta aveva l’espressione «giudaico»: tuttavia questi problemi di linguaggio hanno importanza, perché linguaggio = pensiero, modo di parlare indica modo di pensare e di sentire non solo ma anche di esprimersi, cioè di far capire e sentire). Certo per le altre arti le quistioni di «razionalismo» non si pongono nello stesso modo che per l’architettura, tuttavia il «modello» dell’architettura è utile, dato che a priori si deve ammettere che il bello è sempre tale e presenta gli stessi problemi, qualunque sia l’espressione formale particolare di esso. Si potrebbe dire che si tratta di «tecnica», ma tecnica non è che espressione e il problema rientra nel suo circolo iniziale con diverse parole.
Q14 §2 Letteratura popolare. Quistioni di nomi. È evidente che in architettura «razionalismo» significa semplicemente «moderno»: è anche evidente che «razionale» non è altro che un modo di esprimere il bello secondo il gusto di un certo tempo. Che ciò sia avvenuto nell’architettura prima che in altre arti si capisce, perché l’architettura è «collettiva» non solo come «impiego», ma come «giudizio». Si potrebbe dire che il «razionalismo» è sempre esistito, cioè che si è sempre cercato di raggiungere un certo fine secondo un certo gusto e secondo le conoscenze tecniche della resistenza e dell’adattabilità del «materiale».
Di quanto e del come il «razionalismo» dell’architettura possa diffondersi nelle altre arti è quistione difficile e che sarà risolta dalla «critica dei fatti» (ciò che non vuol dire che sia inutile la critica intellettuale ed estetica che prepara quella dei fatti). Certo è che l’architettura pare di per sé, e per le sue connessioni immediate col resto della vita, la più riformabile e «discutibile» delle arti. Un quadro o un libro o una statuina, può tenersi in luogo «personale» per il gusto personale; non così una costruzione architettonica. È anche da ricordare indirettamente (per ciò che vale in questo caso) l’osservazione del Tilgher che l’opera d’architettura non può essere messa alla stregua delle altre opere d’arte per il «costo», l’ingombro, ecc. Distruggere un’opera costruttiva, cioè fare e rifare, tentando e riprovando, non si adatta molto all’architettura.
Q14 §3 Machiavelli. Centro. Uno studio accurato dei partiti di centro in senso largo sarebbe oltremodo educativo. Termine esatto, estensione del termine, cambiamento storico del termine e dell’accezione. Per esempio, i giacobini furono un partito estremo: oggi sono tipicamente di centro; così i cattolici (nella loro massa); così anche i socialisti,ecc. Credo che un’analisi dei partiti di centro e della loro funzione sia parte importante della storia contemporanea.
E non lasciarsi illudere dalle parole o dal passato: è certo per esempio che i «nichilisti» russi sono da considerarsi partito di centro, e così perfino gli «anarchici» moderni. La quistione è se per simbiosi un partito di centro non serva a un partito «storico», esempio il partito hitleriano (di centro) a Hugenberg e Papen (estremisti: estremisti in un certo senso, agrari e in parte industriali, data la storia tedesca particolare). Partiti di centro e partiti «demagogici» o borghesi‑demagogici.
Lo studio della politica tedesca e francese nell’inverno 1932-33 dà una massa di materiale per questa ricerca, così la contrapposizione della politica estera a quella interna (mentre è sempre la politica interna che detta le decisioni, s’intende di un paese determinato: infatti è chiaro che l’iniziativa, dovuta a ragioni interne, di un paese, diventerà «estera» per il paese che subisce l’iniziativa).
Q14 §4 Letteratura popolare. Origini popolaresche del «superuomo». Ogni volta che ci si imbatte in qualche ammiratore del Nietzsche, è opportuno ricercare se le sue concezioni «superumane», contro la morale convenzionale ecc. ecc., sono di genuina origine nicciana, sono cioè il prodotto di una elaborazione di pensiero da porsi nella sfera della «alta cultura», oppure hanno origini molto più modeste, per esempio sono connesse alla letteratura d’appendice. (Ma lo stesso Nietzsche non sarà stato per nulla influenzato dai romanzi francesi d’appendice? Occorre ricordare che tale letteratura, oggi degradata alla portineria e al sottoscala, è stata molto diffusa tra gli intellettuali fino al 70 almeno, come oggi il romanzo «giallo»). In ogni modo pare si possa dire che molta sedicente superumanità nicciana ha solo come modello e origine «dottrinale» il… Conte di Montecristo di A. Dumas. In Dumas, per quanto mi consta, il tipo di Montecristo è stato rappresentato più volte: esso è da vedere, per es., nell’Athos dei Tre Moschettieri e in Giuseppe Balsamo, ma forse si potrà trovare anche in altri romanzi.
Quando si legge che uno è ammiratore di Balzac, occorre stare attenti: anche in Balzac c’è qualcosa del romanzo d’appendice. Vautrin è anch’egli, a suo modo, un superuomo, e il discorso che egli fa a Rastignac in Papa Goriot ha molto di… nicciano nel senso popolaresco.
Così Rastignac e di Rubempré. (Vincenzo Morello è diventato «Rastignac» per questa filiazione… popolaresca e ha difeso «Corrado Brando»).
Ricordare che Nietzsche è stato edito dal Monanni e si conoscono le origini culturali‑ideologiche del Monanni e la sua clientela. Così Vautrin e l’«amico di Vautrin» hanno lasciato traccia nella letteratura di Paolo Valera e nella sua «Folla». (Ricordare l’«amico di Vautrin» torinese). Così l’ideologia dei «moschettieri», presa dal romanzo di Dumas. Che si abbia un certo pudore a giustificare mentalmente le proprie concezioni con i romanzi di Dumas e di Balzac, s’intende facilmente: le si giustifica perciò col Nietzsche e si ammira Balzac come scrittore d’arte e non come creatore di figure romanzesche del tipo appendice. Ma il nesso reale è certo culturalmente. Il tipo del «superuomo» è Montecristo (liberato di quel particolare alone di «fatalismo» che è proprio del basso romanticismo che è ancora più calcato in Athos e in Giuseppe Balsamo). Montecristo portato nella politica, è certo pittoresco: la lotta contro i «nemici» personali del Montecristo. Si può osservare come certi paesi siano rimasti provinciali e arretrati anche in ciò in confronto di altri; mentre già Sherlock Holmes sembra anacronistico per molta Europa, in certi paesi si è ancora a Montecristo e a Fenimore Cooper (i «selvaggi», «pizzo di ferro» ecc.).
Cfr il libro di Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (Ed. della Cultura); accanto alla ricerca del Praz bisognerebbe fare quest’altra ricerca: del «superuomo» nella letteratura popolare e dei suoi influssi nella vita reale e nei costumi. Ancora: l’Omodeo ha osservato che esiste una specie di «manomorta» culturale ed è costituita dalla letteratura religiosa, di cui nessuno pare voglia occuparsi, come se non avesse una importanza e una funzione nella vita nazionale e popolare. A parte l’epigramma della «manomorta» e la soddisfazione del clero che la sua letteratura non sia sottoposta a critica, esiste un altra sezione della vita culturale nazionale e popolare di cui nessuno si occupa e si preoccupa, criticamente, ed è appunto la letteratura d’appendice propriamente detta e in senso più largo (anche Victor Hugo vi rientra in questo senso e anche Balzac).
In Montecristo vi sono due capitoli dove esplicitamente si «disserta» del superuomo d’appendice: il capitolo intitolato «Ideologia», quando Montecristo si incontra col procuratore Villefort, e il capitolo che descrive la colazione presso il visconte di Morcerf al primo viaggio di Montecristo a Parigi. Sarà da vedere se in altri romanzi del Dumas esistono spunti «ideologici» del genere: nei Tre Moschettieri la figura di Athos ha più dell’uomo fatale generico del basso romanticismo. Si solleticano gli umori popolareschi individualistici piuttosto con l’attività avventurosa ed extralegale dei «moschettieri» come tali. In Giuseppe Balsamo, la potenza dell’individuo è legata a forze oscure di magia e all’appoggio della massoneria europea, quindi meno suggestivo l’esempio per il lettore popolaresco. Non ricordo altre figure tipiche.
Nel Balzac le figure sono più concretamente artistiche, ma tuttavia rientrano nell’atmosfera del romanticismo. Rastignac e Vautrin non sono da confondere certo con i personaggi dumasiani: ma appunto perciò la loro influenza è più «confessabile» non solo da parte di uomini come Paolo Valera e i suoi collaboratori della «Folla», ma anche da mediocri intellettuali, come V. Morello, che però ritengono (e sono ritenuti da molti) di appartenere all’alta cultura.
Q14 §5 Criteri metodologici. Nell’esaminare criticamente una «dissertazione» può essere quistione: 1) di valutare se l’autore dato ha saputo con rigore e coerenza dedurre tutte le conseguenze dalle premesse che ha assunto come punto di partenza (o di vista): può darsi che manchi il rigore, che manchi la coerenza, che ci siano omissioni tendenziose, che manchi la «fantasia» scientifica (che cioè non si sappia vedere tutta la fecondità del principio assunto ecc.); 2) di valutare i punti di partenza (o di vista), le premesse, che possono essere negate in tronco, o limitate, o dimostrate non più valide storicamente; 3) di ricercare se le premesse sono omogenee tra loro, o se, per incapacità o insufficienza dell’autore (o ignoranza dello stato storico della quistione) è avvenuta contaminazione tra premesse o principii contradditori o eterogenei o storicamente non avvicinabili. Così la valutazione critica può avere diversi fini culturali (o anche polemico‑politici): può tendere a dimostrare che Tizio individualmente è incapace e nullo; che il gruppo culturale a cui Tizio appartiene è scientificamente irrilevante; che Tizio il quale «crede» o pretende di appartenere a un gruppo culturale, si inganna o vuole ingannare, che Tizio si serve delle premesse teoriche di un gruppo rispettabile per trarre deduzioni tendenziose e particolaristiche ecc.
Q14 §6 Passato e presente. Fratate. Una ottava di Luigi Pulci (Morgante, XXVIII, 42; è da confrontare): «Sempre i giusti son primi i lacerati; – io non vo’ ragionar più della fede; – ch’io me ne vo poi in bocca a questi frati, – dove vanno anche spesso le lamprede; – e certi scioperon pinzocherati – rapportano: “Il tal disse, il tal non crede”, – donde tanto rumor par che ci sia; – se in principio era buio, e buio fia».
Oggi nella bocca di questi tali frati non vanno tanto lamprede, quanto volgari paste asciutte, ma i «frati» rimangono tali e anche oggi, come al tempo di Pascal, è più facile trovar dei «frati» che delle buone ragioni.
Q14 §7 Passato e presente. Quando si parla di «caratteri nazionali» occorre ben fissare e definire ciò che si intende dire. Intanto occorre distinguere tra nazionale e «folcloristico». A quali criteri ricorrere per giungere a tale distinzione? Uno (e forse il più esatto) può esser questo: il folcloristico si avvicina al «provinciale» in tutti i sensi, cioè sia nel senso di «particolaristico», sia nel senso di anacronistico, sia nel senso di proprio a una classe priva di caratteri universali (almeno europei). C’è un folcloristico nella cultura, a cui non si suole badare: per esempio è folcloristico il linguaggio melodrammatico, così come è tale il complesso di sentimenti e di «pose» snobistiche ispirate dai romanzi d’appendice.
Per esempio Carolina Invernizio che ha creato di Firenze un ambiente romanzesco copiato meccanicamente dai romanzi d’appendice francesi che hanno per ambiente Parigi, ha creato determinate tendenze di folclore. Ciò che è stato detto del rapporto Dumas‑Nietzsche a proposito delle origini popolaresche del «superuomo» dà appunto luogo a motivi di folclore. Se Garibaldi rivivesse oggi, con le sue stravaganze esteriori ecc., sarebbe più folcloristico che nazionale: perciò oggi a molti la figura di Garibaldi fa sorridere ironicamente, e a torto, perché nel suo tempo Garibaldi, in Italia, non era anacronistico e provinciale, perché tutta l’Italia era anacronistica e provinciale. Si può dunque dire che un carattere è «nazionale» quando è contemporaneo a un livello mondiale (o europeo) determinato di cultura ed ha raggiunto (s’intende) questo livello. Era nazionale in questo senso Cavour nella politica liberale, De Sanctis nella critica letteraria (e anche Carducci, ma meno del De Sanctis), Mazzini nella politica democratica; avevano caratteri di folclore spiccato Garibaldi, Vittorio Emanuele II, i Borboni di Napoli, la massa dei rivoluzionari popolari, ecc. Nel rapporto Nietzsche‑superuomo, D’Annunzio ha caratteri folcloristici spiccati, così Gualino nel campo economico-pratico (più ancora Luca Cortese, che è la caricatura di D’Annunzio e Gualino), così Scarfoglio, sebbene meno di D’Annunzio. D’Annunzio tuttavia meno di altri, per la sua cultura superiore e non legata immediatamente alla mentalità del romanzo di appendice. Molti individualisti ‑ anarchici popolareschi sembrano proprio balzati fuori da romanzi d’appendice.
Questo provincialismo‑folcloristico ha altri caratteri in Italia; ad esso è legato ciò che agli stranieri appare essere un istrionismo italiano, una teatralità italiana, qualcosa di filodrammatico, quell’enfasi nel dire anche le cose più comuni, quella forma di chauvinismo culturale che Pascarella ritrae nella Scoperta dell’America, l’ammirazione per il linguaggio da libretto d’opera ecc. ecc.
Q14 §8 Risorgimento. Nella formazione dello Stato unitario italiano c’è stata «eredità» di tutte le funzioni politico‑culturali svolte dai singoli staterelli precedenti o c’è stata, da questo punto di vista, una perdita secca? Cioè la posizione internazionale che venne ad occupare il nuovo Stato riassumeva le singole posizioni particolari degli Stati regionali precedenti, oppure accanto a ciò che fu guadagnato ci fu anche qualcosa di perduto? E le perdite ebbero una conseguenza negli anni di vita unitaria dal 61 al 1914? La quistione non pare sia oziosa. È evidente, per esempio, che altro era il rapporto verso la Francia del Piemonte con la Savoia e altro quello dell’Italia senza la Savoia e Nizza; ciò si dica anche per la Svizzera e per la posizione di Ginevra. Così per il regno di Napoli; l’influenza del Napoletano nel Mediterraneo orientale, i rapporti con la Russia e con l’Inghilterra, non potevano essere quelli dell’Italia. Ciò che poteva permettersi a uno Stato come quello borbonico, di scarsa potenzialità militare e relativamente piccolo, non poteva permettersi al nuovo Stato italiano. Però pare si esageri in questi ultimi anni molto sull’influenza napoletana in Oriente, per ragioni diverse (per trovare precedenti storici all’attuale politica, ma anche per riabilitare i Borboni di Napoli). Per lo Stato della Chiesa la quistione è più complessa. Ma anche Venezia italiana ereditò la funzione che aveva Venezia austriaca o questa funzione passò completamente a Trieste? In quale misura l’atteggiamento dei governi inglesi verso il problema dell’unificazione italiana fu determinato, oltre che dalla funzione dell’Austria in Europa (equilibrio verso la Francia e verso la Russia) anche dai rapporti tra Napoli e la Russia nel Mediterraneo? E in che misura l’opposizione della Russia alla politica coloniale italiana (verso l’Abissinia) fu determinata dalla formazione del nuovo Stato italiano e dalla sua dipendenza dall’Inghilterra?
Q14 §9 Machiavelli. Chi è il legislatore? In uno studio di teoria finanziaria (delle imposte) di Mauro Fasiani (Schemi teorici ed «exponibilia» finanziari, nella Riforma Sociale del settembre‑ottobre 1932) si parla di «volontà supposta di quell’essere un po’ mitico, chiamato legislatore». L’espressione cautelosa ha due significati, cioè si riferisce a due ordini ben distinti di osservazioni critiche. Da una parte, si riferisce al fatto che le conseguenze di una legge possono essere diverse da quelle «previste» cioè volute coscientemente dal legislatore individuale, per cui «obbiettivamente», alla «voluntas legislatoris», cioè agli effetti previsti dal legislatore individuale, si sostituisce la «voluntas legis», cioè l’insieme di conseguenze effettuali che il legislatore individuale non aveva previsto ma che di fatto conseguono dalla legge data. (Naturalmente sarebbe da vedere se gli effetti che il legislatore individuale prevede a parole sono da lui previsti «bona fide» oppure solo per creare l’ambiente favorevole all’approvazione della legge, se i «fini» che il legislatore individuale pretende di voler conseguire non sono un semplice mezzo di propaganda ideologica o demagogica). Ma l’espressione cautelosa ha anche un altro significato che precisa il primo e lo definisce: la parola «legislatore» può essere infatti interpretata in senso molto ampio, «fino ad indicare con essa l’insieme di credenze, di sentimenti, di interessi e di ragionamenti diffusi in una collettività in un dato periodo storico». Ciò in realtà significa: 1) che il legislatore individuale (e legislatore individuale deve intendersi non solo nel caso ristretto dell’attività parlamentare‑statale, ma anche in ogni altra attività «individuale» che cerchi, in sfere più o meno larghe di vita sociale, di modificare la realtà secondo certe linee direttive) non può mai svolgere azioni «arbitrarie», antistoriche, perché il suo atto d’iniziativa, una volta avvenuto, opera come una forza a sé nella cerchia sociale determinata, provocando azioni e reazioni che sono intrinseche a questa cerchia oltre che all’atto in sé; 2) che ogni atto legislativo, o di volontà direttiva e normativa, deve anche e specialmente essere valutato obbiettivamente, per le conseguenze effettuali che potrà avere; 3) che ogni legislatore non può essere che astrattamente e per comodità di linguaggio considerato come individuo, perché in realtà esprime una determinata volontà collettiva disposta a rendere effettuale la sua «volontà», che è volontà solo perché la collettività è disposta a darle effettualità; 4) che pertanto ogni individuo che prescinda da una volontà collettiva e non cerchi di crearla, suscitarla, estenderla, rafforzarla, organizzarla, è semplicemente una mosca cocchiera, un «profeta disarmato», un fuoco fatuo.
Su questo argomento è da vedere ciò che dice il Pareto sulle azioni logiche e non logiche nella sua Sociologia. Secondo il Fasiani per il Pareto sono «azioni logiche quelle che uniscono logicamente il mezzo al fine non solo secondo il giudizio del soggetto agente (fine soggettivo) ma anche secondo il giudizio dell’osservatore (fine oggettivo). Le azioni non‑logiche non hanno tale carattere. Il loro fine oggettivo differisce dal fine soggettivo». Il Fasiani non è soddisfatto da questa terminologia paretiana, ma la sua critica rimane nello stesso terreno puramente formale e schematico del Pareto.
Q14 §10 Passato e presente. Cfr le osservazioni sparse su quel carattere del popolo italiano che si può chiamare «apoliticismo». Questo carattere, naturalmente, è delle masse popolari, cioè delle classi subalterne. Negli strati superiori e dominanti vi corrisponde un modo di pensare che si può dire «corporativo», economico, di categoria, e che del resto è stato registrato nella nomenclatura politica italiana col termine di «consorteria», una variazione italiana della «cricca» francese e della camarilla spagnuola, che indicano qualcosa di diverso, di particolaristico sì, ma nel senso personale o di gruppo strettamente politico‑settario (legato all’attività politica di gruppi militari o di cortigiani), mentre in Italia più legato a interessi economici (specialmente agrari e regionali). Una varietà di questo «apoliticismo» popolare è il «pressappoco» della fisionomia dei partiti tradizionali, il pressappoco dei programmi e delle ideologie. Perciò anche in Italia c’è stato un «settarismo» particolare, non di tipo giacobino alla francese o alla russa (cioè fanatica intransigenza per principii generali e quindi il partito politico che diventa il centro di tutti gli interessi della vita individuale); il settarismo negli elementi popolari corrisponde allo spirito di consorteria nelle classi dominanti, non si basa su principii, ma su passioni anche basse e ignobili e finisce coll’avvicinarsi al «punto di onore» della malavita e all’omertà della mafia e della camorra.
Questo apoliticismo, unito alle forme rappresentative (specialmente dei corpi elettivi locali) spiega la deteriorità dei partiti politici, che nacquero tutti sul terreno elettorale (al Congresso di Genova la quistione fondamentale fu quella elettorale); cioè i partiti non furono una frazione organica delle classi popolari (un’avanguardia, un’élite), ma un insieme di galoppini e maneggioni elettorali, un’accolta di piccoli intellettuali di provincia, che rappresentavano una selezione alla rovescia. Data la miseria generale del paese e la disoccupazione cronica di questi strati, le possibilità economiche che i partiti offrivano erano tutt’altro che disprezzabili. Si è saputo che in qualche posto, circa un decimo degli iscritti ai partiti di sinistra racimolavano una parte dei mezzi per vivere dalle questure, che davano pochi soldi agli informatori data l’abbondanza di essi o li pagavano con permessi per attività marginali da mezzi vagabondi o con l’impunità per guadagni equivoci.
In realtà per essere di un partito bastavano poche idee vaghe, imprecise, indeterminate, sfumate: ogni selezione era impossibile, ogni meccanismo di selezione mancava e le masse dovevano seguire questi partiti perché altri non ne esistevano.
Q14 §11 Argomenti di coltura. Le grandi potenze mondiali. Una ricostruzione storico‑critica dei regimi politici degli Stati che hanno una funzione decisiva nella vita mondiale. Il punto più interessante pare debba essere questo: come la costituzione scritta si adatti (sia adattata) al variare delle congiunture politiche, specialmente a quelle sfavorevoli alle classi dominanti. È quindi necessaria l’esposizione obbiettiva e analitica della costituzione e di tutte le leggi organiche, ma questa descrizione deve essere fatta sul modello di quella che si ha della costituzione spagnola del 1812 nel volume sulla Quistione d’Oriente (ediz. italiana; nell’ed. francese, nell’VIII volume degli Scritti politici), ma è specialmente necessaria una analisi critica delle forze costitutive politiche dei diversi Stati, forze che devono essere viste in una sufficiente prospettiva storica. Così lo studio del regime presidenziale americano (Stati Uniti d’America), con la sua unità tra capo del governo e capo dello Stato è difficile da comprendere per un medio europeo moderno: eppure esso è simile al regime delle repubbliche comunali medioevali italiane (fase economico‑corporativa dello Stato). In ogni costituzione sono da vedere i punti che permettono il passaggio legale dal regime costituzionale‑parlamentare a quello dittatoriale: esempio l’art. 48 della costituzione di Weimar, che tanta importanza ha avuto nella recente storia tedesca. Nella costituzione francese (il cui sviluppo è del massimo interesse) la figura del Presidente della Repubblica ha possibilità di sviluppi di cui ancora non è stato necessario servirsi, ma che non è escluso siano impiegati (ricordare tentativi di Mac‑Mahon e quello recente di Millerand). Ancora è da vedere in che rapporto con la costituzione sono altre leggi organiche (ricordare per l’Italia la funzione che in certe occasioni ha avuto la legge comunale e provinciale e quella di pubblica sicurezza). Si può dire in generale che le costituzioni sono più che altro «testi educativi» ideologici, e che la «reale» costituzione è in altri documenti legislativi (ma specialmente nel rapporto effettivo delle forze sociali nel momento politico‑militare). Uno studio serio di questi argomenti, fatto con prospettiva storica e con metodi critici, può essere uno dei mezzi più efficaci per combattere l’astrattismo meccanicistico e il fatalismo deterministico. Come bibliografia si può accennare da una parte agli studi di geopolitica, per la descrizione delle forze costitutive economico-sociali e delle loro possibilità di sviluppo e dall’altra a libri come quelli del Bryce sulle democrazie moderne. Ma per ogni paese è necessaria una bibliografia specializzata sulla storia generale, sulla storia costituzionale, sulla storia dei partiti politici, ecc. (il Giappone e gli Stati Uniti mi paiono gli argomenti più fecondi di educazione e di allargamento degli orizzonti culturali). La storia dei partiti e delle correnti politiche non può andar disgiunta dalla storia dei gruppi e delle tendenze religiose. Proprio gli Stati Uniti d’America e il Giappone offrono un terreno d’esame eccezionale per comprendere l’interdipendenza tra i gruppi religiosi e quelli politici, cioè per comprendere come ogni ostacolo legale o di violenza privata allo sviluppo spontaneo delle tendenze politiche e al loro organizzarsi in partito determina un moltiplicarsi di sette religiose. Da questo punto di vista la storia politico‑religiosa degli Stati Uniti d’America può essere paragonata a quella della Russia zarista (con la differenza, importante, che nella Russia zarista se mancava la libertà politica legale, mancava anche la libertà religiosa e quindi il settarismo religioso assumeva forme morbose ed eccezionali). Negli Stati Uniti d’America legalmente e di fatto non manca la libertà religiosa (entro certi limiti, come ricorda il processo contro il darwinismo), e se legalmente (entro certi limiti) non manca la libertà politica, essa manca di fatto per la pressione economica e anche per l’aperta violenza privata. Da questo punto di vista assume importanza l’esame critico dell’organizzazione giudiziaria e di polizia, che lasciano impunite e spalleggiano le violenze private rivolte a impedire la formazione di altri partiti oltre quello repubblicano e democratico. Anche il nascere di nuove sette religiose è quasi sempre sollecitato e finanziato dai gruppi economici, per canalizzare gli effetti della compressione culturale‑politica. Le enormi somme destinate in America alla attività religiosa hanno un fine ben preciso politico‑culturale. Nei paesi cattolici, dato il centralismo gerarchico vaticanesco, la creazione di nuovi ordini religiosi (che sostituisce la creazione settaria dei paesi protestanti) non è più sufficiente allo scopo (lo fu prima della Riforma), e si ricorre a soluzioni di carattere locale: nuovi santi, nuovi miracoli, campagne missionarie, ecc. Si può ricordare, per esempio, che nel 1911‑12 al tentativo nell’Italia Meridionale di formare politicamente i contadini attraverso una campagna per il libero scambio (contro gli zuccherieri specialmente, dato che lo zucchero è merce popolare legata all’alimentazione dei bambini, degli ammalati, dei vecchi) si rispose con una campagna missionaria tendente a suscitare il fanatismo superstizioso popolare, talvolta anche in forma violenta (così almeno in Sardegna). Che fosse legata alla campagna per il libero scambio appare dal fatto che contemporaneamente, nei così detti «Misteri» (settimanale popolarissimo, tirato a milioni di copie) si invitava a pregare per i «poveri zuccherieri» attaccati «cainamente» dai «massoni» ecc.
Q14 §12 Argomenti di coltura. Spesso, in queste , è stato fatto riferimento alla Scoperta dell’America del Pascarella come documento di una determinata corrente di coltura folcloristico‑popolare. Si potrebbe addirittura studiare non solo la Scoperta ma anche gli altri componimenti del Pascarella da questo punto di vista, cioè di come il popolino romano aveva assimilato ed esprimeva la cultura liberale‑democratica sviluppatasi in Italia durante il Risorgimento. È inutile ricordare come a Roma questa assimilazione ed espressione abbia dei caratteri peculiari, non solo per la vivacità del popolo romano, ma specialmente perché la cultura liberale‑democratica aveva specialmente un contenuto anticlericale e a Roma, per la vicinanza del Vaticano e per tutta la tradizione passata, questa cultura non poteva non avere un’espressione tipica. (Sarà da vedere la letteratura cronistica sugli avvenimenti romani nel periodo 70‑80 che sono ricchi di episodi popolareschi; vedere per esempio gli Annali di Pietro Vigo; la polemica Cavallotti‑Chauvet; anche il Libro di don Chisciotte dello Scarfoglio, e altra letteratura, specialmente giornalistica, del tempo).
Q14 §13 Machiavelli. Chi è legislatore? Il concetto di «legislatore» non può non identificarsi col concetto di «politico». Poiché tutti sono «uomini politici» tutti sono anche «legislatori». Ma occorrerà fare delle distinzioni. «Legislatore» ha un preciso significato giuridico‑statale, cioè significa quelle persone che sono abilitate dalle leggi a legiferare. Ma può avere anche altri significati. Ogni uomo, in quanto è attivo, cioè vivente contribuisce a modificare l’ambiente sociale in cui si sviluppa (a modificarne determinati caratteri o a conservarne altri), cioè tende a stabilire «norme», regole di vita e di condotta. La cerchia di attività sarà maggiore o minore, la consapevolezza della propria azione e dei fini sarà maggiore o minore; inoltre, il potere rappresentativo sarà maggiore o minore, e sarà più o meno attuato dai «rappresentati» nella sua espressione sistematica normativa. Un padre è un legislatore per i figli, ma l’autorità paterna sarà più o meno consapevole e più o meno obbedita e così via. In generale si può dire che tra la comune degli uomini e altri uomini più specificatamente legislatori la distinzione è data dal fatto che questo secondo gruppo non solo elabora direttive che dovrebbero diventare norma di condotta per gli altri, ma nello stesso tempo elabora gli strumenti attraverso i quali le direttive stesse saranno «imposte» e se ne verificherà l’esecuzione. Di questo secondo gruppo il massimo di potere legislativo è nel personale statale (funzionari elettivi e di carriera) che hanno a loro disposizione le forze coercitive legali dello Stato. Ma non è detto che anche i dirigenti di organismi e organizzazioni «private» non abbiano sanzioni coercitive a loro disposizione, fino anche alla pena di morte. Il massimo di capacità del legislatore si può desumere dal fatto che alla perfetta elaborazione delle direttive corrisponde una perfetta predisposizione degli organismi di esecuzione e di verifica e una perfetta preparazione del consenso «spontaneo» delle masse che devono «vivere» quelle direttive, modificando le proprie abitudini, la propria volontà, le proprie convinzioni conformemente a queste direttive e ai fini che esse si propongono di raggiungere.
Se ognuno è legislatore nel senso più largo del concetto, ognuno continua ad essere legislatore anche se accetta direttive di altri, ed eseguendole controlla che anche gli altri le eseguano, avendole comprese nel loro spirito, le divulga, quasi facendone dei regolamenti di applicazione particolare a zone di vita ristretta e individuata.
Q14 §14 Carattere non nazionale‑popolare della letteratura italiana. Che esista una coscienza diffusa di questo carattere della letteratura italiana si può vedere da certe polemiche che periodicamente ritornano ad accendersi fra i gruppi letterari. Nell’«Italia letteraria» polemiche simili avvengono a ripetizione, ma sono sempre superficiali, perché urtano contro il pregiudizio rettorico che la nazione italiana sia sempre esistita, su un certo numero di idoli e di borie nazionali. Altre volte lo stesso problema è mal posto, per l’influsso di concetti estetici d’origine crociana, specialmente concernente il così detto «moralismo» nell’arte, il «contenuto estrinseco» dell’arte ecc. Non si riesce a capire che l’arte è sempre legata a una determinata cultura o civiltà e che lottando per riformare la cultura, si tende e si giunge a modificare il «contenuto» dell’arte, cioè si lavora a creare una nuova arte non dall’esterno (pretendendo un’arte didascalica, a tesi, moralistica), ma dall’interno, perché si modifica tutto l’uomo, in quanto si modificano i rapporti di cui l’uomo è l’espressione necessaria. Che sia esistita ed esista la coscienza di questo carattere non nazionale‑popolare, si può vedere dalle polemiche: 1) «Perché la letteratura italiana non è popolare in Italia?» per dirla con la parola del Bonghi; 2) sulla non‑esistenza di un teatro italiano, polemica impostata dal F. Martini; 3) sulla quistione della lingua impostata dal Manzoni; 4) se sia esistito un romanticismo italiano.
Un altro elemento è quello della non‑esistenza di «romanzi d’appendice» e di letteratura per l’infanzia (romanzi d’avventura, scientifici, polizieschi, ecc.) e del fatto che tali libri sono introdotti dall’estero (in Italia solo romanzi anticlericali). Da tutti questi elementi è nato il «futurismo» specialmente nella forma più intelligente datagli da Papini e dai gruppi fiorentini di «Lacerba» e «La Voce», col loro speciale «romanticismo» o Sturm und Drang popolaresco. Ultima manifestazione «Strapaese».
Ma sia il futurismo di Marinetti, sia quello del «Lacerba» e della «Voce», sia «Strapaese», hanno urtato contro un ostacolo: l’assenza di carattere dei loro protagonisti e le loro tendenze carnevalesche e pagliaccesche, da piccoli borghesi scettici e aridi. La letteratura regionale è stata troppo folcloristica, «pittoresca»; il popolo regionale era visto «paternalisticamente», dall’esterno, con spirito disincantato, cosmopolitico, da turista in cerca di sensazioni forti e originali per la loro crudezza. Negli scrittori italiani ha proprio nuociuto l’«apoliticismo» intimo, verniciato di rettorica nazionale verbosa: furono, da questo punto di vista, più simpatici Enrico Corradini e il Pascoli col loro nazionalismo confessato e militante, che in Pascoli era popolaresco e ingenuo, senza programmi ben razionalizzati come invece nel Corradini.
Q14 §15 Il teatro di Pirandello. Forse ha ragione il Pirandello a protestare egli per il primo contro il «pirandellismo», cioè a sostenere che il così detto pirandellismo è una costruzione astratta dei sedicenti critici, non autorizzato dal suo concreto teatro, una formula di comodo, che spesso nasconde interessi culturali e ideologici tendenziosi, che non vogliono confessarsi esplicitamente. È certo che Pirandello è sempre stato combattuto dai cattolici: ricordare il fatto che Liolà è stata ritirata dal repertorio dopo le cagnare inscenate al teatro Alfieri di Torino dai giovani cattolici per istigazione del «Momento» e del suo mediocrissimo recensore teatrale Saverio Fino. Lo spunto contro Liolà fu dato da una pretesa oscurità della commedia, ma in realtà tutto il teatro del Pirandello è avversato dai cattolici per la concezione pirandelliana del mondo, che, qualunque essa sia, qualunque sia la sua coerenza filosofica, è indubbiamente anticattolica, come invece non era la concezione «umanitaria» e positivistica del verismo borghese e piccolo borghese del teatro tradizionale. In realtà non pare si possa attribuire al Pirandello una concezione del mondo coerente, non pare si possa estrarre dal suo teatro una filosofia e quindi non si può dire che il teatro pirandelliano sia «filosofia». È certo però che nel Pirandello ci sono dei punti di vista che possono riallacciarsi genericamente a una concezione del mondo, che all’ingrosso può essere identificata con quella soggettivistica. Ma il problema è questo: 1) questi punti di vista sono presentati in modo «filosofico», oppure i personaggi vivono questi punti di vista come individuale modo di pensare? cioè la «filosofia» implicita è esplicitamente solo «cultura» ed «eticità» individuale, cioè esiste, entro certi gradi almeno, un processo di trasfigurazione artistica nel teatro pirandelliano? e ancora si tratta di un riflesso sempre uguale, di carattere logico, o invece le posizioni sono sempre diverse, cioè di carattere fantastico? 2) questi punti di vista sono necessariamente di origine libresca, dotta, presi dai sistemi filosofici individuali, o non sono invece esistenti nella vita stessa, nella cultura del tempo e persino nella cultura popolare di grado infimo, nel folclore?
Questo secondo punto mi pare fondamentale ed esso può essere risolto con un esame comparativo dei diversi drammi, quelli concepiti in dialetto e dove si rappresenta una vita paesana, «dialettale» e quelli concepiti in lingua letteraria e dove si rappresenta una vita superdialettale, di intellettuali borghesi di tipo nazionale e anche cosmopolita. Ora pare che, nel teatro dialettale, il pirandellismo sia giustificato da modi di pensare «storicamente» popolari e popolareschi, dialettali; che non si tratti cioè di «intellettuali» travestiti da popolani, di popolani che pensano da intellettuali, ma di reali, storicamente, regionalmente, popolani siciliani che pensano e operano così proprio perché sono popolani e siciliani. Che non siano cattolici, tomisti, aristotelici non vuol dire che non siano popolani e siciliani; che non possano conoscere la filosofia soggettivistica dell’idealismo moderno non vuol dire che nella tradizione popolare non possano esistere filoni di carattere «dialettico» e immanentistico. Se questo si dimostrasse, tutto il castello del pirandellismo cioè dell’intellettualismo astratto del teatro pirandelliano crollerebbe, come pare debba crollare.
Ma non mi pare che il problema culturale del teatro pirandelliano sia ancora esaurito in questi termini. In Pirandello abbiamo uno scrittore «siciliano», che riesce a concepire la vita paesana in termini «dialettali», folcloristici (se pure il suo folclorismo non è quello influenzato dal cattolicismo, ma quello rimasto «pagano», anticattolico sotto la buccia cattolica superstiziosa), che nello stesso tempo è uno scrittore «italiano» e uno scrittore «europeo». E in Pirandello abbiamo di più: la coscienza critica di essere nello stesso tempo «siciliano», «italiano» ed «europeo», ed è in ciò la debolezza artistica del Pirandello accanto al suo grande significato «culturale» (come ho notato in altre ). Questa «contraddizione», che è intima nel Pirandello, ha esplicitamente avuto espressione in qualche suo lavoro narrativo (in una lunga novella, mi pare Il Turno, si rappresenta l’incontro tra una donna siciliana e un marinaio scandinavo, tra due «province» così lontane storicamente). Quello che importa è però questo: il senso critico‑storico del Pirandello, se lo ha portato nel campo culturale a superare e dissolvere il vecchio teatro tradizionale, convenzionale, di mentalità cattolica o positivistica, imputridito nella muffa della vita regionale o di ambienti borghesi piatti e abbiettamente banali, ha però dato luogo a creazioni artistiche compiute? Se anche l’intellettualismo del Pirandello non è quello identificato dalla critica volgare (di origine cattolica tendenziosa, o tilgheriana dilettantesca) è però il Pirandello libero di ogni intellettualismo? Non è più un critico del teatro che un poeta, un critico della cultura che un poeta, un critico del costume nazionale‑regionale che un poeta? Oppure dove è realmente poeta, dove il suo atteggiamento critico è diventato contenuto‑forma d’arte e non è «polemica intellettuale», logicismo sia pure non da filosofo, ma da «moralista» in senso superiore? A me pare che Pirandello sia artista proprio quando è «dialettale» e Liolà mi pare il suo capolavoro, ma certo anche molti «frammenti» sono da identificare di grande bellezza nel teatro «letterario».
Letteratura su Pirandello. Per i cattolici: Silvio D’Antico, Il Teatro italiano (Treves, 1932) e alcune della «Civiltà Cattolica». Il capitolo di D’Amico sul Pirandello è stato pubblicato nell’«Italia Letteraria» del 30 ottobre 1932 e ha determinato una vivace polemica tra il D’Amico stesso e Italo Siciliano nell’«Italia Letteraria» del 4 dicembre 1932. Italo Siciliano è autore di un saggio, Il Teatro di L. Pirandello, che pare sia abbastanza interessante perché tratta precisamente dell’«ideologia» pirandellista. Per il Siciliano il Pirandello «filosofo» non esiste, cioè la così detta «filosofia pirandelliana» è «un melanconico, variopinto e contradditorio ciarpame di luoghi comuni e di sofismi decrepiti», «la famosa logica pirandelliana è vano e difettoso esercizio dialettico», e «l’una e l’altra (la logica e la filosofia) costituiscono il peso morto, la zavorra che tira giù – e talvolta fatalmente – un’opera d’arte di indubbia potenza». Per il Siciliano «il faticoso arzigogolare del P. non si è trasformato in lirismo o poesia, ma è restato grezzo e, non essendo profondamente vissuto, ma “plaqué”, inassimilato, talvolta incompatibile, ha nociuto, ha impastoiato e soffocato la vera poesia pirandelliana». Il Siciliano, pare, reagì alla critica di Adriano Tilgher, che aveva fatto del Pirandello «il poeta del problema centrale», cioè aveva dato come «originalità artistica» del Pirandello ciò che era un semplice elemento culturale, da tenersi subordinato e da esaminare in sede culturale. Per il Siciliano la poesia del Pirandello non coincide con questo contenuto astratto, sicché questa ideologia è completamente parassitaria: così pare, almeno, e se così è, non pare giusto. Che questo elemento culturale non sia il solo del Pirandello può essere concesso e d’altronde è quistione d’accertamento filologico; che questo elemento culturale non sempre si sia trasfigurato artisticamente è anche da concedersi. Ma in ogni modo rimane da studiare: 1) Se esso è diventato arte in qualche momento; 2) se esso, come elemento culturale, non ha avuto una funzione e un significato nel mutare sia il gusto del pubblico, sprovincializzandolo e modernizzandolo, e se esso non ha mutato le tendenze psicologiche, gli interessi morali degli altri scrittori di teatro, confluendo col futurismo migliore nel lavoro di distruzione del basso ottocentismo piccolo borghese e filisteo.
La posizione ideologica del D’Amico verso il «pirandellismo» è espressa in queste parole: «Con buona pace di quei filosofi che, a cominciare da Eraclito, pensano il contrario, è ben certo che, in senso assoluto, la nostra personalità è sempre identica e una, dalla nascita al Dilà; se ognuno di noi fosse “tanti”, come dice il Padre dei Sei personaggi, ciascuno di questi “tanti” non avrebbe né da godere i benefici né da pagare i debiti degli “altri” che porta in sé; mentre l’unità della coscienza ci dice che ognuno di noi è sempre “quello” e che Paolo deve redimere le colpe di Saulo perché, anche essendo divenuto “un altro”, è sempre la stessa persona».
Questo modo di porre la quistione è abbastanza scempio e ridicolo e d’altronde sarebbe da vedere se nell’arte del Pirandello non predomini l’umorismo, cioè l’autore non si diverta a far nascere certi dubbi «filosofici» in cervelli non filosofici e meschini per «sfottere» il soggettivismo e il solipsismo filosofico. Le tradizioni e l’educazione filosofica del Pirandello sono di origine piuttosto «positivistica» e cartesiana alla francese; egli ha studiato in Germania, ma nella Germania dell’erudizione filologica pedantesca, di origine non certo hegeliana ma proprio positivistica. È stato in Italia professore di stilistica e ha scritto sulla stilistica e sull’umorismo non certo secondo le tendenze idealistiche neohegeliane ma piuttosto in senso positivistico. Perciò appunto è da accertare e fissare che l’«ideologia» pirandelliana non ha origini libresche e filosofiche ma è connessa a esperienze storico‑culturali vissute con apporto minimo di carattere libresco. Non è escluso che le idee del Tilgher abbiano reagito sul Pirandello, che cioè il Pirandello abbia, accettando le giustificazioni critiche del Tilgher, finito col conformarvisi e perciò occorrerà distinguere tra il Pirandello prima dell’ermeneutica tilgheriana e quello successivo.
Q14 §16 Risorgimento italiano. Una derivazione delle diverse «dottrine» sul Risorgimento italiano è quel certo particolare settarismo che caratterizza la mentalità italiana e che si manifesta in una certa mania di persecuzione, nel credersi sempre malgiudicati e malcontenti, nel credersi le vittime di congiure internazionali, nel credere di avere particolari diritti storici misconosciuti e calpestati, ecc. Questa mentalità è diffusa sia nelle correnti democratiche di origine mazziniana sia in quelle conservatrici di origine neoguelfa e giobertiana, ed è legata all’idea di una «missione» nazionale, nebulosamente intesa e misticamente intuita; in ogni caso si cristallizza in gallofobia, poiché appare che sia stata la Francia a carpire all’Italia la primogenitura civile dell’eredità di Roma. Nel periodo del Risorgimento, la lotta contro l’Austria attutì questo sentimento, ma oggi, dopo la scomparsa dell’Impero austriaco, esso ha ripreso e si è ancora acuito per le quistioni balcaniche, che sono viste come un riflesso del malanimo francese.
Q14 §17 Letteratura popolare. Se è vero che la biografia romanzata continua, in un certo senso, il romanzo storico popolare tipo A. Dumas padre, si può dire che da questo punto di vista, in questo particolare settore, in Italia si sta «colmando una lacuna». È da vedere ciò che pubblica la Casa ed. «Corbaccio», e qualche altra, e specialmente i libri di Mazzucchelli. È da notare però che la biografia romanzata, se ha un pubblico popolare, non è popolare in senso completo come il romanzo d’appendice: essa si rivolge a un pubblico che ha o crede avere delle pretese di cultura superiore, alla piccola borghesia rurale e urbana che crede essere diventata «classe dirigente», e arbitra dello Stato. Il tipo moderno del romanzo popolare è quello poliziesco, «giallo», e in questo settore si ha zero. Così si ha zero nel romanzo d’avventure in senso largo, sia del tipo Stevenson, Conrad, London, sia del tipo francese odierno (Mac‑Orlan, Malraux, ecc.).
Q14 §18 Machiavelli. Volontarismo e garibaldinismo. Occorre distinguere: altro è il volontarismo o garibaldinismo che teorizza se stesso come forma organica di attività storico‑politica e si esalta con frasi che non sono altro che una trasposizione del linguaggio del superuomo individuo a un insieme di «superuomini» (esaltazione delle minoranze attive come tali ecc.), altro è il volontarismo o garibaldinismo concepito come momento iniziale di un periodo organico da preparare e sviluppare, in cui la partecipazione della collettività organica, come blocco sociale, avvenga in modo completo. Le «avanguardie» senza esercito di rincalzo, gli «arditi» senza fanteria e artiglieria, sono anch’esse trasposizioni del linguaggio dell’eroismo retorico; non così le avanguardie e gli arditi come funzioni specializzate di organismi complessi e regolari. Così è della concezione delle élites di intellettuali senza massa, ma non degli intellettuali che si sentono legati organicamente a una massa nazionale-popolare. In realtà si lotta contro queste degenerazioni di falsi eroismi e di pseudo‑aristocrazie stimolando la formazione di blocchi sociali omogenei e compatti che esprimono un gruppo di intellettuali, di arditi, un’avanguardia loro propria che reagiscono nel loro blocco per svilupparlo e non solo per perpetuare il loro dominio zingaresco. La bohème parigina del romanticismo è stata anch’essa alle origini intellettuali di molti modi di pensare odierni che pure pare deridano quei bohémiens.
Q14 §19 Letteratura popolare. Il gusto melodrammatico. Come combattere il gusto melodrammatico del popolano italiano quando si avvicina alla letteratura, ma specialmente alla poesia? Egli crede che la poesia sia caratterizzata da certi tratti esteriori, fra cui predomina la rima e il fracasso degli accenti prosodici, ma specialmente dalla solennità gonfia, oratoria, e dal sentimentalismo melodrammatico, cioè dall’espressione teatrale, congiunta a un vocabolario barocco. Una delle cause di questo gusto è da ricercare nel fatto che esso si è formato non alla lettura e alla meditazione intima e individuale della poesia e dell’arte, ma nelle manifestazioni collettive, oratorie e teatrali. E per «oratorie» non bisogna solo riferirsi ai comizi popolari di famigerata memoria, ma a tutta una serie di manifestazioni di tipo urbano e paesano. Nella provincia, per esempio, è molto seguita l’oratoria funebre e quella delle preture e dei tribunali (e anche delle conciliature): queste manifestazioni hanno tutte un pubblico di «tifosi» di carattere popolare, e un pubblico costituito (per i tribunali) da quelli che attendono il proprio turno, testimoni, ecc. In certe sedi di pretura mandamentale, l’aula è sempre piena di questi elementi, che si imprimono nella memoria i giri di frase e le parole solenni, se ne pascono e le ricordano. Così nei funerali di maggiorenti, cui affluisce molta folla, spesso solo per sentire i discorsi.
Le conferenze nelle città hanno lo stesso ufficio e così i tribunali, ecc. I teatri popolari con gli spettacoli così detti da arena (e oggi, forse il cinematografo parlato, ma anche le didascalie del vecchio cinematografo muto, compilato tutto in stile melodrammatico), sono della massima importanza per creare questo gusto e il linguaggio conforme.
Si combatte questo gusto in due modi principali: con la critica spietata di esso, e anche diffondendo libri di poesia scritti o tradotti in lingua non «aulica», e dove i sentimenti espressi non siano retorici o melodrammatici.
Cfr l’Antologia compilata dallo Schiavi; poesie del Gori. Traduzione possibile di M. Martinet e di altri scrittori che oggi (sono) più numerosi che in passato: traduzioni sobrie, del tipo di quelle del Togliatti per Whitman e Martinet.
Q14 §20 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. La prima enciclica papale contro le manifestazioni politiche e filosofiche dell’epoca moderna (liberalismo, ecc.) sarebbe stata del 1832, la Mirari vos di Gregorio XVI; a cui sarebbe seguita l’Enciclica Quanta cura di Pio IX dell’8 settembre 1864, accompagnata dal Sillabo; terza enciclica quella Pascendi di Pio X, contro il modernismo. Queste le tre encicliche «organiche» contro il pensiero moderno ma non mi pare che esse siano i soli documenti del genere. Per il periodo antecedente al 1864 si può vedere nel Sillabo l’elencazione delle altre encicliche e documenti diversi papali contro il pensiero moderno. Per il periodo dal 64 al 1907 (8 settembre, come per il Sillabo) non ricordo se ci sono accenni nell’enciclica Pascendi, che d’altronde ha un suo carattere particolare, in quanto non tanto combatte il pensiero moderno come tale, ma per il fatto che è riuscito a penetrare nell’organizzazione ecclesiastica e nell’attività scientifica propriamente cattolica. Ma nella letteratura polemica non sarà difficile trovare le indicazioni bibliografiche (nella «Civiltà Cattolica» poi le manifestazioni successive al 1908 che sono ancora più interessanti in quanto si riferiscono ad attività statali). In ogni modo queste tre encicliche del 1832, del 1864 e del 1907 sono le più organiche ed estensive teoricamente e a esse occorre riferirsi per fissare le lotte interne tra integralisti, gesuiti e modernisti.
Non si può accanto a tali encicliche dimenticare le altre «costruttive», tipiche la Rerum Novarum e la Quadragesimo anno che integrano le grandi encicliche teoriche contro il pensiero moderno e cercano risolvere a loro modo alcuni dei problemi ad esso legati e connessi. (Non bisogna dimenticare che alcune ricerche per questa rubrica sono connesse a quelle per la rubrica sulla «Storia dell’Azione Cattolica»; cioè i due studi sono inscindibili in un certo senso e come tali devono essere elaborati).
Q14 §21 Il teatro di Pirandello. È da vedere quanto nella «ideologia» pirandelliana sia, per dir così, della stessa origine di ciò che pare formi il nucleo degli scritti «teatrali» di Nicola Evreinov. Per l’Evreinov la teatralità non è solamente una determinata forma di attività artistica, quella che si esprime tecnicamente nel teatro propriamente detto. Per l’Evreinov la «teatralità» è nella vita stessa, è un atteggiamento proprio all’uomo, in quanto l’uomo tende a credere e a farsi credere diverso da ciò che è. Occorre vedere bene queste teorie dell’Evreinov, perché mi pare che egli colga un tratto psicologico esatto, che dovrebbe essere esaminato e approfondito. Cioè esistono parecchie forme di «teatralità» in questo senso: una è quella comunemente nota e appariscente in forma caricaturale che si chiama «istrionismo»; ma ne esistono anche delle altre, che non sono deteriori, o sono meno deteriori e alcune che sono normali e anche meritorie. In realtà ognuno tende, a suo modo, sia pure, a crearsi un carattere, a dominare certi impulsi e istinti, ad acquistare certe forme «sociali» che vanno dallo snobismo, alle convenienze, alla correttezza, ecc. Ora cosa significa: «ciò che si è realmente» e da cui si cerca di apparire «diversi?» «Ciò che si è realmente» sarebbe l’insieme degli impulsi e istinti animaleschi e ciò che si cerca di apparire è il «modello» sociale‑culturale, di una certa epoca storica, che si cerca di diventare; mi pare che ciò «che si è realmente» è dato dalla lotta per diventare ciò che si vuol diventare.
Come ho notato altrove, il Pirandello è criticamente un «paesano» siciliano che ha acquisito certi caratteri nazionali e certi caratteri europei, ma che sente in se stesso questi tre elementi di civiltà come giustapposti e contradditori. Da questa esperienza gli è venuto l’atteggiamento di osservare le contraddizioni nelle personalità degli altri e poi addirittura di vedere il dramma della vita come il dramma di queste contraddizioni.
Del resto un elemento non solo del teatro dialettale siciliano (Aria del continente) ma di ogni teatro dialettale italiano e anche del romanzo popolare è la descrizione, la satira e la caricatura del provinciale che vuole apparire «trasfigurato» in un carattere «nazionale» o europeo‑cosmopolita, e non è altro che un riflesso del fatto che non esiste ancora una unità nazionale‑culturale nel popolo italiano, che il «provincialismo» e particolarismo è ancora radicato nel costume e nei modi di pensare e di agire; non solo, ma che non esiste un «meccanismo» per elevare la vita dal livello provinciale a quello nazionale europeo collettivamente e quindi le «sortite», i «raids» individuali in questo senso assumono forme caricaturali, meschine, «teatrali», ridicole, ecc. ecc.
Q14 §22 Argomenti di cultura. Personalità del mondo economico nazionale. Sono meno conosciute e apprezzate di quanto talvolta meriterebbero. Una loro classificazione: 1) scienziati, scrittori, giornalisti, la cui attività è prevalentemente teorica: che influiscono nella pratica, ma come «educatori» e teorici; 2) pratici, ma che danno molta attività come «pubblicisti» o «relatori» o «conferenzieri» (es. Alberto Pirelli, Teodoro Mayer, Gino Olivetti); 3) pratici, di valore indiscusso e solido (es. Agnelli, Crespi, Silvestri, ecc.) noti al pubblico; 4) pratici che si tengono nell’ombra, quantunque la loro attività sia molto grande (es. Marsaglia); 5) pratici demi‑monde (un esempio tipico era quel ragioniere Panzarasa della società a catena Italgas); 6) esperti statali, specialisti della burocrazia statale per le dogane, le aziende autonome, il commercio internazionale, ecc.; 7) banchieri e speculatori ecc. Si dovrebbero esaminare queste personalità «pratiche» per ogni attività industriale, tecnica, finanziaria, ecc. E anche «politico‑parlamentare» (compilatori e relatori per i bilanci e per le leggi economiche finanziarie al Senato e alla Camera) e «tecnici» (tipo ing. Omodeo). La raccolta delle pubblicazioni periodiche del «Rotary» italiano, le pubblicazioni ufficiali delle Confederazioni industriali e padronali potrebbero dare un certo materiale: così le pubblicazioni del Credito Italiano sulle Società Anonime.
Q14 §23 Machiavelli. Cesarismo ed equilibrio «catastrofico» delle forze politico‑sociali. Sarebbe un errore di metodo (un aspetto del meccanicismo sociologico) ritenere che, nei fenomeni di cesarismo, sia progressivo, sia regressivo, sia di carattere intermedio episodico, tutto il nuovo fenomeno storico sia dovuto all’equilibrio delle forze «fondamentali»; occorre anche vedere i rapporti che intercorrono tra i gruppi principali (di vario genere, sociale‑economico e tecnico‑economico) delle classi fondamentali e le forze ausiliarie guidate o sottoposte all’influenza egemonica. Così non si comprenderebbe il colpo di Stato del 2 dicembre senza studiare la funzione dei gruppi militari e dei contadini francesi.
Un episodio storico molto importante da questo punto di vista è il così detto movimento per l’affare Dreyfus in Francia; anche esso rientra in questa serie di osservazioni non perché abbia portato al «cesarismo», anzi proprio per il contrario, perché ha impedito l’avvento di un cesarismo che si stava preparando, di carattere nettamente reazionario. Tuttavia il movimento Dreyfus è caratteristico perché sono elementi dello stesso blocco sociale dominante che sventano il cesarismo della parte più reazionaria del blocco stesso, appoggiandosi non ai contadini, alla campagna, ma agli elementi subordinati della città guidati dal riformismo socialista (però anche alla parte più avanzata del contadiname). Del tipo Dreyfus troviamo altri movimenti storico‑politici moderni, che non sono certo rivoluzioni, ma non sono completamente reazioni, nel senso almeno che anche nel campo dominante spezzano cristallizzazioni statali soffocanti, e immettono nella vita dello Stato e nelle attività sociali un personale diverso e più numeroso di quello precedente: anche questi movimenti possono avere un contenuto relativamente «progressivo» in quanto indicano che nella vecchia società erano latenti forze operose non sapute sfruttare dai vecchi dirigenti, sia pure «forze marginali», ma non assolutamente progressive, in quanto non possono «fare epoca». Sono rese storicamente efficienti dalla debolezza costruttiva dell’antagonista, non da una intima forza propria, e quindi sono legate a una situazione determinata di equilibrio delle forze in lotta, ambedue incapaci nel proprio campo a esprimere una volontà ricostruttiva in proprio.
Q14 §24 Elementi di cultura italiana. L’ideologia «romana». L’Omodeo afferma («Critica» del 20 settembre 1931): «Cerca (il Bülon) di confortarsi nella luminosa atmosfera di Roma, inebriandosi di quella poesia dell’Urbe, che il Goethe ha diffuso fra i Tedeschi, e che tanto si differenzia dalla retorica romana, per buona parte figlia delle scuole gesuitiche, corrente fra noi». È da notare, a rincalzo, che nei Sepolcri del Foscolo, in cui pure sono contenuti tanti spunti della mentalità e dell’ideologia dell’intellettuale italiano del secolo XIX‑XX, Roma antica ha un posto minimo e quasi nullo. (Lo stesso Primato del Gioberti è forse di origine «gesuitica», anche se il Gioberti era antigesuita).
Q14 §25 Passato e presente. La logica di don Ferrante. Si può avvicinare la forma mentale di don Ferrante a quella che è contenuta nelle così dette «tesi» di Roma (ricordare la discussione sul «colpo di Stato» ecc.). Era proprio come il negare la «peste» e il «contagio» da parte di don Ferrante e così morirne «stoicamente» (se pure non è da usare un altro avverbio più appropriato). Ma in don Ferrante in realtà c’era più ragion «formale» almeno, cioè egli rifletteva il modo di pensare dell’epoca sua (e questo il Manzoni mette in satira, personificandolo in don Ferrante), mentre nel caso più moderno si trattava di anacronismo, come se don Ferrante fosse risuscitato con tutta la sua mentalità in pieno secolo XX.
Q14 §26 di cultura italiana. A proposito del protestantesimo in Italia, ecc. Riferimento a quella corrente intellettuale contemporanea che sostenne il principio che le debolezze della nazione e dello Stato italiano erano dovute alla mancanza di una riforma protestante, corrente rappresentata specialmente dal Missiroli. Il Missiroli, come appare, prese questa sua tesi di peso dal Sorel, che l’aveva presa dal Renan (poiché Renan una tesi simile, adattata alla Francia e più complessa aveva sostenuto nel libro La riforma intellettuale e morale). Nella «Critica» del 1931, in diverse puntate, è stato pubblicato un saggio inedito del Sorel, Germanesimo e storicismo di Ernesto Renan, scritto (datato) del maggio 1915 e che avrebbe dovuto servire di introduzione alla versione italiana del libro di Renan La riforma intellettuale e morale che doveva tradurre Missiroli e pubblicare Laterza. La traduzione del Missiroli non fu pubblicata e si capisce perché: nel maggio 1915 l’Italia intervenne nella guerra e il libro del Renan con la prefazione del Sorel sarebbe apparso un atto di tedescofilia. In ogni modo pare da accertare che la posizione del Missiroli sulla quistione del «protestantesimo in Italia» è una deduzione meccanica dalle idee critiche del Renan e del Sorel sulla formazione e le necessità della cultura francese. Non è però escluso che il Missiroli conoscesse anche le idee del Masaryk sulla cultura russa (egli per lo meno conosceva il saggio sul Masaryk di Antonio Labriola: ma il Labriola accenna a questa tesi «religiosa»? non mi pare) e nel 1918 conobbe dal «Grido del Popolo» il saggio sul Masaryk, con l’accenno alla tesi religiosa, pubblicato dal «Kampf» di Vienna nel 1914 e da me tradotto appunto nel «Grido» (questo saggio era anche conosciuto dal Gobetti). Le critiche fatte al Masaryk in questo saggio, metodologicamente, si avvicinano a quelle fatte dal Croce ai sostenitori di «riforme protestanti» ed è strano che ciò non sia stato visto dal Gobetti (per il quale, del resto, non si può dire che non comprendesse questo problema in modo concreto, a differenza del Missiroli, come dimostravano le sue simpatie politico‑pratiche). Occorrerebbe stroncare invece il Missiroli che è una carta asciugante di alcuni elementi culturali francesi.
Dal saggio del Sorel appare anche una strana tesi sostenuta dal Proudhon, a proposito di riforma intellettuale e morale del popolo francese (il Renan nella sua opera si interessa delle alte classi di cultura ed ha per il popolo un programma particolare: affidarne l’educazione ai parroci di campagna), che si avvicina a quella di Renan riguardante il popolo. Il Sorel sostiene che Renan anzi abbia conosciuto questo atteggiamento di Proudhon e ne sia stato influenzato. Le tesi di Proudhon sono contenute nell’opera La Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, tome V, pp. 342‑44 e per esse si dovrebbe giungere a una riforma intellettuale e morale del popolo francese con l’aiuto del clero, che avrebbe, con il linguaggio e il simbolismo religioso, concretato e assicurato le verità «laiche» della Rivoluzione. Il Proudhon in fondo, nonostante le sue bizzarrie, è più concreto di quanto sembri: egli pare certamente persuaso che occorre una riforma intellettuale in senso laico («filosofico» come dice) ma non sa trovare altro mezzo didattico che il tramite del clero. Anche per Proudhon, il modello è quello protestante, cioè la riforma intellettuale e morale avvenuta in Germania con il protestantesimo, che egli vorrebbe «riprodotta» in Francia, nel popolo francese, ma con più rispetto storico della tradizione storica francese che è contenuta nella Rivoluzione. (Naturalmente occorre leggere bene Proudhon prima di servirsene per questo argomento). Anche la posizione del Sorel è strana in questo problema: la sua ammirazione per Renan e per i tedeschi gli fa vedere i problemi da puro intellettuale astratto.
Questo problema del protestantesimo non deve essere confuso con quello «politico» presentatosi nel periodo del Risorgimento, quando molti liberali, per esempio quelli della «Perseveranza», si servirono dello spauracchio protestante per far pressione sul papa a proposito del potere temporale e di Roma.
Sicché in una trattazione del problema religioso in Italia occorre distinguere in primo luogo tra due ordini fondamentali di fatti: 1) quello reale, effettuale, per cui si verificano nella massa popolare dei movimenti di riforma intellettuale e morale, sia come passaggio dal cattolicismo ortodosso e gesuitico a forme religiose più liberali, sia come evasione dal campo confessionale per una moderna concezione del mondo; 2) i diversi atteggiamenti dei gruppi intellettuali verso una necessaria riforma intellettuale e morale.
La corrente Missiroli è la meno seria di queste, la più opportunistica, la più dilettantesca e spregevole per la persona del suo corifeo.
Così occorre per ognuno di questi ordini di fatti distinguere cronologicamente tra varie epoche: quella del Risorgimento (col liberalismo laico da una parte, e il cattolicismo liberale dall’altra), quella dal 70 al 900 col positivismo e anticlericalismo massonico e democratico; quella dal 900 fino alla guerra, col modernismo e il filosofismo idealistico; quella fino al concordato, con l’organizzazione politica dei cattolici italiani; e quella post‑concordataria, con una nuova posizione del problema, sia per gli intellettuali che per il popolo. È innegabile, nonostante la più potente organizzazione cattolica e il risveglio di religiosità in questa ultima fase, che molte cose stanno mutando nel cattolicesimo, e che la gerarchia ecclesiastica ne è allarmata, perché non riesce a controllare queste trasformazioni molecolari; accanto a una nuova forma di anticlericalismo, più raffinata e profonda di quella ottocentesca, c’è un maggiore interesse per le cose religiose da parte dei laici, che portano nella trattazione uno spirito non educato al rigore ermeneutico dei gesuiti e quindi sconfinante spesso nell’eresia, nel modernismo, nello scetticismo elegante. «Troppa grazia!» per i gesuiti, che vorrebbero invece che i laici non s’interessassero di religione altro che per seguire il culto.
Q14 §27 Letteratura popolare. Origini popolaresche del «superuomo». Da riavvicinare al Balzac per le origini romantiche del «superuomo» è lo Stendhal col Giuliano Sorel del Rosso e Nero e altre figure del suo repertorio romanzesco. Per il «superuomo» nietzschiano, oltre all’influsso romantico dello Stendhal (e in generale del culto di Napoleone I) sono da vedere le tendenze razziste che hanno culminato nel Gobineau e poi nel Chamberlain e nel pangermanismo (Treitschke e le teorie della «potenza» ecc.).
Ma non è questa l’origine di certe forme moderne del superuomo: piuttosto, come ho scritto, Dumas del Montecristo e Balzac di Vautrin. Da vedere anche Dostojevsckij, come reazione panslavista ‑cristiana a queste dottrine della forza e del superuomo, ed è da notare che nel Dostojevsckij è stato grande l’influsso del romanzo francese d’appendice (cfr nel numero della «Cultura» dedicato a Dostojevsckij).
Nel carattere popolaresco del «superuomo» molti elementi teatrali, esteriori, da «prima donna» più che da «superuomo»: molto formalismo «soggettivo e oggettivo», ambizioni fanciullesche di essere il «primo della classe», ma specialmente di essere ritenuto e proclamato tale.
Q14 §28 Letteratura popolare. Luigi Volpicelli, nella «Italia Letteraria» del 1° gennaio 1933 (articolo Arte e religione) nota: «Il quale (il popolo) si potrebbe osservare tra parentesi, ha amato sempre l’arte più per quello che non è arte che per ciò che è essenziale all’arte; e forse proprio per questo è così diffidente verso gli artisti di oggi, i quali, volendo nell’arte la pura e sola arte, finiscono col diventare enigmatici, inintelligibili, profeti di pochi iniziati».
Osservazione senza costrutto né base: è certo che il popolo vuole un’arte «storica» (se non si vuole impiegare la parola «sociale»), cioè vuol un’arte espressa in termini di cultura «comprensibili», cioè universali, o «obbiettivi», o «storici» o «sociali» che è la stessa cosa. Non vuole «neolalismi» artistici specialmente se il «neolalico» è anche un imbecille.
Mi pare che il problema è sempre da porre partendo dalla domanda: «Perché scrivono i poeti? Perché dipingono i pittori? ecc.» (Ricordare l’articolo di Adriano Tilgher nell’«Italia che scrive»). Il Croce risponde, su per giù: per ricordate le proprie opere, dato che, secondo l’estetica crociana, l’opera d’arte è «perfetta» anche già e solo nel cervello dell’artista. Ciò che potrebbe ammettersi approssimativamente e in un certo senso. Ma solo approssimativamente e in un certo senso. In realtà si ricade nella quistione della «natura dell’uomo» e nella quistione «cos’è l’individuo?» Se non si può pensare l’individuo fuori della società, e quindi se non si può pensare nessun individuo che non sia storicamente determinato, è evidente che ogni individuo e anche l’artista, e ogni sua attività, non può essere pensata fuori della società, di una società determinata. L’artista pertanto non scrive o dipinge, ecc., cioè non «segna» esteriormente i suoi fantasmi solo per «un suo ricordo», per poter rivivere l’istante della creazione, ma è artista solo in quanto «segna» esteriormente, oggettivizza, storicizza i suoi fantasmi. Ma ogni individuo‑artista è tale in modo più o meno largo e comprensivo, più o meno «storico» o «sociale». Ci sono i «neolalici» o i «gerghisti», cioè quelli che essi soli possono rivivere il ricordo dell’istante creativo (ed è di solito un’illusione, il ricordo di un sogno o di una velleità), altri che appartengono a conventicole più o meno larghe (che hanno un gergo corporativo) e finalmente quelli che sono universali, cioè «nazionali‑popolari». L’estetica del Croce ha determinato molte degenerazioni artistiche, e non è poi vero che ciò sia avvenuto sempre contro le intenzioni e lo spirito dell’estetica crociana stessa; per molte degenerazioni, sì, ma non per tutte, e specialmente per questa fondamentale, dell’«individualismo» artistico espressivo antistorico (o antisociale, o anti‑nazionalepopolare).
Q14 §29 Argomenti di coltura. L’ossicino di Cuvier. Il principio di Cuvier, della correlazione tra le singole parti organiche di un corpo, per cui da una particella di esso (purché integra in sé) si può ricostruire l’intero corpo (tuttavia è da rivedere bene la dottrina di Cuvier, per esporre con esattezza il suo pensiero), è certo da inserire nella tradizione del pensiero francese, nella «logica» francese ed è da connettere col principio dell’animale‑macchina. Non importa vedere se nella biologia il principio possa dirsi ancora valido in tutto; ciò non pare possibile (per esempio è da ricordare l’ornitorinco, nella cui struttura non c’è «logica» ecc.); è da esaminare se il principio della correlazione sia utile, esatto e fecondo nella sociologia, oltre la metafora. Pare da rispondere nettamente di sì. Ma occorre intendersi: per la storia passata, il principio della correlazione (come quello dell’analogia) non può sostituire il documento, cioè non può dare altro che storia ipotetica, verosimile ma ipotetica. Ma diverso è il caso dell’azione politica e del principio di correlazione (come quello d’analogia) applicato al prevedibile, alla costruzione di ipotesi possibili e di prospettive. Si è appunto nel campo dell’ipotesi e si tratta di vedere quale ipotesi sia più verosimile e più feconda di convinzioni e di educazione. È certo che quando si applica il principio di correlazione agli atti di un individuo o anche di un gruppo, c’è sempre il rischio di cadere nell’arbitrio: gli individui e anche i gruppi non operano sempre «logicamente», «coerentemente», consequenziariamente ecc.; ma è sempre utile partire dalla premessa che così operino. Posta la premessa dell’«irrazionalità» dei motivi d’azione, essa non serve a nulla; può solo avere una portata polemica per poter dire come gli scolastici: «ex absurdo sequitur quodlibet». Invece la premessa della razionalità e quindi della «correlazione» o dell’analogia ha una portata educativa, in quanto può servire ad «aprir gli occhi agli ingenui» e anche a persuadere il «preopinante» se è in buona fede e sbaglia per «ignoranza» ecc.
Q14 §30 Letteratura popolare. Origini popolaresche del superuomo. Per i rapporti tra il basso romanticismo e alcuni aspetti della vita moderna (atmosfera da Conte di Montecristo) è da leggere un articolo di Louis Gillet nella «Revue des deux mondes» del 15 dicembre 1932.
Q14 §31 I nipotini dell’abate Bresciani. A molti poetuzzi odierni si potrebbe applicare il verso del Lasca contro il Ruscelli: «delle Muse e di Febo mariuolo». E più che di poesia si deve infatti parlare di mariuoleria per ottenere premi letterari e sovvenzioni d’Accademia.
Q14 §32 Machiavelli. Teoria e pratica. Riletta la famosa dedica del Bandello a Giovanni delle Bande Nere dove si parla del Machiavelli e dei suoi tentativi inutili per ordinare secondo le sue teorie dell’arte della guerra una moltitudine di soldati in campo, mentre Giovanni delle Bande Nere «in un batter d’occhio con l’aita dei tamburini» ordinò «quella gente in vari modi e forme, con ammirazione grandissima di chi vi si ritrovò». Appare chiaro che né in Bandello e neanche in Giovanni vi fu alcun proposito di «sfottere» il Machiavelli per la sua incapacità, e che lo stesso Machiavelli non se l’ebbe a male. L’impiego di questo aneddoto per trarre conseguenze sull’astrattezza del Machiavelli è un non senso e dimostra che non si capisce la sua portata esatta. Il Machiavelli non era un militare di professione, ecco tutto; cioè non sapeva il «linguaggio» degli ordini e dei segnali militari (trombe, tamburi ecc.). D’altronde prima che un complesso di soldati, graduati, sottufficiali, ufficiali, abbia preso l’abitudine a evolvere in un certo senso, ci vuole molto tempo. Un ordinamento teorico delle milizie può essere ottimo in tutto, ma per essere applicato deve diventare «regolamento», disposizioni d’esercizio, ecc., «linguaggio» subito capito e quasi automaticamente attuato. Si sa che molti legislatori di primo ordine non sanno compilare i «regolamenti» burocratici e organizzare gli uffici e selezionare il personale atto ad applicare le leggi, ecc. Si può dire dunque solo questo del Machiavelli, che fu troppo corrivo ad improvvisarsi «tamburino».
La quistione è tuttavia importante: non si può scindere l’amministratore‑funzionario dal legislatore, l’organizzatore dal dirigente, ecc. Ma ciò non si è attuato neanche oggi e la «divisione del lavoro» supplisce non solo all’incapacità relativa, ma integra «economicamente» l’attività principale del grande stratega, del legislatore, del capo politico, che si fanno aiutare da specialisti in compilare «regolamenti», «istruzioni», «ordinamenti pratici», ecc.
Q14 §33 Machiavelli. Interpretazione del Principe. Se, come è stato scritto in altre , l’interpretazione del Principe deve (o può) esser fatta ponendo come centro del libro l’invocazione finale, è da rivedere quanto di «reale» ci sia nella interpretazione così detta «satirica e rivoluzionaria» di esso (come si esprime Enrico Carrara nella nota al passo rispettivo dei Sepolcri nella sua opera scolastica Storia ed esempi della Letteratura Italiana, VII, L’Ottocento, p. 59 (ed. Signorelli, Milano). Per ciò che riguarda il Foscolo non pare debba parlarsi di una particolare interpretazione del Principe, cioè dell’attribuzione al Machiavelli di intenzioni riposte democratiche e rivoluzionarie; più giusto pare l’accenno del Croce (nel libro sulla Storia del Barocco) che risponde alla lettera dei Sepolcri, e cioè: «Il Machiavelli, per il fatto stesso di “temprare” lo scettro, ecc., di rendere il potere dei principi più coerente e consapevole, ne sfronda gli allori, distrugge i miti, mostra cosa sia realmente questo potere ecc.»; cioè la scienza politica, in quanto scienza, è utile sia ai governanti che ai governati per comprendersi reciprocamente.
Nei Ragguagli del Parnaso del Boccalini la quistione del Principe è invece posta in modo tutto diverso che nei Sepolcri. Ma è da domandare: chi vuole satireggiare il Boccalini?
Machiavelli o i suoi avversari? La quistione è dal Boccalini posta così: «I nemici del Machiavelli reputano il Machiavelli uomo degno di punizione perché ha esposto come i principi governano e così facendo ha istruito il Popolo; ha “messo alle pecore denti di cane”, ha distrutto i miti del potere, il prestigio dell’autorità, ha reso più difficile il governare, poiché i governati ne possono sapere quanto i governanti, le illusioni sono rese impossibili ecc.». È da vedere tutta l’impostazione politica del Boccalini, che in questo ragguaglio mi pare faccia la satira degli antimachiavellici, i quali non sono tali perché non facciano in realtà ciò che il Machiavelli ha scritto, cioè non sono antimachiavellici perché il Machiavelli abbia avuto torto, ma perché ciò che il Machiavelli scrive «si fa e non si dice», anzi è fattibile appunto perché non è criticamente spiegato e sistemato. Il Machiavelli è odiato perché «ha scoperto gli altarini» dell’arte di governo ecc.
La quistione si pone anche oggi e l’esperienza della vita dei partiti moderni è istruttiva; quante volte si è sentito il rimprovero per aver mostrato criticamente gli errori dei governanti: «mostrando ai governanti gli errori che essi fanno, voi insegnate loro a non fare errori», cioè «fate il loro gioco». Questa concezione è legata alla teoria fanciullesca del «tanto peggio, tanto meglio». La paura di «fare il gioco» degli avversari è delle più comiche ed è legata al concetto balordo di ritenere sempre gli avversari degli stupidi; è anche legata alla non comprensione delle «necessità» storico‑politiche, per cui «certi errori devono essere fatti» e il criticarli è utile per educare la propria parte.
Pare che le intenzioni del Machiavelli nello scrivere il Principe siano state più complesse e anche «più democratiche» di quanto non sarebbero secondo l’interpretazione «democratica». Cioè il Machiavelli ritiene che la necessità dello Stato unitario nazionale è così grande che tutti accetteranno che per raggiungere questo altissimo fine siano impiegati i soli mezzi che sono idonei. Si può quindi dire che il Machiavelli si sia proposto di educare il popolo, ma non nel senso che di solito si dà a questa espressione o almeno gli hanno dato certe correnti democratiche. Per il Machiavelli «educare il popolo» può aver significato solo renderlo convinto e consapevole che può esistere una sola politica, quella realistica, per raggiungere il fine voluto e che pertanto occorre stringersi intorno e obbedire proprio a quel principe che tali metodi impiega per raggiungere il fine, perché solo chi vuole il fine vuole i mezzi idonei a raggiungerlo. La posizione del Machiavelli, in tal senso, sarebbe da avvicinare a quella dei teorici e dei politici della filosofia della prassi, che anche essi hanno cercato di costruire e diffondere un «realismo» popolare, di massa e hanno dovuto lottare contro una forma di « gesuitismo» adeguato ai tempi diversi. La «democrazia» del Machiavelli è di un tipo adatto ai tempi suoi, è cioè il consenso attivo delle masse popolari per la monarchia assoluta, in quanto limitatrice e distruttrice dell’anarchia feudale e signorile e del potere dei preti, in quanto fondatrice di grandi Stati territoriali nazionali, funzione che la monarchia assoluta non poteva adempiere senza l’appoggio della borghesia e di un esercito stanziale, nazionale, centralizzato, ecc.
Q14 §34 Machiavelli. Partiti politici e funzioni di polizia. È difficile escludere che qualsiasi partito politico (dei gruppi dominanti, ma anche di gruppi subalterni) non adempia anche una funzione di polizia, cioè di tutela di un certo ordine politico e legale. Se questo fosse dimostrato tassativamente, la quistione dovrebbe essere posta in altri termini: e cioè, sui modi e gli indirizzi con cui una tale funzione viene esercitata. Il senso è repressivo o diffusivo, cioè è di carattere reazionario o progressivo? Il partito dato esercita la sua funzione di polizia per conservare un ordine esteriore, estrinseco, pastoia delle forze vive della storia, o la esercita nel senso che tende a portare il popolo a un nuovo livello di civiltà di cui l’ordine politico e legale è un’espressione programmatica? Infatti, una legge trova chi la infrange: 1) tra gli elementi sociali reazionari che la legge ha spodestato; 2) tra gli elementi progressivi che la legge comprime; 3) tra gli elementi che non hanno raggiunto il livello di civiltà che la legge può rappresentare. La funzione di polizia di un partito può dunque essere progressiva e regressiva: è progressiva quando essa tende a tenere nell’orbita della legalità le forze reazionarie spodestate e a sollevare al livello della nuova legalità le masse arretrate. È regressiva quando tende a comprimere le forze vive della storia e a mantenere una legalità sorpassata, antistorica, divenuta estrinseca. Del resto il funzionamento del Partito dato fornisce criteri discriminanti: quando il partito è progressivo esso funziona «democraticamente» (nel senso di un centralismo democratico), quando il partito è regressivo esso funziona «burocraticamente» (nel senso di un centralismo burocratico). Il Partito in questo secondo caso è puro esecutore, non deliberante: esso allora è tecnicamente un organo di polizia e il suo nome di Partito politico è una pura metafora di carattere mitologico.
Q14 §35 I nipotini di padre Bresciani. Si moltiplicano gli scritti sul distacco tra arte e vita. Articolo di Papini, nella Nuova Antologia del 10 gennaio 1933, articolo di Luigi Chiarini nell’«Educazione Fascista» del dicembre 1932. Attacchi contro Papini nell’«Italia Letteraria» ecc. Polemiche noiose e quanto inconcludenti. Papini è cattolico e anticrociano; le contraddizioni del suo superficiale scritto risultano da questa doppia qualità. In ogni modo questo rinnovarsi delle polemiche (alcuni articoli di «Critica Fascista», quelli di Gherardo Casini e uno di Bruno Spampanato contro gli intellettuali sono i più voli e si avvicinano di più al nocciolo della quistione) è sintomatico e mostra come si senta il disagio per il contrasto tra le parole e i fatti, tra le affermazioni recise e la realtà che le contraddice.
Pare però che oggi sia più possibile far riconoscere la realtà della situazione: c’è indubbiamente più buona volontà di comprendere, più spregiudicatezza ed esse sono date dal diffuso spirito antiborghese anche se generico e di origini spurie. Per lo meno si vorrebbe creare una effettiva unità nazionale‑popolare, anche se con mezzi estrinseci, pedagogici, scolastici, col «volontarismo»: per lo meno si sente che questa unità manca e che tale mancanza è una debolezza nazionale e statale. Ciò differenzia radicalmente l’attuale epoca da quella degli Ojetti, dei Panzini e C. Perciò nella trattazione di questa rubrica conviene tenerne conto. Le debolezze, d’altronde, sono evidenti: la prima è quella dell’essere persuasi che sia avvenuto un rivolgimento radicale popolare‑nazionale; se è avvenuto, vuol dire che non si deve far nulla più oltre di radicale, ma che si tratta solo di «organizzare», educare, ecc.; tutt’al più si parla di «rivoluzione permanente» ma in significato ristretto, nella solita accezione che tutta la vita è dialettica, è milizia, quindi rivoluzione. Le altre debolezze sono di più difficile comprensione: esse infatti possono risultare solo da una esatta analisi della composizione sociale italiana, da cui risulta che la grande massa degli intellettuali appartiene a quella borghesia rurale, la cui posizione economica è possibile solo se le masse contadine sono spremute fino alle midolla. Quando dalle parole si dovesse passare ai fatti concreti, questi significherebbero una distruzione radicale della base economica di questi gruppi intellettuali.
Q14 §36 Criteri metodologici. Una manifestazione tipica del dilettantismo intellettuale (e dell’attività intellettuale dei dilettanti) è questa: che nel trattare una quistione si tende ad esporre tutto quello che si sa e non solo ciò che è necessario e importante di un argomento. Si coglie ogni occasione per fare sfoggio dei propri imparaticci, di tutti gli sbrendoli e nastri del proprio bazar; ogni piccolo fatterello è elevato a momento mondiale per poter dare corso alla propria concezione mondiale, ecc. Avviene poi che, siccome si vuol essere originali e non ripetere le cose già dette, ogni altra volta si deve sostenere un gran mutamento nei «fattori» fondamentali del quadro e quindi si cade in stupidaggini d’ogni genere.
Q14 §37 Letteratura popolare. Italia e Francia. Si può forse affermare che tutta la vita intellettuale italiana fino al 1900 (e precisamente fino al formarsi della corrente culturale idealistica Croce‑Gentile) in quanto ha tendenze democratiche, cioè in quanto vuole (anche se non ci riesce sempre) prendere contatto con le masse popolari è semplicemente un riflesso francese, dell’ondata democratica francese che ha avuto origine dalla Rivoluzione del 1789: l’artificiosità di questa vita è nel fatto che in Italia essa non aveva avuto le premesse storiche che invece erano state in Francia. Niente in Italia di simile alla Rivoluzione del 1789 e alle lotte che ne seguirono; tuttavia in Italia si «parlava» come se tali premesse fossero esistite. Ma si capisce che un tale parlare non poteva essere che a fior di labbra. Da tal punto di vista, s’intende il significato «nazionale», seppure poco profondo, delle correnti conservatrici e reazionarie in confronto di quelle democratiche; queste erano grandi «fuochi di paglia», di grande estensione superficiale, quelle erano di poca estensione, ma ben radicate e intense. Se non si studia la cultura italiana fino al 1900 come un fenomeno di provincialismo francese, se ne comprende ben poco. Tuttavia occorre distinguere: c’è misto un sentimento nazionale antifrancese, nell’ammirazione per le cose di Francia: si vive di riflesso e si odia nello stesso tempo. Almeno fra gli intellettuali. Nel popolo i sentimenti «francesi» non sono tali, appaiono come «senso comune», come cose proprie del popolo stesso e il popolo è francofilo o francofobo secondo che viene aizzato o meno dalle forze dominanti. Era comodo far credere che la Rivoluzione del 1789, poiché avvenuta in Francia, era come se avvenuta in Italia, per quel tanto che delle idee francesi era comodo servirsi per guidare le masse; ed era comodo servirsi dell’antigiacobinismo forcaiolo per andare contro la Francia, quando ciò serviva.
Q14 §38 di cultura italiana. 1) La scienza e la cultura. Le correnti filosofiche idealistiche (Croce e Gentile) hanno determinato un primo processo di isolamento degli scienziati (scienze naturali o esatte) dal mondo della cultura. La filosofia e la scienza si sono staccate e gli scienziati hanno perduto molto del loro prestigio. Un altro processo di isolamento si è avuto per il nuovo prestigio dato al cattolicesimo e per il formarsi del centro neoscolastico. Così gli scienziati «laici» hanno contro la religione e la filosofia più diffusa: non può non avvenire un loro imbozzolamento e una «denutrizione» dell’attività scientifica che non può svilupparsi isolata dal mondo della cultura generale. D’altronde: poiché l’attività scientifica è in Italia strettamente legata al bilancio dello Stato, che non è lauto, all’atrofizzarsi di uno sviluppo del «pensiero» scientifico, della teoria, non può per compenso neanche aversi uno sviluppo della «tecnica» strumentale e sperimentale, che domanda larghezza di mezzi e di dotazioni. Questo disgregarsi dell’unità scientifica, del pensiero generale, è sentito: si è cercato di rimediare elaborando, anche in questo campo, un «nazionalismo» scientifico, cioè sostenendo la tesi della «nazionalità» della scienza. Ma è evidente che si tratta di costruzioni esteriori estrinseche, buone per i Congressi e le celebrazioni oratorie, ma senza efficacia pratica. E tuttavia gli scienziati italiani sono valorosi e fanno, con pochi mezzi, sacrifici inauditi e ottengono risultati mirabili. Il pericolo più grande pare essere rappresentato dal gruppo neoscolastico, che minaccia di assorbire molta attività scientifica sterilizzandola, per reazione all’idealismo gentiliano. (È da vedere l’attività organizzatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’efficacia che ha avuto per sviluppare l’attività scientifica e tecnologica, e quella delle sezioni scientifiche dell’Accademia d’Italia).
2) Centralismo nazionale e burocratico. Lo scioglimento delle associazioni regionali avvenuto verso l’agosto del 1932. Vedere quali reazioni ha suscitato nel tempo. Vi si è visto un movimento di sempre più salda coscienza nazionale. Ma l’illazione è giustificata? Confrontare col movimento di centralizzazione avutosi in Francia dopo la Rivoluzione e specialmente con Napoleone. La differenza pare evidente: in Francia si era avuto un movimento nazionale unitario, di cui l’accentramento fu l’espressione burocratica. In Italia non si è avuto lo stesso processo nazionale, anzi la burocrazia accentrata aveva proprio il fine di ostacolare un tale processo. Sarebbe interessante vedere quali forze unitarie nel dopoguerra si siano formate accanto alla burocraziatradizionale: ciò che è da notare è che tali forze, se pure relativamente voli, non hanno un carattere di omogeneità e di permanente sistematicità, ma sono di tipo «burocratico» (burocrazia sindacale, di partito, podestà, ecc.).
3) Scienza. Vedere il volume pubblicato da Gino Bargagli‑Petrucci (presso il Le Monnier) in cui sono raccolti i discorsi di scienziati italiani all’Esposizione di storia delle scienze del 1929. In questo volume è pubblicato un discorso del padre Gemelli che è segno dei tempi per vedere la baldanza che hanno assunto questi fratacci (su questo discorso è da vedere la recensione nell’«Educazione Fascista» del 1932 e l’articolo di Sebastiano Timpanaro nell’«Italia Letteraria» dell’11 settembre e 16 ottobre 1932).
Q14 §39 Letteratura popolare. Manzoni e gli «umili». L’atteggiamento «democratico» del Manzoni verso gli umili (nei Promessi Sposi) in quanto è d’origine «cristiana» e in quanto è da connettere con gli interessi storiografici che il Manzoni aveva derivato dal Thierry e dalle sue teorie sul contrasto tra le razze (conquistatrice e conquistata) divenuto contrasto di classi. Queste teorie del Thierry sono da vedere in quanto sono legate al romanticismo e al suo interesse storico per il Medio Evo e per le origini delle nazioni moderne, cioè nei rapporti tra razze germaniche invaditrici e razze neolatine invase, ecc. (Su questo argomento del «democraticismo» o «popolarismo» del Manzoni vedere altre ). Anche su questo punto dei rapporti tra l’atteggiamento del Manzoni e le teorie del Thierry è da vedere il libro dello Zottoli, Umili e potenti nella poetica di A. Manzoni.
Queste teorie di Thierry nel Manzoni si complicano, o almeno hanno aspetti nuovi nella discussione sul «romanzo storico» in quanto esso rappresenta persone delle «classi subalterne» che «non hanno storia», cioè la cui storia non lascia tracce nei documenti storici del passato. (Questo punto è da connettere con la rubrica «Storia delle classi subalterne», in cui si può fare riferimento alle dottrine del Thierry, che del resto hanno avuto tanta importanza per le origini della storiografia della filosofia della prassi).
Q14 §40 Passato e presente. Ricordare il saggio pubblicato da Gino Doria (nella «Nuova Italia» del 1930 o 1931) in cui si sostiene che la morale e i comportamenti dei re sono unicamente in rapporto agli interessi della dinastia ed in funzione di questa debbono essere giudicati. Il Doria è napoletano ed è da notare come i teorici più ortodossi della monarchia siano sempre stati napoletani (De Meis, per esempio). Il Doria scrisse il saggio in occasione del così detto anno carlalbertino, quando si ridiscusse la figura di Carlo Alberto, ecc., ma forse le sue intenzioni erano più estensive e comprensive. Ma cosa significa la formula del Doria? Non è poi essa una vacua generalità? E corrisponde alla propaganda che è stata fatta per rafforzare l’istituto monarchico e che ha creato l’«ortodossia»? La tesi del Doria è un riflesso della tesi del Maurras, che poi dipende dalla concezione dello «Stato patrimoniale».
Q14 §41 Balzac. (Cfr qualche altra nota: accenni all’ammirazione per Balzac dei fondatori della filosofia della prassi; lettera inedita di Engels in cui questa ammirazione è giustificata criticamente). Confrontare l’articolo di Paolo Bourget, Les idées politiques et sociales de Balzac nelle «Nouvelles Littéraires» dell’8 agosto 1931. Il Bourget comincia col notare come oggi si dà sempre più importanza alle idee di Balzac: «l’école traditionaliste (cioè forcaiola), que nous voyons grandir chaque jour, inscrit son nom à côté de celui de Bonald, de Le Play, de Taine lui même». Invece non era così nel passato. Sainte‑Beuve, nell’articolo dei Lundis consacrati a Balzac dopo la sua morte, non accenna neppure alle sue idee politiche e sociali. Taine, che ammirava lo scrittore di romanzi, gli negò ogni importanza dottrinale. Lo stesso critico cattolico Caro, verso gli inizi del secondo Impero, giudicava futili le idee del Balzac. Flaubert scrive che le idee politiche e sociali di Balzac non valgono la pena di essere discusse: «Il était catholique, légitimiste, propriétaire! – scrive Flaubert – un immense bonhomme, mais de second ordre». Zola scrive: «Rien de plus étrange que ce soutien du pouvoir absolu, dont le talent est essentiellement démocratique et qui a ecrit l’œuvre la plus révolutionnaire». Eccetera.
Si capisce l’articolo del Bourget. Si tratta di trovare in Balzac l’origine del romanzo positivista, ma reazionario, la scienza al servizio della reazione (tipo Maurras), che d’altronde è il destino più esatto del positivismo stabilito dal Comte.
Balzac e la scienza. Cfr la «Prefazione generale» della Commedia umana, dove il Balzac scrive che il naturalista avrà l’onore eterno di aver mostrato che «l’animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou mieux, les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les espèces zoologiques résultent des ces différences… Pénétré de ce système, je vis que la société ressemble à la nature. Ne fait‑elle pas de l’homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d’hommes différents qu’il y a des variétés zoologiques?… Il a donc existé, il existera de tout temps des espèces sociales comme il y a des espèces zoologiques. Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un oisif (!!), un savant, un homme d’Etat, un commerçant, un marin, un poéte, un pauvre (!!), un prêtre, sont aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l’âne, le corbeau, le requin, le veau marin la brebis».
Che Balzac abbia scritto queste cose e magari le prendesse sul serio e immaginasse di costruire tutto un sistema sociale su queste metafore, non fa maraviglia e neanche diminuisce per nulla la grandezza di Balzac artista. Ciò che è notevole è che oggi il Bourget e, come egli dice, la «scuola tradizionalista», si fondi su queste povere fantasie «scientifiche» per costruire sistemi politico‑sociali senza giustificazione di attività artistica.
Partendo da queste premesse il Balzac si pone il problema di «perfezionare al massimo queste specie sociali» e di armonizzarle tra loro, ma siccome le «specie» sono create dall’ambiente, bisognerà «conservare» e organizzare l’ambiente dato per mantenere e perfezionare la specie data. Eccetera. Pare che non avesse torto Flaubert scrivendo che non merita la pena di discutere le idee sociali di Balzac. E l’articolo del Bourget mostra solo quanto sia fossilizzata la scuola tradizionalista francese.
Ma se tutta la costruzione del Balzac è senza importanza come «programma pratico», cioè dal punto di vista da cui l’esamina il Bourget, in essa sono elementi che hanno interesse per ricostruire il mondo poetico del Balzac, la sua concezione del mondo in quanto si è realizzata artisticamente, il suo «realismo» che, pur avendo origini ideologiche reazionarie, di restaurazione, monarchiche, ecc., non perciò è meno realismo in atto. E si capisce l’ammirazione che per il Balzac nutrirono i fondatori della filosofia della prassi: che l’uomo sia tutto il complesso delle condizioni sociali in cui egli si è sviluppato e vive, che per «mutare» l’uomo occorre mutare questo complesso di condizioni è intuito chiaramente dal Balzac. Che «politicamente e socialmente» egli sia un reazionario, appare solo dalla parte extra‑artistica dei suoi scritti (divagazione, prefazioni, ecc.). Che anche questo «complesso di condizioni» o «ambiente» sia inteso «naturalisticamente» è anche vero; infatti il Balzac precede una determinata corrente letteraria francese, ecc.
Q14 §42 Cultura italiana. Si insiste molto sul fatto che sia aumentato il numero dei libri pubblicati. L’Istituto italiano del Libro comunica che la media annuale del decennio 1908‑1918 è stata esattamente di 7300. I calcoli fatti per il 1929 (i più recenti) danno la cifra di 17 718 (libri ed opuscoli; esclusi quelli della Città del Vaticano, di S. Marino, delle colonie e delle terre di lingua italiana non facenti parte del Regno). Pubblicazioni polemiche e quindi tendenziose. Bisognerebbe vedere: 1) se le cifre sono omogenee cioè se si calcola oggi come nel passato, ossia se non è cambiato il tipo dell’unità editoriale base; 2) bisogna tener conto che nel passato la statistica libraria era molto approssimativa e incerta (ciò si osserva per tutte le statistiche, per esempio quella della raccolta del grano; ma specialmente vero per i libri: si può dire che oggi non solo è mutato il tipo di unità calcolata, ma niente sfugge all’accertamento statistico); 3) è da vedere se e come è mutata la composizione organica del complesso librario: è certo che si sono moltiplicate le case editrici cattoliche, per esempio, e quindi la pubblicazione di opericciuole senza nessuna importanza culturale (così si sono moltiplicare le edizioni scolastiche cattoliche, ecc.). In questo calcolo occorrerebbe tener conto delle tirature, e ciò specialmente per i giornali e le riviste.
Si legge meno o più? E chi legge meno o più? Si sta formando una «classe media colta» più numerosa che in passato, che legge di più, mentre le classi popolari leggono molto meno; ciò appare dal rapporto tra libri, riviste e giornali. I giornali sono diminuiti di numero e stampano meno copie; si leggono più riviste e libri (cioè ci sono più lettori di libri e riviste). Confronto tra Italia e altri paesi nei modi di fare la statistica libraria e nella classificazione per gruppi di ciò che si pubblica.
Q14 §43 Nozioni enciclopediche. Riscossa. Deve essere d’origine militare e francese. Il grido di battaglia dell’esercito di Carlo VIII a Fornovo era appunto: «Montoison à la recousse!» Nel linguaggio militare francese «recousse o rescousse» indicava un nuovo attacco e «A la rescousse!» si gridava in battaglia per domandare soccorsi.
Q14 §44 Concordati. Sul concordato del Laterano è da vedere: il libro di Vincenzo Morello Il conflitto dopo la Conciliazione (Bompiani 1931) e la risposta di Egilberto Martire, Ragioni della Conciliazione (Roma, «Rassegna Romana» 1932). Sulla polemica Morello‑Martire è da vedere l’articolo firmato Novus nella «Critica Fascista» del 1° febbraio 1933 (Una polemica sulla conciliazione). Il Morello pone in rilievo quei punti del Concordato in cui lo Stato è venuto meno a se stesso, ha abdicato alla sua sovranità non solo, ma, pare, mette in rilievo come in alcuni punti le concessioni fatte alla Chiesa siano superiori a quelle fatte da altri paesi concordatari. I punti controversi sono principalmente quattro: 1) Il matrimonio; per l’art. 43 del Concordato il matrimonio è disciplinato dal diritto canonico, cioè è applicato nell’ambito dello Stato un diritto estraneo ad esso. Per esso, i cattolici, per un diritto estraneo allo Stato, possono avere annullato il matrimonio, a differenza dei non‑cattolici, mentre «l’essere o non essere cattolici, dovrebbe essere irrilevante agli effetti civili». 2) Per l’art. 5 comma 3°, c’è l’interdizione da alcuni uffici pubblici per i sacerdoti apostati o irretiti da censura; cioè si applica una «pena» del Codice Penale a persone che non hanno commesso, di fronte allo Stato, nessun reato punibile; l’art. 1° del Codice vuole invece che nessun cittadino possa essere punito se non per un fatto espressamente preveduto dalla legge penale come reato. 3) Per il Morello non si vede quali siano le ragioni di utilità per cui lo Stato ha fatto tabula rasa delle leggi eversive, riconoscendo agli enti ecclesiastici e ordini religiosi esistenza giuridica, facoltà di possedere ed amministrare i propri beni. 4) Insegnamento. Esclusione recisa e totale dello Stato dalle scuole ecclesiastiche, e non solo già da quelle che preparano tecnicamente i sacerdoti (cioè esclusione dello Stato dall’insegnamento della teologia, ecc.), ma dall’insegnamento dell’istruzione generale. L’art. 39 del Concordato si riferisce infatti anche alle scuole elementari e medie tenute dal clero in molti seminari, collegi e conventi, delle quali il clero si serve per attrarre fanciulli e giovinetti al sacerdozio e alla vita monastica, ma che in sé non sono ancora specializzate. Questi alunni dovrebbero aver diritto alla tutela dello Stato. Pare che in altri concordati si sia tenuto conto di certe garanzie verso lo Stato per cui anche il clero non sia formato in modo contrario alle leggi e all’ordine nazionale, e precisamente imponendo che per avere molti uffici ecclesiastici è necessario un titolo di studio pubblico (quello che dà adito alle università).
Q14 §45 Letteratura popolare. Manzoni. Adolfo Faggi nel «Marzocco» del 1° novembre 1931 scrive alcune osservazioni sulla sentenza «Vox populi vox Dei» nei Promessi Sposi. La sentenza è citata due volte (secondo il Faggi) nel romanzo: una volta nell’ultimo capitolo ed appare detta da Don Abbondio a proposito del marchese successore di Don Rodrigo: «E poi non vorrà che si dica che è un grand’uomo. Lo dico e lo voglio dire. E anche se io stessi zitto, già non servirebbe a nulla, perché parlan tutti, e vox populi, vox Dei». Il Faggi fa osservare che questo solenne proverbio è impiegato da don Abbondio un po’ enfaticamente, mentre egli si trova in quella felice disposizione d’animo per la morte di don Rodrigo, ecc.; non ha particolare importanza o significato. L’altra volta la sentenza si trova nel cap. XXXI, dove si parla della peste: «Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, voce di Dio?) deridevano gli auguri sinistri, gli avvertimenti minacciosi dei pochi, ecc.». Qui il proverbio è riportato in italiano e in parentesi, con intonazione ironica. Negli Sposi Promessi (cap. III del tomo IV, ediz. Lesca) il Manzoni scrive a lungo sulle idee tenute generalmente per vere in un tempo o in un altro dagli uomini e conchiude che se oggi si possono trovare ridicole le idee diffuse tra il popolo al tempo della peste di Milano, non possiamo sapere se idee odierne non saranno trovate ridicole domani, ecc. Questo lungo ragionamento della prima stesura è riassunto nel testo definitivo nella breve domanda: «Era anche in questo caso voce di Dio?»
Il Faggi distingue tra i casi in cui per il Manzoni la voce del popolo non è in certi casi voce di Dio, da altri in cui può esser tale. Non sarebbe voce di Dio «quando si tratti d’idee o meglio di cognizioni specifiche, che soltanto dalla scienza e dai suoi continui progressi possono essere determinate; ma quando si tratti di quei principii generali e sentimenti comuni per natura a tutti quanti gli uomini, che gli antichi comprendevano nella ben nota espressione di conscentia generis humani». Ma il Faggi non pone molto esattamente la quistione, che non può essere risolta senza riferirsi alla religione del Manzoni, al suo cattolicismo. Così riporta per esempio il famoso parere di Perpetua a don Abbondio, parere che coincide con l’opinione del card. Borromeo. Ma nel caso non si tratta di una quistione morale o religiosa, ma di un consiglio di prudenza pratica, dettato dal senso comune più banale. Che il card. Borromeo si trovi d’accordo con Perpetua non ha quella importanza che sembra al Faggi. Mi pare sia legato al tempo e al fatto che l’autorità ecclesiastica aveva un potere politico e un’influenza; che Perpetua pensi che don Abbondio debba ricorrere all’arcivescovo di Milano, è cosa naturale (serve solo a mostrare come Don Abbondio avesse perduto la testa in quel momento e Perpetua avesse più «spirito di corpo» di lui), come è naturale che Federico Borromeo così parli. Non c’entra la voce di Dio in questo caso. Così non ha molto rilievo l’altro caso: Renzo non crede all’efficienza del voto di castità fatto da Lucia e in ciò si trova d’accordo col padre Cristoforo. Si tratta anche qui di «casistica» e non di morale. Il Faggi scrive che «il Manzoni ha voluto fare un romanzo di umili», ma ciò ha un significato più complesso di ciò che il Faggi mostri di credere. Tra il Manzoni e gli «umili» c’è distacco sentimentale; gli umili sono per il Manzoni un «problema di storiografia», un problema teorico che egli crede di poter risolvere col romanzo storico, col «verosimile» del romanzo storico. Perciò gli umili sono spesso presentati come «macchiette» popolari, con bonarietà ironica, ma ironica. E il Manzoni è troppo cattolico per pensare che la voce del popolo sia voce di Dio: tra il popolo e Dio c’è la chiesa, e Dio non s’incarna nel popolo, ma nella chiesa. Che Dio s’incarni nel popolo può crederlo il Tolstoi, non il Manzoni.
Certo questo atteggiamento del Manzoni è sentito dal popolo e perciò i Promessi Sposi non sono mai stati popolari: sentimentalmente il popolo sentiva il Manzoni lontano da sé e il suo libro come un libro di devozione non come un’epopea popolare.
Q14 §46 I nipotini di padre Bresciani. Parlando di Gioacchino Belli nella prima edizione dell’Ottocento (Vallardi), Guido Mazzoni ne trova una che è impagabile e può servire per caratterizzare gli scrittori di questa rubrica, specialmente Ugo Ojetti. Per il Mazzoni la debolezza di carattere del Belli «si trasformava in un aiuto di prim’ordine alle sue facoltà artistiche, perché lo rendeva più malleabile alle impressioni».
Q14 §47 Caratteri della cultura italiana. Si potrebbero raccogliere, in uno stesso saggio, diverse serie di , scritte partendo da interessi intellettuali diversi, ma che in realtà sono espressione di uno stesso problema fondamentale. Così le sulle quistioni: della lingua, del romanticismo italiano (se sia esistito), del perché la letteratura italiana non sia popolare, dell’esistenza o meno di un teatro italiano, ecc., con le sulle varie interpretazioni che sono state date del moto del Risorgimento fino alle discussioni più recenti sulla «razionalità» e sul significato del presente regime (psicosi di guerra, ecc.). Tutti questi argomenti sono strettamente collegati e sono da connettere come blocco alle discussioni e alle interpretazioni che della passata storia svoltasi nella penisola italiana si ebbero in tutto il secolo XIX e di cui una parte almeno è documentata nel libro del Croce sulla Storia della Storiografia italiana nel secolo XIX (di cui occorrerà vedere l’ultima edizione, specialmente per la parte che riguarda il Volpe, e la sua Italia in cammino, così come occorrerà vedere la prefazione del Volpe alla terza edizione di questo suo libro, in cui si polemizza col Croce. Del Volpe sono poi da vedere tutti gli scritti di storia e di teoria o storia della storia). Che tali polemiche e tanta varietà di interpretazione dei fatti siano state e siano ancora possibili, è fatto di per se stesso molto importante e caratteristico di una determinata situazione politico‑culturale. Non pare che una cosa simile sia avvenuta per nessun altro paese, almeno con tale assiduità, abbondanza e pertinacia. (Si potrebbe forse ricordare per la Francia l’opera del Jullian sull’elemento celtico nella storia francese, sul suo antiromanesimo, ecc., ma è da notare che in Francia stessa il Jullian ha colpito come una stranezza, nonostante le sue doti di erudito e di scrittore. Forse qualcosa di simile si ha in Ispagna, con le discussioni se la Spagna sia Europa o Africa, ecc.; è da vedere questo lato della coltura spagnola).
In questo fenomeno caratteristico italiano sono da distinguere vari aspetti: 1) il fatto che gli intellettuali sono disgregati, senza gerarchia, senza un centro di unificazione e centralizzazione ideologica e intellettuale, ciò che è risultato di una scarsa omogeneità, compattezza e «nazionalità» della classe dirigente; 2) il fatto che queste discussioni sono, in realtà, la prospettiva e il fondamento storico di programmi politici impliciti, che rimangono impliciti, retorici, perché l’analisi del passato non è fatta obbiettivamente, ma secondo pregiudizi letterari o di nazionalismo letterario (anche di antinazionalismo letterario, come nel caso del Montefredini).
Alla serie di quistioni aggiungere: la quistione meridionale (nell’impostazione del Fortunato, per esempio, o del Salvemini, col relativo concetto di «unità»), la quistione siciliana (da vedere Le più belle pagine di Michele Amari raccolte da V. E. Orlando in modo da fare apparire la Sicilia come un «momento» della storia mondiale); la quistione sarda (carte di Arborea, da paragonare col simile tentativo boemo verso il 48, cioè contemporaneamente).
Che la politica nazionale sia «teorizzata» in forme così astratte, dai letterati, senza che a questi teorici corrisponda un gruppo adeguato di tecnici della politica che sappiano porre le quistioni in termini di «effettuabilità», è il carattere più spiccato della situazione politica italiana; gli affari reali sono nelle mani dei funzionari specializzati, uomini indubbiamente di valore e di capacità dal punto di vista tecnico‑professionale burocratico, ma senza legami continuati con l’«opinione pubblica», cioè con la vita nazionale. Si è avuto in Italia qualcosa di simile a ciò che si aveva nella Germania guglielmina, con questa differenza: che nella Germania dietro la burocrazia c’erano gli Junker, una classe sociale sia pure mummificata e mutilata, mentre in Italia una forza di tal genere non esisteva: la burocrazia italiana può essere paragonata alla burocrazia papale, o meglio ancora, alla burocrazia cinese dei mandarini. Essa certamente faceva gli interessi di gruppi ben precisi (in primo luogo gli agrari, poi l’industria protetta, ecc.), ma senza piano e sistema, senza continuità, sulla base, per dirla rapidamente, dello «spirito di combinazione» che era necessario per «armonizzare» le tante contraddizioni della vita nazionale che non si cercò mai di risolvere organicamente e secondo un indirizzo conseguente. Questa burocrazia non poteva non essere specialmente «monarchica»; per cui si può dire che la monarchia italiana è stata essenzialmente una «monarchia burocratica» e il re il primo dei funzionari, nel senso che la burocrazia era la sola forza «unitaria» del paese, permanentemente «unitaria».
Altro problema tipico italiano: il papato, che anch’esso dette origini a interpretazioni dinamiche del Risorgimento che non sono state senza effetto nella coltura nazionale e lo sono anche ora: basta ricordare il giobertismo e la teoria del Primato, che entra anche oggi nel guazzetto ideologico di moda. Occorre ricordare l’atteggiamento dei cattolici in politica, il non expedit e il fatto che nel dopoguerra il Partito Popolare era un partito che ubbidiva a interessi anazionali, una forma paradossale di ultramontanismo poiché il Papato era in Italia e non poteva apparire politicamente come appariva in Francia e in Germania, cioè nettamente fuori dello Stato.
Tutti questi elementi contradditori si sintetizzano nella posizione internazionale del paese, estremamente debole e precaria, senza possibilità di una linea a lunga prospettiva, situazione che ebbe la sua espressione nella guerra del 14 e nel fatto che l’Italia combatté nel campo opposto a quello delle sue alleanze tradizionali.
Altro documento di interpretazione della storia italiana il volume di Nello Quilici, Origine, sviluppo e insufficienza della borghesia italiana (Edizione dei «Nuovi Problemi», Ferrara).
Q14 §48 Passato e presente. Centralismo organico e centralismo democratico. Disciplina. Come deve essere intesa la disciplina, se si intende con questa parola un rapporto continuato e permanente tra governanti e governati che realizza una volontà collettiva? Non certo come passivo e supino accoglimento di ordini, come meccanica esecuzione di una consegna (ciò che però sarà pure necessario in determinate occasioni, come per esempio nel mezzo di un’azione già decisa e iniziata) ma come una consapevole e lucida assimilazione della direttiva da realizzare. La disciplina pertanto non annulla la personalità in senso organico, ma solo limita l’arbitrio e l’impulsività irresponsabile, per non parlare della fatua vanità di emergere. Se si pensa, anche il concetto di «predestinazione» proprio di alcune correnti del cristianesimo non annulla il così detto «libero arbitrio» nel concetto cattolico, poiché l’individuo accetta «volente» il volere divino (così pone la quistione il Manzoni nella Pentecoste) al quale, è vero, non potrebbe contrastare, ma a cui collabora o meno con tutte le sue forze morali. La disciplina pertanto non annulla la personalità e la libertà: la quistione della «personalità e libertà» si pone non per il fatto della disciplina, ma per l’«origine del potere che ordina la disciplina». Se questa origine è «democratica», se cioè l’autorità è una funzione tecnica specializzata e non un «arbitrio» o una imposizione estrinseca ed esteriore, la disciplina è un elemento necessario di ordine democratico, di libertà. Funzione tecnica specializzata sarà da dire quando l’autorità si esercita in un gruppo omogeneo socialmente (o nazionalmente); quando si esercita da un gruppo su un altro gruppo, la disciplina sarà autonoma e libera per il primo, ma non per il secondo.
In caso di azione iniziata o anche già decisa (senza che ci sia il tempo di rimettere utilmente in discussione la decisione) la disciplina può anche apparire estrinseca e autoritaria. Ma altri elementi allora la giustificano. È osservazione di senso comune che una decisione (indirizzo) parzialmente sbagliata può produrre meno danno di una disubbidienza anche giustificata con ragioni generali, poiché ai danni parziali dell’indirizzo parzialmente sbagliato si cumulano gli altri danni della disubbidienza e del duplicarsi degli indirizzi (ciò si è verificato spesso nelle guerre, quando dei generali non hanno ubbidito a ordini parzialmente erronei e pericolosi, provocando catastrofi peggiori e spesso insanabili).
Q14 §49 Machiavelli. Lo Stato. Il prof. Giulio Miskolczy, direttore dell’Accademia ungherese di Roma, nella «Magyar Szemle» (articolo riportato nella «Rassegna della Stampa Estera» del 3‑10 gennaio 1933) scrive che in Italia il «Parlamento, che prima era, per così dire, fuori dello Stato, è rimasto un collaboratore prezioso, ma è stato inserito nello Stato ed ha subito un cambiamento essenziale nella sua composizione ecc.» Che il Parlamento possa essere «inserito» nello Stato è una scoperta di scienza e di tecnica politica degna dei Cristoforo Colombo del forcaiolismo moderno. Tuttavia l’affermazione è interessante, per vedere come concepiscono lo Stato praticamente molti uomini politici. E in realtà è da porsi la domanda: i Parlamenti fanno parte della struttura degli Stati, anche nei paesi dove pare che i Parlamenti abbiano il massimo di efficienza, oppure che funzione reale hanno? E in che modo, se la risposta è positiva, essi fanno parte dello Stato, e in che modo esplicano la loro funzione particolare? Tuttavia: l’esistenza dei Parlamenti, anche se essi organicamente non fanno parte dello Stato, è senza significato statale? E quale fondamento hanno le accuse che si fanno al parlamentarismo e al regime dei partiti, che è inseparabile dal parlamentarismo? (fondamento obbiettivo, s’intende, cioè legato al fatto che l’esistenza dei Parlamenti, di per sé, ostacola e ritarda l’azione tecnica del governo). Che il regime rappresentativo possa politicamente «dar noia» alla burocrazia di carriera s’intende; ma non è questo il punto. Il punto è se il regime rappresentativo e dei partiti invece di essere un meccanismo idoneo a scegliere funzionari eletti che integrino ed equilibrino i burocratici nominati, per impedire ad essi di pietrificarsi, sia divenuto un inciampo e un meccanismo a rovescio e per quali ragioni. Del resto, anche una risposta affermativa a queste domande non esaurisce la quistione: perché anche ammesso (ciò che è da ammettere) che il parlamentarismo è divenuto inefficiente e anzi dannoso, non è da concludere che il regime burocratico sia riabilitato ed esaltato. È da vedere se parlamentarismo e regime rappresentativo si identificano e se non sia possibile una diversa soluzione sia del parlamentarismo che del regime burocratico, con un nuovo tipo di regime rappresentativo.
Q14 §50 Passato e Presente. Il proverbio: «fratelli, coltelli». È poi così strano e irrazionale che le lotte e gli odi diventino tanto più accanite e grandi quanto più due elementi «sembrano» vicini e portati dalla «forza delle cose» a intendersi e a collaborare? Non pare. Almeno «psicologicamente» il fatto si spiega. Infatti uno non si può attendere nulla di buono da un nemico o da un avversario; invece ha il diritto di attendersi e di fatto si attende unità e collaborazione da chi gli sta vicino, da chi è legato con lui da vincoli di solidarietà o di qualsiasi genere. Infatti, non solo il proverbio «fratelli, coltelli», si applica ai legami di affetto, ma anche ai legami costituiti da obblighi legali. Che ti faccia del male chi ti è nemico o anche solo indifferente, non ti colpisce, ti rimane «indifferente», non suscita reazioni sentimentali di esasperazione. Ma se chi ti fa del male aveva il dovere morale di aiutarti (nelle associazioni volontarie) o l’obbligo legale di fare diversamente (nelle associazioni di tipo statale) ciò ti esaspera e aumenta il male, poiché ti rende difficile prevedere l’avvenire, ti impedisce di fare progetti e piani, di fissarti una linea di condotta.
È certo che ogni uomo cerca di fissare quanti più elementi è possibile di riferimenti certi nella sua condotta, di limitare il «casuale» e la «forza maggiore»; nello sforzo di questa limitazione entra in calcolo la solidarietà, la parola data, le promesse fatte da altri, che dovrebbero portare a certi fatti certi. Se essi vengono a mancare per incuria, per negligenza, per imperizia, per slealtà, al male che ne risulta si aggiunge l’esasperazione morale che è tipica di questo ordine di relazioni. Se un nemico ti arreca un danno e te ne lamenti, sei uno stupido, perché è proprio dei nemici di arrecare danni. Ma se un amico ti arreca danno, è giustificato il tuo risentimento. Così se un rappresentante della legge commette un’illegalità la reazione è diversa che se l’illegalità la commette un bandito. Perciò mi pare che non sia da maravigliarsi dell’accanimento nelle lotte e negli odi tra vicini (per esempio tra due partiti così detti affini); il contrario sarebbe sorprendente cioè l’indifferenza e l’insensibilità morale, come avviene negli urti tra nemici aperti e dichiarati.
Q14 §51 Machiavelli. Morale e politica. Si verifica una lotta. Si giudica della «equità» e della «giustizia» delle pretese delle parti in conflitto. Si giunge alla conclusione che una delle parti non ha ragione, che le sue pretese non sono eque, o addirittura che esse mancano di senso comune. Queste conclusioni sono il risultato di modi di pensare diffusi, popolari, condivisi dalla stessa parte che in tal modo viene colpita da biasimo. Eppure questa parte continua a sostenere di «aver ragione», di essere nell’«equo» e ciò che più conta, continua a lottare, facendo dei sacrifici, ciò che significa che le sue convinzioni non sono superficiali e a fior di labbra, non sono ragioni polemiche, per salvar la faccia, ma realmente profonde e operose nelle coscienze. Significherà che la quistione è mal posta e mal risolta. Che i concetti di equità e di giustizia sono puramente formali. Infatti può avvenire che di due parti in conflitto, ambedue abbiano ragione, «così stando le cose», e una appaia aver più ragione dell’altra «così stando le cose», ma non abbia ragione «se le cose dovessero mutare». Ora appunto in un conflitto ciò che occorre valutare non sono le cose così come stanno, ma il fine che le parti in conflitto si propongono col conflitto stesso; e come questo fine, che non esiste ancora come realtà effettuale e giudicabile, potrà essere giudicato? E da chi potrà essere giudicato? Il giudizio stesso non diventerà un elemento del conflitto, cioè non sarà niente altro che una forza del giuoco a favore o a danno di una o dell’altra parte?
In ogni caso si può dire: 1) che in un conflitto ogni giudizio di moralità è assurdo perché esso può essere fatto sui dati di fatto esistenti che appunto il conflitto tende a modificare; 2) che l’unico giudizio possibile è quello «politico» cioè di conformità del mezzo al fine (quindi implica una identificazione del fine o dei fini graduati in una scala successiva di approssimazione). Un conflitto è «immorale» in quanto allontana dal fine o non crea condizioni che approssimano al fine (cioè non crea mezzi più conformi al raggiungimento del fine) ma non è «immorale» da altri punti di vista «moralistici». Così non si può giudicare l’uomo politico dal fatto che esso è o meno onesto, ma dal fatto che mantiene o no i suoi impegni (e in questo mantenimento può essere compreso l’«essere onesto», cioè l’essere onesto può essere un fattore politico necessario, e in generale lo è, ma il giudizio è politico e non morale), viene giudicato non dal fatto che opera equamente, ma dal fatto che ottiene o no dei risultati positivi o evita un male e in questo può essere necessario l’«operare equamente», ma come mezzo politico e non come giudizio morale.
Q14 §52 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. Nella «Cultura» dell’ottobre‑dicembre 1932 (pp. 846 sgg.) Luigi Salvatorelli scrive di Joseph Turmel recensendo questi due libri: 1) Felix Sartiaux, Joseph Turmel, prêtre historien des dogmes, Paris, Rieder, 1931, pp. 295; 2) J. Turmel, Histoire des dogmes, I, Le péché originel. La rédemption, Paris, Rieder, 1931.
Il libro del Sartiaux è indispensabile per la valutazione del caso Turmel. Secondo il Salvatorelli, il Turmel non sarebbe mai stato un modernista, in quanto non avrebbe mai «concepito l’idea di una trasformazione della chiesa e del domma». E qui si pone il problema, per l’esatta compilazione di questa rubrica, di che cosa debba intendersi per modernista.
È evidente che non esiste un modello fisso e sempre facilmente identificabile del «modernista» e del « modernismo», come non esiste per ogni «‑ista» e «‑ismo». Si è trattato di un movimento complesso e molteplice, con varie accezioni: 1) quella che di se stessi davano i modernisti; 2) quella che dei modernisti davano i loro avversari, che certo non coincidevano. Si può dire che del modernismo esistevano diverse manifestazioni: 1) quella politico‑ sociale, quindi favorevole al socialismo riformista e alla democrazia (questa manifestazione è forse quella che più ha contribuito a suscitare la lotta da parte dei cattolici integrali, legati strettamente alle classi più reazionarie e specialmente alla nobiltà terriera e ai latifondisti in generale, come mostra l’esempio francese dell’Action Française e l’esempio italiano del così detto «Centro cattolico») ossia genericamente alle correnti liberali; 2) quella «scientifico‑religiosa», cioè in sostegno di un nuovo atteggiamento verso il «dogma» e la «critica storica» in confronto della tradizione ecclesiastica, quindi tendenza a una riforma intellettuale della Chiesa. Su questo terreno la lotta tra modernisti e cattolici integrali fu meno aspra, anzi, secondo i gesuiti, ci fu spesso alleanza e collusione tra le due forze, cioè le riviste cattoliche integrali pubblicarono scritti dei modernisti (secondo la «Civiltà cattolica», la rivista di Mons. Benigni pubblicò spesso scritti del Buonaiuti contro i gesuiti. Ciò dietro le quinte, naturalmente, perché sulla scena la lotta doveva presentarsi specialmente, anzi unicamente, come religiosa; ciò che non toglie che i cattolici integrali appoggiassero un ateo dichiarato come il Maurras e che per il Maurras la quistione non potesse essere che solamente politica e sociale.
Per i gesuiti Turmel era ed è un modernista in senso «scientifico» (sebbene il Turmel realmente sia un ateo, cioè completamente fuori dal campo religioso, nella sua coscienza, sebbene continui ad essere «prete» per ragioni subordinate, ciò che pare sia un caso abbastanza comune nel clero come appare dal libro del Sartiaux o dalle Memorie del Loisy).
Ciò che importa qui notare è che sia il modernismo, sia il gesuitismo, sia l’integralismo hanno significati più vasti che non siano quelli strettamente religiosi: sono «partiti» nell’«impero assoluto internazionale» che è la Chiesa Romana ed essi non possono evitare di porre in forma religiosa problemi che spesso sono puramente mondani, di «dominio».
Q14 §53 Machiavelli. La forza dei partiti agrari. Uno dei fenomeni caratteristici dell’epoca moderna è questo: che nei parlamenti, o almeno in una serie di essi, i partiti agrari hanno una forza relativa che non corrisponde alla loro funzione storica, sociale, economica. Ciò è dovuto al fatto che nelle campagne si è mantenuto un blocco di tutti gli elementi della produzione agraria, blocco che spesso è guidato dalla parte più retriva di questi elementi, mentre nelle città e nelle popolazioni di tipo urbano, già da alcune generazioni, un blocco simile si è disciolto, se pure è mai esistito (poiché non poteva esistere, non si allargava il suffragio elettorale). Così avviene che in paesi eminentemente industriali, dato il disgregarsi dei partiti medi, gli agrari abbiano il sopravvento «parlamentare» e impongano indirizzi politici «antistorici». È da fissare perché questo avvenga e se non ne siano responsabili i partiti urbani e il loro corporativismo o gretto economismo.
Q14 §54 Passato e Presente. Oltre al gettito delle imposte (i redditi patrimoniali sono trascurabili) i governi hanno a loro disposizione le grandi somme rappresentate dal movimento delle assicurazioni, che spesso sono imponenti. È da vedere se attraverso le assicurazioni non si riesca a imporre nuove tasse. Vedere quanto costa l’assicurazione e se essa è «pagata» con maggior o minore facilità e subito o con ritardo. Se, rendendola più a buon prezzo, potrebbe diffondersi maggiormente, quali classi sono assicurate e quali escluse; l’assicurazione è una forma di risparmio, anzi la più tipica e popolare. Come lo Stato reintegra le somme che si fa passare dagli istituti di assicurazione? Con buoni del tesoro o con debito pubblico? In ogni modo, il governo ha la possibilità di spendere senza il controllo del Parlamento. È escluso un fallimento o difficoltà delle assicurazioni? Le assicurazioni sono organizzate come una specie di gioco del lotto: si calcola che sempre ci sarà guadagno e ingente. Errore: il guadagno dovrebbe essere ridotto ai margini del calcolo delle probabilità attuarie. Inoltre: i capitali ingenti a disposizione dell’assicurazione dovrebbero avere investimenti sicuri, certo, e di tutto riposo, ma produttivi in senso più elastico che non siano gli investimenti di Stato. Come lo Stato, attraverso l’obbligo della conversione in titoli dei patrimoni di una serie di enti specialmente di beneficenza, sia riuscito a espropriare parti voli del patrimonio dei poveri: esempio il Collegio delle Province di Torino. Le conversioni della rendita e le inflazioni, anche se a lungo intervallo, sono catastrofiche per tali enti e li distruggono completamente.
Q14 §55 Azione Cattolica. Don ErnestoVercesi ha iniziato la pubblicazione di un’opera, I papi del secolo XIX di cui è uscito il primo volume su Pio VII (pp. 340, Torino, Società Editrice Internazionale, L. 12).
Per uno studio dell’Azione Cattolica è necessario studiare la storia generale del Papato e della sua influenza nella vita politica e culturale nel secolo XIX (forse addirittura dal tempo delle monarchie illuminate, del giuseppinismo, ecc., che è la «prefazione» alla limitazione della Chiesa nella società civile e politica). Il libro del Vercesi è anche scritto contro il Croce e la sua Storia d’Europa. Il succo del libro del Vercesi pare sia riassunto in queste parole: «Il secolo XIX attaccò il cristianesimo nei suoi aspetti più diversi, sul terreno politico, religioso, sociale, culturale, storico, filosofico, ecc. Il risultato definitivo fu che al tramonto del secolo XIX il cristianesimo in genere, il cattolicismo romano in ispecie, era più forte, più robusto che all’alba dello stesso secolo. È questo un fatto che non può essere contestato dagli storici imparziali».
Che possa essere «contestato» risulta anche solo da questo fatto: che il cattolicismo è diventato un partito fra gli altri, è passato dal godimento incontestato di certi diritti, alla difesa di essi e alla rivendicazione di essi in quanto perduti. Che sotto certi aspetti la Chiesa abbia rinforzato certe sue organizzazioni è certo incontestabile, che sia più concentrata, che abbia stretto le file, che abbia fissato meglio certi principii e certe direttive, ma questo significa appunto un suo minore influsso nella società e quindi la necessità della lotta e di una più strenua milizia. È anche vero che molti Stati non lottano più con la Chiesa, ma perché vogliono servirsene e vogliono subordinarla ai propri fini.
Si potrebbe fare un elenco di attività specifiche in cui la Chiesa conta molto poco e si è rifugiata in posizioni secondarie; per alcuni aspetti, cioè dal punto di vista della credenza religiosa, è poi vero che il cattolicismo si è ridotto in gran parte a una superstizione di contadini, di ammalati, di vecchi e di donne. Nella filosofia cosa conta oggi la chiesa? In quale Stato il tomismo è filosofia prevalente tra gli intellettuali? E socialmente, dove la chiesa dirige e padroneggia con la sua autorità le attività sociali? Appunto l’impulso sempre maggiore dato all’Azione Cattolica dimostra che la Chiesa perde terreno, sebbene avvenga che ritirandosi si concentri e opponga maggiore resistenza e «sembri» più forte (relativamente).
Q14 §56 Cultura italiana. Servizi pubblici intellettuali: oltre alla scuola, nei suoi vari gradi, quali altri servizi non possono essere lasciati all’iniziativa privata, ma, in una società moderna, devono essere assicurati dallo Stato e dagli enti locali (comuni e province)? Il teatro, le biblioteche, i musei di vario genere, le pinacoteche, i giardini zoologici, gli orti botanici, ecc. È da fare una lista di istituzioni che devono essere considerate di utilità per l’istruzione e la cultura pubblica e che tali sono infatti considerate in una serie di Stati, le quali non potrebbero essere accessibili al grande pubblico (e si ritiene, per ragioni nazionali, devono essere accessibili) senza un intervento statale. È da osservare che proprio questi servizi sono da noi trascurati quasi del tutto; tipico esempio le biblioteche e i teatri. I teatri esistono in quanto sono un affare commerciale: non sono considerati servizio pubblico. Data la scarsezza del pubblico teatrale e la mediocrità delle città, in decadenza.
In Italia invece abbondanti le opere pie e i lasciti di beneficenza: forse più che ogni altro paese. E dovuti all’iniziativa privata. È vero che male amministrati e mal distribuiti. (Questi elementi sono da studiare come nessi nazionali tra governanti e governati, come fattori di egemonia. Beneficenza elemento di «paternalismo»; servizi intellettuali elementi di egemonia, ossia di democrazia in senso moderno).
Q14 §57 Passato e presente. Elementi della crisi economica. Nella pubblicità della «Riforma sociale» le cause «più caratteristiche e gravi» della crisi sono elencate come segue: 1) alte imposte; 2) consorzi industriali; 3) sindacati operai; 4) salvataggi; 5) vincoli; 6) battaglie per il prodotto nazionale; 7) contingentamento; 8) debiti interalleati; 9) armamenti; 10) protezionismo.
Appare che alcuni elementi sono simili, sebbene siano elencati partitamente, come cause specifiche. Altri non sono elencati, esempio le proibizioni all’emigrazione. Mi pare che facendo un’analisi si dovrebbe incominciare dall’elencare gli impedimenti posti dalle politiche nazionali (o nazionalistiche) alla circolazione: 1) delle merci; 2) dei capitali; 3) degli uomini (lavoratori e fondatori di nuove industrie e nuove aziende commerciali). Che non si parli da parte dei liberali degli ostacoli posti alla circolazione degli uomini è sintomatico, poiché nel regime liberale tutto si tiene e un ostacolo ne crea una serie di altri. Se si ritiene che gli ostacoli alla circolazione degli uomini sono «normali», ossia giustificabili, ossia dovuti a «forza maggiore», significa che tutta la crisi è «dovuta a forza maggiore», è «strutturale» e non di congiuntura e non può essere superata che costruendo una nuova struttura, che tenga conto delle tendenze insite nella vecchia struttura e le domini con nuove premesse.
La premessa maggiore in questo caso è il nazionalismo, che non consiste solo nel tentativo di produrre nel proprio territorio tutto ciò che vi si consuma (il che significa che tutte le forze sono indirizzate nella previsione dello stato di guerra), ciò che si esprime nel protezionismo tradizionale, ma nel tentativo di fissare le principali correnti di commercio con determinati paesi, o perché alleati (perché quindi li si vuol sostenere e li si vuol foggiare in un modo più acconcio allo stato di guerra) o perché li si vuole stroncare già prima della guerra militare (e questo nuovo tipo di politica economica è quello dei «contingentamenti» che parte dall’assurdo che tra due paesi vi debba essere «bilancia pari» negli scambi, e non che ogni paese può bilanciare alla pari solo commerciando con tutti gli altri paesi indistintamente).
Tra gli elementi di crisi fissati dalla Riforma Sociale non tutti sono accettabili senza critica; per esempio… «le alte imposte». Esse sono dannose quando sono rivolte a mantenere una popolazione sproporzionata alle necessità amministrative, non quando servono ad anticipare capitali che solo lo Stato può anticipare, anche se questi capitali non sono immediatamente produttivi (e non accenna alla difesa militare). La così detta politica dei «lavori pubblici» non è criticabile in sé, ma solo in condizioni date: cioè sono criticabili i lavori pubblici inutili o anche lussuosi, non quelli che creano le condizioni per un futuro incremento dei traffici o evitano danni certi (alluvioni per esempio) ed evitabili, senza che individualmente nessuno possa esser spinto (abbia il guadagno) a sostituire lo Stato in questa attività. Così dicasi dei «consorzi industriali»: sono criticabili i consorzi «artificiosi» non quelli che nascono per la forza delle cose; se ogni «consorzio» è dannabile, allora il sistema è dannabile, perché il sistema, anche senza spinte artificiali, cioè senza lucri prodotti dalla legge, spinge a creare consorzi, cioè a diminuire le spese generali.
Così è dei «sindacati operai» che non nascono artificialmente, anzi nascono o sono nati nonostante tutte le avversità e gli ostacoli di legge (e non solo di legge, ma dell’attività criminosa privata impunita dalla legge). Gli elementi elencati dalla Riforma Sociale mostrano così la debolezza degli economisti liberali di fronte alla crisi: 1) essi tacciono alcuni elementi; 2) mescolano arbitrariamente gli elementi considerati, non distinguendo quelli che sono «necessari» dagli altri, ecc.
Q14 §58 Passato e presente. Perché gli uomini sono irrequieti? Da che viene l’irrequietezza? Perché l’azione è «cieca», perché si fa per fare. Intanto non è vero che irrequieti siano solo gli «attivi» ciecamente: avviene che l’irrequietezza porta all’immobilità: quando gli stimoli all’azione sono molti e contrastanti, l’irrequietezza appunto si fa «immobilità». Si può dire che l’irrequietezza è dovuta al fatto che non c’è identità tra teoria e pratica, ciò che ancora vuol dire che c’è una doppia ipocrisia: cioè si opera mentre nell’operare c’è una teoria o giustificazione implicita che non si vuole confessare, e si «confessa» ossia si afferma una teoria che non ha una corrispondenza nella pratica. Questo contrasto tra ciò che si fa e ciò che si dice produce irrequietezza, cioè scontentezza, insoddisfazione. Ma c’è una terza ipocrisia: all’irrequietezza si cerca una causa fittizia, che non giustificando e non spiegando, non permette di vedere quando l’irrequietezza stessa finirà. Ma la quistione così posta è semplificata.
Nella realtà le cose sono più complesse. Intanto occorre tener conto che nella realtà gli uomini d’azione non coincidono con gli intellettuali e inoltre che esistono i rapporti tra generazioni anziane e giovani. Le responsabilità maggiori in questa situazione sono degli intellettuali e degli intellettuali più anziani. L’ipocrisia maggiore è degli intellettuali e degli intellettuali anziani. Nella lotta dei giovani contro gli anziani, sia pure nelle forme caotiche del caso, c’è il riflesso di questo giudizio di condanna, che è ingiusto solo nella forma. In realtà gli anziani «dirigono» la vita, ma fingono di non dirigere, di lasciare ai giovani la direzione, ma anche la «finzione» ha importanza in queste cose. I giovani vedono che i risultati delle loro azioni sono contrari alle loro aspettative, credono di «dirigere» (o fingono di credere) e diventano tanto più irrequieti e scontenti. Ciò che aggrava la situazione è che si tratta di una crisi di cui si impedisce che gli elementi di risoluzione si sviluppino con la celerità necessaria; chi domina non può risolvere la crisi, ma ha il potere di impedire che altri la risolva, cioè ha solo il potere di prolungare la crisi stessa. Candido forse potrebbe dire che ciò è appunto necessario perché gli elementi reali della soluzione si preparino e si sviluppino, dato che la crisi è talmente grave e domanda mezzi così eccezionali, che solo chi ha visto l’inferno può decidersi ad impiegarli senza tremare ed esitare.
Q14 §59 Giustificazione delle autobiografie. Una delle giustificazioni può essere questa: aiutare altri a svilupparsi secondo certi modi e verso certi sbocchi. Spesso le autobiografie sono un atto di orgoglio: si crede che la propria vita sia degna di essere narrata perché «originale», diversa dalle altre, perché la propria personalità è originale, diversa dalle altre, ecc. L’autobiografia può essere concepita «politicamente». Si sa che la propria vita è simile a quella di mille altre vite, ma che per un «caso» essa ha avuto uno sbocco che le altre molte non potevano avere e non ebbero di fatto. Raccontando si crea questa possibilità, si suggerisce il processo, si indica lo sbocco. L’autobiografia sostituisce quindi il «saggio politico» o «filosofico»: si descrive in atto ciò che altrimenti si deduce logicamente. È certo che l’autobiografia ha un grande valore storico, in quanto mostra la vita in atto e non solo come dovrebbe essere secondo le leggi scritte o i principii morali dominanti.
Q14 §60 Giornalismo. Almanacchi. Poiché il giornalismo è stato considerato, nelle ad esso dedicate, come esposizione di un gruppo che vuole, attraverso diverse attività pubblicistiche, diffondere una concezione integrale del mondo, si può prescindere dalla pubblicazione di un almanacco? L’almanacco è, in fondo, una pubblicazione periodica annuale, in cui, anno per anno, si esamina l’attività storica complessa di un anno da un certo punto di vista. L’almanacco è il «minimo» di «pubblicità» periodica che si può dare alle proprie idee e ai propri giudizi sul mondo e la sua varietà mostra quanto nel gruppo si sia venuto specializzando ogni singolo momento di tale storia, così come la organicità mostra la misura di omogeneità che il gruppo è venuto acquistando. Certo, per la diffusione, occorre che l’almanacco tenga conto di determinati bisogni del gruppo di compratori cui si rivolge, gruppo che non può, spesso, spendere due volte, per uno stesso bisogno. Occorrerà pertanto scegliere il contenuto: 1) quelle parti che rendono inutile l’acquisto di altro almanacco; 2) quella parte per cui si vuole influire sui lettori per indirizzarli secondo un senso prestabilito. La prima parte sarà ridotta al minimo: a quanto basta per soddisfare il bisogno dato. La seconda parte insisterà su quegli argomenti che si ritengono di maggior peso educativo e formativo.
Q14 §61 Critica letteraria. Sincerità (o spontaneità) e disciplina. La sincerità (o spontaneità) è sempre un pregio e un valore? È un pregio e un valore se disciplinata. Sincerità (e spontaneità) significa massimo di individualismo, ma anche nel senso di idiosincrasia (originalità in questo caso è uguale a idiotismo). L’individuo è originale storicamente quando dà il massimo di risalto e di vita alla «socialità», senza cui egli sarebbe un «idiota» (nel senso etimologico, che però non si allontana dal senso volgare e comune). C’è dell’originalità, della personalità, della sincerità un significato romantico, e questo significato è giustificato storicamente in quanto nacque in opposizione con un certo conformismo essenzialmente «gesuitico»: cioè un conformismo artificioso, fittizio, creato superficialmente per gli interessi un piccolo gruppo o cricca, non di una avanguardia. C’è conformismo «razionale» cioè rispondente alla necessità, al minimo sforzo per ottenere un risultato utile e la disciplina di tale conformismo è da esaltare e promuovere, è da fare diventare «spontaneità» o «sincerità». Conformismo significa poi niente altro che «socialità», ma piace impiegare la parola «conformismo» appunto per urtare gli imbecilli. Ciò non toglie la possibilità di formarsi una personalità e di essere originali, ma rende più difficile la cosa.
È troppo facile essere originali facendo il contrario di ciò che fanno tutti; è una cosa meccanica. È troppo facile parlare diversamente dagli altri, essere neolalici, il difficile è distinguersi dagli altri senza perciò fare delle acrobazie. Avviene proprio oggi che si cerca una originalità e personalità a poco prezzo. Le carceri e i manicomi sono pieni di uomini originali e di forte personalità.
Battere l’accento sulla disciplina, sulla socialità, e tuttavia pretendere sincerità, spontaneità, originalità, personalità: ecco ciò che è veramente difficile e arduo.
Né si può dire che il conformismo è troppo facile e riduce il mondo a un convento. Intanto: qual è il «vero conformismo», cioè qual è la condotta «razionale» più utile, più libera in quanto ubbidisce alla «necessità»? Cioè quale è la «necessità»? Ognuno è portato a far di sé l’archetipo della «moda», della «socialità» e a porsi come «esemplare». Pertanto la socialità, il conformismo, è il risultato di una lotta culturale (e non solo culturale), è un dato «oggettivo» o universale, così come non può non essere oggettiva e universale la «necessità» su cui si innalza l’edificio della libertà. Libertà e arbitrio, ecc.
Nella letteratura (arte) contro la sincerità e spontaneità si trova il meccanismo o calcolo, che può essere un falso conformismo, una falsa socialità, cioè l’adagiarsi nelle idee fatte e abitudinarie.
Ricordare l’esempio classico di Nino Berrini che «scheda» il passato e cerca l’originalità nel fare ciò che non appare nelle schede. Principii del Berrini per il teatro: 1) lunghezza del lavoro: fissare la media della lunghezza, stabilendola su quei lavori che hanno avuto successo; 2) studio dei finali. Quali finali hanno avuto successo e strappato l’applauso? 3) studio delle combinazioni: per esempio nel dramma sessuale borghese, marito, moglie, amante, vedere quali combinazioni sono più sfruttate, e per esclusione «inventare» nuove combinazioni, meccanicamente trovate. Così il Berrini aveva trovato che un dramma non deve avere più di 50 000 parole, cioè non deve durare più di un tanto tempo. Ogni atto o ogni scena principale deve culminare in un modo dato e questo modo è studiato sperimentalmente, secondo una media di quei sentimenti e di quegli stimoli che tradizionalmente hanno avuto successo, ecc. Con questi criteri è certo che non si possono avere catastrofi commerciali. Ma è questo «conformismo», o «socialità», nel senso detto? Certo no. È un adagiarsi nel già esistente.
La disciplina è anche uno studio del passato, in quanto il passato è elemento del presente e del futuro, ma non elemento «ozioso», ma necessario, in quanto è linguaggio, cioè elemento di «uniformità» necessaria, non di uniformità «oziosa», impigrita.
Q14 §62 Giornalismo. I lettori. I lettori devono essere considerati da due punti di vista principali: 1) come elementi ideologici, «trasformabili» filosoficamente, capaci, duttili, malleabili alla trasformazione; 2) come elementi «economici», capaci di acquistare le pubblicazioni e di farle acquistare ad altri. I due elementi, nella realtà, non sono sempre distaccabili, in quanto l’elemento ideologico è uno stimolo all’atto economico dell’acquisto e della diffusione. Tuttavia, occorre nel costruire un piano editoriale, tenere distinti i due aspetti, perché i calcoli siano realisti e non secondo i propri desideri. D’altronde, nella sfera economica, le possibilità non corrispondono alla volontà e all’impulso ideologico e pertanto occorre predisporre perché sia data la possibilità dell’acquisto «indiretto», cioè compensato con servizi (diffusione). Un’impresa editoriale pubblica tipi diversi di riviste e libri, graduati secondo livelli diversi di cultura. È difficile stabilire quanti «clienti» possibili esistano di ogni livello. Occorre partire dal livello più basso e su questo si può stabilire il piano commerciale «minimo», cioè il preventivo più realistico, tenendo conto tuttavia che l’attività può modificare (e deve modificare) le condizioni di partenza non solo nel senso che la sfera della clientela può (deve) essere allargata, ma che può (deve) determinarsi una gerarchia di bisogni da soddisfare e quindi di attività da svolgere.
È osservazione ovvia che le imprese finora esistite si sono burocratizzate, cioè non hanno stimolato i bisogni e organizzato il loro soddisfacimento, per cui è spesso avvenuto che l’iniziativa individuale caotica ha dato migliori frutti dell’iniziativa organizzata. La verità era che in questo secondo caso non esisteva «iniziativa» e non esisteva «organizzazione» ma solo burocrazia e andazzo fatalistico. Spesso la così detta organizzazione invece di essere un potenziamento di sforzi era un narcotico, un deprimente, addirittura un ostruzionismo o un sabotaggio. D’altronde non si può parlare di azienda giornalistica ed editoriale seria se manca questo elemento: l’organizzazione del cliente della vendita, che essendo un cliente particolare (almeno nella sua massa) ha bisogno di una organizzazione particolare, strettamente legata all’indirizzo ideologico della «merce» venduta. È osservazione comune che in un giornale moderno il vero direttore è il direttore amministrativo e non quello redazionale.
Q14 §63 Argomenti di cultura. Come studiare la storia? Ho letto l’osservazione dello storico inglese Seeley il quale faceva notare che, a suo tempo, la storia dell’indipendenza americana attirò meno attenzione della battaglia di Trafalgar, degli amori di Nelson, degli episodi della vita di Napoleone, ecc. Eppure da quei fatti dovevano uscire conseguenze di grande portata per la storia mondiale: l’esistenza degli Stati Uniti come potenza mondiale non è certo piccola cosa nello svolgersi degli avvenimenti degli ultimi anni. Come fare dunque nello studiare la storia? Ci si dovrebbe fermare sui fatti che sono fecondi di conseguenze? Ma nel momento in cui tali fatti nascono come si fa a sapere della loro fecondità avvenire? La quistione è realmente irrisolvibile. Nella affermazione del Seeley si trova implicita la rivendicazione di una storia obbiettiva, in cui l’obbiettività è concepita come nesso di causa ed effetto. Ma quanti fatti non solo sfuggono, ma sono trascurati dagli storici e dall’interesse dei lettori, che obbiettivamente sono importanti?
La lettura dei libri dello Wells sulla storia mondiale richiama a questa trascuratezza e dimenticanza. In realtà ci ha finora interessato la storia europea e abbiamo chiamato «storia mondiale» quella europea con le sue dipendenze non europee. Perché la storia ci interessa per ragioni «politiche» non oggettive sia pure nel senso di scientifiche. Forse oggi questi interessi diventano più vasti con la filosofia della praxis, in quanto ci convinciamo che solo la conoscenza di tutto un processo storico ci può render conto del presente e dare una certa verosimiglianza che le nostre previsioni politiche siano concrete. Ma non è da illudersi neanche su questo argomento. Se in Russia c’è molto interesse per le quistioni orientali, questo interesse nasce dalla posizione geopolitica della Russia e non da influssi culturali più universali e scientifici. Devo dire la verità: tanta gente non conosce la storia d’Italia anche in quanto essa spiega il presente, che mi pare necessario far conoscere questa prima di ogni altra. Però un’associazione di politica estera che studiasse a fondo le quistioni anche della Cocincina e dell’Annam non mi dispiacerebbe intellettualmente: ma quanti ci si interesserebbero?
Q14 §64 Giustificazione dell’autobiografia. L’importanza dei particolari è tanto più grande quanto più in un paese la realtà effettuale è diversa dalle apparenze, i fatti dalle parole, il popolo che fa dagli intellettuali che interpretano questi fatti. Osservazione già fatta del come in certi paesi le costituzioni siano modificate dalle leggi, le leggi dai regolamenti e l’applicazione dei regolamenti dalla loro parola scritta. Chi esegue la «legge» (il regolamento) è arruolato in un certo strato sociale, di un certo livello di cultura, selezionato attraverso un certo stipendio, ecc. La legge è questo esecutore, è il modo in cui viene eseguita, specialmente perché non esistono organi di controllo e di sanzione. Ora solo attraverso l’autobiografia si vede il meccanismo in atto, nella sua funzione effettuale che molto spesso non corrisponde per nulla alla legge scritta. Eppure la storia, nelle sue linee generali, si fa sulla legge scritta: quando poi nascono fatti nuovi che rovesciano la situazione, si pongono delle domande vane, o per lo meno manca il documento del come si è preparato il mutamento «molecolarmente», finché è esploso nel mutamento. Certi paesi sono specialmente «ipocriti», cioè in certi paesi ciò che si vede e ciò che non si vede (perché non si vuol vedere, e perché volta per volta ciò che si vede sembra eccezione o «pittoresco») è specialmente in contrasto: proprio in questi paesi non abbondano i memorialisti oppure le autobiografie sono «stilizzate», strettamente personali e individuali.
Q14 §65 Letteratura popolare. Cosa corrisponde in letteratura al «razionalismo» architettonico? Certamente la letteratura «secondo un piano», cioè la letteratura «funzionale», secondo un indirizzo sociale prestabilito. È strano che in architettura il razionalismo sia acclamato e giustificato e non nelle altre arti. Ci deve essere un equivoco. Forse che l’architettura sola ha scopi pratici? Certo apparentemente così pare, perché l’architettura costruisce le case d’abitazione, ma non si tratta di questo: si tratta di «necessità». Si dirà che le case sono più necessarie che non le altre arti e si vuol dire solo che le case sono necessarie per tutti, mentre le altre arti sono necessarie solo per gli intellettuali, per gli uomini di coltura. Si dovrebbe concludere che proprio i «pratici» si propongono di rendere necessarie tutte le arti per tutti gli uomini, di rendere tutti «artisti».
Ancora. La coercizione sociale! Quanto si blatera contro questa coercizione. Non si pensa che essa è una parola! La coercizione, l’indirizzo, il piano, sono semplicemente un terreno di selezione degli artisti, nulla più: e da scegliere per scopi pratici, cioè in un campo in cui la volontà e la coercizione sono perfettamente giustificate. Sarebbe da vedere se la coercizione non è sempre esistita! Perché è esercitata inconsciamente dall’ambiente e dai singoli e non da un potere centrale o da una forza centralizzata non sarebbe forse coercizione? Si tratta in fondo sempre di «razionalismo» contro l’arbitrio individuale. Allora la quistione non verte sulla coercizione, ma sul fatto se si tratta di razionalismo autentico, di reale funzionalità, o di atto d’arbitrio, ecco tutto. La coercizione è tale solo per chi non l’accetta, non per chi l’accetta: se la coercizione si sviluppa secondo lo sviluppo delle forze sociali non è coercizione, ma «rivelazione» di verità culturale ottenuta con un metodo accelerato. Si può dire della coercizione ciò che i religiosi dicono della determinazione divina: per i «volenti» essa non è determinazione, ma libera volontà. In realtà la coercizione in parola è combattuta perché si tratta di una lotta contro gli intellettuali e contro certi intellettuali, quelli tradizionali e tradizionalisti, i quali, tutto al più, ammettono che le novità si facciano strada a poco a poco, gradualmente.
È curioso che in architettura si contrappone il razionalismo al «decorativismo», e questo viene chiamato «arte industriale». È curioso, ma giusto. Infatti dovrebbe chiamarsi sempre industriale qualsiasi manifestazione artistica che è diretta a soddisfare i gusti di singoli compratori ricchi, ad «abbellire» la loro vita, come si dice. Quando l’arte, specialmente nelle sue forme collettive, è diretta a creare un gusto di massa, ad elevare questo gusto, non è «industriale», ma disinteressata, cioè arte.
Mi pare che il concetto di razionalismo in architettura, cioè di «funzionalismo», sia molto fecondo di conseguenze di principi di politica culturale; non è casuale che esso sia nato proprio in questi tempi di «socializzazioni» (in senso vasto) e di interventi di forze centrali per organizzare le grandi masse contro i residui di individualismi e di estetiche dell’individualismo nella politica culturale.
Q14 §66 Giornalismo. Integralismo. Il tipo di giornalismo che viene considerato in queste è quello «integrale», cioè quello che presuppone non solo di soddisfare tutti i bisogni del suo pubblico, ma di creare questi bisogni e quindi di creare, in un certo senso, il pubblico stesso. Se si osserva, tutte le forme di giornalismo e di attività editoriale in genere esistenti presuppongono che altre forze esistono che sono da integrare. Mi pare invece, per esaurire il problema e vederne tutti i lati, sia da presupporre tutt’altra situazione, che esista solo, come punto di partenza, un gruppo più o meno omogeneo, di un certo tipo, di un certo livello e specialmente con un certo orientamento generale e che su di esso occorra far leva per stabilire un edifizio completo, a cominciare dalla… lingua, cioè dal mezzo di espressione e di contatto. Tutto l’edifizio deve essere costruito secondo principii razionalistici, cioè funzionali, in quanto si hanno determinate premesse e si vuole raggiungere determinate conseguenze. È evidente che durante l’elaborazione le stesse premesse vengono a mutare, perché se è vero che un fine presuppone certe premesse è anche vero che oltre un certo limite il fine stesso reagisce sulle premesse, mutandole. L’esistenza oggettiva delle premesse permette di pensare a certi fini, cioè le premesse date sono tali solo dei fini, solo in quanto… pensabili. Ma se questi fini cominciano a realizzarsi, per il fatto di realizzarsi, di diventare effettuali, mutano necessariamente le premesse iniziali, che non sono più… iniziali e quindi mutano anche i fini pensabili, ecc. È questo un nesso al quale si pensa ben raramente e che pure è chiaro e lampante. La sua applicazione la vediamo nelle imprese «secondo un piano», che non sono puri meccanismi appunto perché si basano su questo modo di pensare, in cui entra più libertà e spirito d’iniziativa di quanto sogliono ammettere, per il ruolo di maschera da commedia dell’arte che recitano, i rappresentanti della «libertà» e dell’«iniziativa».
Q14 §67 Argomenti di cultura. «Razionalismo». Concetto romantico dell’innovatore. Secondo questo concetto è innovatore chi vuol distruggere tutto l’esistente, senza curarsi di ciò che avverrà poi, poiché, già si sa, metafisicamente ogni distruzione è creazione, anzi non si distrugge che ciò che si sostituisce ricreando. A questo concetto romantico si accompagna un concetto «razionale» o «illuministico». Si pensa che tutto ciò che esiste è una «trappola» dei forti contro i deboli, dei furbi contro i poveri di spirito. Il pericolo viene dal fatto che «illuministicamente» le parole sono prese alla lettera, materialmente. La filosofia della prassi contro questo modo di concepire.
La verità è questa, invece: che ogni cosa che esiste è «razionale», cioè ha avuto o ha una funzione utile. Che ciò che esiste sia esistito, cioè abbia avuto la sua ragion d’essere in quanto «conforme» al modo di vita, di pensare, di operare, della classe dirigente, non significa che sia divenuto «irrazionale» perché la classe dominante è stata privata del potere e della sua forza di dare impulso a tutta la società. Una verità che si dimentica è questa: ciò che esiste ha avuto la sua ragione d’esistere, è servito, è stato razionale, ha «facilitato» lo sviluppo storico e la vita.
Che a un certo punto ciò non sia avvenuto più, che da modi di progresso, certe forme di vita siano divenute un inciampo e un ostacolo, è vero, ma non è vero «su tutta l’area»: è vero dove è vero, cioè nelle forme più alte di vita, in quelle decisive, in quelle che segnano la punta del progresso ecc. Ma la vita non si sviluppa omogeneamente, si sviluppa invece per avanzate parziali, di punta, si sviluppa per così dire per crescenza «piramidale». Dunque di ogni modo di vita occorre studiare la storia, cioè l’originaria «razionalità» e poi, riconosciuta questa, porsi la domanda, se ogni singolo caso questa razionalità esiste ancora, in quanto esistono ancora le condizioni su cui la razionalità si basava. Il fatto invece a cui non si bada è questo: che i modi di vita appaiono a chi li vive come assoluti, «come naturali», così come si dice, e che è già una grandissima cosa il mostrarne la «storicità», il dimostrare che essi sono giustificati in quanto esistono certe condizioni, ma mutate queste non sono più giustificati, ma «irrazionali». La discussione pertanto contro certi modi di vita e di operare assume un carattere odioso, persecutorio, diventa un fatto di «intelligenza» o «stupidaggine», ecc. Intellettualismo, illuminismo puro, contro cui occorre combattere incessantemente.
Se ne deduce: 1) che ogni fatto è stato «razionale»; 2) che esso è da combattere in quanto non è più razionale, cioè non più conforme al fine ma si trascina per la vischiosità dell’abitudine; 3) che non bisogna credere che poiché un modo di vivere, di operare o di pensare è diventato «irrazionale» in un ambiente dato, sia diventato irrazionale da per tutto e per tutti e che solo la malvagità o la stupidaggine lo facciano ancora vivere; 4) che però il fatto che un modo di vivere, di pensare, di vivere e di operare, sia diventato irrazionale in qualche posto abbia una grandissima importanza, è vero, ed occorre metterlo in luce in tutti i modi: così si modifica inizialmente il costume, introducendo il modo di pensare storicistico, che faciliterà i mutamenti di fatto appena le condizioni saranno mutate, che cioè renderà meno «vischioso» il costume abitudinario.
Un altro punto da fissare è questo: che un modo di vivere, di operare, di pensare, si sia introdotto in tutta la società perché proprio della classe dirigente, non significa di per sé che sia irrazionale e da rigettare. Se si osserva da vicino si vede: che in ogni fatto esistono due aspetti: uno «razionale», cioè conforme al fine, economico, e uno di «moda», che è un determinato modo di essere del primo aspetto razionale. Portare le scarpe è razionale, ma la determinata foggia di scarpe sarà dovuta alla moda. Portare il colletto è razionale perché permette di cambiare spesso quella parte dell’indumento camicia che più facilmente si sporca, ma la foggia del colletto dipenderà dalla moda, ecc.
Si vede insomma che la classe dirigente «inventando» una utilità nuova, più economica o più conforme alle condizioni date o al fine dato, ha nello stesso tempo dato una «sua» particolare forma all’invenzione, all’utilità nuova. È modo di pensare da muli bendati confondere l’utilità permanente (in quanto lo è) con la moda. Invece compito del moralista e del creatore di costumi è quello di analizzare i modi di essere e di vivere, e di criticarli, sceverando il permanente, l’utile, il razionale, il conforme al fine (in quanto sussiste il fine), dall’accidentale, dallo snobistico, dallo scimmiesco, ecc. Sulla base del «razionale», può essere utile creare una «moda» originale, cioè una forma nuova che interessi.
Che il modo di pensare notato non sia giusto si vede dal fatto che esso ha dei limiti: per esempio nessuno (almeno che sia matto) predicherà di non insegnare più a leggere e a scrivere, perché il leggere e lo scrivere è certamente stato introdotto dalla classe dirigente, perché la scrittura serve a diffondere certa letteratura o a scrivere le lettere di ricatto o i rapporti delle spie.
Q14 §68 Machiavelli. Scritto (a domande e risposte) di Giuseppe Bessarione [Stalin ndc] del settembre 1927 su alcuni punti essenziali di scienza e di arte politica. Il punto che mi pare sia da svolgere è questo: come secondo la filosofia della prassi (nella sua manifestazione politica) sia nella formulazione del suo fondatore, ma specialmente nella precisazione del suo più recente grande teorico, la situazione internazionale debba essere considerata nel suo aspetto nazionale. Realmente il rapporto «nazionale» è il risultato di una combinazione «originale» unica (in un certo senso) che in questa originalità e unicità deve essere compresa e concepita se si vuole dominarla e dirigerla. Certo lo sviluppo è verso l’internazionalismo, ma il punto di partenza è «nazionale» ed è da questo punto di partenza che occorre prender le mosse. Ma la prospettiva è internazionale e non può essere che tale. Occorre pertanto studiare esattamente la combinazione di forze nazionali che la classe internazionale dovrà dirigere e sviluppare secondo la prospettiva e le direttive internazionali. La classe dirigente è tale solo se interpreterà esattamente questa combinazione, di cui essa stessa è componente e in quanto tale appunto può dare al movimento un certo indirizzo in certe prospettive.
Su questo punto mi pare sia il dissidio fondamentale tra Leone Davidovici e Bessarione come interprete del movimento maggioritario. Le accuse di nazionalismo sono inette se si riferiscono al nucleo della quistione. Se si studia lo sforzo dal 1902 al 1917 da parte dei maggioritari si vede che la sua originalità consiste nel depurare l’internazionalismo di ogni elemento vago e puramente ideologico (in senso deteriore) per dargli un contenuto di politica realistica.
Il concetto di egemonia è quello in cui si annodano le esigenze di carattere nazionale e si capisce come certe tendenze di tale concetto non parlino o solo lo sfiorino. Una classe di carattere internazionale in quanto guida strati sociali strettamente nazionali (intellettuali) e anzi spesso meno ancora che nazionali, particolaristi e municipalisti (i contadini), deve «nazionalizzarsi», in un certo senso, e questo senso non è d’altronde molto stretto, perché prima che si formino le condizioni di una economia secondo un piano mondiale, è necessario attraversare fasi molteplici in cui le combinazioni regionali (di gruppi di nazioni) possono essere varie. D’altronde non bisogna mai dimenticare che lo sviluppo storico segue le leggi della necessità fino a quando l’iniziativa non sia nettamente passata dalla parte delle forze che tendono alla costruzione secondo un piano, di pacifica e solidale divisione del lavoro.
Che i concetti non nazionali (cioè non riferibili a ogni singolo paese) siano sbagliati si vede per assurdo: essi hanno portato alla passività e all’inerzia in due fasi ben distinte: 1) nella prima fase, nessuno credeva di dover incominciare, cioè riteneva che incominciando si sarebbe trovato isolato; nell’attesa che tutti insieme si muovessero, nessuno intanto si muoveva e organizzava il movimento; 2) la seconda fase è forse peggiore, perché si aspetta una forma di «napoleonismo» anacronistico e antinaturale (poiché non tutte le fasi storiche si ripetono nella stessa forma).
Le debolezze teoriche di questa forma moderna del vecchio meccanicismo sono mascherate dalla teoria generale della rivoluzione permanente che non è altro che una previsione generica presentata come dogma e che si distrugge da sé, per il fatto che non si manifesta effettualmente.
Mat.Bibliog.: Gramsci, Stalin e Trotzky
Q14 §69 Argomento di cultura. L’autodidatta. Non si vuole ripetere il solito luogo comune che tutti i dotti sono autodidatti, in quanto l’educazione è autonomia e non impressione dal di fuori. Luogo comune tendenzioso che permette di non organizzare nessun apparato di cultura e di negare ai poveri il tempo da dedicare allo studio, unendo allo scorno la beffa, cioè la dimostrazione teorica che se non sono dotti la colpa è loro poiché ecc. ecc.
Ammettiamo dunque che, salvo a pochi eroi della cultura (e nessuna politica può fondarsi sull’eroismo), per istruirsi e educarsi è necessario un apparato di cultura, attraverso cui la generazione anziana trasmette alla generazione giovane tutta l’esperienza del passato (di tutte le vecchie generazioni passate), fa acquistar loro determinate inclinazioni e abitudini (anche fisiche e tecniche che si assimilano con la ripetizione) e trasmette arricchito il patrimonio del passato. Ma non di ciò vogliamo parlare. Vogliamo proprio parlare degli autodidatti in senso stretto, cioè di quelli che sacrificano una parte o tutto il tempo che gli altri appartenenti alla loro generazione dedicano ai divertimenti o ad altre occupazioni, per istruirsi ed educarsi, e rispondere alla domanda: oltre alle istituzioni ufficiali esistono attività che soddisfino i bisogni nascenti da queste inclinazioni e come le soddisfano? Ancora: le istituzioni politiche esistenti, in quanto dovrebbero, si pongono questo compito di soddisfare tali bisogni? Mi pare che questo sia un criterio di critica da non buttar via, da non trascurare in ogni modo.
Si può osservare che gli autodidatti in senso stretto sorgono in certi strati sociali a preferenza di altri e si capisce. Parliamo di quelli che hanno a loro disposizione solo la loro buona volontà e disponibilità finanziarie limitatissime, possibilità di spendere molto piccole o quasi nulle. Devono essere trascurati? Non pare, in quanto appunto pare che nascano partiti dedicati proprio a questi elementi, i quali appunto partono dal concetto di aver che fare con simili elementi. Ebbene: se questi elementi sociali esistono, non esistono le forze che cercano di ovviare ai loro bisogni, di elaborare questo materiale. O meglio: tali forze sociali esistono a parole, ma non nei fatti, come affermazione ma non come attuazione.
D’altronde non è detto che non esistano forze sociali generiche che di tali bisogni si occupano, anzi fanno il loro unico lavoro, la loro precipua attività, con questo risultato: che esse finiscono col contare più di quel che dovrebbero, con avere un influsso più grande di quello che «meriterebbero» e spesso addirittura collo «speculare» finanziariamente su questi bisogni, perché gli autodidatti, nel loro stimolo, se spendono poco singolarmente, finiscono con lo spendere ragguardevolmente come insieme (ragguardevolmente nel senso che permettono con la loro spesa di vivere a parecchie persone).
Il movimento di cui si parla (o si parlava) è quello libertario, e il suo antistoricismo, la sua retrività, si vede dal carattere dell’autodidattismo, che forma persone «anacronistiche» che pensano con modi antiquati e superati e questi tramandano, «vischiosamente». Dunque: 1) un movimento sorpassato, superato, in quanto soddisfa certi bisogni impellenti, finisce con l’avere un influsso maggiore di quanto storicamente gli spetterebbe; 2) questo movimento tiene arretrato il mondo culturale per le stesse ragioni ecc.
Sarebbe da vedere tutta la serie delle ragioni che in Italia per tanto tempo hanno permesso che un movimento arretrato, superato, tenesse più campo di quanto gli spettasse, provocando spesso confusioni e anche catastrofi. D’altronde bisogna affermare energicamente che in Italia il moto verso la cultura è stato grande, ha provocato sacrifici, che cioè le condizioni obbiettive erano molto favorevoli. Il principio che una forza non vale tanto per la propria «forza intrinseca» quanto per la debolezza degli avversari e delle forze in cui si trova inserita, non è tanto vero come in Italia.
Un altro elemento della forza relativa dei libertari è questo: che essi hanno più spirito di iniziativa individuale, più attività personale. Perché questo avvenga dipende da cause complesse: 1) che hanno maggior soddisfazione personale dal loro lavoro; 2) che sono meno intralciati da impacci burocratici, i quali non dovrebbero esistere per le altre organizzazioni: perché mai l’organizzazione che dovrebbe potenziare l’iniziativa individuale, si dovrebbe mutare in burocrazia, cioè in impaccio delle forze individuali ? 3) (e forse maggiore) che un certo numero di persone vivono del movimento, ma ci vivono liberamente, cioè non per posti occupati per nomina, ma in quanto la loro attività li rende degni di essi: per mantenere questo posto, cioè per mantenere il loro guadagno, fanno degli sforzi che altrimenti non farebbero.
Q14 §70 Machiavelli. Quando si può dire che un partito sia formato e non possa essere distrutto con mezzi normali. Il punto di sapere quando un partito sia formato, cioè abbia un compito preciso e permanente, dà luogo a molte discussioni e spesso anche luogo, purtroppo, a una forma di boria che non è meno ridicola e pericolosa che la «boria delle nazioni» di cui parla il Vico. È vero che si può dire che un partito non è mai compiuto e formato, nel senso che ogni sviluppo crea nuovi compiti e mansioni e nel senso che per certi partiti è vero il paradosso che essi sono compiuti e formati quando non esistono più, cioè quando la loro esistenza è diventata storicamente inutile. Così, poiché ogni partito non è che una nomenclatura di classe, è evidente che per il partito che si propone di annullare la divisione in classi, la sua perfezione e compiutezza consiste nel non esistere più perché non esistono classi e quindi loro espressioni.
Ma qui si vuole accennare a un particolare momento di questo processo di sviluppo, al momento successivo a quello in cui un fatto può esistere e può non esistere, nel senso che la necessità della sua esistenza non è ancora divenuta «perentoria», ma dipende in «gran parte» dall’esistenza di persone di straordinario potere volitivo e di straordinaria volontà. Quando un partito diventa «necessario» storicamente? Quando le condizioni del suo «trionfo», del suo immancabile diventar Stato sono almeno in via di formazione e lasciano prevedere normalmente i loro ulteriori sviluppi. Ma quando si può dire, in tali condizioni, che un partito non può essere distrutto con mezzi normali?
Per rispondere occorre sviluppare un ragionamento: perché esista un partito è necessario che confluiscano tre elementi fondamentali (cioè tre gruppi di elementi). 1) Un elemento diffuso, di uomini comuni, medi, la cui partecipazione è offerta dalla disciplina e dalla fedeltà, non dallo spirito creativo ed altamente organizzativo. Senza di essi il partito non esisterebbe, è vero, ma è anche vero che il partito non esisterebbe neanche «solamente» con essi. Essi sono una forza in quanto c’è chi li centralizza, organizza, disciplina, ma in assenza di questa forza coesiva si sparpaglierebbero e si annullerebbero in un pulviscolo impotente. Non si nega che ognuno di questi elementi possa diventare una delle forze coesive, ma di essi si parla appunto nel momento che non lo sono e non sono in condizioni di esserlo, o se lo sono lo sono solo in una cerchia ristretta, politicamente inefficiente e senza conseguenza. 2) L’elemento coesivo principale, che centralizza nel campo nazionale, che fa diventare efficiente e potente un insieme di forze che lasciate a sé conterebbero zero o poco più; questo elemento è dotato di forza altamente coesiva, centralizzatrice e disciplinatrice e anche (anzi forse per questo, inventiva, se si intende inventiva in una certa direzione, secondo certe linee di forza, certe prospettive, certe premesse anche): è anche vero che da solo questo elemento non formerebbe il partito, tuttavia lo formerebbe più che non il primo elemento considerato. Si parla di capitani senza esercito, ma in realtà è più facile formare un esercito che formare dei capitani. Tanto vero che un esercito già esistente è distrutto se vengono a mancare i capitani, mentre l’esistenza di un gruppo di capitani, affiatati, d’accordo tra loro, con fini comuni non tarda a formare un esercito anche dove non esiste. 3) Un elemento medio, che articoli il primo col terzo elemento, che li metta a contatto, non solo «fisico» ma morale e intellettuale. Nella realtà, per ogni partito esistono delle «proporzioni definite» tra questi tre elementi e si raggiunge il massimo di efficienza quando tali «proporzioni definite» sono realizzate.
Date queste considerazioni, si può dire che un partito non può essere distrutto con mezzi normali, quando, esistendo necessariamente il secondo elemento, la cui nascita è legata all’esistenza delle condizioni materiali oggettive (e se questo secondo elemento non esiste, ogni ragionamento è vacuo) sia pure allo stato disperso e vagante, non possono non formarsi gli altri due, cioè il primo che necessariamente forma il terzo come sua continuazione e mezzo di esprimersi. Occorre che perché ciò avvenga si sia formata la convinzione ferrea che una determinata soluzione dei problemi vitali sia necessaria. Senza questa convinzione non si formerà il secondo elemento, la cui distruzione è la più facile per lo scarso suo numero, ma è necessario che questo secondo elemento, se distrutto, abbia lasciato come eredità un fermento da cui riformarsi. E dove questo fermento sussisterà meglio e potrà meglio formarsi che nel primo e nel terzo elemento, che, evidentemente, sono i più omogenei col secondo? L’attività del secondo elemento per costituire questo elemento è perciò fondamentale: il criterio di giudizio di questo secondo elemento sarà da cercare: 1) in ciò che realmente fa; 2) in ciò che prepara nell’ipotesi di una sua distruzione. Tra i due fatti è difficile dire quale sia più importante. Poiché nella lotta si deve sempre prevedere la sconfitta, la preparazione dei propri successori è un elemento altrettanto importante di ciò che si fa per vincere.
A proposito della «boria» del partito, si può dire che essa è peggiore della boria delle nazioni di cui parla Vico. Perché? Perché una nazione non può non esistere e nel fatto che esiste è sempre possibile, sia pure con la buona volontà e sollecitando i testi, trovare che l’esistenza è piena di destino e di significato. Invece un partito può non esistere per forza propria. Non occorre mai dimenticare che nella lotta fra le nazioni, ognuna di esse ha interesse che l’altra sia indebolita dalle lotte interne e che i partiti sono appunto gli elementi delle lotte interne. Per i partiti dunque, è sempre possibile la domanda se essi esistano per forza propria, come propria necessità, o esistano invece solo per interesse altrui (e infatti nelle polemiche questo punto non è mai dimenticato, anzi è motivo d’insistenza anche, specialmente quando la risposta non è dubbia, ciò che significa che ha presa e lascia dubbi). Naturalmente, chi si lasciasse dilaniare da questo dubbio, sarebbe uno sciocco. Politicamente la quistione ha una rilevanza solo momentanea.
Nella storia del così detto principio di nazionalità, gli interventi stranieri a favore dei partiti nazionali che turbavano l’ordine interno degli Stati antagonisti sono innumerevoli, tanto che quando si parla per esempio della politica «orientale» di Cavour si domanda se si trattava di una «politica» cioè di una linea d’azione permanente, o di uno stratagemma del momento per indebolire l’Austria in vista del 59 e del 66. Così nei movimenti mazziniani dei primi del 1870 (esempio, fatto Barsanti) si vede l’intervento di Bismark, che in vista della guerra con la Francia e del pericolo di un’alleanza italo‑francese, pensava, con conflitti interni, a indebolire l’Italia. Così nei fatti del giugno 1914 alcuni vedono l’intervento dello Stato Maggiore austriaco in vista della successiva guerra. Come si vede, la casistica è numerosa e occorre avere idee chiare in proposito. Ammesso che qualunque cosa si faccia, si fa sempre il gioco di qualcuno, l’importante è di cercare in tutti i modi di fare bene il proprio gioco, cioè di vincere nettamente. In ogni modo occorre disprezzare la «boria» del partito e alla boria sostituire i fatti concreti. Chi ai fatti concreti sostituisce la boria, o fa la politica della boria, è da sospettare di poca serietà senz’altro. Non occorre aggiungere che per i partiti occorre evitare anche l’apparenza «giustificata» che si faccia il gioco di qualcuno, specialmente se il qualcuno è uno Stato straniero: che poi si speculi, nessuno può evitare che non avvenga.
Q14 §71 Giornalismo. Movimenti e centri intellettuali. È dovere dell’attività giornalistica (nelle sue varie manifestazioni) seguire e controllare tutti i movimenti e i centri intellettuali che esistono e si formano nel paese. Tutti. Cioè con l’esclusione appena di quelli che hanno un carattere arbitrario e pazzesco; sebbene anche questi, col tono che si meritano, devono essere per lo meno registrati. Distinzione tra centri e movimenti intellettuali e altre distinzioni e graduazioni. Per esempio il cattolicismo è un grande centro e un grande movimento: ma nel suo interno esistono movimenti e centri parziali che tendono a trasformare l’intero, o ad altri fini più concreti e limitati e di cui occorre tener conto. Pare che prima di ogni altra cosa occorra «disegnare» la mappa intellettuale e morale del paese, cioè circoscrivere i grandi movimenti d’idee e i grandi centri (ma non sempre ai grandi movimenti corrispondono grandi centri, almeno coi caratteri di visibilità e di concretezza che di solito si attribuisce a questa parola e l’esempio tipico è il centro cattolico). Occorre poi tener conto delle spinte innovatrici che si verificano, che non sempre sono vitali, cioè hanno una conseguenza, ma non perciò devono essere meno seguite e controllate. Intanto all’inizio un movimento è sempre incerto, di avvenire dubbio, ecc.; bisognerà attendere che abbia acquistato tutta la sua forza e consistenza per occuparsene? Neanche è necessario che esso sia fornito delle doti di coerenza e di ricchezza intellettuale: non sempre sono i movimenti più coerenti ed intellettualmente ricchi quelli che trionfano. Spesso anzi un movimento trionfa proprio per la sua mediocrità ed elasticità logica: tutto ci può stare, i compromessi più vistosi sono possibili e questi appunto possono essere ragioni di trionfo. Leggere le riviste dei giovani oltre quelle che si sono già affermate e rappresentano interessi seri e ben certi. Nell’«Almanacco letterario» Bompiani del 1933 (pp. 360‑361) sono indicati i programmi essenziali di sei riviste di giovani che dovrebbero rappresentare le spinte di movimento della nostra cultura: «Il Saggiatore», «Ottobre», «Il Ventuno», «L’Italia vivente», «L’Orto», «Espero» che non paiono molto perspicue, eccetto forse qualcuna. L’«Espero» per esempio, «per la filosofia» si propone «di ospitare i postidealisti, che eseguiscono un’attenta critica dell’idealismo, e quei soli idealisti che sanno tener conto di tale critica». Il direttore di «Espero» è Aldo Capasso, ed essere postidealista è qualcosa come essere «contemporaneo», cioè proprio nulla. Più chiaro, anzi forse il solo chiaro, è il programma di «Ottobre». Tuttavia tutti questi movimenti sarebbero da esaminare, snobismo a parte.
Distinzione tra movimenti militanti, che sono i più interessanti, e movimenti di «retroguardia» o di idee acquisite e divenute classiche o commerciali. Tra questi dove mettere l’«Italia Letteraria»? Non certo militante e neppure classica! Sacco di patate mi pare proprio la definizione più esatta e appropriata.
Q14 §72 Letteratura popolare. Contenuto e forma. L’accostamento di questi due termini può assumere nella critica d’arte molti significati. Ammesso che contenuto e forma sono la stessa cosa, ecc. ecc., non significa ancora che non si possa fare la distinzione tra contenuto e forma. Si può dire che chi insiste sul «contenuto» in realtà lotta per una determinata cultura, per una determinata concezione del mondo contro altre culture e altre concezioni del mondo; si può anche dire che storicamente, finora, i così detti contenutisti sono stati «più democratici» dei loro avversari parnassiani, per esempio, cioè volevano una letteratura che non fosse per gli «intellettuali», ecc. Si può parlare di una priorità del contenuto sulla forma? Se ne può parlare in questo senso, che l’opera d’arte è un processo e che i cambiamenti di contenuto sono anche cambiamenti di forma, ma è «più facile» parlare di contenuto che di forma, perché il contenuto può essere «riassunto» logicamente. Quando si dice che il contenuto precede la forma si vuol dire semplicemente che, nell’elaborazione, i tentativi successivi vengono presentati col nome di contenuto, niente altro. Il primo contenuto che non soddisfaceva era anche forma e in realtà quando si è raggiunta la «forma» soddisfacente anche il contenuto è cambiato. È vero che spesso quelli che chiacchierano di forma ecc. contro il contenuto, sono completamente vuoti, accozzano parole che non sempre si tengono neanche secondo grammatica (esempio Ungaretti); per tecnica, forma ecc. intendono vacuità di gergo da conventicola di teste vuote.
Anche questa è da porre fra le quistioni della storia nazionale italiana, in altra nota registrata, e assume varie forme: 1) c’è una differenza di stile tra gli scritti dedicati al pubblico e gli altri, per esempio tra le lettere e le opere letterarie. Sembra spesso di aver che fare con due scrittori diversi tanta è la differenza. Nelle lettere (salvo eccezioni, come quella di D’Annunzio che fa la commedia anche allo specchio, per se stesso), nelle memorie e in generale in tutti gli scritti dedicati a poco pubblico o a se stesso, predomina la sobrietà, la semplicità, la immediatezza, mentre negli altri scritti predomina la tronfiezza, lo stile oratorio, l’ipocrisia stilistica. Questa «malattia» è talmente diffusa che si è attaccata al popolo, per il quale infatti «scrivere» significa «montare sui trampoli», mettersi a festa, «fingere» uno stile ridondante, ecc., in ogni modo esprimersi in modo diverso dal comune; e siccome il popolo non è letterato, e di letteratura conosce solo il libretto dell’opera ottocentesca, avviene che gli uomini del popolo «melodrammatizzano». Ecco allora che «contenuto e forma» oltre che un significato «estetico» hanno anche un significato «storico». Forma «storica» significa un determinato linguaggio, come «contenuto» indica un determinato modo di pensare, non solo storico, ma «sobrio», espressivo senza pugni in faccia, passionale senza che le passioni siano arroventate all’Otello o al melodramma, senza la maschera teatrale, insomma. Questo fenomeno, credo, si verifica solo nel nostro paese, come fenomeno di massa, s’intende, perché papi singoli sono da per tutto. Ma occorre stare attenti: perché il paese nostro è quello in cui al convenzionale barocco è successo il convenzionale arcadico: sempre teatro e convenzione però.
Occorre dire che in questi anni le cose sono molto migliorate: D’Annunzio è stato l’ultimo accesso di malattia del popolo italiano e il giornale, per le sue necessità, ha avuto il gran merito di «razionalizzare» la prosa. Però l’ha impoverita e stremenzita e anche questo è un danno. Ma purtroppo nel popolo, accanto ai «futuristi antiaccademici» esistono ancora i «secentisti» di conversione. D’altronde qui si fa una quistione storica, per spiegare il passato, e non una lotta puramente attuale, per combattere mali attuali, sebbene anche questi non siano del tutto scomparsi e si ritrovano in alcune manifestazioni specialmente (discorsi solenni, specialmente funebri, patriottici, iscrizioni idem, ecc.). (Si potrebbe dire che si tratta di «gusto» e sarebbe errato. Il gusto è «individuale» o di piccoli gruppi; qui si tratta di grandi masse, e non può non trattarsi di cultura, di fenomeno storico, di esistenza di due culture; individuale è il gusto «sobrio», non l’altro, il melodramma è il gusto nazionale, cioè la cultura nazionale). Né si dica che di tale quistione non occorre occuparsi: anzi, la formazione di una prosa vivace ed espressiva e nello stesso tempo sobria e misurata deve essere uno dei fini culturali da proporsi. Anche in questo caso forma ed espressione si identificano ed insistere sulla «forma» non è che un mezzo pratico per lavorare sul contenuto, per ottenere una deflazione della retorica tradizionale che guasta ogni forma di cultura, anche quella «antiretorica», ahimè!
La domanda se sia esistito un romanticismo italiano può avere diverse risposte, a seconda di ciò che s’intende per romanticismo. E certo molte sono le definizioni che del termine di romanticismo sono state date. Ma a noi importa una di queste definizioni e importa non precisamente l’aspetto «letterario» del problema. Romanticismo ha, tra gli altri significati, assunto quello di uno speciale rapporto o legame tra gli intellettuali e il popolo, la nazione, cioè è un particolare riflesso della «democrazia» (in senso largo) nelle lettere (in senso largo, per cui anche il cattolicismo può essere stato «democratico» mentre il «liberalismo» può esserlo non stato). In questo senso ci interessa il problema per l’Italia ed esso è legato ai problemi che abbiamo raccolto in serie: se è esistito un teatro italiano, la quistione della lingua, perché la letteratura non è stata popolare, ecc. Occorre dunque, nella sterminata letteratura sul romanticismo, isolare questo aspetto e di esso interessarsi, teoricamente e praticamente, come fatto storico cioè e come tendenza generale che può dar luogo a un movimento attuale, a un attuale problema da risolvere. In questo senso il romanticismo precede, accompagna, sanziona e svolge tutto quel movimento europeo che prese nome dalla Rivoluzione francese; ne è l’aspetto sentimentale‑letterario (più sentimentale che letterario, nel senso che l’aspetto letterario è stato solo una parte dell’espressione della corrente sentimentale che ha pervaso tutta la vita e una parte molto importante della vita, e di questa vita solo una piccolissima parte ha potuto trovare espressione nella letteratura).
La ricerca quindi è di storia della cultura e non di storia letteraria, meglio di storia letteraria in quanto parte e aspetto di una più vasta storia della cultura. Ebbene, in questo preciso senso, il romanticismo non è esistito in Italia, e nel miglior caso le sue manifestazioni sono state minime, scarsissime e in ogni caso di aspetto puramente letterario. (Su questo punto è necessario il ricordo delle teorie del Thierry e del riflesso manzoniano, teorie del Thierry che appunto sono uno degli aspetti più importanti di questo aspetto del romanticismo di cui si vuole parlare). È da vedere come in Italia anche queste discussioni abbiano assunto un aspetto intellettuale e astratto: i pelasgi del Gioberti, le popolazioni «preromane», ecc., in realtà niente che fosse in rapporto col vivente popolo attuale che invece interessava il Thierry e la storiografia politica affine. Si è detto che la parola «democrazia» non deve essere assunta in tal senso, solo nel significato «laico» o «laicista» che si vuol dire; ma anche nel significato «cattolico», anche reazionario, se si vuole; ciò che importa è il fatto che si ricerchi un legame col popolo, con la nazione, che si ritenga necessaria una unità non servile, dovuta all’obbedienza passiva, ma un’unità attiva, vivente, qualunque sia il contenuto di questa vita. Questa unità vivente, a parte ogni contenuto, è appunto mancata in Italia, è mancata almeno nella misura sufficiente a farla diventare un fatto storico, e perciò si capisce il significato della domanda: «è esistito un romanticismo italiano»?
Q14 §73 Giornalismo. Riviste tipo. Confronto tra il primo numero della rivista «Leonardo» edita dal Sansoni di Firenze e i numeri editi da Casa Treves. La differenza è molto notevole e tuttavia Casa Treves è tipograficamente non delle ultime. Grande importanza che ha la veste esteriore di una rivista, sia commercialmente, sia «ideologicamente» per assicurare la fedeltà e l’affezione: in realtà in questo caso è difficile distinguere il fatto commerciale da quello ideologico. Fattori: pagina, composta dai margini, dagli intercolonni, dall’ampiezza delle colonne (lunghezza della linea), dalla compattezza della colonna, cioè dal numero delle lettere per linea e dall’occhio di ogni lettera, dalla carta e dall’inchiostro (bellezza dei titoli, nitidezza del carattere dovuta al maggiore o minore logorio delle matrici o delle lettere a mano, ecc.). Questi elementi non hanno importanza solo per le riviste, ma anche per i quotidiani. Il problema fondamentale di ogni periodico (quotidiano o no) è quello di assicurare una vendita stabile (possibilmente in continuo incremento), ciò che significa poi possibilità di costruire un piano commerciale (in isviluppo, ecc.). Certo l’elemento fondamentale di fortuna per un periodico è quello ideologico, cioè il fatto che soddisfa o no determinati bisogni intellettuali‑politici.
Ma sarebbe grosso errore il credere che questo sia l’unico elemento e specialmente che esso sia valido «isolatamente» preso. Solo in condizioni eccezionali, in determinati periodi di boom dell’opinione pubblica, avviene che un’opinione, qualunque sia la forma esteriore in cui è presentata, ha fortuna. Di solito, il modo di presentazione ha una grande importanza per la stabilità dell’azienda e l’importanza può essere positiva ma anche negativa. Dare gratis o sottocosto non sempre è una «buona speculazione», come non è buona speculazione far pagare troppo caro o dare «poco» per il «proprio denaro». Ciò almeno in politica. Di una opinione la cui manifestazione stampata non costa nulla, il pubblico diffida, ci vede sotto il tranello. E viceversa: diffida «politicamente» di chi non sa amministrare bene i fondi che il pubblico stesso dà. Come potrebbe essere ritenuto capace di amministrare il potere di Stato un partito che non ha o non sa scegliere (il che è lo stesso) gli elementi per amministrare bene un giornale o una rivista? Viceversa: un gruppo che con mezzi scarsi sa ottenere giornalisticamente risultati apprezzabili, dimostra con ciò, o già con ciò, che saprà amministrare bene anche organismi più ampi, ecc.
Ecco perché «l’esteriore» di una pubblicazione deve essere curato con la stessa attenzione che il contenuto ideologico e intellettuale: in realtà le due cose sono inscindibili e giustamente. Un buon principio (ma non sempre) è quello di dare all’esterno di una pubblicazione una caratteristica che di per sé si faccia notare e ricordare: è una pubblicità gratuita, per così dire. Non sempre, perché dipende dalla psicologia del particolare pubblico che si vuole conquistare.
Q14 §74 Passato e presente. L’autocritica e l’ipocrisia del l’autocritica. È certo che l’autocritica è diventata una parola di moda. Si vuole, a parole, far credere che alla critica rappresentata dalla «libera» lotta politica nel regime rappresentativo, si è trovato un equivalente, che di fatto, se applicato sul serio, è più efficace e produttivo di conseguenze dell’originale. Ma tutto sta lì: che il surrogato sia applicato sul serio, che l’autocritica sia operante e «spietata», perché in ciò è la sua maggiore efficacia: che deve essere spietata. Si è trovato invece che l’autocritica può dar luogo a bellissimi discorsi, a declamazioni senza fine e nulla più: l’autocritica è stata «parlamentarizzata». Poiché non è stato osservato finora che distruggere il parlamentarismo non è così facile come pare. Il parlamentarismo «implicito» e «tacito» è molto più pericoloso che non quello esplicito, perché ne ha tutte le deficienze senza averne i valori positivi. Esiste spesso un regime di partito «tacito», cioè un parlamentarismo «tacito» e «implicito» dove meno si crederebbe. È evidente che non si può abolire una «pura» forma, come è il parlamentarismo, senza abolire radicalmente il suo contenuto, l’individualismo, e questo nel suo preciso significato di «appropriazione individuale» del profitto e di iniziativa economica per il profitto capitalistico individuale. L’autocritica ipocrita è appunto di tali situazioni. Del resto la statistica dà l’indizio dell’effettualità della posizione. A meno che non si voglia sostenere che è sparita la criminalità, ciò che del resto altre statistiche smentiscono e come!
Tutto l’argomento è da rivedere, specialmente quello riguardante il regime dei partiti e il parlamentarismo «implicito», cioè funzionante come le «borse nere» e il «lotto clandestino» dove e quando la borsa ufficiale e il lotto di Stato sono per qualche ragione tenuti chiusi. Teoricamente l’importante è di mostrare che tra il vecchio assolutismo rovesciato dai regimi costituzionali e il nuovo assolutismo c’è differenza essenziale, per cui non si può parlare di un regresso; non solo, ma di dimostrare che tale «parlamentarismo nero» è in funzione di necessità storiche attuali, è «un progresso», nel suo genere; che il ritorno al «parlamentarismo» tradizionale sarebbe un regresso antistorico, poiché anche dove questo «funziona» pubblicamente, il parlamentarismo effettivo è quello «nero». Teoricamente mi pare si possa spiegare il fenomeno nel concetto di «egemonia», con un ritorno al «corporativismo», ma non nel senso «antico regime», nel senso moderno della parola, quando la «corporazione» non può avere limiti chiusi ed esclusivisti, come era nel passato; oggi è corporativismo di «funzione sociale», senza restrizione ereditaria o d’altro (vedi sotto)La frase, interrotta a questo punto, continua nel successivo Q14 § 76..
Q14 §75 Passato e presente. Convinzione ogni giorno più radicata che non meno delle iniziative conta il controllo che l’iniziativa sia attuata, che mezzi e fini coincidano perfettamente (sebbene non sia ciò da intendere materialmente) e che si può parlare di volere un fine solo quando si sanno predisporre con esattezza, cura, meticolosità, i mezzi adeguati, sufficienti e necessari (né più né meno, né di qua né di là dalla mira). Convinzione anche radicata che poiché le idee camminano e si attuano storicamente con gli uomini di buona volontà, lo studio degli uomini, la scelta di essi, il controllo delle loro azioni è altrettanto necessario che lo studio delle idee, ecc. Perciò ogni distinzione tra il dirigere e l’organizzare (e nell’organizzare è compreso il «verificare» o controllare) indica una deviazione e spesso un tradimento.
Q14 §76 Passato e presente (continua il penultimo Q14 §) … genere (che del resto era relativa anche nel passato, in cui il carattere più evidente era quello del «privilegio legale»).
Trattando l’argomento è da escludere accuratamente ogni anche solo apparenza di appoggio alle tendenze «assolutiste» e ciò si può ottenere insistendo sul carattere transitorio» (nel senso che non fa epoca, non nel senso di poca durata») del fenomeno. (A questo proposito è da notare come troppo spesso si confonda il «non far epoca» con la scarsa durata «temporale»; si può «durare» a lungo, relativamente, e non «fare epoca»; le forze di vischiosità di certi regimi sono spesso insospettate, specialmente se essi sono «forti» della altrui debolezza, anche procurata: a questo proposito sono da ricordare le opinioni di Cesarino Rossi, che certo erano sbagliate «in ultima istanza», ma realmente avevano un contenuto di realismo effettuale).
Il parlamentarismo «nero» pare un argomento da svolgere con certa ampiezza, anche perché porge l’occasione di precisare i concetti politici che costituiscono la concezione «parlamentare». I raffronti con altri paesi, a questo riguardo, sono interessanti: per esempio, la liquidazione di Leone Davidovi non è un episodio della liquidazione «anche» del parlamento «nero» che sussisteva dopo l’abolizione del parlamento «legale»?
Fatto reale e fatto legale. Sistema di forze in equilibrio instabile che nel terreno parlamentare trovano il terreno «legale» del loro equilibrio «più economico» e abolizione di questo terreno legale, perché diventa fonte di organizzazione e di risveglio di forze sociali latenti e sonnecchianti; quindi questa abolizione è sintomo (o previsione) di intensificarsi delle lotte e non viceversa. Quando una lotta può comporsi legalmente, essa non è certo pericolosa: diventa tale appunto quando l’equilibrio legale è riconosciuto impossibile. (Ciò che non significa che abolendo il barometro si abolisca il cattivo tempo).
Q14 §77 Passato e presente. Viene spesso osservato come un’incongruenza e un sintomo di ciò che la politica di per sé pervertisce gli animi, il fatto che dopo una rottura «si scopre» contro il transfuga o il traditore un mucchio di malefatte che prima pareva si ignorassero. Ma la quistione non è così semplice. In primo luogo la rottura è di solito un lungo processo, del quale solo l’ultimo atto si rivela al pubblico: in questa «istruttoria» si raccolgono tutti i fatti negativi ed è naturale che si cerchi di mettere il «transfuga» in condizioni di torto anche immediato, cioè si finge di essere «longanimi» per mostrare che la rottura era proprio necessaria e inevitabile. Pare che ciò sia abbastanza comprensibile politicamente. Anzi mostra come l’appartenenza a un partito sia ritenuta essere importante e si decida l’atto risolutivo solo quando la misura è colma. Che l’enumerazione dei «fatti» sia facile «dopo» è dunque chiaro: essa non è che il rendere pubblico un processo che privatamente durava già da un pezzo. In secondo luogo, è anche chiaro che tutta una serie di fatti passati può essere illuminata da un ultimo fatto in modo incontrovertibile. Tizio frequenta quotidianamente una casa: niente di notevole, finché non si viene a sapere, per esempio, che quella tal casa è un covo di spionaggio e Tizio è una spia. Evidentemente chi avesse segnato tutte le volte che Tizio si è recato in questa casa, può enumerare quante volte Tizio si è incontrato con delle spie consapevolmente, senza poter recar sorpresa in nessuno.
Q14 §78 Passato e presente. Molti spunti raccolti in questa rubrica di «Passato e presente», in quanto non hanno una portata «storica» concreta, con riferimenti cioè a fatti particolari, possono essere raccolti insieme sul modello dei Ricordi politici e civili del Guicciardini. L’importante è di dar loro la stessa essenzialità e pedagogica universalità e chiarezza, ciò che a dire il vero non è poco, anzi è il tutto, sia stilisticamente, sia teoricamente, cioè come ricerca di verità.
Q14 §79 Passato e presente. È stato osservato che è preferibile il briccone allo sciocco, perché col briccone si può venire a patti e fargli fare il galantuomo per tornaconto, ma dallo sciocco… sequitur quodlibet. È anche vero che il briccone è preferibile al semibriccone. In realtà nella vita non si incontrano mai bricconi dichiarati, tutti d’un pezzo, di carattere, per così dire, ma solo semibricconi, ti vedo e non ti vedo, dalle azioni ambigue, che riuscirebbero sempre a giustificare facendosi applaudire. È da pensare che il briccone sia un’invenzione romantica, oppure sia tale solo quando si incontra con la stupidaggine (ma allora è poco pericoloso perché si scopre da sé). È da osservare che il briccone vero è superiore al galantuomo; infatti: il briccone può anche essere «galantuomo» (cioè può «fare» il galantuomo), mentre il galantuomo non fa bricconerie in nessun caso e per questo appunto è «galantuomo». Stupido davvero chi si aspetta di aver che fare con bricconi dichiarati, patenti, indiscutibili: invece si ha anche troppo spesso a che fare coi semibricconi, che pertanto sono essi i… veri ed unici bricconi, quelli della realtà quotidiana. Per il rapporto «sciocco-briccone» è da ricordare il rapporto «sciocco‑intelligente», nel senso che l’intelligente può fingersi sciocco e riuscire a farsi credere tale, ma lo sciocco non può fingersi intelligente e farsi credere tale, a meno che non trovi gente più sciocca di lui, ciò che non è difficile.
Q14 §80 Giornalismo. Riviste tipo. La rivista di Gentile «Educazione politica» il cui nome fu poi trasformato. Il titolo è vecchio: Arcangelo Ghisleri diresse una rivista di questo titolo e aveva più congruenza col fine proposto. Ma il Ghisleri quante riviste diresse e, a parte l’onestà dell’uomo, con quanta inutilità? È vero che l’educazione può prospettarsi in piani diversi per ottenere livelli diversi. Tutto sta nel livello che crede di avere il «direttore» ed è naturale che i direttori credono sempre di essere al livello più alto e pongono come ideale la loro posizione per il minuto gregge dei lettori.
QUADERNO 15
Quaderno iniziato nel 1933 e scritto senza tener conto delle divisioni di materia e dei raggruppamenti di in quaderni speciali.
Q15 §1 Passato e presente. Studi sulla struttura economica nazionale. Significato esatto delle tre iniziative su cui si è tanto discusso: 1) consorzi obbligatori; 2) Istituto Mobiliare italiano; 3) poteri dello Stato di proibire la creazione di nuove industrie e l’estensione di quelle esistenti (cioè necessità della patente statale per l’iniziativa industriale da un giorno dato); 4) Istituto per la Ricostruzione industriale (diviso in due sezioni giuridicamente autonome: a) sezione finanziamento industriale; b) sezione smobilizzi industriali).
Intanto occorre per ogni istituto una «storia» esatta delle fasi legali attraverso cui è passato e l’identificazione delle cause immediate che ne provocarono la fondazione. Per le prospettive generali di questi istituti, è da tener conto innanzi tutto della particolare funzione svolta dallo Stato italiano in ogni tempo nell’economia in sostituzione della così detta iniziativa privata o assente o «diffidata» dai risparmiatori. La quistione «economica» potrebbe esser questa: se tali istituti non rappresentino una spesa gravosa in confronto di ciò che sarebbe se la loro funzione fosse svolta dall’iniziativa privata. Pare questo un falso problema e non è: certo in quanto manca l’attore privato di una certa funzione e questa è necessaria per svecchiare la vita nazionale, è meglio che lo Stato si assuma la funzione. Ma conviene dirlo apertamente, cioè dire che non si tratta della realizzazione di un progresso effettivo, ma della constatazione di una arretratezza cui si vuole ovviare «ad ogni costo» e pagandone lo scotto. Non è neanche vero che se ne paga lo scotto una volta per tutte: lo scotto che si paga oggi non eviterà di pagare un altro scotto quando dalla nazionalizzazione per rimediare a una certa arretratezza, si passerà alla nazionalizzazione come fase storica organica e necessaria nello sviluppo dell’economia verso una costruzione programmatica. La fase attuale è quella corrispondente, in un certo senso, alle monarchie illuminate del Settecento. Di moderno ha la terminologia esteriore e meccanica, presa da altri paesi dove questa fase è realmente moderna e progressiva.
Q15 §2 Machiavelli. Si pone il problema se i grandi industriali abbiano un partito politico permanente proprio. La risposta mi pare debba essere negativa. I grandi industriali si servono volta a volta di tutti i partiti esistenti, ma non hanno un partito proprio. Essi non sono perciò «agnostici» o «apolitici» in qualsiasi modo: il loro interesse è un determinato equilibrio, che ottengono appunto rafforzando coi loro mezzi, volta a volta, questo o quello dei partiti del vario scacchiere politico (con eccezione, si intende, del solo partito antagonista, il cui rafforzamento non può essere aiutato neppure per mossa tattica). È certo però che se ciò avviene nella vita «normale», nei casi estremi, che poi sono quelli che contano (come la guerra nella vita nazionale), il partito dei grandi industriali è quello degli agrari, i quali hanno invece un proprio partito permanente.
Si può vedere l’esemplificazione di questa nota in Inghilterra, dove il partito conservatore si è mangiato il partito liberale, che pure tradizionalmente appariva come il partito degli industriali. La situazione inglese, con le sue grandi Trade Unions spiega questo fatto. In Inghilterra non esiste formalmente un partito antagonista agli industriali in grande stile, è vero, ma esistono le organizzazioni operaie di massa, ed è stato osservato come esse, in certi momenti, quelli decisivi, si trasformino costituzionalmente dal basso in alto spezzando l’involucro burocratico (es. nel 1919 e nel 1926). D’altronde esistono interessi permanenti stretti tra agrari e industriali (specialmente ora che il protezionismo è diventato generale, agrario e industriale) ed è innegabile che gli agrari sono «politicamente» molto meglio organizzatori degli industriali, attirano più gli intellettuali, sono più «permanenti» nelle loro direttive ecc. La sorte dei partiti «industriali» tradizionali, come quello «liberale‑radicale» inglese e quello radicale francese (che però si differenziò sempre molto dal primo) è interessante (così quello «radicale italiano» di buona memoria): che cosa rappresentavano essi? Un nesso di classi grandi e piccole, non una sola grande classe; perciò il loro vario divenire e sparire; la truppa di «manovra» era data dalla classe piccola, che si trovò in condizioni sempre diverse nel nesso fino a trasformarsi completamente. Oggi dà la truppa ai «partiti demagogici» e si comprende.
In generale si può dire che in questa storia dei partiti, la comparazione tra i vari paesi è delle più istruttive e decisive per trovare l’origine delle cause di trasformazione. Ciò anche nelle polemiche tra partiti dei paesi «tradizionalisti» dove cioè sono rappresentati «scampoli» di tutto il «catalogo» storico.
Q15 §3 Passato e presente. È strano come la identità «Stato‑classe» non essendo di facile comprensione avvenga che un governo (Stato) possa fare rifluire sulla classe rappresentata come un merito e una ragione di prestigio l’aver finalmente fatto ciò che da più di cinquanta anni doveva essere fatto e quindi dovrebbe essere un demerito e una ragione di infamia. Si lascia morire di fame un uomo fino a cinquanta anni; a cinquanta anni ci si accorge di lui. Nella vita individuale ciò sarebbe ragione di una scarica di pedate. Nella vita statale appare un «merito» (Nel ms seguono alcune parole cancellate e rese illeggibili.). Non solo ma il «lavarsi» a cinquanta anni appare superiorità su altri uomini di cinquanta anni che si sono sempre lavati. (Ciò si dice per le bonifiche, i lavori pubblici, le strade ecc. cioè l’attrezzatura civile generale di un paese: che un paese si dia questa attrezzatura che altri si son dati al loro tempo, è conclamato e strombazzato e si dice agli altri: fate altrettanto, se potete. Gli altri non possono, perché l’hanno già fatto al loro tempo e ciò viene presentato come una loro «impotenza»)¹.
Q15 §4 Machiavelli. Elementi di politica. Bisogna proprio dire che i primi ad essere dimenticati sono proprio i primi elementi, le cose più elementari; d’altronde, essi, ripetendosi infinite volte, diventano i pilastri della politica e di qualsivoglia azione collettiva. Primo elemento è che esistono davvero governati e governanti, dirigenti e diretti. Tutta la scienza e l’arte politica si basano su questo fatto primordiale, irriducibile (in certe condizioni generali). Le origini di questo fatto sono un problema a sé, che dovrà essere studiato a sé (per lo meno potrà e dovrà essere studiato come attenuare e far sparire il fatto, mutando certe condizioni identificabili come operose in questo senso), ma rimane il fatto che esistono dirigenti e diretti, governanti e governati. Dato questo fatto sarà da vedere come si può dirigere nel modo più efficace (dati certi fini) e come pertanto preparare nel modo migliore i dirigenti (e in questo più precisamente consiste la prima sezione della scienza e arte politica), e come d’altra parte si conoscono le linee di minore resistenza o razionali per avere l’obbedienza dei diretti o governati.
Nel formare i dirigenti è fondamentale la premessa: si vuole che ci siano sempre governati e governanti oppure si vogliono creare le condizioni in cui la necessità dell’esistenza di questa divisione sparisca? cioè si parte dalla premessa della perpetua divisione del genere umano o si crede che essa sia solo un fatto storico, rispondente a certe condizioni? Occorre tener chiaro tuttavia che la divisione di governati e governanti, seppure in ultima analisi risalga a una divisione di gruppi sociali, tuttavia esiste, date le cose così come sono, anche nel seno dello stesso gruppo, anche socialmente omogeneo; in un certo senso si può dire che essa divisione è una creazione della divisione del lavoro, è un fatto tecnico. Su questa coesistenza di motivi speculano coloro che vedono in tutto solo «tecnica», necessità «tecnica» ecc. per non proporsi il problema fondamentale.
Dato che anche nello stesso gruppo esiste la divisione tra governanti e governati, occorre fissare alcuni principii inderogabili, ed è anzi su questo terreno che avvengono gli «errori» più gravi, che cioè si manifestano le incapacità più criminali, ma più difficili a raddrizzare. Si crede che essendo posto il principio dallo stesso gruppo, l’obbedienza debba essere automatica, debba avvenire senza bisogno di una dimostrazione di «necessità» e razionalità non solo, ma sia indiscutibile (qualcuno pensa e, ciò che è peggio, opera secondo questo pensiero, che l’obbedienza «verrà» senza essere domandata, senza che la via da seguire sia indicata). Così è difficile estirpare dai dirigenti il «cadornismo», cioè la persuasione che una cosa sarà fatta perché il dirigente ritiene giusto e razionale che sia fatta: se non viene fatta, «la colpa» viene riversata su chi «avrebbe dovuto» ecc. Così è difficile estirpare la abitudine criminale di trascurare di evitare i sacrifizi inutili. Eppure il senso comune mostra che la maggior parte dei disastri collettivi (politici) avvengono perché non si è cercato di evitare il sacrifizio inutile, o si è mostrato di non tener conto del sacrifizio altrui e si è giocato, con la pelle altrui. Ognuno ha sentito raccontare da ufficiali del fronte come realmente i soldati arrischiassero la vita quando ciò era necessario, ma come invece si ribellassero quando si vedevano trascurati. Per esempio: una compagnia era capace di digiunare molti giorni perché vedeva che i viveri non potevano giungere per forza maggiore, ma si ammutinava se un pasto solo era saltato per la trascuratezza o il burocratismo ecc.
Questo principio si estende a tutte le azioni che domandano sacrifizio. Per cui sempre, dopo ogni rovescio, occorre prima di tutto ricercare le responsabilità dei dirigenti e ciò in senso stretto (per esempio: un fronte è costituito di più sezioni e ogni sezione ha i suoi dirigenti: è possibile che di una sconfitta siano più responsabili i dirigenti di una sezione che di un’altra, ma si tratta di più e meno, noti di esclusione di responsabilità per alcuno, mai).
Posto il principio che esistono diretti e dirigenti, governati e governanti, è vero che i partiti sono finora il modo più adeguato per elaborare i dirigenti e la capacità di direzione (i «partiti» possono presentarsi sotto i nomi più diversi, anche quello di anti‑partito e di «negazione dei partiti»; in realtà anche i così detti «individualisti» sono uomini di partito, solo che vorrebbero essere «capipartito» per grazia di dio o dell’imbecillità di chi li segue).
Svolgimento del concetto generale che è contenuto nell’espressione «spirito statale». Questa espressione ha un significato ben preciso, storicamente determinato. Ma si pone il problema: esiste qualcosa (di simile) a ciò che si chiama «spirito statale» in ogni movimento serio, cioè che non sia l’espressione arbitraria di individualismi, più o meno giustificati? Intanto lo «spirito statale» presuppone la «continuità» sia verso il passato, ossia verso la tradizione, sia verso l’avvenire, cioè presuppone che ogni atto sia il momento di un processo complesso, che è già iniziato e che continuerà. La responsabilità di questo processo, di essere attori di questo processo, di essere solidali con forze «ig» materialmente, ma che pur si sentono operanti e attive e di cui si tiene conto, come se fossero «materiali» e presenti corporalmente, si chiama appunto in certi casi «spirito statale». È evidente che tale coscienza della «durata» deve essere concreta e non astratta, cioè, in certo senso, non deve oltrepassare certi limiti; mettiamo che i più piccoli limiti siano una generazione precedente e una generazione futura, ciò che non è dir poco, poiché le generazioni si conteranno per ognuna non trenta anni prima e trenta anni dopo di oggi, ma organicamente, in senso storico, ciò che per il passato almeno è facile da comprendere: ci sentiamo solidali con gli uomini che oggi sono vecchissimi e che per noi rappresentano il «passato» che ancora vive fra noi, che occorre conoscere, con cui occorre fare i conti, che è uno degli elementi del presente e delle premesse del futuro. E coi bambini, con le generazioni nascenti e crescenti, di cui siamo responsabili. (Altro è il «culto» della «tradizione» che ha un valore tendenzioso, implica una scelta e un fine determinato, cioè è a base di una ideologia). Eppure, se si può dire che uno «spirito statale» così inteso è in tutti, occorre volta a volta combattere contro deformazioni di esso e deviazioni da esso. «Il gesto per il gesto», la lotta per la lotta ecc. e specialmente l’individualismo gretto e piccino, che poi è un capriccioso soddisfare impulsi momentanei ecc. (In realtà il punto è sempre quello dell’«apoliticismo» italiano che assume queste varie forme pittoresche e bizzarre).
L’individualismo è solo apoliticismo animalesco; il settarismo è «apoliticismo» e se ben si osserva, infatti, il settarismo è una forma di «clientela» personale, mentre manca lo spirito di partito, che è l’elemento fondamentale dello «spirito statale». La dimostrazione che lo spirito di partito è l’elemento fondamentale dello spirito statale è uno degli assunti più cospicui da sostenere e di maggiore importanza; e viceversa che l’«individualismo» è un elemento animalesco, «ammirato dai forestieri» come gli atti degli abitanti di un giardino zoologico.
Q15 §5 Passato e presente. La crisi. Lo studio degli avvenimenti che assumono il nome di crisi e che si prolungano in forma catastrofica dal 1929 ad oggi dovrà attirare speciale attenzione. 1) Occorrerà combattere chiunque voglia di questi avvenimenti dare una definizione unica, o che è lo stesso, trovare una causa o un’origine unica. Si tratta di un processo, che ha molte manifestazioni e in cui cause ed effetti si complicano e si accavallano. Semplificare significa snaturare e falsificare. Dunque: processo complesso, come in molti altri fenomeni, e non «fatto» unico che si ripete in varie forme per una causa ad origine unica. 2) Quando è cominciata la crisi? La domanda è legata alla prima. Trattandosi di uno svolgimento e non di un evento, la quistione è importante. Si può dire che della crisi come tale non vi è data d’inizio, ma solo di alcune «manifestazioni» più clamorose che vengono identificate con la crisi, erroneamente e tendenziosamente. L’autunno del 1929 col crack della borsa di New York è per alcuni l’inizio della crisi e si capisce per quelli che nell’«americanismo» vogliono trovar l’origine e la causa della crisi. Ma gli eventi dell’autunno 1929 in America sono appunto una delle clamorose manifestazioni dello svolgimento critico, niente altro. Tutto il dopoguerra è crisi, con tentativi di ovviarla, che volta a volta hanno fortuna in questo o quel paese, niente altro. Per alcuni (e forse non a torto) la guerra stessa è una manifestazione della crisi, anzi la prima manifestazione; appunto la guerra fu la risposta politica ed organizzativa dei responsabili. (Ciò mostrerebbe che è difficile nei fatti separare la crisi economica dalle crisi politiche, ideologiche ecc., sebbene ciò sia possibile scientificamente, cioè con un lavoro di astrazione). 3) La crisi ha origine nei rapporti tecnici, cioè nelle posizioni di classe rispettive, o in altri fatti? Legislazioni, torbidi ecc.? Certo pare dimostrabile che la crisi ha origini «tecniche» cioè nei rapporti rispettivi di classe, ma che ai suoi inizi,, le prime manifestazioni o previsioni dettero luogo a conflitti di vario genere e a interventi legislativi, che misero più in luce la «crisi» stessa, non la determinarono, o ne aumentarono alcuni fattori. Questi tre punti: 1) che la crisi è un processo complicato; 2) che si inizia almeno con la guerra, se pure questa non ne è la prima manifestazione; 3) che la crisi ha origini interne, nei modi di produzione e quindi di scambio, e non in fatti politici e giuridici, paiono i tre primi punti da chiarire con esattezza.
Altro punto è quello che si dimenticano i fatti semplici, cioè le contraddizioni fondamentali della società attuale, per fatti apparentemente complessi (ma meglio sarebbe dire «lambiccati»). Una delle contraddizioni fondamentali è questa: che mentre la vita economica ha come premessa necessaria l’internazionalismo o meglio il cosmopolitismo, la vita statale si è sempre più sviluppata nel senso del «nazionalismo», «del bastare a se stessi» ecc. Uno dei caratteri più appariscenti della «attuale crisi» è niente altro che l’esasperazione dell’elemento nazionalistico (statale nazionalistico) nell’economia: contingentamenti, clearing, restrizione al commercio delle divise, commercio bilanciato tra due soli Stati ecc. Si potrebbe allora dire, e questo sarebbe il più esatto, che la «crisi» non è altro che l’intensificazione quantitativa di certi elementi, non nuovi e originali, ma specialmente l’intensificazione di certi fenomeni, mentre altri che prima apparivano e operavano simultaneamente ai primi, immunizzandoli, sono divenuti inoperosi o sono scomparsi del tutto. Insomma lo sviluppo del capitalismo è stata una «continua crisi», se così si può dire, cioè un rapidissimo movimento di elementi che si equilibravano ed immunizzavano. Ad un certo punto, in questo movimento, alcuni elementi hanno avuto il sopravvento, altri sono spariti o sono divenuti inetti nel quadro generale. Sono allora sopravvenuti avvenimenti al quali si dà il nome specifico di «crisi», che sono più gravi, meno gravi appunto secondo che elementi maggiori o minori di equilibrio si verificano. Dato questo quadro generale, si può studiare il fenomeno nei diversi piani e aspetti: monetario, finanziario, produttivo, del commercio interno, del commercio internazionale ecc. e non è detto che ognuno di questi aspetti, data la divisione internazionale del lavoro e delle funzioni, nei varii paesi non sia apparso prevalente o manifestazione massima. Ma il problema fondamentale è quello produttivo; e, nella produzione, lo squilibrio tra industrie progressive (nelle quali il capitale costante è andato aumentando) e industrie stazionarie (dove conta molto la mano d’opera immediata). Si comprende che avvenendo anche nel campo internazionale una stratificazione tra industrie progressive e stazionarie, i paesi dove le industrie progressive sovrabbondano hanno sentito più la crisi ecc. Onde illusioni varie dipendenti dal fatto che non si comprende che il mondo è una unità, si voglia o non si voglia, e che tutti i paesi, rimanendo in certe condizioni di struttura, passeranno per certe «crisi». (Per tutti questi argomenti sarà da vedere la letteratura della Società delle Nazioni, dei suoi esperti e della sua commissione finanziaria che servirà almeno ad avere dinanzi tutto il materiale sulla quistione, così anche le pubblicazioni delle più importanti riviste internazionali e delle Camere dei Deputati).
La moneta e l’oro. La base aurea della moneta è resa necessaria dal commercio internazionale e dal fatto che esistono e operano le divisioni nazionali (ciò che porta a fatti tecnici particolari di questo campo da cui non si può prescindere: tra i fatti c’è la rapidità di circolazione che non è un piccolo fatto economico). Dato che le merci si scambiano con le merci, in tutti i campi, la quistione è se questo fatto, innegabile, avvenga in breve o lungo tempo e se questa differenza di tempo abbia la sua importanza. Dato che le merci si scambiano con le merci (intesi tra le merci i servizi) è evidente l’importanza del «credito», cioè il fatto che una massa di merci o servizi fondamentali, che indicano cioè un completo ciclo commerciale, producono dei titoli di scambio e che tali titoli dovrebbero mantenersi uguali in ogni momento (di pari potere di scambio) pena l’arresto degli scambi. È vero che le merci si scambiano con le merci, ma «astrattamente», cioè gli attori dello scambio sono diversi (non c’è il «baratto» individuale, cioè, e ciò appunto accelera il movimento). Perciò se è necessario che nell’interno di uno Stato la moneta sia stabile, tanto più necessario appare sia stabile la moneta che serve agli scambi internazionali, in cui «gli attori reali» scompaiono dietro il fenomeno. Quando in uno Stato la moneta varia (inflazione o deflazione) avviene una nuova stratificazione di classi nel paese stesso, ma quando varia una moneta internazionale (esempio la sterlina, e, meno, il dollaro ecc.) avviene una nuova gerarchia fra gli Stati, ciò che è più complesso e porta ad arresto nel commercio (e spesso a guerre), cioè c’è passaggio «gratuito» di merci e servizi tra un paese e l’altro e non solo tra una classe e l’altra della popolazione. La stabilità della moneta è una rivendicazione, all’interno, di alcune classi e, all’estero (per le monete internazionali, per cui si sono presi gli impegni), di tutti i commercianti; ma perché esse variano? Le ragioni sono molte, certamente: 1) perché lo Stato spende troppo, cioè non vuol far pagare le sue spese a certe classi, direttamente, ma indirettamente ad altre e, se è possibile, a paesi stranieri; 2) perché non si vuole diminuire un costo «direttamente» (esempio il salario) ma solo indirettamente e in un tempo prolungato, evitando attriti pericolosi ecc. In ogni caso, anche gli effetti monetari sono dovuti all’opposizione dei gruppi sociali, che bisogna intendere nel senso non sempre del paese stesso dove il fatto avviene ma di un paese antagonista.
È questo un principio poco approfondito e tuttavia capitale per la comprensione della storia: che un paese sia distrutto dalle invasioni «straniere» o barbariche non vuol dire che la storia di quel paese non è inclusa nella lotta di gruppi sociali. Perché è avvenuta l’invasione? Perché quel movimento di popolazione ecc.? Come, in un certo senso, in uno Stato, la storia è storia delle classi dirigenti, così, nel mondo, la storia è storia degli Stati egemoni. La storia degli Stati subalterni si spiega con la storia degli Stati egemoni. La caduta dell’Impero Romano si spiega collo svolgimento della vita dell’Impero Romano stesso, ma questo dice perché «mancavano» certe forze, cioè è una storia negativa e perciò lascia insoddisfatti. La storia della caduta dell’Impero Romano è da ricercare nello sviluppo delle popolazioni «barbariche» e anche oltre, perché spesso i movimenti delle popolazioni barbariche erano conseguenze «meccaniche» (cioè poco conosciute) di altro movimento affatto sconosciuto. Ecco perché la caduta dell’Impero Romano dà luogo a «brani oratorii» e viene presentata come un enigma: 1) perché non si vuole riconoscere che le forze decisive della storia mondiale non erano allora nell’Impero Romano (fossero pure forze primitive); 2) perché di tali forze mancano i documenti storici. Se c’è enigma, non si tratta di cose «inconoscibili» ma semplicemente «sconosciute» per mancanza di documenti. Rimane da vedere la parte negativa: «perché l’Impero si fece battere?», ma appunto lo studio delle forze negative è quello che soddisfa di meno e a ragione, perché di per sé presuppone l’esistenza di forze positive e non si vuol mai confessare di non conoscere queste. Nella quistione dell’impostazione storica della caduta dell’Impero Romano entrano in gioco anche elementi ideologici, di boria, che sono tutt’altro che trascurabili.
Q15 §6 Machiavelli. Concezioni del mondo e atteggiamenti pratici totalitari e parziali. Un criterio primordiale di giudizio sia per le concezioni del mondo, sia e specialmente per gli atteggiamenti pratici è questo: la concezione del mondo o l’atteggiamento pratico può essere concepito «isolato, indipendente» con tutta la responsabilità della vita collettiva su di sé, o ciò è impossibile e la concezione del mondo e l’atteggiamento pratico può solo essere concepito come «integrazione», perfezionamento, contrappeso ecc. di un’altra concezione del mondo e atteggiamento pratico? Se si riflette, si vede che questo criterio è decisivo per un giudizio ideale sui moti ideali e sui moti pratici e si vede anche che esso ha una portata pratica non piccola. Uno degli idoli più comuni è quello di credere che tutto ciò che esiste è «naturale» esista, non può a meno di esistere e che i propri tentativi di riforma, per male che vadano, non interromperanno la vita, perché le forze tradizionali continueranno ad operare e appunto continueranno la vita. In questo modo di pensare c’è del giusto, certamente, e guai se così non fosse, tuttavia questo modo di pensare oltre certi limiti diventa pericoloso (certi casi della politica del peggio) e in ogni modo, come si è detto, sussiste il criterio di giudizio filosofico, politico e storico. È certo che, se si osserva in fondo, certi moti concepiscono se stessi come marginali; presuppongono cioè un moto principale in cui innestarsi per riformare certi presunti o veri mali, cioè certi moti sono puramente riformistici. Questo principio ha importanza politica perché la verità teorica che ogni classe ha un solo partito è dimostrata, nelle svolte decisive, dal fatto che aggruppamenti varii, ognuno dei quali si presentava come partito «indipendente», si riuniscono e bloccano in unità. La molteplicità esistente prima era solo di carattere «riformistico», cioè riguardava questioni parziali, in un certo senso era una divisione del lavoro politico (utile, nei suoi limiti); ma ogni parte presupponeva l’altra, tanto che nei momenti decisivi, cioè appunto quando le quistioni principali sono state messe in gioco, l’unità si è formata, il blocco si è verificato. Da ciò la conclusione che nella costruzione dei partiti, occorre basarsi su un carattere «monolitico» e non su quistioni secondarie, quindi attenta osservazione che ci sia omogeneità tra dirigenti e diretti, tra capi e massa. Se nei momenti decisivi, i capi passano al loro «vero partito» le masse rimangono in tronco, inerti e senza efficacia.
Si può dire che nessun moto reale acquista coscienza della stia totalitarietà d’un colpo, ma solo per esperienze successive, cioè quando s’accorge, dai fatti, che niente di ciò che è, è naturale (nel senso bislacco della parola) ma esiste perché ci sono certe condizioni, la cui sparizione non rimane senza conseguenze. Così il moto si perfeziona, perde i caratteri di arbitrarietà, di «simbiosi», diventa davvero indipendente, nel senso che per avere certe conseguenze crea le premesse necessarie e anzi sulla creazione di queste premesse impegna tutte le sue forze.
Q15 §7 Machiavelli. Elezioni. In un giornale polacco (la «Gazeta Polska» degli ultimi giorni di gennaio o dei primi di febbraio del 1933) si trova questo enunciato: «Il potere si conquista sempre con un grande plebiscito. Si vota o con delle schede elettorali o con delle fucilate. Il primo metodo è quantitativo, il secondo qualitativo. Col primo bisogna contare sulla maggioranza dei piccoli, col secondo sulla minoranza dei grandi caratteri». Qualche verità affogata in grandi vasche di spropositi. Perché la «fucilata» deve sempre coincidere col grande carattere? Perché chi spara deve sempre essere un grande carattere? Spesso questi grandi caratteri si arruolano con poche lire al giorno, cioè spesso la «fucilata» è più economica dell’elezione, ecco tutto. Dopo il suffragio universale, corrompere l’elettore è diventato caruccio; con venti lire e un fucile si sbandano venti elettori. La legge del tornaconto funziona anche per i «grandi caratteri» di cui parla la «Gazeta Polska».
Q15 §8 Machiavelli. Diritto naturale. Uno degli imparaticci dei teorici di origine nazionalista (es. M. Maraviglia) è quello di contrapporre la storia al diritto naturale. Ma cosa significa una tale contrapposizione? Nulla o solo la con fusione nel cervello dello scrittore. Intanto il «diritto naturale» è un elemento della storia, indica un «senso comune politico e sociale» e come tale è un «fermento» di operosità. La quistione potrebbe esser questa: che un teorico spieghi i fatti col così detto «diritto naturale», ma questo è un problema di carattere individuale, di critica a opere individuali ecc. e in fondo non è altro che critica al «moralismo» come canone d’interpretazione storica, Roba che ha la barba. Ma in realtà, al di sotto di questo sproposito c’è un interesse concreto. Quello di voler sostituire un «diritto naturale» a un altro. E infatti tutta la teoria nazionalista non è basata su «diritti naturali»? Si vuole al modo di pensare «popolare» sostituire un modo di pensare non popolare, altrettanto mancante di critica del primo.
Q15 §9 autobiografiche. Come ho cominciato a giudicare con maggiore indulgenza le catastrofi del carattere. Per esperienza del processo attraverso cui tali catastrofi avvengono. Nessuna indulgenza per chi compie un atto contrario ai suoi principii «repentinamente» e intendo repentinamente in questo senso: per non aver pensato che il rimaner fermi in certi principii avrebbe procurato sofferenze e non averle prevedute. Chi, trovatosi d’un tratto dinanzi alla sofferenza, prima ancora di soffrirla o all’inizio della sofferenza, muta atteggiamento, non merita indulgenza. Ma il caso si pone in forme complesse. È strano che di solito si sia meno indulgenti coi mutamenti «molecolari» che con quelli repentini. Ora il movimento «molecolare» è il più pericoloso, ché, mentre dimostra nel soggetto la volontà di resistere, «fa intravedere» (a chi riflette) un mutamento progressivo della personalità morale che a un certo punto da quantitativo diventa qualitativo: cioè non si tratta più in verità, della stessa persona, ma di due. (S’intende che «indulgenza» non significa altro che mancanza di filisteismo morale, non già che non si tenga conto del mutamento e non si sanzioni; la mancanza di sanzione significherebbe «glorificazione» o per lo meno «indifferenza» al fatto e ciò non permetterebbe di distinguere la necessità e la non necessità, la forza maggiore e la vigliaccheria). Si è formato il principio che un capitano non debba abbandonare la nave naufragata che per ultimo, quando tutti si sono salvati, anzi si giunge in alcuni ad affermare che in tali casi il capitano «deve» ammazzarsi. Queste affermazioni sono meno irrazionali di quanto potrebbe sembrare. Certo non è escluso che non ci sia nulla di male a che un capitano si salvi per il primo. Ma se questa constatazione diventasse un principio, quale garanzia si avrebbe che il capitano ha fatto di tutto: 1) perché il naufragio non avvenga; 2) perché, avvenuto, tutto è stato fatto per ridurre al minimo i danni delle persone e delle cose? (danni delle cose significa poi danno futuro delle persone). Solo il principio, divenuto «assoluto», che il capitano, in caso di naufragio, abbandona per ultimo la nave e anzi muore con essa, dà questa garanzia, senza cui la vita collettiva è impossibile, cioè nessuno prenderebbe impegni e opererebbe abbandonando ad altri la propria sicurezza personale. La vita moderna è fatta in gran parte di questi stati d’animo o «credenze» forti come i fatti materiali.
La sanzione di questi mutamenti, per tornare all’argomento, è un fatto politico, non morale, dipende non da un giudizio morale, ma da uno di «necessità» per l’avvenire, nel senso che se così non si facesse, danni maggiori potrebbero venire: in politica è giusta una «ingiustizia» piccola per evitarne una più grande ecc.
Dico che è «moralmente» più giustificabile chi si modifica «molecolarmente» (per forza maggiore, s’intende) che chi si modifica d’un tratto, sebbene di solito si ragioni diversamente. Si sente dire: «Ha resistito per cinque anni, perché non per sei? Poteva resistere un altro anno e trionfare». Intanto in questo caso si tratta del senno di poi, perché al quinto anno il soggetto non sapeva che «solo» un altro anno di sofferenze lo aspettava. Ma a parte questo: la verità è che l’uomo del quinto anno non è quello del quarto, del terzo, del secondo, del primo ecc.; è una nuova personalità, completamente nuova, nella quale gli anni trascorsi hanno appunto demolito i freni morali, le forze di resistenza che caratterizzavano l’uomo del primo anno. Un esempio tipico è quello del cannibalismo. Si può dire che al livello attuale della civiltà, il cannibalismo ripugna talmente che una persona comune è da credere quando dice: – messo al bivio di essere cannibale, mi ammazzerei. Nella realtà, quella stessa persona, se dovesse trovarsi dinanzi al bivio: «essere cannibale o ammazzarsi» non ragionerebbe più così, perché sarebbero avvenute tali modificazioni nel suo io, che l’«ammazzarsi» non si presenterebbe più come alternativa necessaria: egli diventerebbe cannibale senza pensare per nulla ad ammazzarsi. Se Tizio, nel pieno delle sue forze fisiche e morali viene messo al bivio, c’è una probabilità che s’ammazzi (dopo essersi persuaso che non si tratta di una commedia ma di cosa reale, di alternativa seria); ma questa probabilità non esiste più (o almeno diminuisce molto) se Tizio si trova al bivio dopo aver subito un processo molecolare in cui le sue forze fisiche e morali sono andate distrutte. Ecc.
Così vediamo uomini normalmente pacifici, dare in scoppi repentini di ira e ferocia. Non c’è, in realtà, niente di repentino: c’è stato un processo «invisibile» e molecolare in cui le forze morali che rendevano «pacifico» quell’uomo, si sono dissolte. Questo fatto da individuale può essere considerato collettivo (si parla allora della «goccia che ha fatto traboccare il vaso» ecc.). Il dramma di tali persone consiste in ciò: Tizio prevede il processo di disfacimento, cioè prevede che diventerà… cannibale, e pensa: se ciò avverrà, a un certo punto del processo mi ammazzo. Ma questo «punto» quale sarà? In realtà ognuno fida nelle sue forze e spera nei casi nuovi che lo tolgano dalla situazione data. E così avviene che (salvo eccezioni) la maggior parte si trova in pieno processo di trasformazione oltre quel punto in cui le sue forze ancora erano capaci di reagire sia pure secondo l’alternativa del suicidio.
Questo fatto è da studiare nelle sue manifestazioni odierne. Non che il fatto non si sia verificato nel passato, ma è certo che nel presente ha assunto una sua forma speciale e… volontaria. Cioè oggi si conta che esso avvenga e l’evento viene preparato sistematicamente, ciò che nel passato non avveniva (sistematicamente vuol dire però «in massa» senza escludere naturalmente le particolari «attenzioni» ai singoli). È certo che oggi si è infiltrato un elemento «terroristico» che non esisteva nel passato, di terrorismo materiale e anche morale, che non è sprezzabile. Ciò aggrava la responsabilità di coloro che, potendo, non hanno, per imperizia, negligenza, o anche volontà perversa, impedito che certe prove fossero passate. Contro questo modo di vedere antimoralistico c’è la concezione falsamente eroica, retorica, fraseologica, contro la quale ogni sforzo di lotta è poco.
Q15 §10 Machiavelli. Sociologia e scienza politica (vedere i paragrafi sul Saggio popolare). La fortuna della sociologia è in relazione con la decadenza del concetto di scienza politica e di arte politica verificatasi nel secolo XIX (con più esattezza nella seconda metà, con la fortuna delle dottrine evoluzionistiche e positivistiche). Ciò che di realmente importante è nella sociologia non è altro che scienza politica. «Politica» divenne sinonimo di politica parlamentare o di cricche personali. Persuasione che con le costituzioni e i parlamenti si fosse iniziata un’epoca di «evoluzione» «naturale», che la società avesse trovato i suoi fondamenti definitivi perché razionali ecc. ecc. Ecco che la società può essere studiata col metodo delle scienze naturali. Impoverimento del concetto di Stato conseguente a tal modo di vedere. Se scienza politica significa scienza dello Stato e Stato è tutto il complesso di attività pratiche e teoriche con cui la classe dirigente giustifica e mantiene il suo dominio non solo ma riesce a ottenere il consenso attivo dei governati, è evidente che tutte le quistioni essenziali della sociologia non sono altro che le quistioni della scienza politica. Se c’è un residuo, questo non può essere che di falsi problemi cioè di problemi oziosi. La quistione che pertanto si poneva all’autore del Saggio popolare era quella di determinare in che rapporti poteva essere posta la scienza politica con la filosofia della praxis, se tra le due esiste identità (cosa non sostenibile, o sostenibile solo da un punto di vista del più gretto positivismo) o se la scienza politica è l’insieme di principii empirici o pratici che si deducono da una più vasta concezione del mondo o filosofia propriamente detta, o se questa filosofia è solo la scienza dei concetti o categorie generali che nascono dalla scienza politica ecc. Se è vero che l’uomo non può essere concepito se non come uomo storicamente determinato, cioè che si è sviluppato e vive in certe condizioni, in un determinato complesso sociale o insieme di rapporti sociali, si può concepire la sociologia come studio solo di queste condizioni e delle leggi che ne regolano lo sviluppo? Poiché non si può prescindere dalla volontà e dall’iniziativa degli uomini stessi, questo concetto non può non essere falso.
Il problema di che cosa è la «scienza» stessa è da porre. La scienza non è essa stessa «attività politica» e pensiero politico, in quanto trasforma gli uomini, li rende diversi da quelli che erano prima? Se tutto è «politico» occorre, per non cadere in un frasario tautologico e noioso distinguere con concetti nuovi la politica che corrisponde a quella scienza che tradizionalmente si chiama «filosofia», dalla politica che si chiama scienza politica in senso stretto. Se la scienza è «scoperta» di realtà ignorata prima, questa realtà non viene concepita come trascendente in un certo senso? e non si pensa che esiste ancora qualcosa di «ignoto» e quindi di trascendente? E il concetto di scienza come «creazione» non significa poi come «politica»? Tutto sta nel vedere se si tratta di creazione «arbitraria» o razionale, cioè «utile» agli uomini per allargare il loro concetto della vita, per rendere superiore (sviluppare) la vita stessa.
A proposito del Saggio popolare e della sua appendice Teoria e pratica è da vedere nella Nuova Antologia del 16 marzo 1933 la rassegna filosofica di Armando Carlini, da cui risulta che l’equazione, Teoria: pratica = matematica pura: matematica applicata, è stata enunziata da un inglese (mi pare Whittaker).
Q15 §11 Machiavelli. Il concetto di «rivoluzione passiva» nel senso di Vincenzo Cuoco attribuita al primo periodo del Risorgimento italiano può essere messo in rapporto col concetto di «guerra di posizione» in confronto alla guerra manovrata? Cioè questi concetti si sono avuti dopo la Rivoluzione francese e il binomio Proudhon‑Gioberti può essere giustificato col panico creato dal terrore del 1793 come il sorellismo col panico successivo alle stragi parigine del 1871? Cioè esiste una identità assoluta tra guerra di posizione e rivoluzione passiva? O almeno esiste o può concepirsi tutto un periodo storico in cui i due concetti si debbano identificare, fino al punto in cui la guerra di posizione ridiventa guerra manovrata? È un giudizio «dinamico» che occorre dare sulle «Restaurazioni» che sarebbero una «astuzia della provvidenza» in senso vichiano. Un problema è questo: nella lotta Cavour‑Mazzini, in cui Cavour è l’esponente della rivoluzione passiva – guerra di posizione e Mazzini dell’iniziativa popolare – guerra manovrata, non sono indispensabili ambedue nella stessa precisa misura? Tuttavia bisogna tener conto che mentre Cavour era consapevole del suo compito (almeno in una certa misura) in quanto comprendeva il compito di Mazzini, Mazzini non pare fosse consapevole del suo e di quello del Cavour; se invece Mazzini avesse avuto tale consapevolezza, cioè fosse stato un politico realista e non un apostolo illuminato (cioè non fosse stato Mazzini) l’equilibrio risultante dal confluire delle due attività sarebbe stato diverso, più favorevole al mazzinianismo: cioè lo Stato italiano si sarebbe costituito su basi meno arretrate e più moderne. E poiché in ogni evento storico si verificano quasi sempre situazioni simili, è da vedere se non si possa trarre da ciò qualche principio generale di scienza e di arte politica. Si può applicare al concetto di rivoluzione passiva (e si può documentare nel Risorgimento italiano) il criterio interpretativo delle modificazioni molecolari che in realtà modificano progressivamente la composizione precedente delle forze e quindi diventano matrice di nuove modificazioni. Così nel Risorgimento italiano si è visto come il passaggio al Cavourrismo dopo il 1848 di sempre nuovi elementi del Partito d’Azione ha modificato progressivamente la composizione delle forze moderate, liquidando il neoguelfismo da una parte e dall’altra impoverendo il movimento mazziniano (a questo processo appartengono anche le oscillazioni di Garibaldi ecc.). Questo elemento pertanto è la fase originaria di quel fenomeno che è stato chiamato più tardi «trasformismo» e la cui importanza non è stata, pare, finora, messa nella luce dovuta come forma di sviluppo storico.
Insistere nello svolgimento del concetto che mentre Cavour era consapevole del suo compito in quanto era consapevole criticamente del compito di Mazzini, Mazzini, per la scarsa o nulla consapevolezza del compito di Cavour, era in realtà anche poco consapevole del suo proprio compito, perciò i suoi tentennamenti (così a Milano nel periodo successivo alle cinque giornate e in altre occasioni) e le sue iniziative fuori tempo, che pertanto diventavano elementi solo utili alla politica piemontese. È questa una esemplificazione del problema teorico del come doveva essere compresa la dialettica, impostato nella Miseria della Filosofia: che ogni membro dell’opposizione dialettica debba cercare di essere tutto se stesso e gettare nella lotta tutte le proprie «risorse» politiche e morali, e che solo così si abbia un superamento reale, non era capito né da Proudhon né da Mazzini. Si dirà che non era capito neanche da Gioberti e dai teorici della rivoluzione passiva e «rivoluzione‑restaurazione», ma la quistione cambia: in costoro la «incomprensione» teorica era l’espressione pratica delle necessità della «tesi» di sviluppare tutta se stessa, fino al punto di riuscire a incorporare una parte dell’antitesi stessa, per non lasciarsi «superare», cioè nell’opposizione dialettica solo la tesi in realtà sviluppa tutte le sue possibilità di lotta, fino ad accaparrarsi i sedicenti rappresentanti dell’antitesi: proprio in questo consiste la rivoluzione passiva o rivoluzione‑restaurazione, Certo è da considerare a questo punto la quistione del passaggio della lotta politica da «guerra manovrata» a «guerra di posizione», ciò che in Europa avvenne dopo il 1848 e che non fu compreso da Mazzini e dai mazziniani come invece fu compreso da qualche altro; lo stesso passaggio si ebbe dopo il 1871 ecc. La quistione era difficile da capire allora per uomini come il Mazzini, dato che le guerre militari non avevano dato il modello, ma anzi le dottrine militari si sviluppavano nel senso della guerra di movimento: sarà da vedere se in Pisacane, che del mazzinianismo fu il teorico militare, ci siano accenni in questo senso. (Sarà da vedere la letteratura politica sul 48 dovuta a studiosi della filosofia della prassi; ma non pare che ci sia molto da aspettarsi in questo senso. Gli avvenimenti italiani, per esempio, furono esaminati solo con la guida dei libri di Bolton King ecc.). Pisacane è tuttavia da vedere perché fu il solo che tentò di dare al Partito d'Azione un contenuto non solo formale, ma sostanziale di antitesi superatrice delle posizioni tradizionali. Né è da dire che per ottenere questi risultati storici fosse necessaria perentoriamente l’insurrezione armata popolare, come pensava Mazzini fino all’ossessione, cioè non realisticamente, ma da missionario religioso. L’intervento popolare che non fu possibile nella forma concentrata e simultanea dell’insurrezione, non si ebbe neanche nella forma «diffusa» e capillare della pressione indiretta, ciò che invece era possibile e forse sarebbe stata la premessa indispensabile della prima forma. La forma concentrata o simultanea era resa impossibile dalla tecnica militare del tempo, ma solo in parte, cioè l’impossibilità esistette in quanto alla forma concentrata e simultanea non fu fatto precedere una preparazione politica ideologica di lunga lena, organicamente predisposta per risvegliare le passioni popolari e renderne possibile la concentrazione e lo scoppio simultaneo.
Dopo il 1848 una critica dei metodi precedenti al fallimento fu fatta solo dai moderati e infatti tutto il movimento moderato si rinnovò, il neoguelfismo fu liquidato, uomini nuovi occuparono i primi posti di direzione. Nessuna autocritica invece da parte del mazzinianismo oppure autocritica liquidatrice, nel senso che molti elementi abbandonarono Mazzini e formarono l’ala sinistra del partito piemontese; unico tentativo «ortodosso», cioè dall’interno, furono i saggi del Pisacane, che però non divennero mai piattaforma di una nuova politica organica e ciò nonostante che il Mazzini stesso riconoscesse che il Pisacane aveva una «concezione strategica» della Rivoluzione nazionale italiana.
Q15 §12 Passato e presente. La saggezza degli zulù ha elaborato questa massima riportata da una rivista inglese: «È meglio avanzare e morire che fermarsi e morire».
Q15 §13 Problemi di cultura. Feticismo. Come si può descrivere il feticismo. Un organismo collettivo è costituito di singoli individui, i quali formano l’organismo in quanto si sono dati e accettano attivamente una gerarchia e una direzione determinata. Se ognuno dei singoli componenti pensa l’organismo collettivo come un’entità estranea a se stesso, è evidente che questo organismo non esiste più di fatto, ma diventa un fantasma dell’intelletto, un feticcio. È da vedere se questo modo di pensare, molto diffuso, non sia un residuo della trascendenza cattolica e dei vecchi regimi paternalistici: esso è comune per una serie di organismi, dallo Stato, alla Nazione, ai Partiti politici ecc. È naturale che avvenga per la Chiesa, poiché, almeno in Italia, il lavorio secolare del centro vaticano per annientare ogni traccia di democrazia interna e di intervento dei fedeli nell’attività religiosa è pienamente riuscito ed è divenuto una seconda natura del fedele, sebbene abbia determinato per l’appunto quella speciale forma di cattolicismo che è propria del popolo italiano. Ciò che fa meraviglia, e che è caratteristico, è che il feticismo di questa specie si riproduca per organismi «volontari», di tipo non «pubblico» o statale, come i partiti e i sindacati. Si è portati a pensare i rapporti tra il singolo e l’organismo come un dualismo, e ad un atteggiamento critico esteriore del singolo verso l’organismo (se l’atteggiamento non è di una ammirazione entusiastica acritica). In ogni caso un rapporto feticistico. Il singolo s’aspetta che l’organismo faccia, anche se egli non opera e non riflette che appunto, essendo il suo atteggiamento molto diffuso, l’organismo è necessariamente inoperante.
Inoltre è da riconoscere che essendo molto diffusa una concezione deterministica e meccanica della storia (concezione che è del senso comune ed è legata alla passività delle grandi masse popolari) ogni singolo, vedendo che, nonostante il suo non intervento, qualcosa tuttavia avviene, è portato a pensare che appunto al disopra dei singoli esiste una entità fantasmagorica, l’astrazione dell’organismo collettivo, una specie di divinità autonoma, che non pensa con nessuna testa concreta, ma tuttavia pensa, che non si muove con determinate gambe di uomini, ma tuttavia si muove ecc.
Potrebbe sembrare che alcune ideologie, come quella dell’idealismo attuale (di Ugo Spirito) per cui si identifica l’individuo e lo Stato, dovrebbero rieducare le coscienze individuali, ma non pare ciò avvenga di fatto, perché questa identificazione è meramente verbale e verbalistica. Così è da dire di ogni forma del così detto «centralismo organico», il quale si fonda sul presupposto, che è vero solo in momenti eccezionali, di arroventatura delle passioni popolari, che il rapporto tra governanti e governati sia dato dal fatto che i governanti fanno gli interessi dei governati e pertanto «devono» averne il consenso, cioè deve verificarsi l’identificazione del singolo col tutto, il tutto (qualunque organismo esso sia) essendo rappresentato dai dirigenti. È da pensare che, come per la Chiesa cattolica, un tale concetto non solo è utile, ma necessario e indispensabile: ogni forma di intervento dal basso, disgregherebbe infatti la Chiesa (si vede ciò nelle chiese protestantiche); ma per altri organismi è quistione di vita non il consenso passivo e indiretto, ma quello attivo e diretto, la partecipazione quindi dei singoli, anche se ciò provoca un’apparenza di disgregazione e di tumulto. Una coscienza collettiva, e cioè un organismo vivente, non si forma se non dopo che la molteplicità si è unificata attraverso l’attrito dei singoli: né si può dire che il «silenzio» non sia molteplicità. Un’orchestra che fa le prove, ogni strumento per conto suo, dà l’impressione della più orribile cacofonia; eppure queste prove sono la condizione perché l’orchestra viva come un solo «strumento».
Q15 §14 Caratteri non popolari‑nazionali della letteratura italiana. Sarà da vedere un discorso sul tema «Gli italiani e il romanzo», tenuto da Angelo Gatti e riprodotto in parte dall’«Italia Letteraria» del 9 aprile 1933. Una notazione interessante pare quella che tocca i rapporti tra moralisti e romanzieri in Francia e in Italia. In Francia il tipo del moralista è ben diverso da quello italiano, che è piuttosto «politico»: l’italiano studia come «dominare», come essere più forte, più abile, più furbo; il francese come «dirigere» e quindi come «comprendere» per influenzare e ottenere un «consenso spontaneo e attivo». I Ricordi politici e civili delGuicciardini, sono di questo tipo. Così in Italia grande abbondanza di libri come il Galateo, in cui si bada all’atteggiamento esteriore delle classi alte. Nessun libro come quelli dei grandi moralisti francesi (o di ordine subalterno come in Gaspare Gozzi), con le loro analisi raffinate e capillari, Questa differenza nel «romanzo» che in Italia è più esteriore, gretto, senza contenuto umano nazionale‑popolare o universale.
Q15 §15 Machiavelli. Il rapporto «rivoluzione passiva ‑ guerra di posizione» nel Risorgimento italiano può essere studiato anche in altri aspetti. Importantissimo quello che si può chiamare del «personale» e l’altro della «radunata rivoluzionaria». Quello del «personale» può essere appunto paragonato a quanto si verificò nella guerra mondiale nel rapporto tra ufficiali di carriera e ufficiali di complemento da una parte e tra soldati di leva e volontari‑arditi dall’altra. Gli ufficiali di carriera corrisposero nel Risorgimento ai partiti politici regolari, organici, tradizionali, ecc., che al momento dell’azione (1848) si dimostrarono inetti o quasi e furono nel 1848‑49 soverchiati dall’ondata popolare‑mazziniana‑democratica, ondata caotica, disordinata, «estemporanca» per così dire, ma che tuttavia, al seguito di capi improvvisati o quasi (in ogni caso non di formazioni precostituite come era il partito moderato) ottennero successi indubbiamente maggiori di quelli ottenuti dai moderati: la Repubblica romana e Venezia mostrarono una forza di resistenza molto notevole. Nel periodo dopo il 48 il rapporto tra le due forze, quella regolare e quella «carismatica» si organizzò intorno a Cavour e Garibaldi e diede il massimo risultato, sebbene questo risultato fosse poi incamerato dal Cavour.
Questo aspetto è connesso all’altro, della «radunata». È da osservare che la difficoltà tecnica contro cui andarono sempre a spezzarsi le iniziative mazziniane fu quella appunto della «radunata rivoluzionaria». Sarebbe interessante, da questo punto di vista, studiare il tentativo di invadere la Savoia col Ramorino, poi quello dei fratelli Bandiera, del Pisacane ecc., paragonato con la situazione che si offrì a Mazzini nel 48 a Milano e nel 49 a Roma e che egli non ebbe la capacità di organizzare. Questi tentativi di pochi non potevano non essere schiacciati in germe, perché sarebbe stato maraviglioso che le forze reazionarie, che erano concentrate e potevano operare liberamente (cioè non trovavano nessuna opposizione in larghi movimenti della popolazione) non schiacciassero le iniziative tipo Ramorino, Pisacane, Bandiera, anche se queste fossero state preparate meglio di quanto furono in realtà. Nel secondo periodo (1859‑60) la radunata rivoluzionaria, come fu quella dei Mille di Garibaldi, fu resa possibile dal fatto che Garibaldi si innestava nelle forze statali piemontesi prima e poi che la flotta inglese protesse di fatto lo sbarco di Marsala, la presa di Palermo, e sterilizzò la flotta borbonica. A Milano dopo le cinque giornate, a Roma repubblicana, Mazzini avrebbe avuto la possibilità di costituire piazze d’armi per radunate organiche, ma non si propose di farlo, onde il suo conflitto con Garibaldi a Roma e la sua inutilizzazione a Milano di fronte a Cattaneo e al gruppo democratico milanese.
In ogni modo lo svolgersi del processo del Risorgimento, se pose in luce l’importanza enorme del movimento «demagogico» di massa, con capi di fortuna, improvvisati ecc., in realtà fu riassunto dalle forze tradizionali organiche, cioè dai partiti formati di lunga mano, con elaborazione razionale dei capi ecc. In tutti gli avvenimenti politici dello stesso tipo sempre si ebbe lo stesso risultato (così nel 1830, in Francia, la prevalenza degli orleanisti sulle forze popolari radicali democratiche, e così in fondo anche nella Rivoluzione Francese del 1789, in cui Napoleone, rappresenta, in ultima analisi, il trionfo delle forze borghesi organiche contro le forze piccolo‑borghesi giacobine). Così nella guerra mondiale il sopravvento dei vecchi ufficiali di carriera su quelli di complemento ecc. (su questo argomento cfr in altri quaderni). In ogni caso, l’assenza nelle forze radicali popolari di una consapevolezza del compito dell’altra parte impedì ad esse di avere piena consapevolezza del loro proprio compito e quindi di pesare nell’equilibrio finale delle forze, in rapporto al loro effettivo peso d’intervento, e quindi di determinare un risultato più avanzato, su una linea di maggiore progresso e modernità.
Q15 §16 Nozioni enciclopediche. Aporia. Dubbio, cioè nesso di pensiero ancora in formazione, pieno di contraddizioni che aspettano una soluzione. Pertanto l’aporia può risolversi, come ogni dubbio, positivamente e negativamente.
Congiuntura. Si può definire la congiuntura come l’insieme delle circostanze che determinano il mercato in una fase data, se però queste circostanze sono concepite come in movimento, cioè come un insieme che dà luogo a un processo di sempre nuove combinazioni, processo che è il ciclo economico. Si studia la congiuntura per prevedere e quindi anche, entro certi limiti, determinare il ciclo economico in senso favorevole agli affari. Perciò la congiuntura è stata anche definita l’oscillazione della situazione economica, o l’insieme delle oscillazioni.
Q15 §17 Machiavelli. Il concetto di rivoluzione passiva deve essere dedotto rigorosamente dai due principii fondamentali di scienza politica: 1) che nessuna formazione sociale scompare fino a quando le forze produttive che si sono sviluppate in essa trovano ancora posto per un loro ulteriore movimento progressivo; 2) che la società non si pone compiti per la cui soluzione non siano già state covate le condizioni necessarie ecc. S’intende che questi principii devono prima essere svolti criticamente in tutta la loro portata e depurati da ogni residuo di meccanicismo e fatalismo. Così devono essere riportati alla descrizione dei tre momenti fondamentali in cui può distinguersi una «situazione» o un equilibrio di forze, col massimo di valorizzazione del secondo momento, o equilibrio delle forze politiche e specialmente del terzo momento o equilibrio politico‑militare. Si può osservare che il Pisacane, nei suoi Saggi, si preoccupa appunto di questo terzo momento: egli comprende, a differenza del Mazzini, tutta l’importanza che ha la presenza in Italia di un agguerrito esercito austriaco, sempre pronto a intervenire in ogni parte della penisola, e che inoltre ha dietro di sé tutta la potenza militare dell’Impero absburgico, cioè una matrice sempre pronta a formare nuovi eserciti di rincalzo.
Altro elemento storico da richiamare è lo sviluppo del Cristianesimo nel seno dell’Impero Romano, così come il fenomeno attuale del Gandhismo in India e la teoria della non resistenza al male di Tolstoi che tanto si avvicinano alla prima fase del Cristianesimo (prima dell’editto di Milano). Il Gandhismo e il tolstoismo sono teorizzazioni ingenue e a tinta religiosa della «rivoluzione passiva». Sono anche da richiamare alcuni movimenti così detti «liquidazionisti» e le reazioni che suscitarono, in rapporto ai tempi e alle forme determinate di situazioni (specialmente del terzo momento).
Il punto di partenza dello studio sarà la trattazione di Vincenzo Cuoco, ma è evidente che l’espressione del Cuoco a proposito della Rivoluzione Napoletana del 1799 non è che uno spunto, poiché il concetto è completamente modificato e arricchito.
Q15 §18 Passato e presente. (cfr nota a p. 2 bis in fondo). Eppure il fatto che lo Stato‑governo, concepito come una forza autonoma, faccia rifluire il suo prestigio sulla classe che ne è il fondamento, è dei più importanti praticamente e teoricamente e merita di essere analizzato in tutta la sua estensione se si vuole avere un concetto più realistico dello Stato stesso. D’altronde non si tratta di cosa eccezionale o che sia propria di un solo tipo di Stato: pare si possa far rientrare nella funzione delle élites o avanguardie, quindi dei partiti, in confronto alla classe che rappresentano. Questa classe, spesso, come fatto economico (e tale è essenzialmente ogni classe) non godrebbe di nessun prestigio intellettuale e morale, cioè sarebbe incapace di esercitare un’egemonia, quindi di fondare uno Stato. Perciò la funzione delle monarchie anche nell’epoca moderna, e perciò specialmente il fatto, verificatosi specialmente in Inghilterra e in Germania, che il personale dirigente della classe borghese organizzata in Stato sia costituito di elementi delle vecchie classi feudali spossessate nel predominio economico (Junker e lords) tradizionale ma che hanno trovato nell’industria e nella banca nuove forme di potenza economica, pur non volendosi fondere con la borghesia e rimanendo uniti al loro gruppo sociale tradizionale.
Q15 §19 Passato e presente. Estrarre da questa rubrica una serie di che siano del tipo dei Ricordi politici e civili del Guicciardini (tutte le proporzioni rispettate). I «Ricordi» sono tali in quanto riassumono non tanto avvenimenti autobiografici in senso stretto (sebbene anche questi non manchino), quanto «esperienze» civili e morali (morali più nel senso etico‑politico) strettamente connesse alla propria vita e ai suoi avvenimenti, considerate nel loro valore universale o nazionale. Per molti rispetti, una tal forma di scrittura può essere più utile che le autobiografie in senso stretto, specialmente se essa si riferisce a processi vitali che sono caratterizzati dal continuo tentativo di superare un modo di vivere e di pensare arretrato come quello che era proprio di un sardo del principio del secolo per appropriarsi un modo di vivere e di pensare non più regionale e da «villaggio», ma nazionale, e tanto più nazionale (anzi nazionale appunto perciò) in quanto cercava di inserirsi in modi di vivere e di pensare europei, o almeno il modo nazionale confrontava coi modi europei, le necessità culturali italiane confrontava con le necessità culturali e le correnti europee (nel modo in cui ciò era possibile e fattibile nelle condizioni personali date, è vero, ma almeno secondo esigenze e bisogni fortemente sentiti in questo senso). Se è vero che una delle necessità più forti della cultura italiana era quella di sprovincializzarsi anche nei centri urbani più avanzati e moderni, tanto più evidente dovrebbe apparire il processo in quanto sperimentato da un «triplice o quadruplice provinciale» come certo era un giovane sardo del principio del secolo.
Q15 §20 Caratteri non nazionali‑popolari della letteratura italiana. Polemica svoltasi nell’«Italia Letteraria», nel «Tevere», nel «Lavoro Fascista», nella «Critica Fascista» tra «contenutisti» e «calligrafi». Pareva da alcuni accenni che Gherardo Casini (Direttore del «Lavoro fascista» e redattore capo della «Critica fascista») dovesse impostare almeno criticamente in modo esatto il problema, ma il suo articolo nella «Critica» del 1° maggio è una delusione. Egli non riesce a definire i rapporti tra «politica» e «letteratura» nel terreno della scienza e dell’arte politica come non riesce a definirli nel terreno della critica letteraria: egli non sa praticamente indicare come possa essere impostata e condotta una lotta o aiutato un movimento per il trionfo di una nuova cultura o civiltà, né si pone il problema del come possa avvenire che una nuova civiltà, affermata come già esistente, possa non avere una sua espressione letteraria e artistica, possa non espandersi nella letteratura, mentre è sempre avvenuto il contrario nella storia, che ogni nuova civiltà, in quanto era tale, anche compressa, combattuta, in tutti i modi impastoiata, si sia precisamente espressa letterariamente prima che nella vita statale, anzi la sua espressione letteraria sia stata il modo di creare le condizioni intellettuali e morali per l’espressione legislativa e statale. Poiché nessuna opera d’arte può non avere un contenuto, cioè non essere legata a un mondo poetico e questo a un mondo intellettuale e morale, è evidente che i «contenutisti» sono semplicemente i portatori di una nuova cultura, di un nuovo contenuto e i «calligrafi» i portatori di un vecchio o diverso contenuto, di una vecchia o diversa cultura (a parte ogni quistione di valore su questi contenuti o «culture» per il momento, sebbene in realtà è proprio il valore delle culture in contrasto e la superiorità di una sull’altra che decide del contrasto). Il problema quindi è di «storicità» dell’arte, di «storicità e perpetuità» nel tempo stesso, è di ricerca del fatto se il fatto bruto, economico‑politico, di forza, abbia (e possa) subìto l’elaborazione ulteriore che si esprime nell’arte o se invece si tratti di pura economicità inelaborabile artisticamente in modo originale in quanto l’elaborazione precedente già contiene il nuovo contenuto, che è nuovo solo cronologicamente. Può avvenire infatti, dato che ogni complesso nazionale è una combinazione spesso eterogenea di elementi, che gli intellettuali di esso, per il loro carattere cosmopolitico, non coincidano col contenuto nazionale, ma con un contenuto preso a prestito da altri complessi nazionali o addirittura cosmopoliticamente astratto. Così il Leopardi si può dire il poeta della disperazione portata in certi spiriti dal sensismo settecentesco, a cui in Italia non corrispondeva lo sviluppo di forze e lotte materiali e politiche caratteristico dei paesi in cui il sensismo era forma culturale organica. Quando nel paese arretrato, le forze civili corrispondenti alla forma culturale si affermano ed espandono, è certo che esse non possono creare una nuova originale letteratura, non solo, ma anzi è naturale che ci sia un «calligrafismo» cioè, in realtà, uno scetticismo diffuso e generico per ogni «contenuto» passionale serio e profondo. Pertanto il «calligrafismo» sarà la letteratura organica di vali complessi nazionali, che come Lao‑tse, nascono già vecchi di ottanta anni, senza freschezza e spontaneità di sentimento, senza «romanticismi» ma anche senza «classicismi» o con un romanticismo di maniera, in cui la rozzezza iniziale delle passioni è quella delle «estati di San Martino», di un vecchio voronovizzato, non di una virilità o maschilità irrompente, così come il classicismo sarà anch’esso di maniera, «calligrafismo» appunto, mera forma come una livrea da maggiordomo. Avremo «strapaese» e «stracittà», e lo «stra» avrà più significato di quanto non sembri.
È da notare inoltre come in questa discussione manchi ogni serietà di preparazione: le teorie del Croce saranno da accogliere o da respingere, ma bisognerebbe conoscerle con esattezza e citarle con scrupolo. Invece è da notare come nella discussione esse siano riferite a orecchio, «giornalisticamente». È evidente che il momento «artistico» come categoria, nel Croce, anche se esso è presentato come momento della pura forma, non è il presupposto di nessun calligrafismo né la negazione di nessun contenutismo, cioè del vivace irrompere di nessun nuovo motivo culturale. Neanche conta, in realtà, il concreto atteggiamento del Croce, come politico, verso questa o quella corrente di passioni e sentimenti; come esteta il Croce rivendica il carattere di liricità dell’arte, anche se come politico rivendichi e lotti per il trionfo di un determinato programma invece che di un altro. Pare anzi che con la sua teoria della circolarità delle categorie spirituali, non possa negarsi che nell’artista il Croce presupponga una forte «moralità», anche se non come fatto morale consideri l’opera d’arte ma come fatto estetico, cioè consideri un momento e non un altro del circolo come quello di cui si tratta. Così, per esempio, nel momento economico considera il «brigantaggio», come l’affare di borsa, ma non pare che come uomo lavori allo sviluppo del brigantaggio più che agli affari di borsa (e si può dire che, in misura della sua importanza politica, il suo atteggiamento non sia senza ripercussione sugli affari di borsa). Questo stesso fatto, della poca serietà della discussione e del non soverchio scrupolo dei disputanti nell’impadronirsi dei termini del problema e nello scrupolo dell’esattezza, non è certo documento che il problema sia vitale e di importanza eccezionale: è una polemica di piccoli e mediocri giornalisti più che i «dolori del parto» di una nuova civiltà letteraria.
Q15 §21 Passato e presente. Se si domanda a Tizio, che non ha mai studiato il cinese e conosce bene solo il dialetto della sua provincia, di tradurre un brano di cinese, egli molto ragionevolmente si meraviglierà, prenderà la domanda in ischerzo e, se si insiste, crederà di essere canzonato, si offenderà e farà ai pugni. Eppure lo stesso Tizio, senza essere neanche sollecitato, si crederà autorizzato a parlare di tutta una serie di quistioni che conosce quanto il cinese, di cui ignora il linguaggio tecnico, la posizione storica, la connessione con altre quistioni, talvolta gli stessi elementi fondamentali distintivi. Del cinese almeno sa che è una lingua di un determinato popolo che abita in un determinato punto del globo: di queste quistioni ignora la topografia ideale e i confini che le limitano.
Q15 §22 Introduzione allo studio della filosofia. Teoria e pratica. Poiché ogni azione è il risultato di volontà diverse, con diverso grado di intensità, di consapevolezza, di omogeneità con l’intiero complesso di volontà collettiva, è chiaro che anche la teoria corrispondente e implicita sarà una combinazione di credenze e punti di vista altrettanto scompaginati ed eterogenei. Tuttavia vi è adesione completa della teoria alla pratica, in questi limiti e in questi termini. Se il problema di identificare teoria e pratica si pone, si pone in questo senso: di costruire, su una determinata pratica, una teoria che coincidendo e identificandosi con gli elementi decisivi della pratica stessa, acceleri il processo storico in atto, rendendo la pratica più omogenea, coerente, efficiente in tutti i suoi elementi, cioè potenziandola al massimo; oppure, data una certa posizione teorica, di organizzare l’elemento pratico indispensabile per la sua messa in opera. L’identificazione di teoria e pratica è un atto critico, per cui la pratica viene dimostrata razionale e necessaria o la teoria realistica e razionale. Ecco perché il problema dell’identità di teoria e pratica si pone specialmente in certi momenti storici così detti di transizione, cioè di più rapido movimento trasformativo, quando realmente le forze pratiche scatenate domandano di essere giustificate per essere più efficienti ed espansive, o si moltiplicano i programmi teorici che domandano di essere anch’essi giustificati realisticamente in quanto dimostrano di essere assimilabili dai movimenti pratici che solo così diventano più pratici e reali.
Q15 §23 Nozioni enciclopediche. Per le espressioni «Zunftbürger» e «Pfahlbürger» o «Pfahlbürgerschaft» impiegate nel Manifesto è da vedere, per le corrispondenti figure italiane, il libro di Arrigo Solmi L’amministrazione finanziaria del regno italico nell’alto Medio Evo, Pavia, 1932, pp. XV‑288, L. 20 (cfr recensione analitica di Piero Pieri nella «Nuova Italia» del 20 gennaio 1933). A Pavia esistevano prima del Mille «alcune arti o professioni di mestiere, tenute quasi in regime di monopolio, sotto la dipendenza della Camera o del Palazzo regio di Pavia». Esse appaiono costituite intorno a persone di maggiore esperienza e responsabilità dette magistri: costoro sono di nomina regia, hanno il governo interno dell’«Arte e ne rispondono verso lo Stato, ma provvedono anche a difendere i privilegi del mestiere e a valorizzarne i prodotti. Nessun artigiano può esercitare l’arte se non è iscritto all’organizzazione, e tutti sono sottoposti a tributi di carattere generale e speciale verso la Camera regia». (Camera: il «ministero delle finanze» d’allora).
Q15 §24 Letteratura italiana. È da tener nota della grande Storia della Letteratura Italiana di Giuseppe Zonta, in quattro grossi volumi, con bibliografiche di Gustavo Balsamo‑Crivelli, pubblicata dall’Utet di Torino, per la speciale attenzione che l’autore pare abbia dato all’influsso sociale nello svolgimento dell’attività letteraria. L’opera, pubblicata a fascicoli dal 1928 al 32 non ha dato luogo a grandi discussioni, a quanto pare dalle pubblicazioni disponibili (letto un solo cenno affrettato nell’«Italia Letteraria»). Lo Zonta, d’altronde, non è il primo venuto nel campo della filologia (cfr il suo L’anima dell’ottocento del 1924).
Q15 §25 Machiavelli. Sempre a proposito del concetto di rivoluzione passiva o rivoluzione‑restaurazione nel Risorgimento italiano è da notare che occorre porre con esattezza il problema che in alcune tendenze storiografiche è chiamato dei rapporti tra condizioni oggettive e condizioni soggettive dell’evento storico. Appare evidente che mai possono Mancare le cosidette condizioni soggettive quando esistano le condizioni oggettive in quanto si tratta di semplice distinzione di carattere didascalico: pertanto è nella misura delle forze soggettive e della loro intensità che può vertere discussione, e quindi nel rapporto dialettico tra le forze soggettive contrastanti. Occorre evitare che la quistione sia posta in termini «intellettualistici» e non storico‑politici. Che la «chiarezza» intellettuale dei termini della lotta sia indispensabile, è pacifico, ma questa chiarezza è un valore politico in quanto diventa passione diffusa ed è la premessa di una forte volontà. Negli ultimi tempi, in molte pubblicazioni sul Risorgimento, è stato «rivelato» che esistevano personalità che vedevano chiaro ecc. (ricordare la valorizzazione dell’Ornato fatta da Piero Gobetti), ma queste «rivelazioni» si distruggono da se stesse appunto perché rivelazioni; esse dimostrano che si trattava di elucubrazioni individuali, che oggi rappresentano una forma del «senno di poi». Infatti mai si cimentarono con la realtà effettuale, mai diventarono coscienza popolare‑nazionale diffusa e operante, Tra il Partito d'Azione e il Partito moderato quale rappresentò le effettive «forze soggettive» del Risorgimento? Certo il Partito moderato, e appunto perché ebbe consapevolezza del compito anche del Partito d'Azione: per questa consapevolezza la sua «soggettività» era di una qualità superiore e più decisiva. Nell’espressione sia pure da sergente maggiore, di Vittorio Emanuele II: «Il Partito d’Azione noi l’abbiamo in tasca» c’è più senso storico‑politico che in tutto Mazzini.
Q15 §26 relle di economia politica. Luigi Einaudi ha raccolto in volume i saggi pubblicati in questi anni di crisi. Uno dei motivi su cui l’Einaudi ritorna più spesso è questo: che dalla crisi si uscirà quando l’inventività degli uomini avrà ripreso un certo slancio. Non pare che l’affermazione sia esatta da nessun punto di vista. È certo che il periodo di sviluppo delle forze economiche è stato caratterizzato anche dalle invenzioni, ma è esatto che in questo ultimo periodo le invenzioni siano state meno essenziali e anche meno numerose? Non pare: si può dire, tutt’al più, che hanno colpito meno le immaginazioni, appunto perché precedute da un periodo di tipo simile, ma più originale. Tutto il processo di razionalizzazione non è che un processo di «inventività», di applicazioni di nuovi ritrovati tecnici e organizzativi. Pare che l’Einaudi intenda per invenzioni solo quelle che portano all’introduzione di nuovi tipi di merci, ma anche da questo punto di vista forse l’affermazione non è esatta. In realtà però le invenzioni essenziali sono quelle che determinano una diminuzione dei costi, quindi allargano i mercati di consumo, unificano sempre più vaste masse umane ecc.; da questo punto di vista quale periodo è stato più «inventivo» di quello della razionalizzazione? Anche troppo inventivo, a quanto pare, fino all’«invenzione» della vendita a rate e della creazione artificiosa di nuovi bisogni nel consumo popolare. La verità è che pare quasi impossibile creare «bisogni» nuovi essenziali da soddisfare, con nuove industrie completamente originali, tali da determinare un nuovo periodo di civiltà economica corrispondente a quello dello sviluppo della grande industria. Oppure questi «bisogni» sono propri di strati della popolazione socialmente non essenziali e il cui diffondersi sarebbe morboso (cfr l’invenzione della «seta artificiale» che soddisfa il bisogno di un lusso apparente dei ceti medio borghesi).
Q15 §27 Passato e presente. Poiché oggi la storia del Socialnazionalismo tedesco sarà scritta piuttosto a scopi aulici, occorrerà ricordare il volume di Conrad Heiden, Geschichte des Nazionalsozialismus, die Karriere einer Idee, Berlino, Rowohlt, 1932, in 16°, pp. 305 (cfr recensione di Delio Cantimori nel «Leonardo» del marzo 1933).
Q15 §28 Storia delle classi subalterne. Di Lucien Herr sono stati pubblicati nel 1932 due volumi di Choix d’écrits (Paris, Rieder, in 16°, pp. 282 e 292) in cui è riprodotto l’articolo su Hegel scritto nel 1890 nella Grande Encyclopédie, e i frammenti di un altro studio, al quale lo Herr attendeva nel 1893. Un motivo (al quale accenna il Croce nella «Critica» del gennaio 1933) e che potrebbe essere alla base del pensiero di Engels sul passaggio dal regno della necessità a quello della libertà e dell’ipotesi di un avvenire senza lotta e antagonismi dialettici, è contenuto in questo frammento, là dove lo Herr spiega (secondo le parole del Croce) «per quale processo mentale il filosofo tedesco fosse tratto a pensare che lo Stato politico (al pari della religione) aveva terminato il suo svolgimento, aveva toccato nella sua sfera l’assolutezza (come la religione col cristianesimo), e che perciò non c’era più luogo per rivoluzioni e tendenze a rivoluzioni. Si era entrati nell’età della vita contemplativa, della Filosofia: si era oltrepassato il mondo pel “sopramondo”. Questo tratto antistorico c’era veramente in Hegel storicissimo». Accenni alla funzione avuta dallo Herr nel movimento popolare francese si trovano nelle lettere di Sorel a Lagardelle pubblicate nell’«Educazione Fascista» del 1933.
Q15 §29 Introduzione allo studio della filosofia. Sul così detto «individualismo», cioè sull’atteggiamento che ogni periodo storico ha avuto della posizione dell’individuo nel mondo e nella vita storica. Ciò che oggi si chiama «individualismo» ha avuto origine nella rivoluzione culturale successa al Medio Evo (Rinascimento e Riforma) e indica una determinata posizione verso il problema della divinità e quindi della Chiesa: è il passaggio dal pensiero trascendente all’immanentismo. Pregiudizi contro l’individualismo, fino a ripetere contro di esso le geremiadi, più che critiche, del pensiero cattolico e retrivo. L’«individualismo» che è diventato antistorico oggi è quello che si manifesta nell’appropriazione individuale della ricchezza, mentre la produzione della ricchezza si è andata sempre più socializzando. Che i cattolici poi siano i meno adatti a gemere sull’individualismo si può dedurre dal fatto che essi sempre, politicamente, hanno riconosciuto una personalità politica solo alla proprietà, cioè l’uomo valeva non per sé, ma in quanto integrato da beni materiali. Cosa significava il fatto che si era elettori in quanto si aveva un censo e che si apparteneva a tante comunità politico‑amministrative in quante comunità si aveva beni materiali, se non un abbassamento dello «spirito» di fronte alla «materia»? Se è concepito «uomo» solo chi possiede, e se è diventato impossibile che tutti possiedano, perché sarebbe antispirituale il cercare una forma di proprietà in cui le forze materiali integrino e contribuiscano a costituire tutte le personalità? In realtà, implicitamente si riconosceva che la «natura» umana era non dentro l’individuo, ma nell’unità dell’uomo e delle forze materiali: pertanto la conquista delle forze materiali è un modo, e il più importante, di conquistare la personalità. (In questi ultimi tempi è stato molto lodato un libro del giovane scrittore cattolico francese Daniel Rops Le monde sans âme, Parigi, Plon, 1932, tradotto anche in Italia, in cui sarebbe da prendere in esame tutta una serie di concetti attraverso i quali, sofisticamente, si rimettono in onore posizioni del passato come fossero di attualità ecc.).
Q15 §30 Americanismo. Il Duhamel ha espresso l’idea che un paese di alta civiltà debba fiorire anche artisticamente. Ciò è stato detto per gli Stati Uniti, e il concetto è esatto: ma è esatto in ogni momento dello sviluppo di un paese? Ricordare la teoria americana che in ogni periodo di civiltà i grandi uomini esprimono l’attività fondamentale dell’epoca, che è anch’essa unilaterale. Mi pare che le due idee possono accordarsi nella distinzione tra fase economica corporativa di uno Stato e fase etico‑politica. La fioritura artistica per gli Stati Uniti può concepirsi essere quella europea, data l’omogeneità nelle forme di vita civile; così in un certo periodo l’Italia produceva artisti per tutta la cosmopoli europea ecc. I paesi allora «tributari» dell’Italia si sviluppavano «economicamente» e a questo sviluppo è successa una propria fioritura artistica, mentre l’Italia è decaduta: così è avvenuto dopo il Rinascimento per rispetto alla Francia, alla Germania, all’Inghilterra. Un elemento storico molto importante nello studio delle «fioriture artistiche» è il fatto della continuità dei gruppi intellettuali, cioè dell’esistenza di una forte tradizione culturale, ciò che appunto è mancato in America. Un altro elemento negativo, da questo punto di vista, è certamente rappresentato da ciò, che la popolazione americana non si è sviluppata organicamente su una base nazionale, ma è il prodotto di una continua giustapposizione di nuclei emigrati, sia pure emigrati da paesi anglosassoni.
Q15 §31 Introduzione allo studio della filosofia. Dal Saggio popolare e da altre pubblicazioni dello stesso genere si può trarre la dimostrazione del modo acritico con cui determinati concetti e nessi di concetti sono stati accolti da sviluppi delle filosofie tradizionali i più disparati e contraddittori. Occorrerebbe fare la storia di ognuno di tali concetti, riportarlo alle sue origini e riassumerne le critiche a cui ha già dato luogo. L’origine di molti spropositi contenuti nel Saggio è da ricercarsi nell’Antidühring e nel tentativo, troppo esteriore e formale, di elaborare un sistema di concetti, intorno al nucleo originario di filosofia della praxis, che soddisfacesse il bisogno scolastico di compiutezza. Invece di fare lo sforzo di elaborare questo nucleo stesso, si sono prese affermazioni già in circolazione nel mondo della cultura e sono state assunte come omogenee a questo nucleo originario, affermazioni che erano state già criticate ed espulse da forme di pensiero superiore, anche se non superiore alla filosofia della praxis.
Q15 §32 Storia del Risorgimento. Polemica tra B. Spaventa e il padre Taparelli della «Civiltà Cattolica» sui rapporti tra Stato e Chiesa. È da confrontare la raccolta degli scritti dello Spaventa fatta da G. Gentile: La politica dei gesuiti nel secolo XVI e nel XIX, ediz. Albrighi e Segati, 1911. È da notare anche la prefazione del Gentile, che deve essere messa in rapporto con gli atteggiamenti del Gentile stesso a proposito del Concordato.
A proposito dei rapporti tra Stato e Chiesa è da vedere l’atteggiamento del gruppo del «Saggiatore» (nel febbraio 1933 un articolo in proposito, al quale si accenna nella «Critica Fascista» del 1° maggio). La formula della religione «affare privato» è di origine liberale e non propria della filosofia della praxis come crede il collaboratore di «Critica». Evidentemente è una formula politica immediata, che può essere fatta propria come formula di compromesso, in quanto non si vuole scatenare una guerra religiosa, né ricorrere alla forza materiale ecc. Dalla polemica dello Spaventa appare che neanche per i liberali la religione è un affare privato in senso assoluto, ma liberalismo ha sempre più significato un metodo di governo e sempre meno una concezione del mondo e pertanto è nata la formula come formula «permanente».
Q15 §33 Introduzione allo studio della filosofia. Ecco come nella «Critica fascista» del 1° maggio 1933 è riassunto il punto di vista del «Saggiatore»: «Siamo ... nel campo dell’oggettivismo assoluto. Solo criterio di verità è l’esperimento, l’immanenza del pensiero nel realmente saputo. 1 Sola mediazione fra il pensiero e il reale, la scienza 2. E realmente voluto è solo quello che l’uomo può fare, e fa, nella sua vita storica, che è vita associata circostanziata, definita dai concreti compiti emergenti dallo svolgimento. Di questa attività umana, che si realizza nella storia, lo Stato 3 è il controllo e la misura. Esso distingue, praticamente, fra quelle che sono le velleità vaganti dell’individuo disperso e le effettuali posizioni di una volontà operosa che la storia sancisce, unificandole e facendole durevoli nelle creazioni collettive». (1. o nel realmente vissuto? cioè nell’identità di teoria e pratica? 2. ma la scienza non è anch’essa pensiero? invece di scienza, tecnologia, e allora, tra scienza e reale sola mediazione la tecnologia; 3. ma cosa significa Stato? Solo l’apparato statale o tutta la società civile organizzata? O l’unità dialettica tra il potere governativo e la società civile?)
I punti di vista del gruppo del «Saggiatore» sono interessanti in quanto dimostrano l’insofferenza per i sistemi filosofici verbalistici, ma esso stesso è un qualcosa di indistinto e incondito. È però un documento di quanto la cultura moderna sia permeata dei concetti realistici della filosofia della praxis. È da notare come contemporaneamente (cfr stesso articolo della «Critica Fascista») si moltiplichino le cosidette «ricerche di Dio»: «G. Gentile, in scritti recenti, si offriva a provare l’esistenza di Dio con argomenti attualistici» (è da vedere cosa intende dire il Gentile e se non giuochi sull’equivoco); «Il Prof. Carlini, ... ha svolto, in “Vita e Pensiero”, una lunga polemica con Mons. Olgiati, … polemica raccolta ora in volume – su la neo‑scolastica, l’idealismo e lo spiritualismo: in altri termini, sul problema di Dio». Nel «Leonardo» del marzo 1933, il Carlini passa in rassegna una serie di volumi sul «problema di Dio», specialmente francesi.
Q15 §34 Passato e presente. Stella Nera. Giovanni Ansaldo compila a Genova un «Raccoglitore Ligure», «una pubblicazione di studi e di ricerche non solo folkloristiche ma bene spesso storiche, letterarie, artistiche, compilata con tutti i sette sacramenti da “Stella Nera”, il quale vi mette a partito quel suo particolarissimo gusto per l’erudizione spicciola, e per la “trouvaille” storicistica, coadiuvato da un gruppetto di vere e proprie “competenze”» («Italia Letteraria», 19 febbraio 1933). Pare sia la giusta conclusione delle tendenze intellettuali dell’Ansaldo questa letteratura di tipo «gesuitico» o da «Giornale dei cretini e dei curiosi», come avrebbe detto Edoardo Scarfoglio.
Q15 §35 Passato e presente. Storia dei 45 cavalieri ungheresi. Ettore Ciccotti, durante il governo Giolitti di prima del 1914, soleva spesso ricordare un episodio della guerra dei Trent’Anni: pare che 45 cavalieri ungari si fossero stabiliti nelle Fiandre e poiché la popolazione era stata disarmata e demoralizzata dalla lunga guerra, siano riusciti per oltre sei mesi a tiranneggiare il paese. In realtà, in ogni occasione è possibile che sorgano «45 cavalieri ungari», là dove non esiste un sistema protettivo delle popolazioni inermi, disperse, costrette al lavoro per vivere e quindi non in grado, in ogni momento, di respingere gli assalti, le scorrerie, le depredazioni, i colpi di mano eseguiti con un certo spirito di sistema e con un minimo di previsione «strategica». Eppure a quasi tutti pare impossibile che una situazione come questa da «45 cavalieri ungari» possa mai verificarsi: e in questa «miscredenza» è da vedere un documento di innocenza politica. Elementi di tale «miscredenza» sono specialmente una serie di «feticismi», di idoli, prima fra tutti quello del «popolo» sempre fremente e generoso contro i tiranni e le oppressioni. Ma forse che, proporzionalmente, sono più numerosi gli inglesi in India di quanto fossero i cavalieri ungari nelle Fiandre? E ancora: gli inglesi hanno i loro seguaci fra gli indiani, quelli che stanno sempre col più forte, non solo, ma anche dei seguaci «consapevoli», coscienti, ecc. Non si capisce che in ogni situazione politica la parte attiva è sempre una minoranza, e che se questa, quando è seguita dalle moltitudini, non organizza stabilmente questo seguito, e viene dispersa, per un’occasione qualsiasi propizia alla minoranza avversa, tutto l’apparecchio si sfascia e se ne forma uno nuovo, in cui le vecchie moltitudini non contano nulla e non possono più muoversi e operare. Ciò che si chiamava «massa» è stata polverizzata in tanti atomi senza volontà e orientamento e una nuova «massa» si forma, anche se di volume inferiore alla prima, ma più compatta e resistente, che ha la funzione di impedire che la primitiva massa si riformi e diventi efficiente. Tuttavia molti continuano a richiamarsi a questo fantasma del passato, lo immaginano sempre esistente, sempre fremente ecc. Così il Mazzini immaginava sempre l’Italia del 48 come un’entità permanente che occorreva solo indurre, con qualche artifizio, a ritornare in piazza ecc. L’errore è anche legato a un’assenza di «sperimentalità»: il politico realista, che conosce le difficoltà di organizzare una volontà collettiva, non è portato a credere facilmente che essa si riformi meccanicamente dopo che si è disgregata. L’ideologo, che come il cuculo, ha posto le uova in un nido già preparato e non sa costruire nidi, pensa che le volontà collettive siano un dato di fatto naturalistico, che sbocciano e si sviluppano per ragioni insite nelle cose ecc.
Q15 §36 Passato e presente. Nella «Critica» del 20 marzo 1933 è contenuta una «Postilla» del Croce: Il mondo va verso…. Pare però che il Croce non abbia accennato a tutti gli aspetti della formula che è essenzialmente una formula politica, di azione politica. Riuscire a convincere che il «mondo va verso…» una certa direzione significa niente altro che riuscire a convincere della ineluttabilità della propria azione e ottenere il consenso passivo per la sua esplicazione. Come questa convinzione si formi è certo un argomento interessante: che vi contribuisca la «viltade» e altre forme di bassezza morale è indubbio: ma anche il fatto che tanta «viltade» e tanta bassezza siano diffuse è un fatto politico che andrebbe analizzato e di cui bisognerebbe trovare le origini concrete. Da questa analisi forse scaturirebbe il risultato che lo stesso atteggiamento del Croce verso la vita è una delle origini di questa diffusione. Il non volersi impegnare a fondo, il distinguere tra ciò che deve fare un intellettuale e ciò che il politico (come se l’intellettuale non fosse anche un politico e non solo un politico dell’… intellettualità) e in fondo tutta la concezione storica crociana è all’origine di questa diffusione. Si vede che essere partigiano della libertà in astratto non conta nulla, è semplicemente una posizione da uomo di tavolino che studia i fatti del passato, ma non da uomo attuale partecipe della lotta del suo tempo.
Questa formula del «mondo che va» a sinistra o a destra o verso un compromesso ecc. ha incominciato a diffondersi in Italia nel 1921 ed era un segno evidente della demoralizzazione che conquistava vasti strati della popolazione. Si potrebbe ricostruire questo movimento intellettuale quasi con una data certa. Che la formula in sé non significhi nulla, è vero. Intanto è comoda l’espressione del «mondo» corpulento che va in qualche parte. Si tratta di una «previsione» che non è altro che un giudizio sul presente, interpretato nel modo più facilonesco, per rafforzare un determinato programma d’azione con la suggestione degli imbecilli e dei pavidi. Ma se il compito dell’intellettuale è visto come quello di mediatore tra due estremismi e questo compito di mediazione non è affidato allo sviluppo storico stesso, cosa fa l’intellettuale se non collaborare coll’attore del dramma storico che ha meno scrupoli e meno senso di responsabilità? Questo pare sia stato l’atteggiamento del Croce. Non sarebbe stato più onesto intellettualmente di apparire sulla scena nel vero compito, di alleato «con riserve» di una delle due parti? invece che di voler apparire come superiore alle miserie passionali delle parti stesse e come incarnazione della «storia»? Come si è notato altre volte, questa «parte» di arbitraria mediazione dialettica ha una lunga e sfortunata storia: Proudhon in Francia per il quale Napoleone III non nascose le sue simpatie (il libro di Sainte-Beuve), Gioberti in Italia, che giustamente può essere assunto a simbolo del disordine intellettuale e politico del 1848 ecc.
Su questo nesso di problemi è da vedere l’articolo di Ugo Spirito nell’«Italia Letteraria» del 13 novembre 1932 (storicismo rivoluzionario e storicismo antistorico). È notevole il fatto che anche lo Spirito collega l’attuale polemica sullo «storicismo» con la polemica svoltasi nel secolo scorso intorno alla formula che «natura non facit saltus». Ma lo Spirito non sa andare oltre la superficie dei fatti e delle idee e se afferma, come l’Anti‑Proudhon, che è necessario che i termini dialettici si volgano in tutta la loro potenza e come «estremismi» contrapposti, non sa vedere che la sua posizione stessa è una mediazione o superamento arbitrario, in quanto si basa su ciò, che l’antitesi è violentemente soppressa e si pone come antitesi appunto un tentativo di mediazione tutto intellettualistico che è vivo solo nel cervello di pochi intellettuali di non grande statura. Anche lo Spirito è da porre tra i teorici (più o meno inconsci poiché nei suoi scritti, specialmente in «Critica Fascista», appare la sua preoccupazione di «dare qualcosa perché non si perda tutto»: è da vedere in proposito specialmente un articolo scritto dopo il Convegno corporativo di Ferrara e l’esposizione della tesi della «corporazione proprietaria») della «rivoluzione passiva o rivoluzione‑restaurazione» e non già, come egli pretenderebbe, fra gli «estremisti» di una qualsiasi dialettica ideale o reale. Se il torto del Croce è di voler apparire diverso da quello che è realmente, lo stesso torto è dello Spirito e del suo gruppo; e in fondo i due torti praticamente si identificano; si tratta di due fratelli siamesi che contendono perché troppo uniti.
Q15 §37 Letteratura italiana. Nel «Marzocco» del 18 settembre 1932 Tullia Franz scrive sulla quistione sorta tra il Manzoni e il traduttore inglese dei Promessi Sposi, il pastore anglicano Carlo Swan, a proposito della espressione, contenuta verso la fine del capitolo settimo, impiegata per indicare Shakespeare: «Tra il primo concetto di una impresa terribile e l’esecuzione di essa (ha detto un barbaro che non era privo d’ingegno) l’intervallo è un sogno pieno di fantasmi e di paure». Lo Swan scrisse al Manzoni. «Un barbaro che non era privo d’ingegno is a phrase, calculated to draw upon you the anathema of every admirer of our bard». Nonostante che Swan conoscesse gli scritti del Voltaire contro Shakespeare, egli non colse l’ironia manzoniana, che era appunto rivolta contro il Voltaire (che aveva definito lo Shakespeare «un sauvage avec des étincelles de génie»). Lo Swan pubblicò come prefazione alla sua traduzione la lettera dove il Manzoni gli spiega il significato della sua espressione ironica. Ma la Franzi ricorda che nelle altre traduzioni inglesi l’espressione manzoniana o è taciuta o è resa anodina (scrive uno scrittore straniero ecc.). Così nelle traduzioni in altre lingue, ciò che dimostra come questa ironia che ha bisogno di essere spiegata per essere compresa e assaporata, sia in fondo un’ironia in «gergo», da conventicola letteraria. Mi pare che il fatto sia molto più esteso di quanto non sembri, e renda difficile tradurre dall’italiano non solo ma anche, spesso, comprendere un italiano che parla in conversazione. La «finezza» di cui pare si abbia bisogno in tali conversazioni non è un fatto dell’intelligenza normale, ma il fatto di dover conoscere fatterelli e atteggiamenti intellettuali di «gergo», proprii di letterati e anzi di certi gruppi di letterati. (Nell’articolo della Franzi è da notare una metafora «femminile» sorprendente: «Col sentimento di un uomo che, strapazzato e battuto dalla sua sposa per sospetto geloso, si rallegra tutto di quegli sdegni e benedice quelle percosse che gli sono testimonianza di amore, il Manzoni accolse questa lettera». Un uomo che si rallegra di essere bastonato dalla moglie è certo una forma originale di femminismo contemporaneo).
Q15 §38 Criteri di critica letteraria. Il concetto che l’arte è arte e non propaganda politica «voluta» e proposta, è poi, in se stesso, un ostacolo alla formazione di determinate correnti culturali che siano il riflesso del loro tempo e che contribuiscano a rafforzare determinate correnti politiche? Non pare, anzi pare che tale concetto ponga il problema in termini più radicali e di una critica più efficiente e conclusiva. Posto il principio che nell’opera d’arte sia solamente da ricercare il carattere artistico, non è per nulla esclusa la ricerca di quale massa di sentimenti, di quale atteggiamento verso la vita circoli nell’opera d’arte stessa. Anzi che ciò sia ammesso dalle moderne correnti estetiche si vede nel De Sanctis e nello stesso Croce. Ciò che si esclude è che un’opera sia bella per il suo contenuto morale e politico e non già per la sua forma in cui il contenuto astratto si è fuso e immedesimato. Ancora si ricerca se un’opera d’arte non sia fallita perché l’autore sia stato deviato da preoccupazioni pratiche esteriori, cioè posticce e insincere. Questo pare il punto cruciale della polemica: Tizio «vuole» esprimere artificiosamente un determinato contenuto e non fa opera d’arte. Il fallimento artistico dell’opera d’arte data (poiché Tizio ha dimostrato di essere artista in altre opere da lui realmente sentite e vissute) dimostra che quel tale contenuto in Tizio è materia sorda e ribelle, che l’entusiasmo di Tizio è fittizio e voluto esteriormente, che Tizio in realtà non è, in quel determinato caso, artista, ma servo che vuol piacere ai padroni. Ci sono dunque due serie di fatti: uno di carattere estetico, o di arte pura, l’altro di politica culturale (cioè di politica senz’altro). Il fatto che si giunge a negare il carattere artistico di un’opera può servire al critico politico come tale per dimostrare che Tizio come artista non appartiene a quel determinato mondo politico, e poiché la sua personalità è prevalentemente artistica, che nella sua vita intima e più sua, quel determinato mondo non opera, non esiste: Tizio pertanto è un commediante della politica, vuol far credere di essere ciò che non è ecc. ecc. Il critico politico dunque denuncia Tizio, non come artista, ma come «opportunista politico». Che l’uomo politico faccia una pressione perché l’arte del suo tempo esprima un determinato mondo culturale è attività politica, non di critica artistica: se il mondo culturale per il quale si lotta è un fatto vivente e necessario, la sua espansività sarà irresistibile, esso troverà i suoi artisti. Ma se nonostante la pressione, questa irresistibilità non si vede e non opera, significa che si trattava di un mondo fittizio e posticcio, elucubrazione cartacea di mediocri che si lamentano che gli uomini di maggior statura non siano d’accordo con loro. Lo stesso modo di porre la quistione può essere un indizio della saldezza di un tal mondo morale e culturale: e infatti il così detto «calligrafismo» non è che la difesa di piccoli artisti che opportunisticamente affermano certi principii ma si sentono incapaci di esprimerli artisticamente cioè nell’attività loro propria e allora vaneggiano di pura forma che è il suo stesso contenuto ecc. ecc. Il principio formale della distinzione delle categorie spirituali e della loro unità di circolazione, pur nel suo astrattismo, permette di cogliere la realtà effettuale e di criticare l’arbitrarietà e la pseudovita di chi non vuole giocare a carte scoperte o è semplicemente un mediocre che è stato dal caso posto a un luogo di comando.
Q15 §39 Passato e presente. Sindacato e corporazione. Difficoltà che trovano i teorici del corporativismo a inquadrare il fatto sindacale (organizzazione delle categorie) e sorda lotta tra sindacalisti tradizionali (per es. E. Rossoni) e corporativisti di nuova mentalità (per es. Giuseppe Bottai e Ugo Spirito). In realtà il Rossoni non riesce a superare la vecchia concezione del sindacalismo formale ed astratto ma è anche vero che neanche il Bottai e lo Spirito riescono a comprendere e superare l’esigenza che sia pure grossolanamente e sordamente il Rossoni rappresenta. D’altronde neanche il Bottai e lo Spirito sono d’accordo. Il Bottai afferma che il sindacato è un’istituzione necessaria che non può essere assorbita dalla corporazione, ma non riesce a definire cosa debba essere e quale funzione debba avere il sindacato; lo Spirito invece, con una consequenziarità formale, sostiene che il sindacato deve essere assorbito nella corporazione, ma in questo assorbimento non appare quali compiti nuovi e quali nuove forme debbano risultare. Lo Spirito in due scritti sul libro del Bottai (Il Consiglio nazionale delle Corporazioni, Milano, Mondadori, 1932, pp. XI‑427), il primo pubblicato nel «Leonardo» del marzo 1933 (Il fascismo nella fase corporativa) e il secondo nell’«Italia Letteraria» del 26 marzo 1933 (Origine e avvenire della Corporazione fascista) accenna al suo dissenso col Bottai. Scrive lo Spirito in questo secondo articolo: «Di quali prospettive intenda parlare il Bottai, si comprende da quel che egli osserva nello stesso articolo (articolo in «Lo Spettacolo Italiano» del settembre 1930) a proposito del rapporto tra sindacalismo e corporativismo, e quindi tra sindacati e corporazioni e tra corporazioni nazionali e corporazioni di categoria. In una nota pubblicata in “Leonardo” … ho già accennato al risoluto atteggiamento assunto dal Bottai contro ogni tentativo verso un corporativismo integrale che risolva in sé il sindacalismo. Eppure penso che il concepire in tal modo l’ulteriore sviluppo del corporativismo sia nella stessa logica di tutto il suo pensiero e della sua azione politica, volta a dare realtà e concretezza alla corporazione. Se la corporazione stenta ancora a trovare quella ricchezza che le è indubbiamente riservata, è soltanto perché non riesce a riassorbire in sé il sindacato, al quale resta giustapposta e in gran parte estranea. Il sindacalismo di Stato ha segnato il primo passo verso il corporativismo; oggi bisogna porre il problema del superamento definitivo di una forma sociale troppo legata ancora al passato e perciò in qualche modo limitatrice dell’originalità del fascismo. Il sindacalismo è espressione del classismo; col sindacato di Stato le classi sono messe allo stesso livello e avviate a una più spirituale collaborazione, ma soltanto con la corporazione il classismo sarà superato sul serio e con esso il principio dell’arbitraria concorrenza (liberalismo) e della materialistica lotta (socialismo). Allora la corporazione si arricchirà di tutta la vita del sindacato e liberata dalla funzione di comporre il dualismo inerente all’ordinamento sindacale, potrà operare senza limiti nella costruzione della nuova vita economica e politica». Appaiono evidenti le ragioni per cui il Bottai non accetta la tesi dello Spirito, ragioni politiche ed economiche, come appare evidente che la costruzione dello Spirito è una non molto brillante e feconda utopia libresca. Ma è interessante notare che in verità non si comprende neanche cosa lo Spirito intenda per sindacato e per categoria e come egli paia non conoscere la letteratura in proposito. Gli si potrebbero ricordare le polemiche sull’organizzazione per fabbrica (di tipo industriale) in contrapposto a quella per categoria, il diverso significato che la parola categoria ha avuto (dal semplice mestiere, per es. di tornitore, a quella di operaio metallurgico ecc.) e la discussione stessa se nonostante che fosse un progresso l’amalgamazione di tutti gli elementi di un’industria in un solo sindacato unitario, tuttavia non fosse necessario, per ragioni tecnico‑professionali (sviluppo delle forme di lavoro, degli utensili ecc.) conservare una traccia dell’organizzazione di mestiere, in quanto il mestiere tecnicamente si mantiene distinto e indipendente.
È da notare, in ogni modo, la giustezza fondamentale dell’intuizione dello Spirito, per la quale, ammesso che il classismo sia stato superato dal corporativismo e da una forma qualsiasi di economia regolata e programmatica, le vecchie forme sindacali nate sul terreno del classismo devono essere aggiornate, ciò che potrebbe anche voler dire assorbite dalla corporazione (da ciò si deduce che la resistenza del vecchio sindacalismo formale e astratto è una forma di critica reale ad affermazioni che si possono fare solo sulla carta). Cioè il sindacalismo astratto e formale è solo una forma di feticismo e di superstizione? Nell’elemento sindacato prevale ancora il salariato da una parte e il percettore di profitto dall’altra, oppure realmente il fatto produttivo ha superato quello della distribuzione del reddito industriale tra i vari elementi della produzione? Fino a quando l’operaio da una parte e l’industriale dall’altra dovranno preoccuparsi del salario e del profitto, è evidente che il sindacalismo vecchio tipo non è superato e non può essere assorbito in altre istituzioni. Il torto scientifico dello Spirito è quello di non esaminare in concreto questi problemi, ma nel presentare le quistioni nel loro aspetto formale e apodittico, senza le necessarie distinzioni e le indispensabili fasi di transizione, da ciò forse non solo il suo contrasto col Rossoni ma anche quello col Bottai, il cui spirito politico non può non sentire queste necessità. Se si parte dal punto di vista della produzione e non da quello della lotta per la distribuzione del reddito, è evidente che il terreno sindacale deve essere completamente mutato. In una fabbrica di automobili d’una certa estensione, oltre gli operai meccanici, lavora un certo numero di operai di altre «categorie»: muratori, elettricisti, materassai, carrozzieri, pellettieri, vetrai ecc, Questi operai a quale sindacato dovranno appartenere, dal punto di vista della produzione? Certamente al sindacato metallurgico, o meglio ancora, al sindacato dell’automobile, perché il loro lavoro è necessario per la costruzione dell’automobile. Cioè in ogni complesso produttivo, tutti i mestieri sono rivolti alla costruzione dell’oggetto principale per cui il complesso è specializzato. Ma se la base è il salario, è evidente che i muratori dovranno unirsi ai muratori ecc. per regolare il mercato del lavoro ecc. D’altronde pure riconosciuta la necessità che tutti i mestieri di un’azienda produttiva si uniscano per la produzione, intorno al prodotto stesso, occorre tener conto che ogni mestiere è un fatto tecnico in continuo sviluppo e che di questo sviluppo bisogna esista un organo che controlli, diffonda, favorisca le innovazioni progressive. Si può riconoscere che nell’attuale grande azienda razionalizzata, le vecchie qualifiche di mestiere vanno sempre più perdendo importanza e si sviluppano nuove qualifiche, spesso limitate a un’azienda o a un gruppo di aziende: tuttavia l’esigenza rimane ed è dimostrata dalle difficoltà del «turnover» e dalla spesa che l’eccessivo turnover rappresenta per l’azienda stessa. La soluzione rappresentata dai delegati di reparto eletti dalle squadre di lavorazione, per cui nel complesso rappresentativo tutti i mestieri hanno un rilievo, pare sia finora la migliore trovata. È possibile infatti riunire i delegati per mestiere nelle quistioni tecniche e l’insieme dei delegati sulle quistioni produttive. Finora lo Spirito non si è mai interessato delle quistioni di fabbrica e di azienda: eppure non è possibile parlare con competenza dei sindacati e dei problemi che essi rappresentano, senza occuparsi della fabbrica o dell’azienda amministrativa, delle sue esigenze tecniche, dei rapporti reali che vi si annodano e dei diversi atteggiamenti vitali che gli addetti vi assumono. Per l’assenza di questi interessi vivi, tutta la costruzione dello Spirito è puramente intellettualistica e, se attuata, darebbe luogo solamente a schemi burocratici senza impulso e senza possibilità di sviluppo.
Q15 §40 Azione Cattolica. Importanza speciale dell’Azione Cattolica francese. È evidente che in Francia l’Azione Cattolica dispone di un personale molto più scelto e preparato che negli altri paesi. Le Settimane sociali portano in discussione argomenti d’interesse più vasto e attuale che negli altri paesi. Un confronto tra le Settimane francesi e quelle italiane sarebbe interessante. Inoltre i cattolici hanno un influsso intellettuale in Francia che non hanno altrove, e questo influsso è meglio centralizzato e organizzato (ciò per il settore cattolico, s’intende, che per alcuni aspetti è in Francia ristretto dall’esistenza di una forte centralizzazione della cultura laica). In Francia inoltre, è stata costituita l’Union Catholique d’Etudes Internationales, tra le cui iniziative è quella di una speciale Settimana Cattolica Internazionale. Mentre è riunita la Assemblea annuale della Società delle Nazioni, personalità cattoliche di ogni paese si riuniscono in Francia per una settimana e discutono i problemi internazionali, contribuendo a creare una unità concreta di pensiero fra i cattolici di tutto il mondo. Sotto il velo della cultura si tratta evidentemente di una Internazionale laica cattolica, distinta dal Vaticano e sulla linea dell’attività politica parlamentare dei partiti popolari. Nella «Civiltà Cattolica» del 6 maggio 1933 si recensisce il volume che raccoglie le relazioni della terza di queste Settimane internazionali (Les grandes activités de la Société des Nations devant la pensée chrétienne. Conférences de la troisième semaine catholique internationale 14‑20 septembre 1931, Éditions Spes, Paris 1932, in 16°, pp. 267, Fr. 15). È da appuntare la risposta che il prof. Halecki dell’Università di Varsavia dà nella sua conferenza alla domanda: «come va che la Chiesa dopo duemila anni dacché propaga la pace non ha ancora potuto darcela?» La risposta è questa: «L’insegnamento di Cristo e della sua Chiesa s’indirizza individualmente alla persona umana, a ciascuna anima in particolare. È questa verità che ci spiega perché il cristianesimo non può operare che assai lentamente sulle istituzioni e sulle pratiche attività collettive, dovendo conquistare un’anima dopo l’altra e ricominciare questo sforzo ad ogni nuova generazione». Per la «Civiltà Cattolica» questa è una «buona risposta, che può rafforzarsi con la considerazione semplicissima che l’azione pacificatrice della Chiesa è contrastata ed elisa di continuo da quel residuo irriducibile (sic) di paganesimo che sopravvive tuttora ed infiamma le passioni della violenza. La Chiesa è un buon medico, ed offre salutari farmachi alla società inferma, ma questa ricusa in tutto o in parte le medicine». Risposta molto sofistica e non di difficile confutazione: d’altronde essa è in contraddizione con altre pretese clericali. Quando conviene i clericali pretendono che un paese è cattolico al 99% per dedurne una particolare posizione di diritto della Chiesa nei confronti dello Stato ecc. Quando conviene, si fanno piccini piccini ecc. Se fosse vero quello che dice il prof. Halecki, l’attività della Chiesa in duemila anni sarebbe stata un lavoro di Sisifo e così dovrebbe continuare ad essere. Ma che valore dovrebbe darsi a una istituzione che non costruisce mai nulla che si prolunghi di generazione in generazione per forza propria, che non modifica in nulla la cultura e la concezione del mondo di nessuna generazione, tanto che occorre sempre riprendere tutto da capo? Il sofisma è chiaro: quando conviene la Chiesa è identificata con la società stessa (col 99% di essa almeno), quando non conviene la Chiesa è solo l’organizzazione ecclesiastica o addirittura la persona del Papa. Allora la Chiesa è un «medico» che indica alla società i farmachi ecc. Così è molto curioso, che i gesuiti parlino di «residuo irriducibile» di paganesimo: se è irriducibile non sparirà mai, la Chiesa non trionferà mai ecc.
Q15 §41 Risorgimento italiano. In una recensione («Nuova Italia» del 20 aprile 1933) del libro di Cecil Roth (Gli Ebrei in Venezia, Trad. di Dante Lattes, Ed. Cremonese, Roma, 1933, pp. VII‑446, L. 20) Arnaldo Momigliano fa alcune giuste osservazioni sull’ebraismo in Italia. «La storia degli Ebrei di Venezia, come la storia degli Ebrei di qualsiasi città italiana in genere, è essenzialmente appunto la storia della formazione della loro coscienza nazionale italiana. Né, si badi, questa formazione è posteriore alla formazione della coscienza nazionale italiana in genere, in modo che gli Ebrei si sarebbero venuti a inserire in una coscienza nazionale già precostituita. La formazione della coscienza nazionale italiana negli Ebrei è parallela alla formazione della coscienza nazionale nei Piemontesi o nei Napoletani o nei Siciliani: è un momento dello stesso processo e vale a caratterizzarlo. Come dal XVII al XIX secolo, a prescindere dalle tracce anteriori, i Piemontesi o i Napoletani si sono fatti italiani, così nel medesimo tempo gli Ebrei abitanti in Italia si sono fatti Italiani. Il che naturalmente non ha impedito che essi nella loro fondamentale italianità conservassero in misura maggiore o minore peculiarità ebraiche, come ai Piemontesi o ai Napoletani il diventare Italiani non ha impedito di conservare caratteristiche regionali». Questa tesi, storicamente esatta nella sua essenza, è da confrontare con quella di un altro ebreo, Giacomo Lumbroso nel libro I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII , 1796-1800, Firenze, Le Monnier, 1932, in 8° pp. VIII‑228 (e in proposito vedi «Critica» del 20 marzo 1933, pp. 140 sgg.). Che nei moti popolari registrati dal Lumbroso ci fosse qualsiasi traccia di spirito nazionale è un’allegra trovata, anche se tali moti siano degni di studio e di interpretazione. In realtà essi furono popolari per modo di dire e solo per un aspetto molto secondario e meschino: il misoneismo e la passività conservatrice delle masse contadine arretrate e imbarbarite. Presero significato dalle forze consapevoli che li istigavano e li guidavano più o meno apertamente e queste forze erano nettamente reazionarie e antinazionali o anazionali. Solo recentemente i gesuiti hanno preso a sostenere la tesi dell’italianismo dei sanfedisti che solo «volevano unificare l’Italia a modo loro».
Un’altra osservazione notevole è accennata nella recensione del Momigliano: che cioè nel tormento e negli squilibri di Leone Ebreo ci fosse una complicata insoddisfazione della cultura ebraica come di quella profana, insoddisfazione che «è tra i più importanti indizi che il Seicento ci offre della trasformazione che stava avvenendo nelle coscienze ebraiche».
In Italia non esiste antisemitismo proprio per le ragioni accennate dal Momigliano, che la coscienza nazionale si costituì e doveva costituirsi dal superamento di due forme culturali: il particolarismo municipale e il cosmopolitismo cattolico, che erano in stretta connessione fra loro e costituivano la forma italiana più caratteristica di residuo medioevale e feudale. Che il superamento del cosmopolitismo cattolico e in realtà quindi la nascita di uno spirito laico, non solo distinto ma in lotta col cattolicismo, dovesse negli ebrei avere come manifestazione una loro nazionalizzazione, un loro disebreizzarsi, pare chiaro e pacifico. Ecco perché può esser giusto ciò che scrive il Momigliano, che la formazione della coscienza nazionale italiana negli ebrei vale a caratterizzare l’intero processo di formazione della coscienza nazionale italiana, sia come dissoluzione del cosmopolitismo religioso che del particolarismo, perché negli ebrei il cosmopolitismo religioso diventa particolarismo nella cerchia degli Stati nazionali.
Q15 §42 Carattere non nazionale‑popolare della letteratura italiana. Per questa rubrica è da studiare il volume di B. Croce, Poesia popolare e poesia d’arte: Studi sulla poesia italiana dal tre al cinquecento, Laterza, Bari, 1933. Il concetto di popolare nel libro del Croce non è quello di queste : per il Croce si tratta di un atteggiamento psicologico, per cui il rapporto tra poesia popolare e poesia d’arte è come quello tra il buon senso e il pensiero critico, tra l’accorgimento naturale e l’accorgimento esperto, tra la candida innocenza e l’avveduta e accurata bontà. Tuttavia dalla lettura di alcuni saggi di questo libro pubblicati nella «Critica» pare si possa dedurre che mentre dal Trecento al Cinquecento la poesia popolare, anche in questo senso, ha una importanza notevole, perché è legata ancora a una certa vivacità di resistenza delle forze sociali sorte col movimento di ripresa verificatosi dopo il Mille e culminato nei Comuni, dopo il Cinquecento queste forze sono abbrutite completamente e la poesia popolare decade fino alle forme attuali in cui l’interesse popolare è soddisfatto dal Guerin Meschino, e da simile letteratura. Dopo il Cinquecento cioè si rende radicale quel distacco tra intellettuali e popolo che è alla base di queste e che tanto significato ha avuto per la storia italiana moderna politica e culturale.
Q15 §43 relle di economia. Nella Riforma Sociale di marzo‑aprile 1933 è contenuta una recensione firmata tre stelle di An essay on the nature and significance of economic science, by Lionel Robbins, professore di economia all’Università di Londra (London, Macmillan and Co., 1932, pp. XII‑141). Anche il recensore si pone la domanda «che cosa è la scienza economica?» e in parte accetta, in parte rettifica o integra i concetti esposti dal Robbins. Pare che il libro corrisponda all’esigenza posta dal Croce nei suoi saggi di prima del 1900 sulla necessità di far precedere ai trattati di economia una prefazione teorica in cui siano esposti i concetti e i metodi proprii dell’economia stessa, ma la corrispondenza deve essere intesa con discrezione: non pare che il Robbins abbia quel rigore filosofico che il Croce domandava e sia piuttosto un «empirico» e un logico formale. Il libro può essere interessante come il più recente saggio di questa linea di ricerche, dipendente dalla insoddisfazione che si nota spesso da parte degli economisti a proposito delle definizioni della loro scienza e dei limiti che ad essa si sogliono porre. Anche per il Robbins l’«economia» finisce per avere una significazione amplissima e genericissima, che malamente coincide con i problemi concreti che gli economisti realmente studiano, e che coincide piuttosto con quella che il Croce chiama una «categoria dello spirito», il «momento pratico» o economico, cioè il rapporto razionale del mezzo al fine. Il Robbins «esamina quali sono le condizioni che caratterizzano l’attività umana studiata dagli economisti ed arriva a concludere che esse sono: 1) la diversità dei fini; 2) la insufficienza dei mezzi; 3) la possibilità di usi alternativi. In conseguenza definisce l’economia come quella scienza che studia il modo di comportarsi degli uomini quale relazione tra i fini ed i mezzi scarsi che abbiano usi alternativi».
Pare che il Robbins voglia liberare l’economia dal così detto principio «edonistico» e separare nettamente l’economia dalla psicologia, «rifiutando gli ultimi residui di quella che è stata l’associazione passata tra utilitarismo ed economia» (ciò che probabilmente significa che il Robbins ha elaborato un nuovo concetto dell’utile diverso e più comprensivo di quello tradizionale).
A parte ogni apprezzamento sul merito della quistione, è da mettere in rilievo quali attenti studi gli economisti moderni dedichino a perfezionare continuamente gli strumenti logici della loro scienza, tanto che si può dire che una gran parte del prestigio che gli economisti godono è dovuto al loro rigore formale, all’esattezza dell’espressione ecc. La stessa tendenza non si verifica nell’economia critica che si vale troppo spesso di espressioni stereotipate, e si esprime in un tono di superiorità a cui non corrisponde il valore dell’esposizione: dà l’impressione di arroganza noiosa e niente altro e perciò pare utile mettere in rilievo questo aspetto degli studi economici e della letteratura economica. Nella Riforma Sociale le pubblicazioni del tipo di questa del Robbins sono sempre segnalate e non sarà difficile avere una bibliografia in proposito.
È da vedere se l’impostazione che il Robbins dà al problema economico non sia in genere una demolizione della teoria marginalista, quantunque pare egli dica che sull’analisi marginale è possibile costruire «la complessiva teoria economica in modo perfettamente unitario» (cioè abbandonando completamente il dualismo ancora sostenuto dal Marshall, nei criteri della spiegazione del valore, cioè il doppio gioco della utilità marginale e del costo di produzione). Infatti se le valutazioni individuali sono la sola fonte di spiegazione dei fenomeni economici, cosa significa che il campo dell’economia è stato separato dal campo della psicologia e dell’utilitarismo?
Per ciò che riguarda la necessità di una introduzione metodico‑filosofica ai trattati di economia, ricordare l’esempio delle prefazioni al primo volume di Economia critica e al volume di Critica dell’Economia politica: ognuna di esse è forse troppo breve e scarna, ma il principio è seguito: d’altronde nel corpo dei volumi molti accenni metodici filosofici.
Q15 §44 Risorgimento italiano. Cfr articolo di Salvatore Valitutti La grande industria in Italia nella «Educazione Fascista» del febbraio 1933, scritto per accenni e rapide allusioni, ma abbastanza interessante e da rivedere all’occasione.
Non è però esatto porre la quistione così: «Era vero … che l’economia dell’Italia meridionale era agricola, feudale e che quella della restante Italia era più industriale e moderna». Nell’Italia meridionale c’era e c’è una determinata attività agricola e il protezionismo agrario giovò più al Nord che al Sud, perché fu protezione sui cereali, di cui il Nord era grande produttore (relativamente più del Sud). La differenza tra Nord e Sud era anche e specialmente nella composizione sociale, nella diversa posizione delle masse contadine, che nel Sud dovevano mantenere col loro lavoro una troppo grande quantità di popolazione passiva economicamente, di redditieri ecc. Né si può dire che «la pratica di raccoglimento e di modestia» nei primi trent’anni del regno – una pratica più modesta di quella che realmente si ebbe, «avrebbe fermato il progresso delle attività economiche più bisognose di movimento e di ricchezza ed, esercitata nell’interesse del meridionale, avrebbe conseguito l’effetto di rifondere e di riorganizzare la vita italiana sulla base del Regno di Napoli». Perché poi esercitata nell’interesse del meridionale? Nell’interesse di tutte le forze nuove nazionali contemperate e non gerarchizzate dai privilegi. Invece la struttura arretrata meridionale fu sfruttata, resa permanente, accentuata perfino, per drenare il risparmio delle sue classi parassitarie verso il Nord.
Anche la funzione del movimento socialista nella formazione dell’Italia moderna è presentata in modo non esatto per molti aspetti, sebbene sia esaltata e lodata. La posizione di Bonomi fu una caricatura di quella che era stata prospettata da Engels nella «Critica Sociale» (prime annate) e in questo senso era naturale la reazione sindacalista che si ispirò in parte alle indicazioni dell’Engels, e infatti fu piuttosto meridionalista ecc. (il Valitutti si deve riferire al mio articolo sulla quistione meridionale). Per la posizione del Bonomi sarà da vedere il suo libro sulle Vie nuove, nel quale tutta la quistione deve essere esposta più organicamente.
Q15 §45 relle di economia (cfr p. 26). Il rapporto tra l’economia politica e l’economia critica non è stato saputo mantenere nelle sue forme organiche e storicamente attuali. In che cosa le due correnti di pensiero si distinguono nell’impostazione del problema economico? Si distinguono attualmente, nei termini culturali attuali e non già e più nei termini culturali di ottanta anni fa? Dai manuali di economia critica ciò non appare (per esempio dal Précis), eppure è questo il punto che interessa subito i principianti e dà l’orientamento generale per tutta la ricerca posteriore. In generale questo punto viene dato non solo per noto ma per accettato senza discussione, mentre nessuna delle due cose è vera. Così avviene che solo gli spiriti gregari e che fondamentalmente si infischiano della quistione sono avviati allo studio dei problemi economici e ogni sviluppo scientifico è reso impossibile. Ciò che colpisce è questo: come un punto di vista critico che richiede il massimo di intelligenza, di spregiudicatezza, di freschezza mentale e di inventività scientifica sia divenuto il monopolio di biascicazione di cervelli ristretti e meschini, che solo per la posizione dogmatica riescono a mantenere una posizione non nella scienza, ma nella bibliografia marginale della scienza. Una forma di pensare ossificata è il pericolo più grande in queste quistioni: è da preferire una certa sbrigliatezza disordinata alla difesa filistea delle posizioni culturali costituite.
Q15 §46 Ordine intellettuale e morale. Brani del libro Lectures and Essays on University subjects del cardinale Newman. Anzitutto e in linea generalissima, la università ha il compito umano di educare i cervelli a pensare in modo chiaro, sicuro e personale, districandoli dalle nebbie e dal caos in cui minacciava di sommergerli una cultura inorganica, pretenziosa e confusionaria, ad opera di letture male assortite, conferenze più brillanti che solide, conversazioni e discussioni senza costrutto: «Un giovane d’intelletto acuto e vivace, sfornito di una solida preparazione, non ha di meglio da presentare che un acervo di idee, quando vere quando false, che per lui hanno lo stesso valore. Possiede un certo numero di dottrine e di fatti, ma scuciti e dispersi, non avendo principii attorno ai quali raccoglierli e situarli.
Dice, disdice e si contraddice, e quando lo si costringe a esprimere chiaramente il suo pensiero non si raccappezza più. Scorge le obbiezioni, meglio che le verità, propone mille quesiti ai quali nessuno saprebbe rispondere, ma intanto egli nutre la più alta opinione di sé e si adira con quelli che dissentono da lui».
Il metodo che la disciplina universitaria prescrive per ogni forma di ricerca è ben altro e ben altro è il risultato: è «la formazione dell’intelletto, cioè un abito di ordine e di sistema, l’abito di riportare ogni conoscenza nuova a quelle che possediamo, e di aggiustarle insieme, e, quel che più importa, l’accettazione e l’uso di certi principii, come centro di pensiero… Là dove esiste una tale facoltà critica, la storia non è più un libro di novelle, né la biografia un romanzo; gli oratori e le pubblicazioni della giornata perdono la infallibilità; la eloquenza non vale più il pensiero, né le affermazioni audaci o le descrizioni colorite tengono il posto di argomenti». La disciplina universitaria deve essere considerata come un tipo di disciplina per la formazione intellettuale attuabile anche in istituzioni non «universitarie» in senso ufficiale.
Q15 §47 Machiavelli. Articolo di Sergio Panunzio nella «Gerarchia» dell’aprile 1933 (La fine del parlamentarismo e l’accentramento delle responsabilità). Superficiale. Un punto curioso è quello in cui il Panunzio scrive che le funzioni dello Stato non sono solo tre «secondo i vecchi figurini costituzionalisti» e cioè la «legislativa», l’«amministrativa» e la «giudiziaria», ma «che a queste bisogna aggiungerne un’altra, che è poi, anche nel regime parlamentare, la principale, la primigenia, e la fondamentale, la “funzione di governo”, ossia la determinazione dell’indirizzo politico. Indirizzo politico rispetto al quale la stessa legislazione si comporta come un esecutivo (!), inquantoché è il programma politico di governo che si traduce come in tanti capitoli successivi nelle leggi ed è il presupposto di queste». Presupposto e contenuto, e quindi nesso inscindibile? Il Panunzio in realtà ragiona per figurini, cioè formalisticamente, peggio dei vecchi costituzionalisti. Ciò che egli dovrebbe spiegare, per il suo assunto, è come mai sia avvenuto il distacco e la lotta tra parlamento e governo in modo che l’unità di queste due istituzioni non riesca più a costruire un indirizzo permanente di governo, ma ciò non si può spiegare per schemi logici ma solo riferendosi ai mutamenti avvenuti nella struttura politica del paese, cioè realisticamente, con un’analisi storico‑politica. Si tratta infatti di difficoltà di costruire un indirizzo politico permanente e di vasta portata, non di difficoltà senz’altro. L’analisi non può prescindere dall’esame: 1) del perché si siano moltiplicati i partiti politici; 2) del perché sia diventato difficile formare una maggioranza permanente tra tali partiti parlamentari; 3) quindi del perché i grandi partiti tradizionali abbiano perduto il potere di guidare, il prestigio ecc. Questo fatto è puramente parlamentare, o è il riflesso parlamentare di radicali mutazioni avvenute nella società stessa, nella funzione che i gruppi sociali hanno nella vita produttiva ecc.? Pare che la sola via di ricercare l’origine del decadimento dei regimi parlamentari sia questa, cioè sia da ricercare nella società civile e certo in questa via non si può fare a meno di studiare il fenomeno sindacale; ma ancora, non il fenomeno sindacale inteso nel suo senso elementare di associazionismo di tutti i gruppi sociali e per qualsiasi fine, ma quello tipico per eccellenza, cioè degli elementi sociali di nuova formazione, che precedentemente non avevano «voce in capitolo» e che per il solo fatto di unirsi modificano la struttura politica della società.
Sarebbe da ricercare come sia avvenuto che i vecchi sindacalisti sorelliani (o quasi) a un certo punto siano divenuti semplicemente degli associazionisti o unionisti in generale. Forse il germe di questo decadimento era nello stesso Sorel, cioè in un certo feticismo sindacale o economistico.
Q15 §48 Machiavelli. I. Studio delle parole d’ordine come quella del «terzo Reich» delle correnti di destra germaniche, di questi miti storici, che non sono altro che una forma concreta ed efficace di presentare il mito della «missione storica» di un popolo. Il punto da studiare è appunto questo: perché una tale forma sia «concreta ed efficace» o più efficace di un’altra. In Germania la continuità ininterrotta (non interrotta da invasioni straniere permanenti) tra il periodo medioevale del Sacro Romano Impero (primo Reich) e quello moderno (da Federico il Grande al 1914) rende immediatamente comprensibile il concetto di terzo Reich. In Italia, il concetto di «terza Italia» del Risorgimento non poteva essere facilmente compreso dal popolo per la non continuità storica e la non omogeneità tra la Roma antica e quella papale (in vero anche tra la Roma repubblicana e quella imperiale non c’era omogeneità perfetta). Quindi la relativa fortuna della parola mazziniana di «Italia del popolo» che tendeva a indicare un rinnovamento completo, in senso democratico, di iniziativa popolare, della nuova storia italiana in contrapposto al «primato» giobertiano che tendeva a presentare il passato come continuità ideale possibile col futuro, cioè con un determinato programma politico presente presentato come di larga portata. Ma il Mazzini non riuscì a radicare la sua formula mitica e i suoi successori la diluirono e la immeschinirono nella retorica libresca. Un precedente per il Mazzini sarebbero potuti essere i Comuni medioevali che furono un rinnovamento storico effettivo e radicale, ma essi furono sfruttati piuttosto dai federalisti come Cattaneo. (L’argomento è da porre in rapporto con le prime scritte nel quaderno speciale su Machiavelli).
II. La quistione posta dal Panunzio sull’esistenza di un «quarto» potere statale, quello di «determinazione dell’indirizzo politico» pare che debba essere posta in connessione coi problemi suscitati dalla scomparsa dei partiti politici e quindi dallo svuotamento del Parlamento. È un modo «burocratico» di porre un problema che prima era risolto dal normale funzionamento della vita politica nazionale, ma non appare come possa essere la soluzione «burocratica» di esso. I partiti erano appunto gli organismi che nella società civile elaboravano gli indirizzi politici non solo, ma educavano e presentavano gli uomini supposti in grado di applicarli. Nel terreno parlamentare gli «indirizzi» elaborati, totali o parziali, di lunga portata o di carattere immediato, venivano confrontati, sfrondati dai caratteri particolaristici ecc. e uno di essi diventava «statale» in quanto il gruppo parlamentare del partito più forte diventava il «governo» o guidava il governo. Che, per la disgregazione parlamentare, i partiti siano divenuti incapaci di svolgere questo compito non ha annullato il compito stesso né ha mostrato una via nuova di soluzione: così anche per l’educazione e la messa in valore delle personalità. La soluzione «burocratica» di fatto maschera un regime di partiti della peggiore specie in quanto operano nascostamente, senza controllo; i partiti sono sostituiti da camarille e influssi personali non confessabili: senza contare che restringe le possibilità di scelta e ottunde la sensibilità politica e l’elasticità tattica. È opinione di Max Weber, per esempio, che una gran parte delle difficoltà attraversate dallo Stato tedesco nel dopoguerra sono dovute all’assenza di una tradizione politico‑parlamentare e di vita di partito prima del 1914.
Q15 §49 Passato e presente. Da un articolo di Manlio Pompei nella «Critica Fascista» del 1° maggio 1933: «Nella generica affermazione di una necessaria ripresa morale abbiamo sentito spesso ricordare la famiglia, come l’istituto intorno a cui si deve riannodare questa inderogabile ripresa. Su questo punto non mancano i pareri discordi: una recente polemica sulla letteratura infantile e sulla educazione dei nostri ragazzi ha fatto affiorare il concetto che il vincolo famigliare, gli affetti che legano i membri di una stessa famiglia, possano a un certo punto costituire un intralcio per quella educazione guerriera e virile, che è nelle finalità del Fascismo. A nostro avviso la famiglia è e deve restare la cellula madre della società fascista». Tutto l’articolo è interessante, sebbene la quistione non sia impostata con rigore. Il Pompei descrive la crisi della famiglia in tutti gli strati sociali, e invero non indica né come tale crisi possa essere arginata o condotta a una soluzione razionale, né come lo Stato possa intervenire per costruire o stimolare la costruzione di un nuovo tipo di famiglia. Il Pompei anzi afferma che la crisi è necessaria, connessa com’è a tutto un processo di rinnovazione sociale e culturale, e perciò è tanto più notevole l’effettivo disorientamento suo, nonostante le affermazioni generiche costruttive.
Q15 §50 Machiavelli. Sul concetto di previsione o prospettiva. È certo che prevedere significa solo veder bene il presente e il passato in quanto movimento: veder bene, cioè identificare con esattezza gli elementi fondamentali e permanenti del processo. Ma è assurdo pensare a una previsione puramente «oggettiva». Chi fa la previsione in realtà ha un «programma» da far trionfare e la previsione è appunto un elemento di tale trionfo. Ciò non significa che la previsione debba sempre essere arbitraria e gratuita o puramente tendenziosa. Si può anzi dire che solo nella misura in cui l’aspetto oggettivo della previsione è connesso con un programma esso aspetto acquista oggettività: 1) perché solo la passione aguzza l’intelletto e coopera a rendere più chiara l’intuizione; 2) perché essendo la realtà il risultato di una applicazione della volontà umana alla società delle cose (del macchinista alla macchina), prescindere da ogni elemento volontario o calcolare solo l’intervento delle altrui volontà come elemento oggettivo del gioco generale mutila la realtà stessa. Solo chi fortemente vuole identifica gli elementi necessari alla realizzazione della sua volontà. Perciò ritenere che una determinata concezione del mondo e della vita abbia in se stessa una superiorità di capacità di previsione è un errore di grossolana fatuità e superficialità. Certo una concezione del mondo è implicita in ogni previsione e pertanto che essa sia una sconnessione di atti arbitrari del pensiero o una rigorosa e coerente visione non è senza importanza, ma l’importanza appunto l’acquista nel cervello vivente di chi fa la previsione e la vivifica con la sua forte volontà. Ciò si vede dalle previsioni fatte dai così detti «spassionati»: esse abbondano di oziosità, di minuzie sottili, di eleganze congetturali. Solo l’esistenza nel «previsore» di un programma da realizzare fa sì che egli si attenga all’essenziale, a quegli elementi che essendo «organizzabili», suscettibili di essere diretti o deviati, in realtà sono essi soli prevedibili. Ciò va contro il comune modo di considerare la quistione. Si pensa generalmente che ogni atto di previsione presuppone la determinazione di leggi di regolarità del tipo di quelle delle scienze naturali. Ma siccome queste leggi non esistono nel senso assoluto o meccanico che si suppone, non si tiene conto delle altrui volontà e non si «prevede» la loro applicazione. Pertanto si costruisce su una ipotesi arbitraria e non sulla realtà.
Q15 §51 Passato e presente. Nella «Civiltà Cattolica» del 20 maggio 1933 è dato un breve riassunto delle Conclusioni all’inchiesta sulla nuova generazione. (Estratto del fascicolo 28 del «Saggiatore», Roma, Arti grafiche Zamperini, 1933, in 8°, pp. 32). Si sa come tali inchieste siano necessariamente unilaterali, monche, tendenziose, e come di solito diano ragione al modo di pensare di chi le ha promosse. Tanto più occorre esser cauti, quanto più pare che attualmente sia difficile conoscere ciò che le nuove generazioni pensano e vogliono. Secondo la «Civiltà Cattolica» il succo dell’inchiesta sarebbe: «La nuova generazione sarebbe dunque: senza morale e senza principi immutabili di moralità, senza religiosità ovvero atea, con poche idee e con molto istinto». «La generazione prebellica credeva e si faceva dominare dalle idee di giustizia, di bene, di disinteresse e della religione; la moderna spiritualità si è sbarazzata di tali idee, le quali in pratica sono immorali. I piccoli fatti della vita richiedono elasticità e pieghevolezza morale, che si comincia ad ottenere con la spregiudicatezza della nuova generazione. Nella nuova generazione perdono valore tutti quei principi morali che si sono imposti quali assiomi alle coscienze individuali. La morale è divenuta assolutamente pragmatistica: essa scaturisce dalla vita pratica, dalle diverse situazioni in cui l’uomo viene a trovarsi. La nuova generazione non è né spiritualistica, né positivistica, né materialistica, essa tende a superare razionalmente tanto gli atteggiamenti spiritualistici, quanto le viete posizioni positivistiche e materialistiche. Sua principale caratteristica è la mancanza di qualsiasi forma di reverenzialità per tutto ciò che incarna il vecchio mondo. Nella massa dei giovani si è affievolito il senso religioso e tutti i diversi astratti imperativi morali, ormai divenuti inadatti alla vita di oggigiorno. I giovanissimi hanno meno idee e più vita, hanno invece acquistata naturalezza e confidenza nell’atto sessuale, sì che l’amore non è più considerato nel senso di un peccato, di una trasgressione, di una cosa proibita. I giovani, diretti attivamente nelle direzioni che la vita moderna indica, risultano immuni da ogni possibile ritorno ad una religiosità dommatica dissolvente».
Pare che questa serie di affermazioni non sia altro che il programma stesso del «Saggiatore», e questo pare piuttosto una curiosità che una cosa seria. È in fondo, un ripensamento popolaresco del «superuomo» nato dalle più recenti esperienze della vita nazionale, un «superuomo» strapaesano, da circolo dei signori e da farmacia filosofica. Se si riflette, significa che la nuova generazione è diventata, sotto l’aspetto di un volontarismo estremo, della massima abulicità. Non è vero che non abbia ideali: questi solo sono tutti contenuti nel codice penale che si suppone fatto una volta per sempre nel suo complesso. Significa anche che manca nel paese ogni direzione culturale all’infuori di quella cattolica, ciò che farebbe supporre che per lo meno l’ipocrisia religiosa debba finire per incrementarsi. Sarebbe tuttavia interessante sapere di quale nuova generazione il «Saggiatore» intenda parlare.
Pare che l’«originalità» del «Saggiatore» consista nell’aver trasportato alla «vita» il concetto di «esperienza» proprio non già della scienza ma dell’operatore da gabinetto scientifico. Le conseguenze di questa meccanica trasposizione sono poco brillanti: esse corrispondono a ciò che era abbastanza noto col nome di «opportunismo» o di mancanza di principii (ricordare certe interpretazioni giornalistiche del relativismo di Einstein quando, nel 1921, questa teoria diventò preda dei giornalisti). Il sofisma consiste in ciò: che quando l’operatore da gabinetto «prova e riprova», il suo riprovare ha conseguenze limitate allo spazio dei provini e alambicchi: egli «riprova» fuori di sé, senza dare di se stesso all’esperimento altro che l’attenzione fisica e intellettuale. Ma nei rapporti tra gli uomini le cose si comportano ben diversamente e le conseguenze sono di ben diversa portata. L’uomo trasforma il reale e non si limita a esaminarlo sperimentalmente in vitro per riconoscerne le leggi di regolarità astratta. Non si dichiara una guerra per «esperimento», né si sovverte l’economia di un paese ecc., per trovare le leggi del migliore assetto sociale possibile. Che nel costruire i propri piani di trasformazione della vita occorra basarsi sull’esperienza, cioè sull’esatto rilievo dei rapporti sociali esistenti e non su vuote ideologie o generalità razionali, non importa che non si debbano avere principii, che non sono altro che esperienza messa in forma di concetti o di norme imperative. La filosofia del «Saggiatore», oltre che una reazione plausibile all’ubriacatura attualistica e religiosa, è però essenzialmente connessa a tendenze conservatrici e passive e in realtà contiene la più alta «reverenzialità» per l’esistente, cioè per il passato cristallizzato. In un articolo di Giorgio Granata (nel «Saggiatore», riferito nella «Critica Fascista» del 1° maggio 1933) ci sono molti spunti di tale filosofia: per il Granata la concezione del «partito politico», con il suo «programma» utopico, «come mondo del dover essere (!) di fronte al mondo dell’essere, della realtà» ha fatto il suo tempo e perciò la Francia sarebbe «inattuale»: come se proprio la Francia non avesse sempre nell’Ottocento dato l’esempio del più piatto opportunismo politico, cioè del servilismo a ciò che esiste alla realtà, cioè ai «programmi» in atto di forze ben determinate e identificabili. E l’essere servili ai fatti voluti e compiuti dagli altri è il vero punto di vista del «Saggiatore», cioè indifferenza e abulia sotto la veste di grande attività da formiche: la filosofia dell’uomo del Guicciardini che riappare sempre in certi periodi della vita italiana. Che per tutto ciò si dovesse rifarsi al Galilei e riprendere il titolo di «Saggiatore» è solo una bella impudenza, ed è da scommettere che i signori Granata e C. non abbiano da temere nuovi roghi e inquisizioni. (La concezione che del «partito politico» esprime il Granata coincide d’altronde con quella espressa dal Croce nel capitolo «Il partito come giudizio e come pregiudizio» del volume Cultura e vita morale e col programma dell’«Unità» fiorentina, problemistica ecc.).
E tuttavia questo gruppo del «Saggiatore» merita di essere studiato e analizzato: 1) perché esso cerca di esprimere, sia pur rozzamente, tendenze che sono diffuse e vagamente concepite dal gran numero; 2) perché esso è indipendente da ogni «grande filosofo» tradizionale e anzi si oppone a ogni tradizione cristallizzata; 3) perché molte affermazioni del gruppo sono indubbiamente ripetizioni a orecchio di posizioni filosofiche della filosofia della praxis entrate nella cultura generale ecc. (Ricordare il «provando e riprovando» dell’on. Giuseppe Canepa come Commissario per gli approvvigionamenti durante la guerra: questo Galileo della scienza amministrativa aveva bisogno di una esperienza con morti e feriti per sapere che dove manca il pane corre sangue).
Q15 §52 Risorgimento italiano. Serie di interpretazioni. A proposito del libro del Rosselli su Pisacane. Le interpretazioni del passato, quando del passato stesso si ricercano le deficienze e gli errori (di certi partiti o correnti) non sono «storia» ma politica attuale in nuce. Ecco perché anche i «se» spesso non tediano. È da dire che le «interpretazioni» del Risorgimento in Italia sono legate a una serie di fatti: 1) a spiegare perché sia avvenuto il così detto «miracolo» del Risorgimento: cioè si riconosce che le forze attive per l’unità e l’indipendenza erano scarse e che l’evento non può essere spiegato solo con tali forze, ma d’altronde non si vuole riconoscerlo apertamente per ragioni di politica nazionale, e si costruiscono romanzi storici; 2) per non toccare il Vaticano; 3) per non spiegare razionalmente il «brigantaggio» meridionale; 4) più tardi per spiegarsi la debolezza statale durante le guerre d’Africa (da ciò prese lo spunto Oriani specialmente e quindi gli orianisti), per spiegare Caporetto e il sovversivismo elementare del dopoguerra con le sue conseguenze dirette e indirette.
La debolezza di tale tendenza «interpretativa» consiste in ciò che rimase puro fatto intellettuale, non divenne la premessa a un movimento politico nazionale. Solo con Piero Gobetti ciò stava delineandosi e in una biografia del Gobetti bisognerebbe ricordarlo: perciò il Gobetti si stacca dall’orianesimo e da Missiroli. Col Gobetti occorre porre il Dorso e come ombra nel gioco Giovanni Ansaldo che è più intellettuale del Missiroli. (Ansaldo è «l’uomo del Guicciardini» divenuto esteta e letterato e che ha letto le pagine del De Sanctis sull’uomo del Guicciardini. Si potrebbe dire dell’Ansaldo: «Un giorno l’uomo del Guicciardini lesse le pagine del De Sanctis su se stesso e si cammuffò da G. Ansaldo, prima e da stelletta nera più tardi: ma il suo “particulare” non riuscì a camuffarlo…»).
Una quistione che il Rosselli non pone bene nel Pisacane è questa: come una classe dirigente possa dirigere le masse popolari, cioè essere «dirigente»; il Rosselli non ha studiato cosa sia stato il «giacobinismo» francese e come la paura del giacobinismo abbia appunto paralizzato l’attività nazionale. Non spiega poi perché si sia formato il mito del «Mezzogiorno polveriera d’Italia» in Pisacane e quindi in Mazzini. Tuttavia questo punto è basilare per comprendere Pisacane e l’origine delle sue idee che sono le stesse che in Bakunin ecc. Così non si può vedere in Pisacane un «precursore» in atto del Sorel, ma semplicemente un esemplare del «nichilismo» di origine russa e della teoria della «pandistruzione» creatrice (anche con la malavita). L’«iniziativa popolare» da Mazzini a Pisacane si colora delle tendenze «populiste» estreme. (Forse il filone Herzen indicato da Ginzburg nella «Cultura» del 1932 è da approfondire). Anche la lettera ai parenti dopo la fuga con una donna maritata potrebbe essere sottoscritta dal Bazàrov di Padri e figli (la lettera è pubblicata integralmente nella «Nuova Antologia» del 1932): c’è tutta la morale dedotta dalla natura come la rappresenta la scienza naturale e il materialismo filosofico. Deve essere quasi impossibile ricostruire la «cultura libresca» del Pisacane e fissare le «fonti» dei suoi concetti: il solo modo di procedere è quello di ricostruire un certo ambiente intellettuale di una certa emigrazione politica di dopo il ’48 in Francia e in Inghilterra, di una «cultura parlata» di comunicazioni ideologiche avvenute attraverso le discussioni e le conversazioni.
Q15 §53 Storia letteraria o della cultura. L’origine della teoria americana (riferita dal Cambon in una sua prefazione a un volume del Ford) che in ogni epoca i grandi uomini sono tali nell’attività fondamentale dell’epoca stessa, cosa per cui sarebbe assurdo «rimproverare» agli Americani di non avere grandi artisti quando hanno «grandi tecnici», come sarebbe rimproverare al Rinascimento di aver avuto grandi pittori e scultori e non grandi tecnici, si può trovare in Carlyle (Sugli eroi e l’eroismo). Carlyle deve dire presso a poco che Dante se avesse dovuto fare il guerriero, ossia se si fosse trovato a sviluppare la sua personalità in un momento di necessità militare ecc. sarebbe stato grande lo stesso ecc., cioè l’eroismo sarebbe quasi da concepire come una forma che si riempie del contenuto eroico prevalente nel corregge un precedente «del». tempo o nell’ambiente determinato.
Si può tuttavia dire che in tempi di avvilimento pubblico, di compressione ecc. è impossibile ogni forma di «grandezza». Dove il grande carattere morale è combattuto non si può essere grande artista ecc. Metastasio non può essere Dante o Alfieri. Dove prospera Ojetti può esserci un Dante? Forse un Michele Barbi! Ma la quistione in generale non pare seria, se impostata sulla necessità che appaiano grandi genii. Si può solo giudicare dell’atteggiamento verso la vita, più o meno conformista o eroico, metastasiano o alfieriano, il che certo non è poco. Non è da escludere che dove la tradizione ha lasciato un largo strato di intellettuali, e un interesse vivace o prevalente per certe attività, si sviluppino «genii» che non corrispondono ai tempi in cui vivono concretamente, ma a quelli in cui vivono «idealmente» e culturalmente. Machiavelli potrebbe essere uno di questi. Inoltre si dimentica che ogni tempo o ambiente è contraddittorio e che si esprime e si corrisponde al proprio tempo o ambiente combattendoli strenuamente oltre che collaborando alle forme di vita ufficiale. Pare che anche in questo argomento è da tener conto della quistione degli intellettuali e del loro modo di selezionarsi nelle varie epoche di sviluppo della civiltà. E da questo punto di vista può esserci molta verità nell’affermazione americana. Epoche progressive nel campo pratico possono non aver avuto il tempo ancora di manifestarsi nel campo creativo estetico e intellettuale, o possono essere in questo arretrate, filistee ecc.
Q15 §54 Ugo Bernasconi. Scrittore di massime morali, novelliere, critico d’arte e credo anche pittore. Collaboratore del «Viandante» di Monicelli e quindi di una certa tendenza.
Si potrebbero estrarre alcune delle sue massime migliori. «Vivere è sempre un adattarsi. Ma adattarsi a qualche cosa per salvare qualche cos’altro. In questa alternativa si forma e si palesa tutto il carattere di un uomo».
«La vera Babele non è tanto dove si parlano lingue diverse, ma dove tutti credono di parlare la stessa lingua, e ciascuno dà alle stesse parole un significato diverso».
«Tanto è il valore del pensiero teorico per un proficuo operare, che talvolta può dare buon frutto anche la più balorda delle teorie, che è quella: non teorie ma fatti». («Pègaso» del giugno 1933).
Q15 §55 Passato e presente. Una delle manifestazioni più tipiche del pensiero settario (pensiero settario è quello per cui non si riesce a vedere come il partito politico non sia solo l’organizzazione tecnica del partito stesso, ma tutto il blocco sociale attivo di cui il partito è la guida perché l’espressione necessaria) è quella per cui si ritiene di poter fare sempre certe cose anche quando la «situazione politico-militare» è cambiata. Tizio lancia un grido e tutti applaudono e si entusiasmano; il giorno dopo, la stessa gente che ha applaudito e si è entusiasmata a sentire lanciare quel grido, finge di non sentire, scantona ecc.; al terzo giorno la stessa gente rimprovera Tizio, lo rintuzza, e anche lo bastona o lo denunzia. Tizio non ne capisce nulla; ma Caio che ha comandato Tizio, rimprovera Tizio di non aver gridato bene, o di essere un vigliacco o un inetto ecc. Caio è persuaso che quel grido, elaborato dalla sua eccellentissima capacità teorica, deve sempre entusiasmare e trascinare, perché nella sua conventicola infatti i presenti fingono ancora di entusiasmarsi ecc. Sarebbe interessante descrivere lo stato d’animo di stupore e anche di indignazione del primo francese che vide rivoltarsi il popolo siciliano dei Vespri.
Q15 §56 Risorgimento italiano. Sulla rivoluzione passiva. Protagonisti i «fatti» per così dire e non gli «uomini individuali». Come sotto un determinato involucro politico necessariamente si modificano (Nel manoscritto segue una parola cancellata e di difficile lettura.) i rapporti sociali fondamentali e nuove forze effettive politiche sorgono e si sviluppano, che influiscono indirettamente, con la pressione lenta ma incoercibile, sulle forze ufficiali che esse stesse si modificano senza accorgersene o, quasi.
Q15 §57 Passato e presente. Da una lettera a Uberto Lagardelle di Giorgio Sorel (scritta il 15 agosto 1898 e pubblicata nell’«Educazione Fascista» del marzo 1933): «Deville a pour grand argument que la campagne pour Dreyfus donne de la force aux militaristes et peut amener une réaction. Le malheureux ne voit pas que c’est tout le contraire: la réaction était en train express et elle se bute devant une résistence inopinée, où les avancés ont pour auxiliaire des modérés. Les gens qui ne voyaient pas le mouvement réel, qui en étaient aux apparences trompeuses des scrutins, croyaient que la France marchait dare dare vers le socialisme; j’ai toujours vu qu’elle marchait vers le césarisme. Le mouvement apparait maintenant, parce qu’il y a une pierre dans l’engrenage, les dents grincent et se cassent; mais ce n’est pas la pierre qui a fait naître l’engrenage, mais elle force les aveugles à s’apercevoir qu’il existe».
La mentalità alla Deville è sempre stata diffusa. Quistione dell’offensiva e della difensiva. È da domandare se ogni qualvolta lo «scrutinio» era favorevole alla sinistra, non ci sia stata una preparazione di colpo di Stato da parte della destra, che non avrebbe mai permesso alla sinistra di avere dalla sua parte la forza e il prestigio della così detta «legalità» statale. (Ricordare gli articoli del Garofalo nell’«Epoca» del 1922. Il libro di Nino Daniele su D’Annunzio politico. Modo di impostare la narrazione degli avvenimenti del 1918‑19‑20 ecc.). Nelle memorie del diplomatico Aldovrandi pubblicate nella Nuova Antologia del 15 maggio - 1° giugno 1933 alcuni spunti utilissimi per valutare gli avvenimenti dell’aprile 1919 a Milano. La quistione legata a quella della così detta «violenza» come metodo dogmatico, stupidissima forma di rosolia di quegli anni. (Orlando, che nell’aprile 1919 era a Parigi, non deve essere stato estraneo agli avvenimenti di Milano, che eranonecessari alla commissione italiana per sostenere la sua posizione. Anche l’abbiosciamento di Giacinto Menotti non dovette essere senza un motivo forse determinato indirettamente dal governo).
Q15 §58 Critica letteraria. Nel fascicolo del marzo 1933 dell’«Educazione Fascista» l’articolo polemico di Argo con Paul Nizan (Idee d’oltre confine) a proposito della concezione di una nuova letteratura che sorga da un integrale rinnovamento intellettuale e morale. Il Nizan pare ponga bene il problema quando comincia dal definire che cosa è un integrale rinnovamento delle premesse culturali e limita il campo della ricerca stessa. L’unica obbiezione fondata di Argo è questa: l’impossibilità di saltare uno stadio nazionale, autoctono della nuova letteratura e i pericoli «cosmopolitici» della concezione del Nizan. Da questo punto di vista molte critiche del Nizan a gruppi di intellettuali francesi sono da rivedere: «Nouvelle Revue Française», il populismo ecc., fino al gruppo del «Monde», non perché le critiche non colpiscono nel giusto politicamente, ma appunto perché è impossibile che la nuova letteratura non si manifesti «nazionalmente» in combinazioni e leghe diverse, più o meno ibride. È tutta la corrente che occorre esaminare e studiare, obbiettivamente. D’altronde per il rapporto tra letteratura e politica, occorre tener presente questo criterio: che il letterato deve avere prospettiva necessariamente meno precise e definite che l’uomo politico, deve essere meno «settario» se così si può dire, ma in modo «contraddittorio». Per l’uomo politico ogni immagine «fissata» a priori è reazionaria: il politico considera tutto il movimento nel suo divenire. L’artista deve invece avere immagini «fissate» e colate nella loro forma definitiva. Il politico immagina l’uomo come è e nello stesso tempo come dovrebbe essere per raggiungere un determinato fine; il suo lavoro consiste appunto nel condurre gli uomini a muoversi, a uscire dal loro essere presente per diventare capaci collettivamente di raggiungere il fine proposto, cioè a «conformarsi» al fine. L’artista rappresenta necessariamente «ciò che è» in un certo momento di personale, di non conformista ecc., realisticamente. Perciò dal punto di vista politico, il politico non sarà mai contento dell’artista e non potrà esserlo: lo troverà sempre in arretrato coi tempi, sempre anacronistico, sempre superato dal movimento reale. Se la storia è un continuo processo di liberazione e di autocoscienza, è evidente che ogni stadio, come storia, in questo caso come cultura, sarà subito superato e non interesserà più. Di ciò mi pare occorra tener conto nel valutare i giudizi del Nizan sui diversi gruppi.
Ma da un punto di vista obiettivo, come ancora oggi per certi strati della popolazione è «attuale» Voltaire, così possono essere attuali, e anzi lo sono, questi gruppi letterari e le combinazioni che essi rappresentano: obiettivo vuol dire, in questo caso, che lo sviluppo del rinnovamento intellettuale e morale non è simultaneo in tutti gli strati sociali, tutt’altro: ancora oggi, giova ripeterlo, molti sono tolemaici e non copernicani. (Esistono molti «conformismi», molte lotte per nuovi conformismi, e combinazioni diverse tra ciò che è, variamente atteggiato, e ciò che si lavora a far diventare, e sono molti che lavorano in questo senso). Porsi dal punto di vista di una «sola» linea di movimento progressivo, per cui ogni acquisizione nuova si accumula e diventa la premessa di nuove acquisizioni, è grave errore: non solo le linee sono molteplici, ma si verificano anche dei passi indietro nella linea «più» progressiva. Inoltre il Nizan non sa porre la quistione della così detta «letteratura popolare», cioè della fortuna che ha in mezzo alle masse nazionali la letteratura da appendice (avventurosa, poliziesca, gialla ecc.), fortuna che è aiutata dal cinematografo e dal giornale. Eppure è questa quistione che rappresenta la parte maggiore del problema di una nuova letteratura in quanto espressione di un rinnovamento intellettuale e morale: perché solo dai lettori della letteratura d’appendice si può selezionare il pubblico sufficiente e necessario per creare la base culturale della nuova letteratura. Mi pare che il problema sia questo: come creare un corpo di letterati che artisticamente stia alla letteratura d’appendice come Dostojevskij stava a Sue e a Soulié o come Chesterton, nel romanzo poliziesco, sta a Conan Doyle e a Wallace ecc. Bisogna a questo scopo abbandonare molti pregiudizi, ma specialmente occorre pensare che non si può avere il monopolio, non solo, ma che si ha di contro una formidabile organizzazione d’interessi editoriali. Il pregiudizio più comune è questo: che la nuova letteratura debba identificarsi con una scuola artistica di origine intellettuale, come fu per il futurismo.
La premessa della nuova letteratura non può non essere storico‑politica, popolare: deve tendere a elaborare ciò che già esiste, polemicamente o in altro modo non importa; ciò che importa è che essa affondi le sue radici nell’humus della cultura popolare così come è, coi suoi gusti, le sue tendenze ecc., col suo mondo morale e intellettuale sia pure arretrato e convenzionale.
Q15 §59 Risorgimento Italiano. I. La funzione del Piemonte nel Risorgimento italiano è quella di una «classe dirigente». In realtà non si tratta del fatto che in tutto il territorio della penisola esistessero nuclei di classe dirigente omogenea la cui irresistibile tendenza a unificarsi abbia determinato la formazione del nuovo Stato nazionale italiano. Questi nuclei esistevano, indubbiamente, ma la loro tendenza a unirsi era molto problematica, e ciò che più conta, essi, ognuno nel suo ambito, non erano «dirigenti». Il dirigente presuppone il «diretto», e chi era diretto da questi nuclei? Questi nuclei non volevano «dirigere» nessuno, cioè non volevano accordare i loro interessi e aspirazioni con gli interessi ed aspirazioni di altri gruppi. Volevano «dominare» non «dirigere», e ancora: volevano che dominassero i loro interessi, non le loro persone, cioè volevano che una forza nuova, indipendente da ogni compromesso e condizione, divenisse l’arbitra della Nazione: questa forza fu il Piemonte e quindi la funzione della monarchia. Il Piemonte ebbe pertanto una funzione che può, per certi aspetti, essere paragonata a quella del partito, cioè del personale dirigente di un gruppo sociale (e si parlò sempre infatti di «partito piemontese»), con la determinazione che si trattava di uno Stato, con un esercito, una diplomazia ecc.
Questo fatto è della massima importanza per il concetto di «rivoluzione passiva»: che cioè non un gruppo sociale sia il dirigente di altri gruppi, ma che uno Stato, sia pure limitato come potenza, sia il «dirigente» del gruppo che esso dovrebbe essere dirigente e possa porre a disposizione di questo un esercito e una forza politico‑diplomatica. Si può riferirsi a quella che è stata chiamata la funzione del «Piemonte» nel linguaggio politico‑storico internazionale. La Serbia prima della guerra si atteggiava a «Piemonte» dei Balcani. (Del resto la Francia, dopo il 1789 e per molti anni, fino al colpo di Stato di Luigi Napoleone fu, in questo senso, il Piemonte dell’Europa). Che la Serbia non sia riuscita come è riuscito il Piemonte è dovuto al fatto che nel dopoguerra si è avuto un risveglio politico dei contadini quale non esisteva dopo il 1848. Se si studia da vicino ciò che avviene nel regno jugoslavo, si vede che in esso le forze «serbiste» o favorevoli all’egemonia serba, sono le forze contrarie alla riforma agraria. Troviamo un blocco rurale-intellettuale antiserbo, e le forze conservatrici favorevoli alla Serbia sia in Croazia che nelle altre regioni non serbe. Anche in questo caso non esistono nuclei locali «dirigenti», ma diretti dalla forza serba, mentre le forze sovvertitrici non hanno, come funzione sociale, una grande importanza. Per chi osserva superficialmente le cose serbe, sarebbe da domandare cosa sarebbe avvenuto se il così detto brigantaggio che si ebbe nel napoletano e in Sicilia dal ’60 al ’70 si fosse avuto dopo il 1919. Indubbiamente il fenomeno è lo stesso, ma il peso sociale e l’esperienza politica delle masse contadine è ben diverso dopo il 1919, da quelli che erano dopo il 1848.
L’importante è di approfondire il significato che ha una funzione tipo «Piemonte» nelle rivoluzioni passive, cioè il fatto che uno Stato si sostituisce ai gruppi sociali locali nel dirigere una lotta di rinnovamento. È uno dei casi in cui si ha la funzione di «dominio» e non di «dirigenza» in questi gruppi: dittatura senza egemonia. L’egemonia sarà di una parte del gruppo sociale sull’intiero gruppo, non di questo su altre forze per potenziare il movimento, radicalizzarlo, ecc. sul modello «giacobino».
II. Studi rivolti a cogliere le analogie tra il periodo successivo alla caduta di Napoleone e quello successivo alla guerra del ’14‑18. Le analogie sono viste solo sotto due punti di vista: la divisione territoriale e quella, più vistosa e superficiale, del tentativo di dare una organizzazione giuridica stabile ai rapporti internazionali (Santa Alleanza e Società delle Nazioni). Pare invece che il tratto più importante da studiare sia quello che si è detto della «rivoluzione passiva», problema che non appare vistosamente perché manca un parallelismo esteriore alla Francia del 1789‑1815. E tuttavia tutti riconoscono che la guerra del ’14‑18 rappresenta una frattura storica, nel senso che tutta una serie di quistioni che molecolarmente si accumulavano prima del 1914 hanno appunto fatto «mucchio», modificando la struttura generale del processo precedente: basta pensare all’importanza che ha assunto il fenomeno sindacale, termine generale in cui si assommano diversi problemi e processi di sviluppo di diversa importanza e significato (parlamentarismo, organizzazione industriale, democrazia, liberalismo, ecc.), ma che obiettivamente riflette il fatto che una nuova forza sociale si è costituita, ha un peso non più trascurabile, ecc. ecc.
Q15 §60 Risorgimento italiano. Cavour. Cosa significa nel libro di Alberto Cappa sul Cavour, l’insistere continuamente nell’affermazione che la politica del Cavour rappresenta il «giusto mezzo»? Perché «giusto»? Forse perché ha trionfato? La «giustezza» della politica del Cavour non può essere teorizzata a priori; non può trattarsi di una «giustezza» razionale, assoluta ecc. In realtà non si può parlare di una funzione da intermediario in Cavour, ciò che diminuirebbe la sua figura e il suo significato. Cavour seguì una sua linea, che trionfò non perché mediasse opposti estremismi, ma perché rappresentava la sola politica giusta dell’epoca, appunto per l’assenza di validi e intelligenti (politicamente) competitori. Nel Cappa il «giusto mezzo» rassomiglia molto al «giusto prezzo», all’«ottimo governo» ecc. In realtà avviene che sfugge poi al Cappa quale sia stata la reale politica cavourriana, la politica indipendente, originale ecc., qualunque sia il giudizio che di essa si possa dare per i risultati che ha avuto nell’epoca successiva, cioè anche se si debba dire che essa fu molto meno «nazionale» di quanto il Cappa, secondo i figurini ufficiali, vuol far credere, anche se essa fu una lotta vittoriosa contro le forze popolari (senza «giusto mezzo»), ciò che contribuì a costituire uno Stato angusto, settario, senza possibilità d’azione internazionale perché sempre minacciato dall’insorgere di forze sovvertitrici elementari che appunto Cavour non volle «nazionalizzare». Che il Cavour abbia, come metodo di propaganda politica, assunto una posizione da «giusto mezzo» non ha che un significato secondario. In realtà le forze storiche cozzano tra loro per il loro programma «estremo». Che tra queste forze, una assuma la funzione di «sintesi» superatrice degli opposti estremismi è una necessità dialettica, non un metodo aprioristico. E saper trovare volta per volta il punto di equilibrio progressivo (nel senso del proprio programma) è l’arte del politico non del giusto mezzo, ma proprio del politico che ha una linea molto precisa e di grande prospettiva per l’avvenire. Il Cappa può essere portato come esempio nell’esposizione della forma italiana del «proudhonismo» giobertiano, dell’antidialettica dell’opportunismo empirico e di corta vista.
Q15 §61 Introduzione allo studio della filosofia. 1) Egemonia della cultura occidentale su tutta la cultura mondiale. Ammesso anche che altre culture abbiano avuto importanza e significato nel processo di unificazione «gerarchica» della civiltà mondiale (e certamente ciò è da ammettere senz’altro), esse hanno avuto valore universale in quanto sono diventate elementi costitutivi della cultura europea, la sola storicamente o concretamente universale, in quanto cioè hanno contribuito al processo del pensiero europeo e sono state da questo assimilate.
2) Ma anche la cultura europea ha subito un processo di unificazione, e, nel momento storico che ci interessa, ha culminato nello Hegel e nella critica all’hegelismo.
3) Dai due primi punti risulta che si tiene conto del processo culturale che si impersona negli intellettuali; non è da parlare delle culture popolari, per le quali non si può parlare di elaborazione critica e di processo di sviluppo.
4) Non è neanche da parlare di quei processi culturali che culminano nell’attività reale, come si verificò nella Francia del secolo XVIII, o almeno è da parlarne solo in connessione col processo culminato in Hegel e nella filosofia classica tedesca, come una riprova «pratica», nel senso cui si è più volte e altrove accennato, della reciproca traducibilità dei due processi, l’uno, quello francese, politico‑giuridico, l’altro, quello tedesco, teorico‑speculativo.
5) Dalla decomposizione dell’hegelismo risulta l’inizio di un nuovo processo culturale, di carattere diverso da quelli precedenti, in cui, cioè, si unificano il movimento pratico e il pensiero teorico (o cercano di unificarsi attraverso una lotta e teorica e pratica).
6) Non è rilevante il fatto che tale nuovo movimento abbia la sua culla in opere filosofiche mediocri, o, per lo meno, non in capolavori filosofici. Ciò che è rilevante è che nasce un nuovo modo di concepire il mondo e l’uomo, e che tale concezione non è più riservata ai grandi intellettuali, ai filosofi di professione, ma tende a diventare popolare, di massa, con carattere concretamente mondiale, modificando (sia pure col risultato di combinazioni ibride) il pensiero popolare, la mummificata cultura popolare.
7) Che tale inizio risulti dal confluire di vari elementi, apparentemente eterogenei, non maraviglia: Feuerbach, come critico di Hegel, la scuola di Tubinga come affermazione della critica storica e filosofica della religione ecc. Anzi è da notare che un tale capovolgimento non poteva non avere connessioni con la religione.
8) La filosofia della prassi come risultato e coronamento di tutta la storia precedente. Dalla critica dell’hegelismo nascono l’idealismo moderno e la filosofia della prassi. L’immanentismo hegeliano diventa storicismo; ma è storicismo assoluto solo con la filosofia della prassi, storicismo assoluto o umanesimo assoluto. (Equivoco dell’ateismo ed equivoco del deismo in molti idealisti moderni: evidente che l’ateismo è una forma puramente negativa e infeconda, a meno che non sia concepito come un periodo di pura polemica letterario‑popolare).
Q15 §62 Passato e presente. Epilogo primo. L’argomento della «rivoluzione passiva» come interpretazione dell’età del Risorgimento e di ogni epoca complessa di rivolgimenti storici. Utilità e pericoli di tale argomento. Pericolo di disfattismo storico, cioè di indifferentismo, perché l’impostazione generale del problema può far credere a un fatalismo, ecc.; ma la concezione rimane dialettica, cioè presuppone, anzi postula come necessaria, un’antitesi vigorosa e che metta in campo tutte le sue possibilità di esplicazione intransigentemente. Dunque non teoria della «rivoluzione passiva» come programma, come fu nei liberali italiani del Risorgimento, ma come criterio di interpretazione in assenza di altri elementi attivi in modo dominante. (Quindi lotta contro il morfinismo politico che esala da Croce e dal suo storicismo). (Pare che la teoria della rivoluzione passiva sia un necessario corollario critico dell’Introduzione alla critica dell’economia politica). Revisione di alcuni concetti settari sulla teoria dei partiti, che appunto rappresentano una forma di fatalismo del tipo «diritto divino». Elaborazione dei concetti del partito di massa e del piccolo partito di élite e mediazione tra i due. (Mediazione teorica e pratica: teoricamente può esistere un gruppo, relativamente piccolo, ma sempre notevole, per esempio di qualche migliaia di persone, omogeneo socialmente e ideologicamente, senza che la sua stessa esistenza dimostri una vasta condizione di cose e di stati d’animo corrispondenti, che non possono esprimersi solo per cause meccaniche estranee e perciò transitorie?)
Q15 §63 Risorgimento italiano. Cfr Attilio Monaco, I galeotti politici napoletani dopo il Quarantotto, Roma, Libreria Internazionale Treves ‑ Treccani ‑ Tumminelli, 1933, pp. 873, in 2 voll., L. 50. Quando nel 1849 cominciò la reazione borbonica nel napoletano, gli inscritti nelle liste degli «attendibili» cioè colpiti dalla sorveglianza poliziesca furono 31 062 e raggiunsero fino alla fine i 100 000. La maggior parte incorsero nelle pene minori del domicilio forzoso, dell’esilio, della detenzione, della reclusione o scontarono semplicemente il carcere preventivo per mesi e anche anni.
Il Monaco ha cercato di ricostruire la lista di questi lottatori, ma ha dovuto limitarsi ai condannati alle pene più gravi e specialmente ai condannati dalle Grandi Corti speciali e che passarono lunghi anni nelle galere. Questi sono stati circa un migliaio, di varia origine sociale: possidenti e commercianti, medici e avvocati, sarti e falegnami, contadini e braccianti… Il libro del Monaco deve essere molto interessante per varie ragioni: 1) perché mostra che gli elementi attivi politici furono nel Napoletano più numerosi di quanto si potesse pensare (100 000 sospetti e sottoposti a misure di polizia è un bel numero in tempi in cui i partiti erano embrionali); 2) perché dà informazioni sul regime carcerario borbonico per i politici e per i comuni (che si trovavano insieme): 157 politici morirono in galera, almeno 10 divennero pazzi; 3) si può, dal libro, vedere quale partecipazione dettero all’attività politica le diverse categorie sociali. Il bagno di Procida fu il più popolato di politici: nel 1854 ve ne erano 398.
Q15 §64 Traducibilità delle diverse culture nazionali. Parallelo tra la civiltà greca e quella latina e importanza che hanno avuto rispettivamente il mondo greco e quello latino nel periodo dell’Umanesimo e del Rinascimento. (Pubblicazioni attuali sulla vecchia quistione della «superiorità» e «originalità» della arte greca in confronto con quella latina: vedi lo studio di Augusto Rostagni Autonomia della letteratura latina nell’«Italia Letteraria» del 21 maggio 1933 e segg.). Per ciò che riguarda l’Umanesimo e il Rinascimento il Rostagni non distingue i diversi aspetti della cultura italiana: 1) Lo studio umanistico‑erudito della classicità greco‑romana che diventa esemplare, modello di vita ecc. 2) Il fatto che tale riferimento al mondo classico non è altro che l’involucro culturale in cui si sviluppa la nuova concezione della vita e del mondo in concorrenza e spesso (poi sempre più) in opposizione alla concezione religiosa-medioevale. 3) Il movimento originale che l’«uomo nuovo» realizza come tale, e che è nuovo e originale nonostante l’involucro umanistico, esemplato sul mondo antico. A questo riguardo è da osservare che spontaneità e vigore di arte si ha prima che l’umanesimo si «sistemi», quindi la proposizione altrove prospettata che l’umanesimo sia un fenomeno in gran parte reazionario, cioè rappresenti il distacco degli intellettuali dalle masse che andavano nazionalizzandosi e quindi un’interruzione della formazione politico‑nazionale italiana, per ritornare alla posizione (in altra forma) del cosmopolitismo imperiale e medioevale.
Il parallelo tra Greci e Romani è un falso e inutile problema, di origine e carattere politico. Hanno avuto i Romani una filosofia? Hanno avuto un loro «modo di pensare» e di concepire l’uomo e la vita e questa è stata la loro reale «filosofia», incorporata nelle dottrine giuridiche e nella pratica politica. Si può dire (in un certo senso) per i Romani e i Greci ciò che Hegel dice a proposito della politica francese e della filosofia tedesca.
Q15 §65 Introduz. allo studio della filosofia. Cfr il libro di Santino Caramella, Senso comune, Teoria e Pratica, pp. 176, Bari, Laterza, 1933. Contiene tre saggi: 1) La critica del «senso comune»; 2) I rapporti fra la teoria e la pratica; 3) Universalità e nazionalità nella storia della filosofia italiana.
Q15 §66 Passato e presente. Nel succedersi delle generazioni (e in quanto ogni generazione esprime la mentalità di un’epoca storica) può avvenire che si abbia una generazione anziana dalle idee antiquate e una generazione giovane dalle idee infantili, che cioè manchi l’anello storico intermedio, la generazione che abbia potuto educare i giovani.
Tutto ciò è relativo, s’intende. Questo anello intermedio non manca mai del tutto, ma può essere molto debole «quantitativamente» e quindi materialmente nell’impossibilità di sostenere il suo compito. Ancora: ciò può avvenire per un gruppo sociale e non per un altro. Nei gruppi subalterni il fenomeno si verifica più spesso e in modo più grave, per la difficoltà, insita nell’essere «subalterno», di una continuità organica dei ceti intellettuali dirigenti e per il fatto che per i pochi elementi che possono esistere all’altezza dell’epoca storica è difficile organizzare ciò che gli americani chiamano trust dei cervelli.
Q15 §67 Quistione agraria. Cosa deve intendersi per «azienda agricola»? Una organizzazione industriale per la produzione agricola che abbia caratteri permanenti di continuità organica. Differenza tra azienda e impresa. L’impresa può essere per fini immediati, mutevoli ogni anno o gruppo di anni, ecc., senza investimenti fondiari, ecc., con capitale d’esercizio «d’avventura». La quistione ha importanza perché l’esistenza dell’azienda o del sistema aziendale indica il grado di industrializzazione raggiunto ed ha una ripercussione sulla mentalità della massa contadina. Arrigo Serpieri: «La stabilizzazione nello spazio dell’impresa è realizzata quando essa coincide con una azienda, unità tecnico-economica che stabilmente coordina terra, capitali e forze di lavoro occorrenti alla produzione». (Su alcuni di questi problemi cfr l’articolo del Serpieri Il momento attuale della bonifica, nella «Gerarchia» del luglio 1933).
Q15 §68 Argomenti di cultura. Origini popolaresche del concetto di superuomo. Su questo argomento sarà da vedere l’opera del Farinelli, Il romanticismo nel mondo latino (3 voll., Bocca). (Nel vol. 2°, capitolo dove si parla del motivo dell’«uomo fatale» e del «genio incompreso»).
Q15 §69 Passato e presente. In una memoria politico-giuridica giovanile di Daniele Manin (cfr l’articolo di A. Levi sulla Politica di Daniele Manin nella «Nuova Rivista Storica» del maggio‑agosto 1933) si usa l’espressione «matto per decreto». Il Tommaseo, annotando lo scritto del Manin, ricorda come di una signora, ammirata pubblicamente da Napoleone, si dicesse che era «bella per decreto». Per decreto si può diventare molte cose e l’epigramma è sempre vivo.
Q15 §70 Rinascimento. Sulla figura e l’importanza di Lorenzo il Magnifico sono da vedere gli studi di Edmondo Rho. Si annunziano studi di R. Palmarocchi che non pare abbia la capacità di interpretare la funzione del Magnifico. Dal punto di vista storico‑politico il Rho sostiene che il Magnifico fu un mediocre, privo di capacità creativa. Diplomatico, non politico. Il Magnifico avrebbe semplicemente seguito il programma di Cosimo. Come politica estera (italiana, riguardante l’intera penisola) Lorenzo avrebbe avuto l’idea geniale di organizzare una lega italica che però non fu attuata ecc. (Il Palmarocchi ha raccolto Le più belle pagine di Lorenzo nell’ed. Ojetti e nell’introduzione ha cercato di rappresentare la figura di Lorenzo).
La funzione di Lorenzo è importante per ricostruire il nodo storico italiano che rappresenta il passaggio da un periodo di sviluppo imponente delle forze borghesi alla loro decadenza rapida ecc. Lo stesso Lorenzo può essere assunto come «modello» della incapacità borghese di quell’epoca a formarsi in classe indipendente e autonoma per l’incapacità di subordinare gli interessi personali e immediati a programmi di vasta portata. In questo caso, saranno da vedere i rapporti con la Chiesa di Lorenzo e dei Medici che lo precedettero e gli successero. Chi sostiene che il Savonarola fu «uomo del Medio Evo» non tiene sufficiente conto della sua lotta col potere ecclesiastico, lotta che in fondo tendeva a rendere Firenze indipendente dal sistema feudale chiesastico. (Per il Savonarola si fa la solita confusione tra l’ideologia che si fonda su miti del passato e la funzione reale che deve prescindere da questi miti ecc.).
Q15 §71 Passato e presente. Cfr articolo di Crispolto Crispolti nella «Gerarchia» del luglio 1933 su Leone XIII e l’Italia (sul volume di Eduardo Soderini, Il Pontificato di Leone XIII, vol. II, Rapporti con l’Italia e con la Francia, Mondadori editore). Il Crispolti scrive che l’anticlericalismo italiano (e quindi lo sviluppo della Massoneria) dal 1878 al 1903 (pontificato di Leone XIII) fu una conseguenza della politica antitaliana del Vaticano. Anche il Crispolti non è soddisfatto dei volumi del Soderini. Richiamo al volume del Salata e all’«Archivio Galimberti». Volumi del Soderini «aulici, ufficiali» del Vaticano. L’articolo del Crispolti è interessante.
Q15 §72 Machiavelli (Nuovo Machiavelli, cfr quaderno speciale ecc.). A proposito del Rinascimento, di Lorenzo dei Medici ecc., quistione di «grande politica e di piccola politica», politica creativa, e politica di equilibrio, di conservazione, anche se si tratta di conservare una situazione miserabile. Accusa ai francesi (e ai Galli fin da Giulio Cesare) di essere volubili ecc. E in questo senso gli italiani del Rinascimento non sono mai stati «volubili», anzi forse occorre distinguere tra la grande politica che gli italiani facevano all’«estero», come forza cosmopolita (finché la funzione cosmopolita durò) e la piccola politica all’interno, la piccola diplomazia, l’angustia dei programmi ecc., quindi la debolezza di coscienza nazionale che avrebbe domandato una attività audace e di fiducia nelle forze popolari‑nazionali. Finito il periodo della funzione cosmopolita, rimase quello della «piccola politica» all’interno, lo sforzo immane per impedire ogni mutamento radicale. In realtà il «piede di casa», le mani nette ecc. che tanto sono rimproverati alle generazioni dell’Ottocento non sono che la coscienza della fine di una funzione cosmopolita nel modo tradizionale e l’incapacità di crearsene una nuova facendo leva sul popolo‑nazione.
Q15 §73 Risorgimento italiano. Cfr A. Rossi, Le cause storico‑politiche della tardiva unificazione e indipendenza d’Italia, Roma, Cremonese, 1933, pp. 112, L. 8,00. (Il titolo stesso è curioso e mostra come sia diffusa la concezione mitologico‑fatalistica nello studio del Risorgimento).
Q15 §74 Freud e l’uomo collettivo. Il nucleo più sano e immediatamente accettabile del freudismo è l’esigenza dello studio dei contraccolpi morbosi che ha ogni costruzione di «uomo collettivo», di ogni «conformismo sociale», di ogni livello di civiltà, specialmente in quelle classi che «fanaticamente» fanno del nuovo tipo umano da raggiungere una «religione», una mistica ecc. È da vedere se il freudismo necessariamente non dovesse conchiudere il periodo liberale, che appunto è caratterizzato da una maggiore responsabilità (e senso di tale responsabilità) di gruppi selezionati nella costruzione di «religioni» non autoritarie, spontanee, libertarie ecc. Un soldato di coscrizione non sentirà per le possibili uccisioni commesse in guerra lo stesso grado di rimorso che un volontario ecc. (dirà: mi è stato comandato, non potevo fare diversamente, ecc.). Lo stesso si può notare per le diverse classi: le classi subalterne hanno meno «rimorsi» morali, perché ciò che fanno non le riguarda che in senso lato ecc. Perciò il freudismo è più una «scienza» da applicare alle classi superiori e si potrebbe dire, parafrasando Bourget (o un epigramma su Bourget) che l’«inconscio» incomincia solo dopo tante decine di migliaia di lire di rendita. Anche la religione è meno fortemente sentita come causa di rimorsi dalle classi popolari, che forse non sono troppo aliene dal credere che in ogni caso anche Gesù Cristo è stato crocifisso per i peccati dei ricchi. Si pone il problema se sia possibile creare un «conformismo», un uomo collettivo senza scatenare una certa misura di fanatismo, senza creare dei «tabù», criticamente, insomma, come coscienza di necessità liberamente accettata perché «praticamente» riconosciuta tale, per un calcolo di mezzi e fini da adeguare, ecc.
Q15 §75 Argomenti di cultura. Il dizionario del Rezasco. Vi accenna Felice Bernabei nelle Memorie inedite di un archeologo (prima parte pubblicata sulla Nuova Antologia del 16 luglio 1933). Il Rezasco (Giulio) fu più volte Segretario Generale della Pubblica Istruzione (cioè sottosegretario). Il Bernabei ne parla un po’ sottogamba come compilatore di un «Vocabolario della Burocrazia» e scrive: «Non so se qualche parte di questo Vocabolario del Rezasco sia stata mai pubblicata». (La redazione della «Nuova Antologia» non ha creduto opportuno annotare). Pare che il Rezasco non si occupasse dei suoi doveri burocratici e impiegasse l’orario d’ufficio a compilare il vocabolario.
Q15 §76 Risorgimento italiano. Recensione del libro di Nello Rosselli su Pisacane pubblicata nella «Nuova Rivista Storica» del 1933 (pp. 156 sgg.). Appartiene alla serie delle «interpretazioni» del Risorgimento così come il libro del Rosselli. Anche l’autore della recensione (come il Rosselli) non intende come ciò che è mancato nel Risorgimento sia stato un fermento «giacobino» nel senso classico della parola e come il Pisacane sia figura altamente interessante perché dei pochi che intese tale assenza, sebbene egli stesso non sia stato «giacobino» così come era necessario all’Italia. Si può osservare ancora che lo spauracchio che dominò l’Italia prima del 1859 non fu quello del comunismo, ma quello della Rivoluzione francese e del terrore, non fu «panico» di borghesi, ma panico di «proprietari terrieri», e del resto comunismo, nella propaganda di Metternich, era semplicemente la quistione e la riforma agraria.
QUADERNO 16
ARGOMENTI DI CULTURA I
Q16 §1 La religione, il lotto e l’oppio della miseria. Nelle
Conversazioni critiche (Serie II, pp. 300‑301) il Croce ricerca
la «fonte» del Paese di Cuccagna di Matilde Serao e la trova in
un pensiero del Balzac. Nel racconto La Rabouilleuse scritto nel
1841 e poi intitolato Un ménage de garçon, narrandosi di madama
Descoings, la quale da ventun anno giocava un famoso suo terno,
il «sociologo e filosofo romanziere» osserva: «Cette passion, si
universellement condamnée, n’a jamais été étudiée. Personne n’y
a vu l’opium de la misère. La loterie, la plus puissante fée du
monde, ne développerait‑elle pas des espérances magiques? Le
coup de roulette qui faisait voir aux joueurs des masses d’or et
de jouissances ne durait que ce que dure un éclair: tandis que
la loterie donnait cinq jours d’existence à ce magnifique
éclair. Quelle est aujourd’hui la puissance sociale qui peut,
pour quarante sous, vous rendre heureux pendant cinq jours et
vous livrer idéalement tous les bonheurs de la civilisation?»
Il Croce aveva già notato (nel suo saggio sulla Serao, Letteratura della nuova Italia, III, p. 51) che il Paese di Cuccagna (1890) aveva la sua idea generatrice in un brano dell’altro libro della Serao, Il ventre di Napoli (1884), nel quale «si lumeggia il gioco del lotto come “il grande sogno di felicità” che il popolo napoletano “rifà ogni settimana”, vivendo “per sei giorni in una speranza crescente, invadente, che si allarga, esce dai confini della vita reale”; il sogno “dove sono tutte le cose di cui esso è privato, una casa pulita, dell’aria salubre e fresca, un bel raggio di sole caldo per terra, un letto bianco e alto, un comò lucido, i maccheroni e la carne ogni giorno, e il litro di vino, e la culla pel bimbo, e la biancheria per la moglie, e il cappello nuovo per il marito”».
Il brano di Balzac potrebbe anche connettersi con l’espressione «oppio del popolo» impiegata nella Critica della filosofia del Diritto di Hegel pubblicata nel 1844 (verificare la data), il cui autore fu un grande ammiratore di Balzac: «Aveva una tale ammirazione per Balzac che si proponeva di scrivere un saggio critico sulla Commedia umana», scrive Lafargue neisuoi ricordi su Carlo Marx pubblicati nella nota raccolta del Riazanov (p. 114 dell’edizione francese). In questi ultimi tempi (forse nel 1931) è stata pubblicata una lettera inedita di Engels in cui si parla diffusamente del Balzac e dell’importanza culturale che occorre attribuirgli.
È probabile che il passaggio dall’espressione «oppio della miseria» usata dal Balzac per il lotto, all’espressione «oppio del popolo» per la religione, sia stato aiutato dalla riflessione sul «pari» di Pascal, che avvicina la religione al gioco d’azzardo, alle scommesse. È da ricordare che proprio nel 1843 Victor Cousin segnalò il manoscritto autentico delle Pensées di Pascal che erano state stampate per la prima volta nel 1670 dai suoi amici di Port‑Royal molto scorrettamente, e furono ristampate nel 1844 dall’editore Faugère dal manoscritto segnalato dal Cousin. Le Pensées, in cui Pascal svolge il suo argomento del «pari», sono i frammenti di una Apologie de la Religion chrétienne che Pascal non condusse a termine. Ecco la linea del pensiero di Pascal (secondo G. Lanson, Storia della letteratura francese, 19a ed., pp. 464): «Les hommes ont mépris pour la religion, ils en ont haine et peur qu’elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n’est point contraire à la raison; ensuite, qu’elle est vénérable, en donner respect; la rendre ensuite aimable, faire souhaiter aux bons qu’elle fût vraie, et puis montrer qu’elle est vraie».
Dopo il discorso contro l’indifferenza degli atei che serve come introduzione generale dell’opera, Pascal esponeva la sua tesi dell’impotenza della ragione, incapace di saper tutto e di saper qualcosa con certezza, ridotta a giudicare dalle apparenze offerte dall’ambiente delle cose. La fede è un mezzo superiore di conoscenza: essa si esercita oltre i limiti cui può giungere la ragione. Ma anche se ciò fosse, anche se nessun mezzo si avesse per giungere a Dio, attraverso la ragione o attraverso una qualsiasi altra via, nell’assoluta impossibilità di sapere, bisognerebbe tuttavia operare come se si sapesse. Poiché, secondo il calcolo delle probabilità, c’è vantaggio a scommettere che la religione è vera, e a regolare la propria vita come se essa fosse vera. Vivendo cristianamente si rischia infinitamente poco, qualche anno di torbidi piaceri (plaisir mêlé), per guadagnare l’infinito, la gioia eterna. È da riflettere che il Pascal è stato molto fine nel dare forma letteraria, giustificazione logica e prestigio morale a questo argomento della scommessa, che in realtà è un diffuso modo di pensare verso la religione, ma un modo di pensare che «si vergogna di se stesso» perché nel tempo stesso che soddisfa, appare indegno e basso. Pascal ha affrontato la «vergogna» (se così si può dire, poiché potrebbe essere che l’argomento del «pari» oggi popolare, in forme popolari, sia derivato dal libro del Pascal e non sia stato conosciuto prima) e ha cercato di dare dignità e giustificazione al modo di pensare popolare (quante volte si è sentito dire: «cosa ci perdi ad andare in chiesa, a credere in Dio? Se non c’è, pazienza; ma se c’è, quanto ti sarà utile aver creduto? ecc.). Questo modo di pensare, anche nella forma pascaliana del «pari», sente alquanto di volterrianismo e ricorda il modo di esprimersi di Heine: «chissà che il padre eterno non ci prepari una qualche bella sorpresa dopo la morte» o qualcosa di simile. (Vedere come gli studiosi del Pascal spiegano e giustificano moralmente l’argomento del «pari». Ci deve essere uno studio di P. P. Trompeo nel volume Rilegature gianseniste in cui si parla dell’argomento del «pari» in rapporto al Manzoni. Da vedere anche il Ruffini pel suo studio sul Manzoni religioso).
Da un articolo di Arturo Marescalchi, Durare! Anche nella bachicoltura, nel «Corriere della Sera» del 24 aprile 1932: «Per ogni mezza oncia di seme messo in allevamento si concorre a premi che da modesta cifra (ve ne sono 400 da mille lire) arrivano ai parecchi da 10 a 20 mila lire e cinque che vanno da 25 mila a 250 mila lire. Nel popolo italiano è sempre vivo il senso del tentare la sorte; nelle campagne tutt’oggi non v’è chi si astenga dalle “pesche” e dalle tombole. Qui si avrà gratis il biglietto che permette di tentare la fortuna».
Del resto c’è una stretta connessione tra il lotto e la religione, le vincite mostrano che si è stati «eletti», che si è avuta una particolare grazia da un Santo o dalla Madonna. Si potrebbe fare un confronto tra la concezione attivistica della grazia presso i protestanti che ha dato la forma morale allo spirito d’intrapresa capitalistica e la concezione passiva e lazzaronesca della grazia propria del popolino cattolico. Osservare la funzione che ha l’Irlanda nel rimettere in vigore le lotterie nei paesi anglosassoni e le proteste dei giornali che rappresentano lo spirito della Riforma, come il «Manchester Guardian».
È da vedere inoltre se Baudelaire nel titolo del suo libro I paradisi artificiali (e anche nella trattazione) si sia ispirato all’espressione «oppio del popolo»: la formula potrebbe essergli giunta indirettamente dalla letteratura politica o giornalistica. Non mi pare probabile (ma non è escluso) che esistesse già prima del libro del Balzac qualche modo di dire per cui l’oppio e gli altri stupefacenti e narcotici erano presentati come mezzo per godere un paradiso artificiale. (Bisogna ricordare, d’altronde, che Baudelaire fino al 1848 partecipò a una certa attività pratica, fu direttore di settimanali politici e prese parte attiva agli avvenimenti parigini del 1848).
Q16 §2 Quistioni di metodo. Se si vuole studiare la nascita di una concezione del mondo che dal suo fondatore non è stata mai esposta sistematicamente (e la cui coerenza essenziale è da ricercare non in ogni singolo scritto o serie di scritti ma nell’intiero sviluppo del lavoro intellettuale vario in cui gli elementi della concezione sono impliciti) occorre fare preliminarmente un lavoro filologico minuzioso e condotto col massimo scrupolo di esattezza, di onestà scientifica, di lealtà intellettuale, di assenza di ogni preconcetto ed apriorismo o partito preso. Occorre, prima di tutto, ricostruire il processo di sviluppo intellettuale del pensatore dato per identificare gli elementi divenuti stabili e «permanenti», cioè che sono stati assunti come pensiero proprio, diverso e superiore al «materiale» precedentemente studiato e che ha servito di stimolo; solo questi elementi sono momenti essenziali del processo di sviluppo. Questa selezione può essere fatta per periodi più o meno lunghi, come risulta dall’intrinseco e non da notizie esterne (che pure possono essere utilizzate) e dà luogo a una serie di «scarti», cioè di dottrine e teorie parziali per le quali quel pensatore può aver avuto, in certi momenti, una simpatia, fino ad averle accettate provvisoriamente ed essersene servito per il suo lavoro critico o di creazione storica e scientifica. È osservazione comune di ogni studioso, come esperienza personale, che ogni nuova teoria studiata con «eroico furore» (cioè quando non si studia per mera curiosità esteriore ma per un profondo interesse) per un certo tempo, specialmente se si è giovani, attira di per se stessa, si impadronisce di tutta la personalità e viene limitata dalla teoria successivamente studiata finché non si stabilisce un equilibrio critico e si studia con profondità senza però arrendersi subito al fascino del sistema o dell’autore studiato. Questa serie di osservazioni valgono tanto più quanto più il pensatore dato è piuttosto irruento, di carattere polemico e manca dello spirito di sistema, quando si tratta di una personalità nella quale l’attività teorica e quella pratica sono indissolubilmente intrecciate, di un intelletto in continua creazione e in perpetuo movimento, che sente vigorosamente l’autocritica nel modo più spietato e conseguente. Date queste premesse, il lavoro deve seguire queste linee: 1) la ricostruzione della biografia non solo per ciò che riguarda l’attività pratica ma specialmente per l’attività intellettuale; 2) il registro di tutte le opere, anche le più trascurabili, in ordine cronologico, diviso secondo motivi intrinseci: di formazione intellettuale, di maturità, di possesso e applicazione del nuovo modo di pensare e di concepire la vita e il mondo. La ricerca del leit‑motiv, del ritmo del pensiero in isviluppo, deve essere più importante delle singole affermazioni casuali e degli aforismi staccati.
Questo lavoro preliminare rende possibile ogni ulteriore ricerca. Tra le opere del pensatore dato, inoltre, occorre distinguere tra quelle che egli ha condotto a termine e pubblicate e quelle rimaste inedite, perché non compiute, e pubblicate da qualche amico o discepolo, non senza revisioni, rifacimenti, tagli, ecc., ossia non senza un intervento attivo dell’editore. È evidente che il contenuto di queste opere postume deve essere assunto con molta discrezione e cautela, perché non può essere ritenuto definitivo, ma solo materiale ancora in elaborazione, ancora provvisorio; non può escludersi che queste opere, specialmente se da lungo tempo in elaborazione e che l’autore non si decideva mai a compiere, in tutto o in parte fossero ripudiate dall’autore o non ritenute soddisfacenti.
Nel caso specifico del fondatore della filosofia della praxis, l’opera letteraria può essere distinta in queste sezioni: 1) lavori pubblicati sotto la responsabilità diretta dell’autore: tra questi devono essere considerati, in linea generale, non solo quelli materialmente dati alle stampe, ma quelli «pubblicati» o messi in circolazione in qualsiasi modo dall’autore, come le lettere, le circolari, ecc. (un esempio tipico sono le Glosse al programma di Gotha e l’epistolario); 2) le opere non stampate sotto la responsabilità diretta dell’autore, ma da altri, postume; intanto di queste sarebbe bene avere il testo diplomatico, ciò che è già in via di essere fatto, o per lo meno una minuziosa descrizione del testo originale fatta con criteri diplomatici.
L’una e l’altra sezione dovrebbero essere ricostruite per periodi cronologico‑critici, in modo da poter stabilire confronti validi e non puramente meccanici ed arbitrari.
Dovrebbe essere minutamente studiato e analizzato il lavoro di elaborazione compiuto dall’autore sul materiale delle opere poi da lui stesso stampate: questo studio darebbe per lo meno degli indizi e dei criteri per valutare criticamente l’attendibilità delle redazioni compilate da altri delle opere postume. Quanto più il materiale preparatorio delle opere edite dall’autore si allontana dal testo definitivo redatto dallo stesso autore, e tanto meno è attendibile la redazione di altro scrittore di un materiale dello stesso tipo. Un’opera non può mai essere identificata col materiale bruto, raccolto per la sua compilazione: la scelta definitiva, la disposizione degli elementi componenti, il peso maggiore o minore dato a questo o a quello degli elementi raccolti nel periodo preparatorio, sono appunto ciò che costituisce l’opera effettiva.
Anche lo studio dell’epistolario deve essere fatto con certe cautele: un’affermazione recisa fatta in una lettera non sarebbe forse ripetuta in un libro. La vivacità stilistica delle lettere, se spesso è artisticamente più efficace dello stile più misurato e ponderato di un libro, talvolta porta a deficienze di argomentazione; nelle lettere, come nei discorsi, come nelle conversazioni si verificano più spesso errori logici; la rapidità maggiore del pensiero è spesso a scapito della sua solidità.
Solo in seconda linea, nello studio di un pensiero originale e innovatore, viene il contributo di altre persone alla sua documentazione. Così, almeno in linea di principio, come metodo, deve essere impostata la quistione dei rapporti di omogeneità tra i due fondatori della filosofia della praxis. L’affermazione dell’uno o dell’altro sull’accordo reciproco vale solo per l’argomento dato. Anche il fatto che uno ha scritto qualche capitolo per il libro scritto dall’altro, non è una ragione perentoria perché tutto il libro sia considerato come risultato di un perfetto accordo. Non bisogna sottovalutare il contributo del secondo, ma non bisogna neanche identificare il secondo col primo, né bisogna pensare che tutto ciò che il secondo ha attribuito al primo sia assolutamente autentico e senza infiltrazioni. È certo che il secondo ha dato la prova di un disinteresse e di un’assenza di vanità personale unici nella storia della letteratura, ma non di ciò si tratta, né di porre in dubbio l’assoluta onestà scientifica del secondo. Si tratta che il secondo non è il primo e che se si vuole conoscere il primo occorre cercarlo specialmente nelle sue opere autentiche, pubblicate sotto la sua diretta responsabilità. Da queste osservazioni conseguono parecchie avvertenze di metodo e alcune indicazioni per ricerche collaterali. Per esempio che valore ha il libro di Rodolfo Mondolfo sul Materialismo Storico di Federico Engels edito dal Formiggini nel 1912? Il Sorel (in una lettera al Croce) pone in dubbio che si possa studiare un argomento di tal fatta, data la scarsa capacità di pensiero originale dell’Engels, e spesso ripete che bisogna non confondere tra i due fondatori della filosofia della praxis. A parte la quistione posta dal Sorel, pare che per il fatto stesso che si suppone (si afferma) una scarsa capacità teoretica nel secondo dei due amici (per lo meno una sua posizione subalterna rispetto al primo) sia indispensabile ricercare a chi spetti il pensiero originale, ecc. In realtà una ricerca sistematica di questo genere (eccetto il libro del Mondolfo) nel mondo della cultura non è mai stata fatta, anzi le esposizioni del secondo, alcune relativamente sistematiche, sono ormai assunte in primo piano, come fonte autentica e anzi sola fonte autentica. Perciò il volume del Mondolfo pare molto utile, almeno per la direttiva che traccia.
Q16 §3 Un repertorio della filosofia della praxis.Q16 §1 Sarebbe utilissimo un inventario critico di tutte le quistioni che sono state sollevate e discusse intorno alla filosofia della praxis, con ampie bibliografie critiche. Il materiale per una simile opera enciclopedica specializzata è talmente esteso, disparato, di diversissimo valore, in tante lingue, che solo un comitato di redazione potrebbe elaborarlo in un tempo non breve. Ma l’utilità che una compilazione di tal genere avrebbe, sarebbe di una importanza immensa sia nel campo scientifico sia nel campo scolastico e tra i liberi studiosi. Diverrebbe uno strumento di primo ordine per la diffusione degli studi sulla filosofia della praxis, e per il loro consolidamento in disciplina scientifica, staccando nettamente due epoche: quella moderna da quella precedente di imparaticci, di pappagallismi e di dilettantismi giornalistici. Per costruire il progetto sarebbe da studiare tutto il materiale dello stesso tipo pubblicato dai cattolici dei vari paesi a proposito della Bibbia, degli Evangeli, della Patrologia, della Liturgia, dell’Apologetica, grosse enciclopedie specializzate di vario valore ma che si pubblicano continuamente e mantengono l’unità ideologica delle centinaia di migliaia di preti e altri dirigenti che formano la impalcatura e la forza della Chiesa Cattolica. (Per la bibliografia della filosofia della praxis in Germania sono da vedere le compilazioni di Ernst Drahn, citate dallo stesso Drahn nell’introduzione ai numeri 6068‑6069 della Reklams Universal Bibliothek).
2. Occorrerebbe fare per la filosofia della praxis un lavoro come quello che il Bernheim ha fatto per il metodo storico (E. Bernheim: Lehrbuch der historischen Methode, ediz. 6a, 1908, Leipzig, Duncker u. Humblot, tradotto in italiano e pubblicato dall’editore Sandron di Palermo). Il libro del Bernheim non è un trattato della filosofia dello storicismo, tuttavia implicitamente le è legato. La cosidetta «sociologia della filosofia della praxis» dovrebbe stare a questa filosofia come il libro del Bernheim sta allo storicismo in generale cioè essere una esposizione sistematica di canoni pratici di ricerca e di interpretazione per la storia e la politica; una raccolta di criteri immediati, di cautele critiche ecc., una filologia della storia e della politica, come sono concepite dalla filosofia della praxis. Per alcuni rispetti occorrerebbe fare, di alcune tendenze della filosofia della praxis (e per avventura le più diffuse per la loro grossolanità) una stessa critica (o tipo di critica) che lo storicismo moderno ha fatto del vecchio metodo storico e della vecchia filologia, che avevano portato a forme ingenue di dogmatismo e sostituivano l’interpretazione e la costruzione storica con la descrizione esteriore e l’elencazione delle fonti grezze spesso accumulate disordinatamente ed incoerentemente. La forza maggiore di queste pubblicazioni consisteva in quella specie di misticismo dogmatico che si era venuto creando e popolarizzando e che si esprimeva nell’affermazione non giustificata di essere seguaci del metodo storico e della scienza.
3. Intorno a questi argomenti è da richiamare qualche osservazione della serie «Riviste tipo» e di quelle intorno a un «Dizionario critico».
Q16 §4 I giornali delle grandi capitali. Una serie di saggi sul giornalismo delle più importanti capitali degli Stati del mondo, seguendo questi criteri: 1) Esame dei giornali quotidiani che in un giorno determinato (non scelto a caso, ma in cui è registrato un qualche avvenimento importante per lo Stato in quistione) escono in una capitale – Londra, Parigi, Madrid, Berlino, Roma ecc. – per avere un termine il più omogeneo possibile di comparazione, cioè l’avvenimento principale e la relativa somiglianza degli altri, in modo da avere un quadro del modo diverso con cui i partiti e le tendenze riflettono le loro opinioni e formano la così detta opinione pubblica. Ma perché nessun giornale quotidiano, specialmente in certi paesi, non è quotidianamente lo stesso dal punto di vista tecnico, occorrerà procurarsi per ognuno gli esemplari di una intera settimana o del periodo in cui si ha il ciclo completo di certe rubriche specializzate e di certi supplementi, il cui complesso permette di comprendere la fortuna che hanno presso gli assidui.
2) Esame di tutta la stampa periodica, di ogni specie (da quella sportiva, ai bollettini parrocchiali) che completa l’esame dei quotidiani, in quanto sono pubblicati dopo il quotidiano tipo.
3) Informazioni sulla tiratura, sul personale, sulla direzione, sui finanziatori, sulla pubblicità. Insomma si dovrebbe ricostruire per ogni capitale l’assieme del meccanismo editoriale periodico che diffonde le tendenze ideologiche che operano continuamente e simultaneamente sulla popolazione.
4) Stabilire il rapporto della stampa della capitale con quella delle province; questo rapporto varia da paese a paese. In Italia la diffusione dei giornali romani è molto inferiore a quella dei giornali milanesi. L’organizzazione territoriale della stampa francese è diversissima che in Germania ecc. Il tipo del settimanale politico italiano è forse unico nel mondo e corrisponde a un tipo di lettore determinato.
5) Per certi paesi occorre tener conto dell’esistenza di altri centri dominanti oltre la capitale, come Milano per l’Italia, Barcellona per la Spagna, Monaco per la Germania, Manchester e Glasgow per l’Inghilterra, ecc.
6) Per l’Italia lo studio potrebbe essere esteso a tutto il paese e a tutta la stampa periodica, graduando l’esposizione per importanza dei centri: per es.: 1° Roma, Milano; 2° Torino, Genova; 3° Trieste, Bologna, Napoli, Palermo, Firenze, ecc.; 4° Stampa settimanale politica; 5° Riviste politiche, letteratura, scienza, religione, ecc.
Q16 §5 L’influsso della cultura araba nella civiltà occidentale. Ezio Levi ha pubblicato nel volume Castelli di Spagna (Treves, Milano) una serie di articoli pubblicati sparsamente nelle riviste e riguardanti i rapporti di cultura tra la civiltà europea e gli arabi, verificatisi specialmente attraverso la Spagna, dove gli studi in proposito sono numerosi e contano molti specialisti: i saggi del Levi prendevano quasi sempre lo spunto dalle opere di arabisti spagnoli. Nel «Marzocco» del 29 maggio 1932 il Levi recensisce la introduzione al libro L’eredità dell’Islam di Angel Gonzales Palencia (l’introduzione è uscita in opuscolo indipendente col titolo: El Islam y Occidente, Madrid, 1931) ed enumera tutta una serie di prestiti fatti all’Europa dal mondo orientale nella cucina, nella medicina, nella chimica, ecc. Il libro completo del Gonzales Palencia sarà molto interessante per lo studio del contributo dato dagli Arabi alla civiltà europea, per un giudizio della funzione avuta dalla Spagna nel Medioevo e per una caratterizzazione del Medio Evo stesso più esatta di quella corrente.
Q16 §6 Il capitalismo antico e una disputa tra moderni. Si può esporre, in forma di rassegna critico‑bibliografica, la così detta quistione del capitalismo antico. 1) Un confronto tra le due edizioni, la prima in francese, che fu poi tradotta in alcune altre lingue europee, e la seconda, recente, in italiano, del volumetto del Salvioli sul Capitalismo antico con prefazione di G. Brindisi (ed. Laterza). 2) Articoli e libri di Corrado Barbagallo (per es. L’Oro e il Fuoco, i volumi riguardanti l’età classica della Storia Universale che è in via di pubblicazione presso l’Utet di Torino, ecc.) e la polemica svoltasi qualche tempo fa sull’argomento nella «Nuova Rivista Storica» tra il Barbagallo, Giovanni Sanna e Rodolfo Mondolfo. Nel Barbagallo è specialmente da notare, in questa polemica, il tono disincantato di chi la sa lunga sulle cose di questo mondo. La sua concezione del mondo è che niente è nuovo sotto il sole, che «tutto il mondo è paese», che «più le cose cambiano e più sono le stesse». La polemica pare un seguito farsesco della famosa «Disputa tra gli antichi e i moderni». Ma questa disputa ebbe una grande importanza culturale e un significato progressivo; è stata l’espressione di una coscienza diffusa che esiste uno svolgimento storico, che si era ormai entrati in pieno in una nuova fase storica mondiale, completamente rinnovatrice di tutti i modi di esistenza, ed aveva una punta avvelenata contro la religione cattolica che deve sostenere che quanto più retrocediamo nella storia tanto più dobbiamo trovare gli uomini perfetti, perché più vicini alle comunicazioni dell’uomo con dio, ecc.
(A questo proposito è da vedere ciò che ha scritto Antonio Labriola nel frammento postumo del libro non scritto Da un secolo all’altro sul significato del nuovo calendario instaurato dalla Rivoluzione francese: tra il mondo antico e il mondo moderno non c’era stata mai una così profonda coscienza di distacco, neanche per l’avvento del cristianesimo).
Invece la polemica del Barbagallo era proprio il contrario di progressiva, tendeva a diffondere scetticismo, a togliere ai fatti economici ogni valore di sviluppo e di progresso.
Questa posizione del Barbagallo può essere interessante da analizzare perché il Barbagallo si dichiara ancora seguace della filosofia della praxis (cfr la sua polemichetta col Croce nella «Nuova Rivista Storica» di alcuni anni fa), ha scritto un volumetto su questo argomento nella Biblioteca della Federazione delle Biblioteche popolari di Milano. Ma il Barbagallo è legato da forti vincoli intellettuali a Guglielmo Ferrero (ed è un po’ loriano). È curioso che sia professore di storia dell’economia e si affatichi a scrivere una Storia Universale chi ha della storia una concezione così puerile e superficialmente acritica; ma non sarebbe maraviglioso che questo suo modo di pensare il Barbagallo lo attribuisse alla filosofia della praxis.
Q16 §7 La funzione mondiale di Londra. Come si è costituita storicamente la funzione economica mondiale di Londra? Tentativi americani e francesi per sostituire Londra. La funzione di Londra è un aspetto dell’egemonia economica inglese, che continua anche dopo che l’industria e il commercio inglesi hanno perduto la posizione precedente. Quanto rende alla borghesia inglese la funzione di Londra? In alcuni scritti dell’Einaudi di anteguerra vi sono larghi accenni su questo argomento. Il libro di Mario Borsa su Londra. Il libro di Angelo Crespi sull’Impero inglese. Il libro di Guido de Ruggiero.
L’argomento è stato in parte trattato dal Presidente della Westminster Bank nel discorso tenuto nell’assemblea sociale del 1929: l’oratore ha accennato ai lamenti perché gli sforzi fatti per conservare la posizione di Londra come centro finanziario internazionale impongono sacrifizi eccessivi all’industria e al commercio, ma ha osservato che il mercato finanziario di Londra produce un reddito che contribuisce in larga misura a saldare il deficit della bilancia dei pagamenti. Da un’inchiesta fatta dal Ministero del Commercio risulta che nel 1928 questo contributo fu di 65 milioni di sterline, nel 27 di 63 milioni, nel 26 di 60 milioni; questa attività deve considerarsi perciò come una fra le maggiori industrie «esportatrici» inglesi. Va tenuto conto della parte importante che spetta a Londra nell’esportazione di capitali, che frutta un reddito annuo di 285 milioni di sterline e che facilita l’esportazione di merci inglesi perché gli investimenti aumentano la capacità d’acquisto dei mercati esteri. L’esportatore inglese trova poi nel meccanismo che la finanza internazionale s’è creata a Londra, facilitazioni bancarie, cambiali ecc. superiori a quelle esistenti in qualsiasi altro paese. È evidente dunque che i sacrifizi fatti per conservare a Londra la sua supremazia nel campo della finanza internazionale sono ampiamente giustificati dai vantaggi che ne derivano, ma per conservare questa supremazia si credeva essenziale che il sistema monetario inglese avesse per base il libero movimento dell’oro; si credeva che ogni misura che intralciasse questa libertà andrebbe a danno di Londra come centro internazionale per il denaro a vista. I depositi esteri fatti a Londra a questo titolo rappresentavano somme volissime messe a disposizione di quella piazza. Si pensava che se questi fondi avessero cessato di affluire, il tasso del denaro sarebbe forse pìù stabile ma sarebbe indubbiamente più alto.
Cosa è avvenuto dopo il crollo della sterlina di tutti questi punti di vista? (Sarebbe interessante vedere quali termini del linguaggio commerciale sono diventati internazionali per questa funzione di Londra, termini che ricorrono spesso non solo nella stampa tecnica, ma anche nei giornali e nella stampa periodica politica generale).
Q16 §8 Roberto Ardigò e la filosofia della praxis. (Cfr il volume Scritti vari raccolti e ordinati da Giovanni Marchesini, Firenze, Le Monnier, 1922). Raccoglie una parte di scritti di occasione, tanto del periodo in cui l’Ardigò era sacerdote (per esempio una interessante polemica con Luigi De Sanctis, prete cattolico spretato e divenuto quindi uno dei propagandisti più verbosi e scriteriati dell’Evangelismo), quanto del periodo successivo allo spretamento dello stesso Ardigò e del suo pontificato positivistico, che l’Ardigò stesso aveva ordinato e disposto per la pubblicazione. Questi scritti possono essere interessanti per un biografo dell’Ardigò e per stabilire con esattezza le sue tendenze politiche, ma in massima parte sono paccotiglia senza nessun valore e scritti in modo scelleratissimo.
Il libro è diviso in varie sezioni. Tra le polemiche (1a sezione) è notevole quella contro la massoneria del 1903; l’Ardigò era antimassone e in forma vivace ed aggressiva.
Tra le lettere (4a sezione) quella indirizzata alla «Gazzetta di Mantova» a proposito del pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele II (nella «Gazzetta di Mantova» del 29 novembre 1883). L’Ardigò aveva accettato di far parte di un comitato promotore del pellegrinaggio. «Il pellegrinaggio però non andava ai versi a molti scalmanati rivoluzionari, che si erano immaginati che io la pensassi come loro e quindi sconfessassi la mia fede politico‑sociale colla suddetta adesione. E così si espressero privatamente e pubblicamente colle più fiere invettive al mio indirizzo». Le lettere dell’Ardigò sono enfatiche ed altisonanti: «Ieri, perché tornava loro conto di farmi passare per uno dei loro, che non sono mai stato (e lo sanno o devono saperlo), mi proclamarono, con lodi che mi facevano schifo, il loro maestro; e ciò senza intendermi o intendendomi a rovescio. Oggi, perché non mi trovano pronto a prostituirmi alle loro mire parricide, vogliono pigliarmi per un orecchio perché ascolti e impari la lezione che (molto ingenuamente) si arrogano di recitarmi. Oh! quanto ho ragione di dire con Orazio: Odi profanum vulgus et arceo!»
In una successiva lettera del 4 dicembre 1883 al «Bacchiglione», giornale democratico di Padova, scrive: «Come sapete fui amico di Alberto Mario; ne venero la memoria e caldeggio con tutta l’anima quelle idee e quei sentimenti che ebbi comuni con lui. E conseguentemente avverso senza esitazione le basse fazioni anarchiche antisociali… Tale mia avversione l’ho sempre espressa recisissimamente. Alcuni anni fa in un’adunanza della Società dell’Eguaglianza sociale di Mantova ho parlato così: “La sintesi delle vostre tendenze è l’odio, la sintesi della mia è l’amore; perciò io non sono con voi”. Ma si continuava a voler far credere alla mia solidarietà col socialismo antisociale di Mantova. Sicché sentii il dovere di protestare ecc.». La lettera fu ristampata nella «Gazzetta di Mantova» (del 10 dicembre 1883; la «Gazzetta» era un giornale conservatore di estrema destra, allora diretto da A. Luzio) con un’altra coda violentissima perché gli avversari gli avevano ricordato il canonicato ecc.
Nel luglio 1884 scrive al Luzio che «nulla mi impedirebbe di assentire» alla proposta fattagli di entrare nella lista moderata per le elezioni comunali di Mantova. Scrive anche di credere il Luzio «più radicale di molti sedicenti democratici... Molti si chiamano democratici e non sono che arruffoni sciocchi…». Nel giugno‑agosto 1883 si serviva però del giornale socialista di Imola «Il Moto» per rispondere a una serie di articoli anonimi della liberale (sarà stato conservatore) «Gazzetta dell’Emilia» di Bologna, in cui si diceva che l’Ardigò era un liberale di fresca data e lo si sfotteva brillantemente se pure con molta evidente malafede polemica. Il «Moto» di Imola «naturalmente» difende l’Ardigò a spada tratta e lo esalta, senza che l’Ardigò cerchi di distinguersi.
Tra i pensieri, tutti triti e banali, spicca quello sul Materialismo storico (p. 271), che senz’altro è da mettere insieme all’articolo sull’Influenza sociale dell’aeroplano di A. Loria. Ecco il pensiero completo: «Colla Concezione materialistica della Storia si vuole spiegare una formazione naturale (!), che ne (sic) dipende solo in parte e solo indirettamente, trascurando altri essenziali coefficenti. E mi spiego. L’animale non vive, se non ha il suo nutrimento. E può procurarselo, perché in lui nasce il sentimento della fame, che lo porta a cercare il cibo. Ma in un animale, oltre il sentimento della fame, si producono molti altri sentimenti, relativi ad altre operazioni, i quali, pur essi, agiscono a muoverlo. Egli è che, col nutrimento si mantiene un dato organismo, che ha attitudini speciali, quali in una specie, quali in un’altra. Una caduta d’acqua fa muovere un mulino a produrre la farina e un telaio a produrre un drappo. Sicché, pel mulino, oltre la caduta dell’acqua, occorre il grano damacinare e pel telaio occorrono i fili da comporre insieme. Mantenendosi col movimento un organismo, l’ambiente, colle sue importazioni d’altro genere (!?), determina, come dicemmo, molti funzionamenti, che non dipendono direttamente dal nutrimento, ma dalla struttura speciale dell’apparecchio funzionante, da una parte, e dall’azione, ossia importazione nuova dell’ambiente dall’altra. Un uomo quindi, per esempio, è incitato in più sensi. E in tutti irresistibilmente. È incitato dal sentimento della fame, è incitato da altri sentimenti, prodotti in ragione della struttura sua speciale, e delle sensazioni e delle idee fatte nascere in lui per l’azione esterna, e per l’ammaestramento ricevuto, ecc. ecc. (sic). Deve obbedire al primo, ma deve ubbidire anche agli altri, voglia o non voglia. E gli equilibri che si formano tra l’impulso del primo e di questi altri, per la risultante dell’azione, riescono diversissimi, seconda una infinità di circostanze, che fanno giocare più l’uno che l’altro dei sentimenti incitanti. In una mandra di porci il sopravvento rimane al sentimento della fame, in una popolazione di uomini, ben diversamente, poiché hanno anche altre cure all’infuori di quella d’ingrassare. Nell’uomo stesso l’equilibrio si diversifica secondo le disposizioni che poterono farsi in lui, e quindi, col sentimento della fame, il ladro ruba e il galantuomo invece lavora: avendo quanto gli occorre per soddisfare alla fame, l’avaro cerca anche il non necessario, e il filosofo se ne contenta e dedica la sua opera alla scienza. L’antagonismo poi può esser tale, che riescono in prevalenza i sentimenti che sono diversi da quelli della fame, fino a farli tacere affatto, fino a sopportare di morire, ecc. ecc. (sic). La forza, onde è, ed agisce l’animale, è quella della natura, che lo investe e lo sforza ad agire in sensi multiformi, trasformandosi variamente nel suo organismo. Poniamo che sia la luce del sole, alla quale si dovrebbe ridurre la concezione materialistica della storia, anziché alla ragione economica. Alla luce del sole, intesa in modo, che anche ad essa si possa riferire il fatto della idealità impulsiva dell’uomo». (Fine).
Il brano è stato pubblicato la prima volta in un numero unico (forse stampato dal «Giornale d’Italia») a beneficio della Croce Rossa, nel gennaio 1915. È interessante non so lo per dimostrare che l’Ardigò non si era preoccupato mai di informarsi direttamente sull’argomento trattato e non aveva letto che qualche articolo strafalcionesco di qualche periodichetto, ma perché serve a documentare le strane opinioni diffuse in Italia sulla «quistione di ventre».
Perché poi solamente in Italia era diffusa questa strana interpretazione «ventraiolesca»? Essa non può non essere connessa ai movimenti per la fame, ma così l’accusa di «ventraiolismo» è più umiliante per i dirigenti che la facevano che per i governati che soffrivano realmente la fame. E nonostante tutto, Ardìgò non era il primo venuto.
Q16 §9 Alcuni problemi per lo studio dello svolgimento della filosofia della praxis. La filosofia della praxis è stata un momento della cultura moderna; in una certa misura ne ha determinato o fecondato alcune correnti. Lo studio di questo fatto, molto importante e significativo, è stato trascurato o è addirittura ignorato dai così detti ortodossi e per la seguente ragione: che la combinazione filosofica più rilevante è avvenuta tra la filosofia della praxis e diverse tendenze idealistiche, ciò che ai così detti ortodossi, legati essenzialmente alla particolare corrente di cultura dell’ultimo quarto del secolo scorso (positivismo, scientismo) è parso un controsenso se non una furberia da ciarlatani (tuttavia nel saggio di Plekhanov su i Problemi fondamentali c’è qualche accenno a questo fatto, ma solamente sfiorato e senza tentativo alcuno di spiegazione critica). Per ciò pare sia necessario rivalutare la impostazione del problema così come fu tentata da Antonio Labriola.
È avvenuto questo: la filosofia della praxis ha subito realmente una doppia revisione, cioè è stata sussunta in una doppia combinazione filosofica. Da una parte, alcuni suoi elementi, in modo esplicito o implicito, sono stati assorbiti e incorporati da alcune correnti idealistiche (basta citare il Croce, il Gentile, il Sorel, lo stesso Bergson, il pragmatismo; dall’altra i così detti ortodossi, preoccupati di trovare una filosofia che fosse, secondo il loro punto di vista molto ristretto, più comprensiva di una «semplice» interpretazione della storia, hanno creduto di essere ortodossi, identificandola fondamentalmente nel materialismo tradizionale. Un’altra corrente è ritornata al kantismo (e si può citare, oltre il prof. Max Adler viennese, i due professori italiani Alfredo Poggi e Adelchi Baratono). Si può osservare, in generale, che le correnti che hanno tentato combinazioni della filosofia della praxis con tendenze idealistiche sono in grandissima parte di intellettuali «puri», mentre quella che ha costituito l’ortodossia era di personalità intellettuali più spiccatamente dedite all’attività pratica e quindi più legate (con legami più o meno estrinseci) alle grandi masse popolari (ciò che del resto non ha impedito alla più gran parte di fare capitomboli non di poca importanza storico‑politica). Questa distinzione ha una grande portata. Gli intellettuali «puri», come elaboratori delle più estese ideologie delle classi dominanti, come leaders dei gruppi intellettuali dei loro paesi, non potevano non servirsi almeno di alcuni elementi della filosofia della praxis, per irrobustire le loro concezioni e moderare il soverchio filosofismo speculativo col realismo storicista della teoria nuova, per fornire di nuove armi l’arsenale del gruppo sociale cui erano legati. D’altra parte la tendenza ortodossa si trovava a lottare con l’ideologia più diffusa nelle masse popolari, il trascendentalismo religioso e credeva di superarlo solo col più crudo e banale materialismo che era anch’esso una stratificazione non indifferente del senso comune, mantenuta viva, più di quanto si credesse e si creda, dalla stessa religione che nel popolo ha una sua espressione triviale e bassa, superstiziosa e stregonesca, in cui la materia ha una funzione non piccola.
Il Labriola si distingue dagli uni e dagli altri per la sua affermazione (non sempre sicura, a dire il vero) che la filosofia della praxis è una filosofia indipendente e originale che ha in se stessa gli elementi di un ulteriore sviluppo per diventare da interpretazione della storia filosofia generale. Occorre lavorare appunto in questo senso, sviluppando la posizione di Antonio Labriola, di cui i libri di Rodolfo Mondolfo non paiono (almeno per quanto si ricorda) un coerente svolgimento. Pare che il Mondolfo non abbia mai abbandonato completamente il fondamentale punto di vista del positivismo di alunno di Roberto Ardìgò. Il libro del discepolo del Mondolfo, il Diambrini Palazzi (presentato da una prefazione del Mondolfo) sulla Filosofia di Antonio Labriola è un documento della povertà di concetti e di direttive dell’insegnamento universitario del Mondolfo stesso.
Perché la filosofia della praxis ha avuto questa sorte, di aver servito a formare combinazioni, coi suoi elementi principali, sia coll’idealismo che con il materialismo filosofico? Il lavoro di ricerca non può non essere complesso e delicato: domanda molta finezza nell’analisi e sobrietà intellettuale. Perché è molto facile lasciarsi prendere dalle somiglianze esteriori e non vedere le somiglianze nascoste e i nessi necessari ma camuffati. L’identificazione dei concetti che la filosofia della praxis ha «ceduto» alle filosofie tradizionali e per cui queste hanno trovato un qualche istante di ringiovanimento, deve essere fatta con molta cautela critica, e significa né più né meno che fare la storia della cultura moderna dopo l’attività dei fondatori della filosofia della praxis. L’assorbimento esplicito evidentemente non è difficile da rintracciare, quantunque anche esso debba essere analizzato criticamente. Un esempio classico è quello rappresentato dalla riduzione crociana della filosofia della praxis a canone empirico di ricerca storica, concetto che è penetrato anche fra i cattolici (cfr il libro di mons. Olgiati), che ha contribuito a creare la scuola storiografica economico‑giuridica italiana che si è diffusa anche fuori d’Italia. Ma la ricerca più difficile e delicata è quella degli assorbimenti «impliciti», non confessati, avvenuti appunto perché la filosofia della praxis è stata un momento della cultura moderna, un’atmosfera diffusa, che ha modificato i vecchi modi di pensare per azioni e reazioni non apparenti e non immediate. Lo studio del Sorel è specialmente interessante da questo punto di vista, perché attraverso il Sorel e la sua fortuna si possono avere molti indizi in proposito; così dicasi del Croce. Ma lo studio più importante pare debba essere quello della filosofia bergsoniana e il pragmatismo per vedere in quanto certe loro posizioni sarebbero inconcepibili senza l’anello storico della filosofia della praxis.
Un altro aspetto della quistione è l’insegnamento pratico di scienza politica che la filosofia della praxis ha dato agli stessi avversari che la combattono aspramente per principio, così come i gesuiti combattevano teoricamente Machiavelli pur essendone in pratica i migliori discepoli. In una Opinione pubblicata da Mario Missiroli nella «Stampa» del tempo in cui fu corrispondente da Roma (intorno al 1925) si dice su per giù che sarebbe da vedere se nell’intimo della loro coscienza gli industriali più intelligenti non siano persuasi che l’Economia Critica non abbia visto molto bene nelle cose loro e non si servano degli insegnamenti così appresi. Tutto ciò non sarebbe per nulla sorprendente, perché se il fondatore della filosofia della praxis ha esattamente analizzato la realtà, egli non ha fatto che sistemare razionalmente e coerentemente ciò che gli agenti storici di questa realtà sentivano e sentono confusamente e istintivamente e di cui hanno preso maggior coscienza dopo la critica avversaria.
L’altro aspetto della quistione è ancor più interessante. Perché anche i così detti ortodossi hanno «combinato» la filosofia della praxis con altre filosofie e con una piuttosto che con altre in prevalenza? Infatti quella che conta è la combinazione col materialismo tradizionale; la combinazione col kantismo non ha avuto che un successo limitato e presso solo ristretti gruppi intellettuali. Sull’argomento è da vedere il saggio della Rosa sui Progressi e arresti nello sviluppo della filosofia della praxis che nota come le parti costituenti questa filosofia si siano sviluppate in misura diversa, ma sempre a seconda delle necessità dell’attività pratica. Cioè i fondatori della filosofia nuova avrebbero precorso di molto le necessità del loro tempo e anche di quello successivo, avrebbero creato un arsenale con armi che ancora non giovavano perché anacronistiche e che solo col tempo sarebbero state ripulite. La spiegazione è un po’ capziosa, in quanto non fa che dare in gran parte come spiegazione il fatto stesso da spiegare astrattizzato, tuttavia c’è in essa qualcosa di vero che si può approfondire. Una delle ragioni storiche pare sia da ricercare nel fatto che la filosofia della praxis ha dovuto allearsi con tendenze estranee per combattere i residui del mondo precapitalistico nelle masse popolari, specialmente nel terreno religioso. La filosofia della praxis aveva due compiti: combattere le ideologie moderne nella loro forma più raffinata, per poter costituire il proprio gruppo di intellettuali indipendenti, e educare le masse popolari, la cui cultura era medioevale. Questo secondo compito, che era fondamentale, dato il carattere della nuova filosofia, ha assorbito tutte le forze, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente; per ragioni «didattiche», la nuova filosofia si è combinata in una forma di cultura che era un po’ superiore a quella media popolare (che era molto bassa), ma assolutamente inadeguata per combattere le ideologie delle classi colte, mentre la nuova filosofia era proprio nata per superare la più alta manifestazione culturale del tempo, la filosofia classica tedesca, e per suscitare un gruppo di intellettuali proprii del nuovo gruppo sociale di cui era la concezione del mondo. D’altra parte la cultura moderna, specialmente idealistica, non riesce a elaborare una cultura popolare, non riesce a dare un contenuto morale e scientifico ai propri programmi scolastici, che rimangono schemi astratti e teorici; essa rimane la cultura di una ristretta aristocrazia intellettuale, che talvolta ha presa sulla gioventù solo in quanto diventa politica immediata e occasionale.
È da vedere se questo modo di «schieramento» culturale non sia una necessità storica e se nella storia passata non si ritrovino schieramenti simili, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo. L’esempio classico e precedente alla modernità, è indubbiamente quello del Rinascimento in Italia e della Riforma nei paesi protestanti. Nel volume Storia dell’età barocca in Italia, a p. 11, il Croce scrive: «Il movimento della Rinascita era rimasto aristocratico, di circoli eletti, e nella stessa Italia, che ne fu madre e nutrice, non uscì dai circoli di corte, non penetrò fino al popolo, non divenne costume o “pregiudizio”, ossia collettiva persuasione e fede. La Riforma, invece, ebbe bensì questa efficacia di penetrazione popolare, ma la pagò con un ritardo del suo intrinseco sviluppo, con la lenta e più volte interrotta maturazione del suo germe vitale». E a p. 8: «E Lutero, come quegli umanisti, depreca la tristezza e celebra la letizia, condanna l’ozio e comanda il lavoro; ma, d’altra parte, è condotto a diffidenza e ostilità contro le lettere e gli studi, sicché Erasmo poté dire: ubicumque regnat lutheranismus, ibi literarum est interitus; e certo, se non proprio per solo effetto di quella avversione in cui era entrato il suo fondatore, il protestantesimo tedesco fu per un paio di secoli pressoché sterile negli studi, nella critica, nella filosofia. I riformatori italiani, segnatamente quelli del circolo di Giovanni de Valdès e i loro amici, riunirono invece senza sforzo l’umanesimo al misticismo, il culto degli studi all’austerità morale. Il calvinismo, con la sua dura concezione della grazia e la dura disciplina, neppur esso favorì la libera ricerca e il culto della bellezza, ma gli accadde, interpretando e svolgendo e adattando il concetto della grazia e quello della vocazione, di venire a promuovere energicamente la vita economica, la produzione e l’accrescimento della ricchezza». La riforma luterana e il calvinismo suscitarono un vasto movimento popolare‑nazionale dove si diffusero, e solo in periodi successivi una cultura superiore; i riformatori italiani furono infecondi di grandi successi storici. È vero che anche la Riforma nella sua fase superiore necessariamente assunse i modi della Rinascita e come tale si diffuse anche nei paesi non protestanti dove non c’era stata l’incubazione popolare; ma la fase di sviluppo popolare ha permesso ai paesi protestanti di resistere tenacemente e vittoriosamente alla crociata degli eserciti cattolici e così nacque la nazione germanica come una delle più vigorose dell’Europa moderna. La Francia fu lacerata dalle guerre di religione con la vittoria apparente del cattolicismo, ma ebbe una grande riforma popolare nel Settecento con l’illuminismo, il voltairianismo, l’enciclopedia che precedé e accompagnò la rivoluzione del 1789; si trattò realmente di una grande riforma intellettuale e morale del popolo francese, più completa di quella tedesca luterana, perché abbracciò anche le grandi masse contadine della campagna, perché ebbe un fondo laico spiccato e tentò di sostituire alla religione una ideologia completamente laica rappresentata dal legame nazionale e patriottico; ma neanche essa ebbe una fioritura immediata di alta cultura, altro che per la scienza politica nella forma di scienza positiva del diritto. (Cfr il paragone fatto da Hegel delle particolari forme nazionali assunte dalla stessa cultura in Francia e in Germania nel periodo della rivoluzione francese; concezione hegeliana che attraverso una catena un po’ lunga portò al famoso verso carducciano: «accomunati nella stessa fé, – decapitaro Emmanuel Kant iddio, Massimiliano Robespierre il re»).
Una concezione della filosofia della praxis come riforma popolare moderna (poiché sono dei puri astrattisti quelli che aspettano una riforma religiosa in Italia, una nuova edizione italiana del calvinismo, come Missiroli e C.) è stata forse intravista da Giorgio Sorel, un po’ (o molto) dispersamente, intellettualisticamente, per una specie di furore giansenistico contro le brutture del parlamentarismo e dei partiti politici. Sorel ha preso da Renan il concetto della necessità di una riforma intellettuale e morale, ha affermato (in una lettera al Missiroli) che spesso grandi movimenti storici non sono rappresentati da una cultura moderna ecc. Ma mi pare che una tale concezione sia implicita nel Sorel quando si serve del cristianesimo primitivo come termine di paragone, con molta letteratura, è vero, ma tuttavia con più di un granello di verità, con riferimenti meccanici e spesso artificiosi, ma tuttavia con qualche lampo di intuizione profonda. La filosofia della praxis presuppone tutto questo passato culturale, la Rinascita e la Riforma, la filosofia tedesca e la rivoluzione francese, il calvinismo e la economia classica inglese, il liberalismo laico e lo storicismo che è alla base di tutta la concezione moderna della vita. La filosofia della praxis è il coronamento di tutto questo movimento di riforma intellettuale e morale, dialettizzato nel contrasto tra cultura popolare e alta cultura. Corrisponde al nesso Riforma protestante + Rivoluzione francese: è una filosofia che è anche una politica e una politica che è anche una filosofia. Attraversa ancora la sua fase popolaresca: suscitare un gruppo di intellettuali indipendenti non è cosa facile, domanda un lungo processo, con azioni e reazioni, con adesioni e dissoluzioni e nuove formazioni molto numerose e complesse: è la concezione di un gruppo sociale subalterno, senza iniziativa storica, che si amplia continuamente, ma disorganicamente, e senza poter oltrepassare un certo grado qualitativo che è sempre al di qua dal possesso dello Stato, dall’esercizio reale dell’egemonia su l’intera società che solo permette un certo equilibrio organico nello sviluppo del gruppo intellettuale. La filosofia della praxis è diventata anch’essa «pregiudizio» e «superstizione»; così come è, è l’aspetto popolare dello storicismo moderno, ma contiene in sé un principio di superamento di questo storicismo. Nella storia della cultura, che è molto più larga della storia della filosofia, ogni volta che la cultura popolare è affiorata, perché si attraversava una fase di rivolgimenti e dalla ganga popolare si selezionava il metallo di una nuova classe, si è avuta una fioritura di «materialismo», viceversa nello stesso momento le classi tradizionali si aggrappavano allo spiritualismo. Hegel, a cavallo della Rivoluzione francese e della Restaurazione, ha dialettizzato i due momenti della vita del pensiero, materialismo e spiritualismo, ma la sintesi fu «un uomo che cammina sulla testa». I continuatori di Hegel hanno distrutto quest’unità e si è ritornati ai sistemi materialistici da una parte e a quelli spiritualistici dall’altra. La filosofia della praxis, nel suo fondatore, ha rivissuto tutta questa esperienza, di hegelismo, feuerbacchismo, materialismo francese – per ricostruire la sintesi dell’unità dialettica: «l’uomo che cammina sulle gambe». Il laceramento avvenuto per l’hegelismo si è ripetuto per la filosofia della praxis, cioè dall’unità dialettica si è ritornati da una parte al materialismo filosofico, mentre l’alta cultura moderna idealistica ha cercato di incorporare ciò che della filosofia della praxis le era indispensabile per trovare qualche nuovo elisir. «Politicamente» la concezione materialistica è vicina al popolo, al senso comune; essa è strettamente legata a molte credenze e pregiudizii, a quasi tutte le superstizioni popolari (stregonerie, spiriti, ecc.). Ciò si vede nel cattolicismo popolare e specialmente nell’ortodossia bizantina. La religione popolare è crassamente materialistica, tuttavia la religione ufficiale degli intellettuali cerca di impedire che si formino due religioni distinte, due strati separati, per non staccarsi dalle masse, per non diventare anche ufficialmente, come è realmente, una ideologia di ristretti gruppi. Ma da questo punto di vista, non bisogna far confusione tra l’atteggiamento della filosofia della praxis e quello del cattolicismo. Mentre quella mantiene un contatto dinamico e tende a sollevare continuamente nuovi strati di massa ad una vita culturale superiore, quello tende a mantenere un contatto puramente meccanico, un’unità esteriore, basata specialmente sulla liturgia e sul culto più appariscentemente suggestivo sulle grandi folle. Molti tentativi ereticali furono manifestazioni di forze popolari per riformare la chiesa e avvicinarla al popolo, innalzando il popolo. La chiesa ha reagito spesso in forma violentissima, ha creato la Compagnia di Gesù, si è catafratta con le decisioni del Concilio di Trento, quantunque abbia organizzato un maraviglioso meccanismo di religione «democratica» dei suoi intellettuali, ma come singoli individui, non come espressione rappresentativa di gruppi popolari. Nella storia degli sviluppi culturali, occorre tenere uno speciale conto dell’organizzazione della cultura e del personale in cui tale organizzazione prende forma concreta. Nel volume di G. De Ruggiero su Rinascimento e Riforma si può vedere quale sia stato l’atteggiamento di moltissimi intellettuali, con a capo Erasmo: essi piegarono dinanzi alle persecuzioni e ai roghi. Il portatore della Riforma è stato perciò proprio il popolo tedesco nel suo complesso, come popolo indistinto, non gli intellettuali. Appunto questa diserzione degli intellettuali dinanzi al nemico spiega la «sterilità» della Riforma sulla sfera immediata dell’alta cultura, finché dalla massa popolare, rimasta fedele, non si seleziona lentamente un nuovo gruppo di intellettuali che culmina nella filosofia classica. Qualcosa di simile è avvenuto finora per la filosofia della praxis; i grandi intellettuali formatisi nel suo terreno, oltre ad essere poco numerosi, non erano legati al popolo, non sbocciarono dal popolo, ma furono l’espressione di classi intermedie tradizionali, alle quali ritornarono nelle grandi «svolte» storiche; altri rimasero, ma per sottoporre la nuova concezione a una sistematica revisione, non per procurarne lo sviluppo autonomo. L’affermazione che la filosofia della praxis è una concezione nuova, indipendente, originale, pur essendo un momento dello sviluppo storico mondiale, è l’affermazione della indipendenza e originalità di una nuova cultura in incubazione che si svilupperà con lo svilupparsi dei rapporti sociali. Ciò che volta per volta esiste è una combinazione variabile di vecchio e nuovo, un equilibrio momentaneo dei rapporti culturali corrispondente all’equilibrio dei rapporti sociali. Solo dopo la creazione dello Stato, il problema culturale si impone in tutta la sua complessità e tende a una soluzione coerente. In ogni caso l’atteggiamento precedente alla formazione statale non può non essere critico‑polemico, e mai dogmatico, deve essere un atteggiamento romantico, ma di un romanticismo che consapevolmente aspira alla sua composta classicità.
Nota I. Studiare il periodo della Restaurazione come periodo di elaborazione di tutte le dottrine storicistiche moderne, compresa la filosofia della praxis che ne è il coronamento e che del resto fu elaborata proprio alla vigilia del 48, quando la Restaurazione crollava da ogni parte e il patto della Santa Alleanza andava in pezzi. È noto che Restaurazione è soltanto una espressione metaforica; in realtà non ci fu nessuna restaurazione effettuale dell’ancien regime, ma solo una nuova sistemazione di forze, in cui le conquiste rivoluzionarie delle classi medie furono limitate e codificate. Il re in Francia e il papa a Roma divennero capi dei rispettivi partiti e non più indiscussi rappresentanti della Francia o della cristianità. La posizione del papa fu specialmente scossa e da allora ha inizio la formazione di organismi permanenti dei «cattolici militanti» che dopo altre tappe intermedie: il 1848‑49, il 1861 (quando avvenne la prima disgregazione dello Stato pontificio con l’annessione delle Legazioni emiliane), il 1870 e il dopoguerra, diventeranno la potente organizzazione dell’Azione Cattolica, potente, ma in posizione difensiva. Le teorie storicistiche della restaurazione si oppongono alle ideologie settecentesche, astrattiste e utopistiche, che continuano a vivere come filosofia, etica e politica proletaria, diffusa specialmente in Francia, fino al 1870. La filosofia della praxis si oppone a queste concezioni settecentesche‑popolari come filosofia di massa, in tutte le loro forme, da quelle più infantili, a quella del Proudhon, che subisce un qualche innesto dello storicismo conservatore e che pare possa esser chiamato il Gioberti francese, ma delle classi popolari, per il rapporto di arretratezza della storia italiana in confronto a quella francese, come appare nel periodo del 1848. Se gli storicisti conservatori, tecnici del vecchio, sono ben piazzati per criticare il carattere utopistico delle ideologie giacobine mummificate, i filosofi della praxis sono meglio piazzati sia per apprezzare il valore storico reale e non astratto che il giacobinismo aveva avuto come elemento creatore della nuova nazione francese, cioè come fatto di attività circoscritte in determinate circostanze e non idoleggiate, sia per apprezzare il compito storico di questi stessi conservatori, che in realtà erano figli vergognosi dei giacobini, pur maledicendone gli eccessi mentre ne amministravano con cura l’eredità. La filosofia della praxis non solo pretendeva di spiegare e giustificare tutto il passato, ma di spiegare e giustificare storicamente anche se stessa, cioè era il massimo «storicismo», la liberazione totale da ogni «ideologismo» astratto, la reale conquista del mondo storico, l’inizio di una nuova civiltà.
Q16 §10 La religione, il lotto e l’oppio della miseria. Giulio Lachelier, filosofo francese (sul quale cfr la prefazione di G. De Ruggiero al volume dello stesso Lachelier Psicologia e Metafisica, Bari, Laterza, 1915) ha scritto una nota («acuta» dice il De Ruggiero) sul «pari» di Pascal, pubblicata nel volume Du fondement de l’induction (Paris, Alcan, nella «Bibliothèque de philosophìe contemporaine»). L’obbiezione principale all’impostazione che il Pascal ha dato del problema religioso nel «pari» è quella della «lealtà intellettuale» verso se stessi. Pare che tutta la concezione del «pari», per quanto ricordo, sia più vicina alla morale gesuitica, che a quella giansenistica, sia troppo «mercantile», ecc. (cfr nel precedente quaderno altre su questo argomento).
Q16 §11 Rapporti tra Stato e Chiesa. Il «Vorwaerts» del 14 giugno 1929 in un articolo sul concordato tra la Città del Vaticano e la Prussia scrive che: «Roma ha ritenuto fosse decaduta (la legislazione precedente che già costituiva di fatto un concordato) in seguito ai cambiamenti politici intervenuti in Germania». Questo principio ammesso, anzi affermato di sua iniziativa dal Vaticano, può condurre molto lontano ed essere ricco di molte conseguenze politiche.
Nella «Vossische Zeitung» del 18 giugno 1929 il ministro delle finanze prussiano Hoepker‑Aschoff, poneva così la stessa quistione: «Egualmente non è possibile disconoscere la fondatezza della tesi di Roma che, in presenza dei molti cambiamenti politici e territoriali avvenuti, richiedeva che gli accordi venissero adattati alle nuove circostanze». Nello stesso articolo lo Hoepker‑Aschoff ricorda che «lo Stato prussiano aveva sempre sostenuto che gli accordi del 1821 erano ancora in vigore». Per il Vaticano, pare, la guerra del 1870 coi suoi mutamenti territoriali e politici (ingrandimenti della Prussia, costituzione dell’Impero germanico sotto l’egemonia prussiana) e il periodo del Kulturkampf non erano «mutamenti» tali da costituire «nuove circostanze», mentre essenziali sarebbero stati i mutamenti avvenuti dopo la grande guerra. È cambiato evidentemente il pensiero giuridico del Vaticano e potrebbe ancora cambiare secondo le convenienze politiche.
«Col 1918 si aveva una importantissima innovazione nel nostro diritto, innovazione che stranamente (ma nel 1918 c’era la censura sulla stampa!) passava tra la disattenzione generale: lo Stato riprendeva a sussidiare il culto cattolico, abbandonando dopo sessantatré anni il principio cavourriano ch’era stato posto a base della legge sarda 29 maggio 1855: lo Stato non deve sussidiare alcun culto». A. C. Jemolo nell’articolo Religione dello Stato e confessioni ammesse in «Nuovi Studi di Diritto, Economia, Politica», Anno 1930, p. 30. La innovazione fu introdotta con D.L. Luogotenenziale 17 marzo 1918 n. 396 e 9 maggio 1918 n. 655. In proposito lo Jemolo rimanda alla nota di D. Schiappoli I recenti provvedimenti economici a vantaggio del clero, Napoli, 1922, estratta dal vol. XLVIII degli Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli.
(Concordati e trattati internazionali). La capitolazione dello Stato moderno che si verifica per i concordati viene mascherata identificando verbalmente concordati e trattati internazionali. Ma un concordato non è un comune trattato internazionale: nel concordato si realizza di fatto una interferenza di sovranità in un solo territorio statale, poiché tutti gli articoli di un concordato si riferiscono ai cittadini di uno solo degli Stati contrattanti, sui quali il potere sovrano di uno Stato estero giustifica e rivendica determinati diritti e poteri di giurisdizione (sia pure di una speciale determinata giurisdizione). Che poteri ha acquistato il Reich sulla Città del Vaticano in virtù del recente concordato? E ancora la fondazione della Città del Vaticano dà un’apparenza di legittimità alla finzione giuridica che il concordato sia un comune trattato internazionale bilaterale. Ma si stipulavano concordati anche prima che la Città del Vaticano esistesse, ciò che significa che il territorio non è essenziale per l’autorità pontificia (almeno da questo punto di vista). Un’apparenza, perché mentre il concordato limita l’autorità statale di una parte contraente, nel suo proprio territorio, e influisce e determina la sua legislazione e la sua amministrazione, nessuna limitazione è accennata per territorio dell’altra parte: se limitazione esiste per questa altra parte, essa si riferisce all’attività svolta nel territorio del primo Stato, sia da parte dei cittadini della Città del Vaticano, sia dei cittadini dell’altro Stato che si fanno rappresentare dalla Città del Vaticano. Il concordato è dunque il riconoscimento esplicito di una doppia sovranità in uno stesso territorio statale. Non si tratta certo più della stessa forma di sovranità supernazionale (suzeraineté) quale era formalmente riconosciuta al papa nel Medio Evo, fino alle monarchie assolute e in altra forma anche dopo, fino al 1848, ma ne è una derivazione necessaria di compromesso. D’altronde anche nei periodi più splendidi del papato e del suo potere supernazionale, le cose non andarono sempre molto liscie: la supremazia papale, anche se riconosciuta giuridicamente, era contrastata di fatto in modo spesso molto aspro e nell’ipotesi più ottimista si riduceva ai privilegi politici, economici e fiscali dell’episcopato dei singoli paesi.
I concordati intaccano in modo essenziale il carattere di autonomia della sovranità dello Stato moderno. Lo Stato ottiene una contropartita? Certamente, ma la ottiene nel suo stesso territorio per ciò che riguarda i suoi stessi cittadini. Lo Stato tiene (e in questo caso occorrerebbe dire meglio il governo) che la Chiesa non intralci l’esercizio del potere, ma anzi lo favorisca e lo sostenga, così come una stampella sostiene un invalido. La Chiesa cioè si impegna verso una determinata forma di governo (che è determinata dall’esterno, come documenta lo stesso concordato) di promuovere quel consenso di una parte dei governati che lo Stato esplicitamente riconosce di non poter ottenere con mezzi propri: ecco in che consiste la capitolazione dello Stato, perché di fatto esso accetta la tutela di una sovranità esteriore di cui praticamente riconosce la superiorità. La stessa parola «concordato» è sintomatica. Gli articoli pubblicati nei «Nuovi Studi» sul concordato sono tra i più interessanti e si prestano più facilmente alla confutazione. (Ricordare il «trattato» subito dalla Repubblica democratica georgiana dopo la sconfitta del generale Denikin).
Ma anche nel mondo moderno, cosa significa praticamente la situazione creata in uno Stato dalle stipulazioni concordatarie? Significa il riconoscimento pubblico a una casta di cittadini dello stesso Stato di determinati privilegi politici. La forma non è più quella medioevale, ma la sostanza è la stessa. Nello sviluppo della storia moderna, quella casta aveva visto attaccato e distrutto un monopolio di funzione sociale che spiegava e giustificava la sua esistenza, il monopolio della cultura e dell’educazione. Il concordato riconosce nuovamente questo monopolio, sia pure attenuato e controllato, poiché assicura alla casta posizioni e condizioni preliminari che, con le sole sue forze, con l’intrinseca adesione della sua concezione del mondo alla realtà effettuale, non potrebbe mantenere e avere.
Si intende quindi la lotta sorda e sordida degli intellettuali laici e laicisti contro gli intellettuali di casta per salvare la loro autonomia e la loro funzione. Ma è innegabile la loro intrinseca capitolazione e il loro distacco dallo Stato. Il carattere etico di uno Stato concreto, di un determinato Stato, è definito dalla sua legislazione in atto e non dalle polemiche dei franchi tiratori della cultura. Se questi affermano: lo Stato siamo noi, essi affermano solo che il così detto Stato unitario è solo appunto «così detto», perché di fatto nel suo seno esiste una scissione molto grave, tanto più grave in quanto è affermato implicitamente dagli stessi legislatori e governanti i quali infatti dicono che lo Stato è nello stesso tempo due cose: quello delle leggi scritte e applicate e quello delle coscienze che intimamente non riconoscono quelle leggi come efficienti e cercano sordidamente di svuotarle (o almeno limitarle nelle applicazioni) di contenuto etico. Si tratta di un machiavellismo da piccoli politicanti; i filosofi dell’idealismo attuale, specialmente della sezione pappagalli ammaestrati dei «Nuovi Studi», si possono dire le più illustri vittime del machiavellismo. È utile da studiare la divisione del lavoro che si cerca di stabilire tra la casta e gli intellettuali laici: alla prima viene lasciata la formazione intellettuale e morale dei giovanissimi (scuole elementari e medie), agli altri lo sviluppo ulteriore dei giovani nell’Università. Ma la scuola universitaria non è sottoposta allo stesso regime di monopolio cui invece sottostà la scuola elementare e media. Esiste l’Università del Sacro Cuore e potranno essere organizzate altre Università Cattoliche equiparate in tutto alle Università statali. Le conseguenze sono ovvie: la scuola elementare e media è la scuola popolare e della piccola borghesia, strati sociali che sono monopolizzati educativamente dalla casta, poiché la maggioranza dei loro elementi non giungono all’Università, cioè non conosceranno l’educazione moderna nella sua fase superiore critico‑storica ma solo conosceranno l’educazione dogmatica. L’Università è la scuola della classe (e del personale) dirigente in proprio, è il meccanismo attraverso il quale avviene la selezione degli individui delle altre classi da incorporare nel personale governativo, amministrativo, dirigente. Ma con l’esistenza, a parità di condizioni, di università cattoliche, anche la formazione di questo personale non sarà più unitaria e omogenea. Non solo: ma la casta, nelle università proprie, realizzerà una concentrazione di cultura laico‑religiosa, quale da molti decenni non si vedeva più e si troverà di fatto in condizioni molto migliori della concentrazione laico‑statale. Non è infatti neanche lontanamente paragonabile l’efficienza della Chiesa, che sta tutta come un blocco a sostegno della propria università, con l’efficienza organizzativa della cultura laica. Se lo Stato (anche nel senso più vasto di società civile) non si esprime in una organizzazione culturale secondo un piano centralizzato e non può neanche farlo, perché la sua legislazione in materia religiosa è quella che è, e la sua equivocità non può non essere favorevole alla Chiesa, data la massiccia struttura di questa e il peso relativo e assoluto che da tale struttura omogenea si esprime, e se i titoli dei due tipi di università sono equiparati, è evidente che si formerà la tendenza a che le università cattoliche siano esse il meccanismo selettivo degli elementi più intelligenti e capaci delle classi inferiori da immettere nel personale dirigente. Favoriranno questa tendenza: il fatto che non c’è discontinuità educativa tra le scuole medie e l’Università cattolica, mentre tale discontinuità esiste per le Università laico‑statali; il fatto che la Chiesa, in tutta la sua struttura, è già attrezzata per questo lavoro di elaborazione e selezione dal basso. La Chiesa, da questo punto di vista, è un organismo perfettamente democratico (in senso paternalistico): il figlio di un contadino o di un artigiano, se intelligente e capace, e se duttile abbastanza per lasciarsi assimilare dalla struttura ecclesiastica e per sentirne il particolare spirito di corpo e di conservazione e la validità degli interessi presenti e futuri, può, teoricamente, diventare cardinale e papa. Se nell’alta gerarchia ecclesiastica l’origine democratica è meno frequente di quanto potrebbe essere, ciò avviene per ragioni complesse, in cui solo parzialmente incide la pressione delle grandi famiglie aristocratiche cattoliche o la ragione di Stato (internazionale): una ragione molto forte è questa, che molti Seminari sono assai male attrezzati e non possono educare compiutamente il popolano intelligente, mentre il giovane aristocratico dal suo stesso ambiente famigliare riceve senza sforzo di apprendimento unaserie di attitudini e di qualità che sono di primo ordine per la carriera ecclesiastica: la tranquilla sicurezza della propria dignità e autorità e l’arte di trattare e governare gli altri.
Una ragione di debolezza della Chiesa nel passato consisteva in ciò che la religione dava scarse possibilità di carriera all’infuori della carriera ecclesiastica: il clero stesso era deteriorato qualitativamente dalle «scarse vocazioni» o dalle vocazioni di soli elementi intellettualmente subalterni. Questa crisi era già molto visibile prima della guerra: era un aspetto della crisi generale delle carriere a reddito fisso con organici lenti e pesanti, cioè dell’inquietudine sociale dello strato intellettuale subalterno (maestri, insegnanti medi, preti, ecc.) in cui operava la concorrenza delle professioni legate allo sviluppo dell’industria e dell’organizzazione privata capitalistica in generale (giornalismo, per esempio, che assorbe molti insegnanti, ecc.). Era già incominciata l’invasione delle scuole magistrali o delle Università da parte delle donne e, con le donne, dei preti, ai quali la Curia (dopo le leggi Credaro) non poteva proibire di procurarsi un titolo pubblico che permettesse di concorrere anche a impieghi di Stato e aumentare così la «finanza» individuale. Molti di questi preti, appena ottenuto il titolo pubblico, abbandonarono la Chiesa (durante la guerra, per la mobilitazione e il contatto con ambienti di vita meno soffocanti e angusti di quelli ecclesiastici, questo fenomeno acquistò una certa ampiezza). L’organizzazione ecclesiastica subiva dunque una crisi costituzionale che poteva essere fatale alla sua potenza, se lo Stato avesse mantenuto integra la sua posizione di laicità, anche senza bisogno di una lotta attiva. Nella lotta tra le forme di vita, la Chiesa stava per perire automaticamente, per esaurimento proprio. Lo Stato salvò la Chiesa.
Le condizioni economiche del clero furono migliorate a più riprese, mentre il tenore della vita generale, ma specialmente dei ceti medi, peggiorava. Il miglioramento è stato tale che le «vocazioni» si sono meravigliosamente moltiplicate, impressionando lo stesso pontefice, che le spiegava appunto con la nuova situazione economica. La base della scelta degli idonei al clericato è stata quindi ampliata, permettendo più rigore e maggiori esigenze culturali.
Ma la carriera ecclesiastica, se è il fondamento più solido della potenza vaticana, non esaurisce le sue possibilità. La nuova struttura scolastica permette l’immissione nel personale dirigente laico di cellule cattoliche che andranno sempre più rafforzandosi, di elementi che dovranno la loro posizione solamente alla Chiesa. È da pensare che l’infiltrazione clericale nella compagine dello Stato sia per aumentare progressivamente, poiché nell’arte di selezionare gli individui e di tenerli permanentemente a sé legati, la Chiesa è quasi imbattibile. Controllando i licei e le altre scuole medie, attraverso i suoi fiduciari, essa seguirà, con la tenacia che le è caratteristica, i giovani più valenti delle classi povere e li aiuterà a proseguire gli studi nelle Università cattoliche. Borse di studio, sussidiate da convitti, organizzati con la massima economia, accanto alle Università, permetteranno questa azione. La Chiesa, nella sua fase odierna, con l’impulso dato dall’attuale pontefice all’Azione Cattolica, non può accontentarsi solo di creare preti; essa vuole permeare lo Stato (ricordare la teoria del governo indiretto elaborata dal Bellarmino) e per ciò sono necessari i laici, è necessaria una concentrazione di cultura cattolica rappresentata da laici. Molte personalità possono diventare ausiliari della Chiesa più preziosi come professori d’Università, come alti funzionari dell’amministrazione, ecc., che come cardinali o vescovi.
Allargata la base di scelta delle «vocazioni», una tale attività laico‑culturale ha grandi possibilità di estendersi. L’Università del Sacro Cuore e il centro neoscolastico sono solo le prime cellule di questo lavoro. È intanto stato sintomatico il Congresso filosofico del 1929: vi si scontrarono idealisti attuali e neoscolastici e questi parteciparono al Congresso animati da spirito battagliero di conquista. Il gruppo neoscolastico, dopo il concordato voleva appunto apparire battagliero, sicuro di sé per interessare i giovani. Occorre tener conto che una delle forze dei cattolici consiste in ciò che essi si infischiano delle «confutazioni perentorie» dei loro avversari non cattolici: la tesi confutata essi la riprendono imperturbati e come se nulla fosse. Il «disinteresse» intellettuale, la lealtà e onestà scientifica essi non le capiscono o le capiscono come debolezza e dabbenaggine degli altri. Essi contano sulla potenza della loro organizzazione mondiale che si impone come fosse una prova di verità, e sul fatto che la grande maggioranza della popolazione non è ancora «moderna», è ancora tolemaica come concezione del mondo e della scienza.
Se lo Stato rinunzia a essere centro attivo e permanentemente attivo di una cultura propria, autonoma, la Chiesa non può che trionfare sostanzialmente. Ma lo Stato non solo non interviene come centro autonomo, ma distrugge ogni oppositore della Chiesa che abbia la capacità di limitarne il dominio spirituale sulle moltitudini.
Si può prevedere che le conseguenze di una tale situazione di fatto, restando immutato il quadro generale delle circostanze, possono essere della massima importanza. La Chiesa è uno Shylok anche più implacabile dello Shylok shakespeariano: essa vorrà la sua libbra di carne anche a costo di dissanguare la sua vittima e con tenacia, mutando continuamente i suoi metodi, tenderà a raggiungere il suo programma massimo. Secondo l’espressione di Disraeli, i cristiani sono gli ebrei più intelligenti che hanno capito come occorreva fare per conquistare il mondo. La Chiesa non può essere ridotta alla sua forza «normale» con la confutazione in sede filosofica dei suoi postulati teorici e con le affermazioni platoniche di una autonomia statale (che non sia militante): ma solo con l’azione pratica quotidiana, con l’esaltazione delle forze umane creatrici in tutta l’area sociale.
Un aspetto della quistione che occorre ben valutare è quello delle possibilità finanziarie del centro vaticano. L’organizzazione sempre più in isviluppo del cattolicismo negli Stati Uniti dà la possibilità di raccogliere fondi molto vistosi, oltre alle rendite normali ormai assicurate (che però dal 1937 diminuiranno di 15 milioni all’anno per la conversione del debito pubblico dal 5% al 3,5%) e all’obolo di S. Pietro. Potrebbero nascere quistioni internazionali a proposito dell’intervento della Chiesa negli affari interni dei singoli paesi, con lo Stato che sussidia permanentemente la Chiesa? La quistione è elegante, come si dice.
La quistione finanziaria rende molto interessante il problema della così detta indissolubilità tra Trattato e Concordato proclamata dal pontefice. Ammesso che il papa si trovasse nella necessità di ricorrere a questo mezzo politico di pressione sullo Stato, non si porrebbe subito il problema della restituzione delle somme riscosse (che sono legate appunto al Trattato e non al Concordato)? Ma esse sono così ingenti ed è pensabile che saranno state spese in gran parte nei primi anni, che la loro restituzione può ritenersi praticamente impossibile. Nessuno Stato potrebbe fare un così gran prestito al Pontefice per trarlo d’imbarazzo e tanto meno un privato o una banca. La denunzia del Trattato scatenerebbe una tale crisi nella organizzazione pratica della Chiesa, che la solvibilità di questa, sia pure a grande scadenza, sarebbe annientata. La convenzione finanziaria annessa al Trattato deve essere pertanto considerata come la parte essenziale del Trattato stesso, come la garanzia di una quasi impossibilità di denunzia del Trattato, prospettata per ragioni polemiche e di pressione politica.
Brano di lettera di Leone XIII a Francesco Giuseppe (in data pare del giugno 1892, riportata app. 244 e sgg. del libro: Francesco Salata, Per la storia diplomatica della Questione Romana, I, Treves, 1929): «E non taceremo, che in mezzo a tali impacci Ci manca pure il modo di sopperire del proprio alle incessanti e molteplici esigenze materiali, inerenti al governo della Chiesa. Vero è che ne vengono in soccorso le offerte spontanee della carità; ma Ci sta sempre innanzi con rammarico il pensiero che esse tornano di aggravio ai Nostri figli; e d’altra parte non si deve pretendere che inesauribile sia la carità pubblica». «Di proprio» significa «riscosse con imposte» dai cittadini di uno Stato pontificio, per i cui sacrifizi non si prova rammarico, a quanto pare: sembra naturale che le popolazioni italiane paghino le spese della Chiesa universale.
Nel conflitto tra Bismarck e la Santa Sede si possono trovare gli spunti di una serie di quistioni che potrebbero essere sollevate per il fatto che il Vaticano ha la sede in Italia ed ha determinati rapporti con lo Stato italiano: Bismarck «fece lanciare da’ suoi giuristi (scrive il Salata, vol. cit., p. 271) la teoria della responsabilità dello Stato italiano per i fatti politici del Papa che l’Italia aveva costituito in tale condizione di invulnerabilità e irresponsabilità per danni ed offese recate dal Pontefice ad altri Stati».
Q16 §12 Naturale, contro natura, artificiale, ecc. Cosa significa dire che una certa azione, un certo modo di vivere, un certo atteggiamento o costume sono «naturali» o che essi invece sono «contro natura»? Ognuno, nel suo intimo, crede di sapere esattamente cosa ciò significhi, ma se si domanda una risposta esplicita e motivata si vede che la cosa non è poi così facile come poteva sembrare. Occorre intanto fissare che non si può parlare di «natura» come di alcunché di fisso, immutabile e oggettivo. Ci si accorge che quasi sempre «naturale» significa «giusto e normale» secondo la nostra attuale coscienza storica, ma i più non hanno coscienza di questa attualità determinata storicamente e ritengono il loro modo di pensare eterno e immutabile.
Si osserva presso alcuni gruppi fanatici della «naturalità» questa opinione: azioni che alla nostra coscienza appaiono «contro natura» sono per essi «naturali» perché compiute dagli animali; e non sono gli animali «gli esseri più naturali del mondo»? Questa opinione si sente espressa in certi ambienti frequentemente a proposito soprattutto di questioni connesse ai rapporti sessuali. Per esempio: perché l’incesto sarebbe «contro natura» se esso è diffuso nella «natura»? Intanto anche tali affermazioni sugli animali non sempre sono esatte, perché le osservazioni sono fatte su animali addomesticati dall’uomo per il suo utile e costretti a una forma di vita che per gli animali stessi non è «naturale» ma è conforme ai fini dell’uomo. Ma se fosse anche vero che certi atti si verificano tra gli animali, che significato avrebbe ciò per l’uomo? Perché dovrebbe derivarne una norma di condotta? La «natura» dell’uomo è l’insieme dei rapporti sociali che determina una coscienza storicamente definita; questa coscienza solo può indicare ciò che è «naturale» o «contro natura». Inoltre: l’insieme dei rapporti sociali è contradditorio in ogni momento ed è in continuo svolgimento, sicché la «natura» dell’uomo non è qualcosa di omogeneo per tutti gli uomini in tutti i tempi.
Si sente dire spesso che una certa abitudine è diventata una «seconda natura»; ma la«prima natura» sarà stata proprio la «prima»?. In questo modo di esprimersi del senso comune non è implicito l’accenno alla storicità della «natura umana»?
Constatato che, essendo contradditorio l’insieme dei rapporti sociali, non può non essere contradditoria la coscienza degli uomini, si pone il problema del come si manifesta tale contraddizione e del come possa essere progressivamente ottenuta l’unificazione: si manifesta nell’intero corpo sociale, con l’esistenza di coscienze storiche di gruppo (con l’esistenza di stratificazioni corrispondenti a diverse fasi dello sviluppo storico della civiltà e con antitesi nei gruppi che corrispondono a uno stesso livello storico) e si manifesta negli individui singoli come riflesso di una tale disgregazione «verticale e orizzontale». Nei gruppi subalterni, per l’assenza di autonomia nell’iniziativa storica, la disgregazione è più grave e più forte la lotta per liberarsi dai principii imposti e non proposti nel conseguimento di una coscienza storica autonoma: i punti di riferimento in tale lotta sono disparati e uno di essi, quello appunto che consiste nella «naturalità», nel porre come esemplare la «natura» ottiene molta fortuna perché pare ovvio e semplice. Come invece dovrebbe formarsi questa coscienza storica proposta autonomamente? Come ognuno dovrebbe scegliere e combinare gli elementi per la costituzione di una tale coscienza autonoma? Ogni elemento «imposto» sarà da ripudiarsi a priori? Sarà da ripudiare come imposto, ma non in se stesso, cioè occorrerà dargli una nuova forma che sia propria del gruppo dato. Che l’istruzione sia obbligatoria non significa infatti che sia da ripudiare e neppure che non possa essere giustificata, con nuovi argomenti, una nuova forma di obbligatorietà: occorre fare «libertà» di ciò che è «necessario», ma perciò occorre riconoscere una necessità «obbiettiva», cioè che sia obbiettiva precipuamente per il gruppo in parola. Bisogna perciò riferirsi ai rapporti tecnici di produzione, a un determinato tipo di civiltà economica che per essere sviluppato domanda un determinato modo di vivere, determinate regole di condotta, un certo costume. Occorre persuadersi che non solo è «oggettivo» e necessario un certo attrezzo, ma anche un certo modo di comportarsi, una certa educazione, un certo modo di convivenza ecc.; in questa oggettività e necessità storica (che peraltro non è ovvia, ma ha bisogno di chi la riconosca criticamente e se ne faccia sostenitore in modo completo e quasi «capillare») si può basare l’«universalità» del principio morale, anzi non è mai esistita altra universalità che questa oggettiva necessità della tecnica civile, anche se interpretata con ideologie trascendenti o trascendentali e presentata volta per volta nel modo più efficace storicamente perché si raggiungesse lo scopo voluto.
Una concezione come quella su esposta pare condurre a una forma di relativismo e quindi di scetticismo morale. Si osserva che altrettanto si può dire di tutte le concezioni fin qui elaborate dalla filosofia, la cui imperatività categorica e oggettiva è stata sempre passibile di essere ridotta, dalla «cattiva volontà», a forme di relativismo e di scetticismo. Perché la concezione religiosa potesse almeno apparire assoluta e oggettivamente universale, sarebbe necessario che essa si presentasse monolitica, per lo meno intellettualmente uniforme in tutti i credenti, ciò che è molto lontano dalla realtà (differenza di scuola, sette, tendenze e differenze di classe: semplici e colti, ecc.): da ciò la funzione del papa come maestro infallibile.
Lo stesso si può dire dell’imperativo categorico di Kant: «opera come vorresti operassero tutti gli uomini nelle stesse circostanze». È evidente che ognuno può pensare, bona fide, che tutti dovrebbero operare come lui, anche quando compie azioni che invece sono repugnanti a coscienze più sviluppate o di civiltà diversa. Un marito geloso che ammazza la moglie infedele pensa che tutti i mariti dovrebbero ammazzare le mogli infedeli ecc. Si può osservare che non esiste delinquente il quale non giustifichi intimamente il reato commesso, per scellerato che possa essere: e pertanto non sono senza una certa convinzione di buona fede le proteste di innocenza di tanti condannati; in realtà ognuno di questi conosce esattamente le circostanze oggettive e soggettive in cui ha commesso il reato e da questa conoscenza, che spesso non può trasmettere razionalmente agli altri, trae la convinzione di essere «giustificato»; solo se muta il suo modo di concepire la vita, giunge a un giudizio diverso, cosa che spesso avviene e spiega molti suicidi. La formula kantiana, analizzata realisticamente, non supera qualsiasi ambiente dato, con tutte le sue superstizioni morali e i suoi costumi barbarici; è statica, è una vuota forma che può essere riempita da qualsiasi contenuto storico attuale e anacronistico (con le sue contraddizioni, naturalmente, per cui ciò che è verità di là dai Pirenei, è bugia di qua dai Pirenei). La formula kantiana sembra superiore perché gli intellettuali la riempiono del loro particolare modo di vivere e di operare e si può ammettere che talvolta certi gruppi di intellettuali siano più progrediti e civili del loro ambiente.
L’argomento del pericolo di relativismo e scetticismo non è dunque valido. Il problema da porre è un altro: questa data concezione morale ha in sé i caratteri di una certa durata? oppure è mutevole ogni giorno o dà luogo, nello stesso gruppo, alla formulazione della teoria della doppia verità? Inoltre: sulla sua base può costituirsi una élite che guidi le moltitudini, le educhi e sia capace di essere «esemplare»? Risolti questi punti affermativamente la concezione è giustificata e valida.
Ma ci sarà un periodo di rilassatezza, anzi di libertinaggio e di dissolvimento morale. Ciò è tutt’altro che escluso, ma non è neppure esso argomento valido. Periodi di dissoluzione morale si sono spesso verificati nella storia, pur mantenendo il suo predominio la stessa concezione morale generale e hanno avuto origine da cause reali e concrete e non dalle concezioni morali: essi molto spesso indicano che una concezione è invecchiata, si è disgregata, è diventata pura ipocrisia formalistica, ma tenta di mantenersi in auge coercitivamente, costringendo la società a una vita doppia; all’ipocrisia e alla doppiezza appunto reagiscono in forme esagerate i periodi di libertinaggio e di dissolvimento che annunziano quasi sempre che una nuova concezione si va formando.
Il pericolo di non vivacità morale è invece rappresentato dalla teoria fatalistica di quei gruppi che condividono la concezione della «naturalità» secondo la «natura» dei bruti e per cui tutto è giustificato dall’ambiente sociale. Ogni senso di responsabilità individuale si viene così a ottundere e ogni responsabilità singola è annegata in una astratta e irreperibile responsabilità sociale. Se questo concetto fosse vero, il mondo e la storia sarebbero sempre immobili. Se infatti l’individuo, per cambiare, ha bisogno che tutta la società si sia cambiata prima di lui, meccanicamente, per chissà quale forza extraumana, nessun cambiamento avverrebbe mai. La storia invece è una continua lotta di individui e di gruppi per cambiare ciò che esiste in ogni momento dato, ma perché la lotta sia efficiente questi individui e gruppi dovranno sentirsi superiori all’esistente, educatori della società, ecc. L’ambiente quindi non giustifica ma solo «spiega» il comportamento degli individui e specialmente di quelli storicamente più passivi. La «spiegazione» servirà talvolta a rendere indulgenti verso i singoli e darà materiale per l’educazione, ma non deve mai diventare «giustificazione» senza condurre necessariamente a una delle forme più ipocrite e rivoltanti di conservatorismo e di «retrivismo».
Al concetto di «naturale» si contrappone quello di «artificiale», di «convenzionale». Ma cosa significa «artificiale» e «convenzionale» quando è riferito ai fenomeni di massa? Significa semplicemente «storico», acquisito attraverso lo svolgimento storico e inutilmente si cerca di dare un senso deteriore alla cosa, perché essa è penetrata anche nella coscienza comune con l’espressione di «seconda natura». Si potrà quindi parlare di artificio e di convenzionalità con riferimento a idiosincrasie personali, non a fenomeni di massa già in atto. Viaggiare in ferrovia è «artificiale» ma non certo come il darsi il belletto alla faccia.
Secondo gli accenni fatti nei paragrafi precedenti, come positività si pone il problema di chi dovrà decidere che una determinata condotta morale è la più conforme a un determinato stadio di sviluppo delle forze produttive. Certo non si può parlare di creare un «papa» speciale o un ufficio competente. Le forze dirigenti nasceranno per il fatto stesso che il modo di pensare sarà indirizzato in questo senso realistico e nasceranno dallo stesso urto dei pareri discordi, senza «convenzionalità» e «artificio» ma «naturalmente».
Q16 §13 Origine popolaresca del «superuomo». Ogni volta che ci si imbatte in qualche ammiratore del Nietzsche, è opportuno domandarsi e ricercare se le sue concezioni «superumane», contro la morale convenzionale, ecc. ecc., siano di pretta origine nicciana, siano cioè il prodotto di una elaborazione di pensiero da porsi nella sfera della «alta cultura», oppure abbiano origini molto più modeste, siano, per esempio, connesse con la letteratura d’appendice. (E lo stesso Nietzsche non sarà stato per nulla influenzato dai romanzi francesi d’appendice? Occorre ricordare che tale letteratura, oggi degradata alle portinerie e ai sottoscala, è stata molto diffusa tra gli intellettuali, almeno fino al 1870, come oggi il così detto romanzo «giallo»). In ogni modo pare si possa affermare che molta sedicente «superumanità» nicciana ha solo come origine e modello dottrinale non Zaratustra ma Il conte di Montecristo di A. Dumas. Il tipo più compiutamente rappresentato dal Dumas in Montecristo trova, in altri romanzi dello stesso autore, numerose repliche: esso è da identificare, per esempio, nell’Athos dei Tre Moschettieri, in Giuseppe Balsamo e forse anche in altri personaggi.
Così, quando si legge che uno è ammiratore del Balzac, occorre porsi in guardia: anche nel Balzac c’è molto del romanzo d’appendice. Vautrin è anch’egli, a suo modo, un superuomo, e il discorso che egli fa a Rastignac nel Papà Goriot ha molto di… nicciano in senso popolaresco; lo stesso deve dirsi di Rastignac e di Rubempré. (Vincenzo Morello è diventato «Rastignac» per una tale filiazione… popolaresca e ha difeso «Corrado Brando»).
La fortuna del Nietzsche è stata molto composita: le sue opere complete sono edite dall’editore Monanni e si conoscono le origini culturali‑ideologiche del Monanni e della sua più affezionata clientela.
Vautrin e l’«amico di Vautrin» hanno lasciato larga traccia nella letteratura di Paolo Valera e della sua «Folla» (ricordare il torinese «amico di Vautrin» della «Folla»). Largo seguito popolaresco ha avuto l’ideologia del «moschettiere» presa dal romanzo del Dumas.
Che si abbia un certo pudore a giustificare mentalmente le proprie concezioni coi romanzi di Dumas e di Balzac, s’intende facilmente: perciò le si giustifica col Nietzsche e si ammira Balzac come scrittore d’arte e non come creatore di figure romanzesche del tipo appendice. Ma il nesso reale pare certo culturalmente.
Il tipo del «superuomo» è Montecristo, liberato di quel particolare alone di «fatalismo» che è proprio del basso romanticismo e che áèñ ancor più calcato in Athos e in G. Balsamo. Montecristo portato nella politica è certo oltremodo pittoresco: la lotta contro i «nemici personali» del Montecristo, ecc.
Si può osservare come certi paesi siano rimasti provinciali e arretrati anche in questa sfera in confronto di altri; mentre già Sherlock Holmes è diventato anacronistico per molta Europa, in alcuni paesi si è ancora a Montecristo e a Fenimore Cooper (cfr «i selvaggi», «pizzo di ferro», ecc.).
Cfr il libro di Mario Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (Edizione della Cultura): accanto alla ricerca del Praz, sarebbe da fare quest’altra ricerca: del «superuomo» nella letteratura popolare e dei suoi influssi nella vita reale e nei costumi (la piccola borghesia e piccoli intellettuali sono particolarmente influenzati da tali immagini romanzesche, che sono come il loro «oppio», il oro «paradiso artificiale» in contrasto con la meschinità e le strettezze della loro vita reale immediata): da ciò la fortuna di alcuni motti come: «è meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora», fortuna particolarmente grande in chi è proprio e irrimediabilmente pecora. Quante di queste «pecore» dicono: oh! avessi io il potere anche per un giorno solo ecc.; essere «giustizieri» implacabili è l’aspirazione di chi sente l’influsso di Montecristo.
Adolfo Omodeo ha osservato che esiste una specie di «manomorta» culturale, costituita dalla letteratura religiosa, di cui nessuno pare voglia occuparsi, come se non avesse importanza e funzione nella vita nazionale e popolare.
A parte l’epigramma della «manomorta» e la soddisfazione del clero che la sua speciale letteratura non sia sottoposta a un esame critico, esiste un’altra sezione della vita culturale nazionale e popolare di cui nessuno si occupa e si preoccupa criticamente ed è appunto la letteratura d’appendice propriamente detta e anche in senso largo (in questo senso vi rientra Victor Hugo e anche il Balzac).
In Montecristo vi sono due capitoli dove esplicitamente si disserta del «superuomo» d’appendice: quello intitolato «Ideologia», quando Montecristo si incontra col procuratore Villefort e quello che descrive la colazione presso il visconte di Morcerf al primo viaggio di Montecristo a Parigi. È da vedere se in altri romanzi del Dumas esistono spunti «ideologici» del genere. Nei Tre moschettieri, Athos ha più dell’uomo fatale generico del basso romanticismo: in questo romanzo gli umori individualistici popolareschi sono piuttosto solleticati con l’attività avventurosa ed extralegale dei moschettieri come tali. In Giuseppe Balsamo, la potenza dell’individuo è legata a forze oscure di magia e all’appoggio della massoneria europea, quindi l’esempio è meno suggestivo per il lettore popolaresco. Nel Balzac le figure sono più concretamente artistiche, ma tuttavia rientrano nell’atmosfera del romanticismo popolaresco. Rastignac e Vautrin non sono certo da confondersi coi personaggi dumasiani e appunto perciò la loro influenza è più «confessabile», non solo da parte di uomini come Paolo Valera e i suoi collaboratori della «Folla» ma anche da mediocri intellettuali come V. Morello, che però ritengono (o sono ritenuti da molti) appartenere alla «alta coltura».
Da avvicinare al Balzac è lo Stendhal con la figura di Giuliano Sorel e altre del suo repertorio romanzesco.
Per il «superuomo» del Nietzsche, oltre all’influsso romantico francese (e in generale del culto di Napoleone)
sono da vedere le tendenze razziste che hanno culminato nel Gobineau e quindi nel Chamberlain e nel pangermanismo (Treitschke, la teoria della potenza ecc.).
Ma forse il «superuomo» popolaresco dumasiano è da ritenersi proprio una reazione «democratica» alla concezione d’origine feudale del razzismo, da unire all’esaltazione del «gallicismo» fatta nei romanzi di Eugenio Sue.
Come reazione a questa tendenza del romanzo popolare francese è da ricordare Dostojevschi: Raskolnikov è Montecristo «criticato» da un panslavista‑cristiano. Per l’influsso esercitato su Dostojevschi dal romanzo francese d’appendice è da confrontare il numero unico dedicato a Dostojevschi dalla «Cultura».
Nel carattere popolaresco del «superuomo» sono contenuti molti elementi teatrali, esteriori, da «primadonna» più che da superuomo; molto formalismo «soggettivo e oggettivo», ambizioni fanciullesche di essere il «primo della classe», ma specialmente di essere ritenuto e proclamato tale.
Per i rapporti tra il basso romanticismo e alcuni aspetti della vita moderna (atmosfera da Conte di Montecristo) è da leggere un articolo di Louis Gillet nella «Revue des deux mondes» del 15 dicembre 1932.
Questo tipo di «superuomo» ha la sua espressione nel teatro (specialmente francese, che continua per tanti rispetti la letteratura d’appendice quarantottesca): è da vedere il repertorio «classico» di Ruggero Ruggeri come Il marchese di Priola, L’artiglio, ecc. e molti lavori di Henry Bernstein.
Q16 §14 Rapporti tra Stato e Chiesa. (Cfr p. 15 bis). Il Direttore Generale del Fondo per il Culto, Raffaele Jacuzio, ha pubblicato un Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica con prefazione di Alfredo Rocco (Torino, Utet, 1932, in 8°, pp. 693, L. 60) dove raccoglie e commenta tutti gli atti sia degli organi statali italiani, che di quelli vatica
neschi per la messa in esecuzione del concordato. Accennando alla quistione dell’Azione Cattolica lo Jacuzio scrive (p. 203): «Ma poiché nel concetto di politica non rientra soltanto la tutela dell’ordinamento giuridico dello Stato ma anche tutto quanto si attiene alle provvidenze di ordine economico sociale, è ben difficile… ritenere nel
l’Azione Cattolica a priori esclusa ogni azione politica quando… si fanno rientrare in essa l’azione sociale ed economica e l’educazione spirituale della gioventù».
Sul concordato è anche da vedere il libro di Vincenzo Morello: Il conflitto dopo il Concordato (Bompiani, 1931) e la risposta di Egilberto Martire: Ragioni della Conciliazione (Roma, «Rassegna Romana», 1932). Sulla polemica Morello‑Martire è da vedere l’articolo firmato Novus nella «Critica Fascista» del 1° febbraio 1933 (Una polemica sulla Conciliazione). Il Morello pone in rilievo quei punti del Concordato in cui lo Stato è venuto meno a se stesso, ha abdicato alla sua sovranità, non solo, ma, pare, mette anche in rilievo come in alcuni punti le concessioni fatte alla Chiesa siano più ampie di quelle fatte da altri paesi concordatari. I punti controversi sono principalmente quattro: 1) il matrimonio; per l’art. 43 del Concordato il matrimonio è disciplinato dal diritto canonico, cioè viene applicato nell’ambito statale un diritto ad esso estraneo. Per esso i cattolici, in base a un diritto estraneo allo Stato, possono avere annullato il matrimonio, a differenza dei non cattolici, mentre «l’essere o non essere cattolici dovrebbe essere irrilevante agli effetti Civili»; 2) per l’art. 5, comma 3° c’è l’interdizione da alcuni uffici pubblici per i sacerdoti apostati o irretiti da censura, cioè si applica una «pena» del Codice Penale a persone che non hanno commesso, di fronte allo Stato, nessun reato punibile; l’art. 1° del Codice vuole invece che nessun cittadino possa essere punito se non per un fatto espressamente preveduto dalla legge penale comereato; 3) per il Morello non si vede quali siano le ragioni di utilità per cui lo Stato ha fatto tabula rasa delle leggi eversive, riconoscendo agli enti ecclesiastici e ordini religiosi l’esistenza giuridica, la facoltà di possedere ed amministrare i propri beni; 4) insegnamento; esclusione recisa e totale dello Stato dalle scuole ecclesiastiche e non già solo da quelle che preparano tecnicamente i sacerdoti (cioè esclusione del controllo statale dall’insegnamento della teologia, ecc.) ma da quelle dedicate all’insegnamento generale. L’art. 39 del Concordato si riferisce infatti anche alle scuole elementari e medie tenute dal clero in molti Seminari, collegi e conventi, delle quali il clero si serve per attrarre fanciulli e giovinetti al sacerdozio e alla vita monastica, ma che in sé non sono ancora specializzate. Questi alunni dovrebbero aver diritto alla tutela dello Stato. Pare che in altri concordati si sia tenuto conto di certe garanzie verso lo Stato, per cui anche il clero non sia formato in modo contrario alle leggi e all’ordine nazionale, e precisamente imponendo che per avere molti uffici ecclesiastici è necessario un titolo di studio pubblico (quello che dà adito alle Università).
Q16 §15 Origine popolaresca del superuomo. (Cfr pagina 23 bis). Su questo argomento è da vedere l’opera del Farinelli Il romanticismo nel mondo latino (3 voll., Bocca, Torino). Nel vol. 2°, un capitolo dove si parla del motivo dell’«uomo fatale» e del «genio incompreso».
Q16 §16 I fondatori della filosofia della praxis e l’Italia. Una raccolta sistematica di tutti gli scritti (anche dell’epistolario) che riguardano l’Italia o considerano problemi italiani. Ma una raccolta che si limitasse a questa scelta non sarebbe organica e compiuta. Esistono scritti dei due autori che, pure non riguardando specificatamente l’Italia, hanno un significato per l’Italia, e un significato non generico, s’intende, perché altrimenti tutte le opere dei due scrittori si può dire che riguardino l’Italia. Il piano della raccolta potrebbe essere costruito secondo questi criteri: 1) scritti che specificatamente si riferiscono all’Italia; 2) scritti che riguardano argomenti «specifici» di critica storica e politica, che pur non riferendosi all’Italia, hanno attinenza con problemi italiani. Esempi: l’articolo sulla costituzione spagnola del 1812 ha attinenza con l’Italia, per la funzione politica che tale costituzione ha avuto nei movimenti italiani fino al 48. Così ha attinenza con l’Italia la critica della Miseria della filosofia contro la falsificazione della dialettica hegelìana fatta dal Proudhon, che ha riflessi in corrispondenti moti intellettuali italiani (Gioberti; l’hegelismo dei moderati; concetto di rivoluzione passiva; dialettica di rivoluzione‑restaurazione). Lo stesso si dica dello scritto di Engels sui moti libertari spagnoli del 1873 (dopo l’abdicazione di Amedeo di Savoia) che ha attinenza con l’Italia, ecc.
Di questa seconda serie di scritti non bisogna forse fare la raccolta, ma è sufficiente un’esposizione critico‑analitica. Forse il piano più organico potrebbe essere quello in tre parti: 1) introduzione storico‑critica; 2) scritti sull’Italia; 3) analisi degli scritti attinenti indirettamente l’Italia, cioè che si propongono di risolvere quistioni che sono essenziali e specifiche anche per l’Italia.
Q16 §17 La tendenza a diminuire l’avversario: è di per se stessa un documento della inferiorità di chi ne è posseduto. Si tende infatti a diminuire rabbiosamente l’avversario per poter credere di esserne sicuramente vittoriosi. In questa tendenza è perciò insito oscuramente un giudizio sulla propria incapacità e debolezza (che si vuol far coraggio), e si potrebbe anche riconoscervi un inizio di autocritica (che si vergogna di se stessa, che ha paura di manifestarsi esplicitamente e con coerenza sistematica). Si crede nella «volontà di credere» come condizione della vittoria, ciò che non sarebbe sbagliato se non fosse concepito meccanicamente e non diventasse un autoinganno (quando contiene una indebita confusione tra massa e capi e abbassa la funzione del capo al livello del più arretrato e incondito gregario: al momento dell’azione il capo può cercare di infondere nei gregari la persuasione che l’avversario sarà certamente vinto, ma egli stesso deve farsi un giudizio esatto e calcolare tutte le possibilità, anche le più pessimistiche). Un elemento di questa tendenza è di natura oppiacea: è infatti proprio dei deboli abbandonarsi alla fantasticheria, sognare ad occhi aperti che i propri desideri sono la realtà, che tutto si svolge secondo i desideri. Perciò si vede da una parte l’incapacità, la stupidaggine, la barbarie, la vigliaccheria ecc., dall’altra le più alte doti del carattere e dell’intelligenza: la lotta non può essere dubbia e già pare di tenere in pugno la vittoria. Ma la lotta rimane sognata e vinta in sogno. Un altro aspetto di questa tendenza è quello di vedere le cose oleograficamente, nei momenti culminanti di alta epicità. Nella realtà, da dovunque si cominci ad operare, le difficoltà appaiono subito gravi perché non si era mai pensato concretamente ad esse; e siccome occorre sempre cominciare da piccole cose (per lo più le grandi cose sono un insieme di piccole cose) la «piccola cosa» viene a sdegno; è meglio continuare a sognare e rimandare l’azione al momento della «grande cosa». La funzione di sentinella è gravosa, noiosa, defatigante; perché «sprecare» così la personalità umana e non conservarla per la grande ora dell’eroismo? e così via.
Non si riflette che se l’avversario ti domina e tu lo diminuisci, riconosci di essere dominato da uno che consideri inferiore; ma allora come sarà riuscito a dominarti? Come mai ti ha vinto ed è stato superiore a te proprio in quell’attimo decisivo che doveva dare la misura della tua superiorità e della sua inferiorità? Certo ci sarà stata di mezzo la «coda del diavolo». Ebbene, impara ad avere la coda del diavolo dalla tua parte.
Uno spunto letterario: nel capitolo XIV della seconda parte del Don Chisciotte il cavaliere degli Specchi sostiene di aver vinto Don Chisciotte: «Y héchole confesar que es más hermosa mi Casildea que su Dulcinea; y en solo este vencimiento hago cuenta que he vencido á todos los caballeros del mundo, porque el tal Don Quijote que digo, los ha vencido á todos; y habiéndole yo vencido á él, su gloria, su fama y su honra, se ha transferido y pasado á mi persona,
Y tanto el vencedor es más honrado
Cuanto más el vencido es reputado;
así, que ya corren por mi cuenta y son mías las innumerables hazañas del ya referido Don Quijote».
Q16 §18 «Paritario e paritetico». Il significato di paritario e paritetico è dei più interessanti e «significativi». Significa che 1 000 000 ha gli stessi diritti di 10 000, talvolta che uno ha gli stessi diritti di 50 000. Cosa significa paritario nelle officine Schneider del Creusot? Cosa significa nel Consiglio nazionale per l’industria delle miniere di carbone, in Inghilterra? Cosa significa nel Consiglio direttivo dell’u.i.l. di Ginevra, ecc.? Tra chi viene stabilita una parità? Il curioso è che siano i cattolici i più strenui assertori del paritarismo, per i quali una persona umana (un’anima) dovrebbe essere pari a un’altra ecc.; ma già il Rosmini voleva che il potere rappresentativo fosse stabilito non secondo l’«anima immortale» ugualmente cara a dio, ma secondo la proprietà. Altro che spiritualismo!
Q16 §19 Il medico cattolico e l’ammalato (moribondo) acattolico. Cfr nella «Civiltà Cattolica» del 19 novembre 1932, p. 381, la recensione del libro di Luigi Scremin, Appunti di morale professionale per i medici (Roma, Editrice «Studium», 1932, in 12°, pp. 118, L. 5): «... così a p. 95, pur citando il Prümmer, è detto male che “per un acattolico che desideri ed esiga un ministro della sua religione, è lecito al medico, in mancanza di altri, far conoscere al ministro stesso il desiderio dell’infermo, ed è anche tenuto (sic) a farlo solo quando giudichi dannoso per l’infermo non soddisfare questo desiderio”. La sentenza del moralista è ben altra; ed infatti il Prümmer (I, 526) ci dice che non si deve chiamare un ministro acattolico, il quale non ha alcuna potestà di amministrare i sacramenti: ma piuttosto aiutare l’infermo a fare un atto di contrizione. Che se l’infermo esige assolutamente che si chiami il ministro acattolico e dal rifiuto nascerebbero gravi danni si può (non già si deve) far conoscere a detto ministro il desiderio dell’infermo. E si dovrebbe distinguere ancora, quando l’infermo fosse in buona fede ed appartenesse a un rito acattolico, in cui i ministri fossero insigniti di vero ordine sacro, come tra i Greci separati». Il brano è significativo.
Q16 §20 Le innovazioni nel diritto processuale e la filosofia della prassi. L’espressione contenuta nella prefazione alla Critica dell’Economia politica (1859): «così come non si giudica ciò che un individuo è da ciò che egli sembra a se stesso» può essere riallacciata al rivolgimento avvenuto nel diritto processuale e alle discussioni teoriche in proposito, e che nel 1859 erano relativamente recenti. La vecchia procedura infatti esigeva la confessione dell’imputato (specialmente per i delitti capitali) per emettere la sentenza di condanna: l’«habemus confitentem reum» pareva il fastigio di ogni procedimento giudiziario, donde le sollecitazioni, le pressioni morali e i vari gradi di tortura (non come pena, ma come mezzo istruttorio).
Nella procedura rinnovata, l’interrogatorio dell’imputato diventa solo un elemento talvolta trascurabile, in ogni caso utile solo per dirigere le ulteriori indagini dell’istruttoria e del processo, tanto che l’imputato non giura e gli viene riconosciuto il diritto di non rispondere, di essere reticente e anche di mentire, mentre il peso massimo è dato alle prove materiali oggettive e alle testimonianze disinteressate (tanto che i funzionari dello Stato non dovrebbero essere considerati testimoni ma solo referendari del pubblico ministero).
È da ricercare se sia già stato fatto un tale riavvicinamento tra il metodo istruttorio per ricostruire la responsabilità penale dei singoli individui e il metodo critico, proprio della filosofia della prassi, di ricostruire la «personalità» oggettiva degli accadimenti storici e del loro svolgimento, e (se sia già stato) esaminato il movimento per la rinnovazione del diritto processuale come un elemento «suggestivo» per la rinnovazione dello studio della storia: il Sorel avrebbe potuto fare l’osservazione, che rientra nel suo stile.
È da osservare come il rinnovamento del diritto processuale, che ebbe una importanza non lieve anche nella sfera politica, determinando un rafforzamento della tendenza alla divisione dei poteri, e all’indipendenza della magistratura (quindi alla riorganizzazione generale della struttura dell’apparato governativo) si sia attenuato in molti paesi, riportando in molti casi ai vecchi metodi istruttori e perfino alla tortura: i sistemi della polizia americana, con il terzo grado degli interrogatori, sono abbastanza noti. Così ha perduto molto dei suoi caratteri la figura dell’avvocato fiscale, che dovrebbe rappresentare oggettivamente gli interessi della legge e della società legale, i quali sono lesi non solo quando un colpevole rimane impunito ma anche e specialmente se un innocente viene condannato. Pare invece si sia formata la convinzione che il fisco sia un avvocato del diavolo che vuole nell’inferno specialmente gli innocenti per fare le fiche a dio, e che il fisco debba perciò sempre volere sentenze di condanna.
Q16 §21. Oratoria, conversazione, cultura. Il Macaulay, nel suo saggio sugli Oratori attici (controllare la citazione), attribuisce la facilità di lasciarsi abbagliare da sofismi quasi puerili propria dei Greci anche più colti al predominio che nell’educazione e nella vita greca aveva il discorso vivo e parlato. L’abitudine della conversazione e dell’oratoria genera una certa facoltà di trovare con grande prontezza argomenti di una qualche apparenza brillante che chiudono momentaneamente la bocca dell’avversario e lasciano sbalordito l’ascoltatore. Questa osservazione si può trasportare anche ad alcuni fenomeni della vita moderna e alla labilità della base culturale di alcuni gruppi sociali come gli operai di città. Essa spiega in parte la diffidenza dei contadini contro gli intellettuali comizianti: i contadini, che rimuginano a lungo le affermazioni che hanno sentito declamare e dal cui luccicore sono stati momentaneamente colpiti, finiscono, col buon senso che ha ripreso il sopravvento dopo l’emozione suscitata dalle parole trascinanti, col trovarne le deficienze e la superficialità e quindi diventano diffidenti per sistema.
Un’altra osservazione del Macaulay è da ritenere: egli riferisce una sentenza di Eugenio di Savoia, il quale diceva che più grandi generali erano riusciti quelli che erano stati messi d’un tratto alla testa dell’esercito e quindi nella necessità di pensare alle manovre grandi e complessive. Cioè chi per professione è diventato schiavo delle minuzie si burocratizza: vede l’albero e non più la foresta, il regolamento e non il piano strategico. Tuttavia i grandi capitani sapevano contemperare l’una cosa e l’altra: il controllo del rancio dei soldati e la grande manovra ecc.
Si può ancora aggiungere che il giornale si avvicina molto all’oratoria e alla conversazione. Gli articoli di giornale sono di solito affrettati, improvvisati, simili, in grandissima parte, per la rapidità dell’ideazione e dell’argomentazione, ai discorsi da comizio. Sono pochi i giornali che hanno redattori specializzati e, d’altronde, anche l’attività di questi è in gran parte improvvisata: la specializzazione serve per improvvisare meglio e più rapidamente. Mancano, specialmente nei giornali italiani, le rassegne periodiche più elaborate e ponderate (per il teatro, per l’economia, ecc.); i collaboratori suppliscono solo in parte e, non avendo un indirizzo unitario, lasciano tracce scarse. La solidità di una cultura può essere perciò misurata in tre gradi principali: a) quella dei lettori di soli giornali; b) quella di chi legge anche riviste non di varietà; c) quella dei lettori di libri, senza tener conto di una grande moltitudine (la maggioranza) che non legge neanche i giornali e si forma qualche opinione assistendo alle riunioni periodiche e dei periodi elettorali, tenute da oratori di livelli diversissimi. Osservazione fatta nel carcere di Milano, dove era in vendita «Il Sole»: la maggioranza dei detenuti, anche politici, leggeva «La Gazzetta dello Sport». Tra circa 2500 detenuti si vendevano, al massimo, 80 copie del «Sole»; dopo la «Gazzetta dello Sport» le pubblicazioni più lette erano la «Domenica del Corriere» e «Il Corriere dei Piccoli».
È certo che il processo dell’incivilimento intellettuale si è svolto per un periodo lunghissimo specialmente nella forma oratoria e retorica, cioè con nullo o troppo scarso sussidio di scritti: la memoria delle nozioni udite esporre a viva voce era la base di ogni istruzione (e tale rimane ancora in alcuni paesi, per esempio in Abissinia). Una nuova tradizione comincia coll’Umanesimo, che introduce il «compito scritto» nelle scuole e nell’insegnamento: ma si può dire che già nel Medio Evo, con la scolastica, si critichi implicitamente la tradizione della pedagogia fondata sull’oratoria e si cerchi di dare alla facoltà mnemonica uno scheletro più saldo e permanente. Se si riflette, si può osservare che l’importanza data dalla scolastica allo studio della logica formale è di fatto una reazione contro la «faciloneria» dimostrativa dei vecchi metodi di cultura. Gli errori di logica formale sono specialmente comuni nell’argomentazione parlata.
L’arte della stampa ha poi rivoluzionato tutto il mondo culturale, dando alla memoria un sussidio di valore inestimabile e permettendo una estensione dell’attività educatrice inaudita. In questa ricerca è pertanto implicita l’altra, delle modificazioni qualitative oltre che quantitative (estensione di massa) apportate al modo di pensare dallo sviluppo tecnico e strumentale dell’organizzazione culturale.
Anche oggi la comunicazione parlata è un mezzo di diffusione ideologica che ha una rapidità, un’area d’azione e una simultaneità emotiva enormemente più vaste della comunicazione scritta (il teatro, il cinematografo e la radio, con la diffusione di altoparlanti nelle piazze, battono tutte le forme di comunicazione scritta, dal libro, alla rivista, al giornale, al giornale murale) ma in superficie, non in profondità.
Le Accademie e le Università come organizzazioni di cultura e mezzi per diffonderla. Nelle Università la lezione orale e i lavori di seminario e di gabinetto sperimentale, la funzione del grande professore e quella dell’assistente. La funzione dell’assistente professionale e quella degli «anziani di Santa Zita» della scuola di Basilio Puoti, di cui parla il De Sanctis, cioè la formazione nella stessa classe di assistenti «volontari», avvenuta per selezione spontanea dovuta agli stessi allievi che aiutano l’insegnante e proseguono le sue lezioni, insegnando praticamente a studiare.
Alcune delle precedenti osservazioni sono state suggerite dalla lettura del Saggio popolare di sociologia, che risente appunto di tutte le deficienze della conversazione, della faciloneria argomentativa dell’oratoria, della debole struttura della logica formale. Sarebbe curioso fare su questo libro una esemplificazione di tutti gli errori logici indicati dagli scolastici, ricordando la giustissima osservazione che anche i modi del pensare sono elementi acquisiti e non innati, il cui giusto impiego (dopo l’acquisizione) corrisponde a una qualifica professionale. Non possederli, non accorgersi di ánonñ possederli, non porsi il problema di acquistarli attraverso un «tirocinio», equivale alla pretesa di costruire un’automobile sapendo impiegare e avendo a propria disposizione l’officina e gli attrezzi di un fabbro ferraio da villaggio. Lo studio della «vecchia logica formale» è ormai caduto in discredito e in parte a ragione. Ma il problema di far fare il tirocinio della logica formale come controllo della faciloneria dimostrativa dell’oratoria si ripresenta non appena si pone il problema fondamentale di creare una nuova cultura su una base sociale nuova, che non ha tradizioni come la vecchia classe degli intellettuali. Un «blocco intellettuale tradizionale» con la complessità e capillarità delle sue articolazioni riesce ad assimilare nello svolgimento organico di ogni singolo componente, l’elemento «tirocinio della logica» anche senza bisogno di un tirocinio distinto e individuato (così come i ragazzi di famiglie colte imparano a parlare «secondo grammatica» cioè imparano il tipo di lingua delle persone colte anche senza bisogno di particolari e faticosi studi grammaticali, a differenza dei ragazzi di famiglie dove si parla un dialetto o una lingua dialettizzata). Ma neanche ciò avviene senza difficoltà, attriti e perdite secche di energia.
Lo sviluppo delle scuole tecnico‑professionali in tutti i gradi post‑elementari, ha ripresentato il problema in altre forme. È da ricordare l’affermazione del prof. G. Peano, che anche nel Politecnico e nelle matematiche superiori risultano meglio preparati gli allievi provenienti dal ginnasio‑liceo in confronto a quelli provenienti dagli istituti tecnici. Questa migliore preparazione è data dal complesso insegnamento «umanistico» (storia, letteratura, filosofia) come è più ampiamente dimostrato in altre (la serie sugli «intellettuali» e il problema scolastico). Perché la matematica (lo studio della matematica) non può dare gli stessi risultati, se la matematica è così vicina alla logica formale da confondersi con essa? Alla stregua del fatto pedagogico se c’è somiglianza, c’è anche una enorme differenza. La matematica si basa essenzialmente sulla serie numerica, cioè su un’infinita serie di uguaglianze (1 = 1) che possono essere combinate in modi infiniti. La logica formale tende a far lo stesso, ma solo fino a un certo punto: la sua astrattezza si mantiene solo all’inizio dell’apprendimento, nella formulazione immediata nuda e cruda dei suoi principii, ma si attua concretamente nel discorso stesso in cui la formulazione astratta viene fatta. Gli esercizi di lingue che si fanno nel ginnasio-liceo fanno apparire dopo un certo tempo che nelle traduzioni latino‑italiane, greco‑italiane, non c’è mai identità nei termini delle lingue poste a confronto, o almeno che tale identità che pare esista agli inizi dello studio (rosa italiano = rosa latino) va sempre più complicandosi col progredire del «tirocinio», va cioè allontanandosi dallo schema matematico per giungere a un giudizio storico e di gusto, in cui le sfumature, l’espressività «unica e individualizzata» hanno la prevalenza. E non solo ciò avviene nel confronto tra due lingue, ma avviene nello studio della storia di una stessa «lingua», che fa apparire come varii semanticamente lo stesso suono‑parola attraverso il tempo e come varii la sua funzione nel periodo (cambiamenti morfologici, sintattici, semantici, oltre che fonetici).
Nota. Un’esperienza fatta per dimostrare quanto sia labile l’apprendimento fatto per via «oratoria»: dodici persone di un certo grado elevato di cultura ripetono una all’altra un fatto complesso e poi ognuna scrive ciò che ricorda del fatto sentito: le dodici versioni differiscono dalla narrazione originale (scritta per controllo) spesso in modo sbalorditivo. Questa esperienza ripetuta può servire a mostrare come occorra diffidare della memoria non educata con metodi appropriati.
Q16 §22 Sentimento religioso e intellettuali del secolo XIX (fino alla guerra mondiale). Nel 1921 l’editore Bocca di Torino raccolse in tre grossi volumi, con prefazione di D. Parodi, una serie di Confessioni e professioni di fede di Letterati, Filosofi, uomini politici, ecc., apparse precedentemente nella rivista «Coenobium», pubblicata a Lugano dal Bignami, come risposte a un quistionario sul sentimento religioso e i suoi diversi rapporti. La raccolta può essere interessante per chi vuole studiare le correnti di opinione verso la fine del secolo scorso e il principio dell’attuale tra gli intellettuali specialmente «democratici», sebbene sia difettosa per molti aspetti. Nel 1° volume sono contenute le risposte dei seguenti letterati, ecc. italiani: Angiolo Silvio Novaro, prof. Alfredo Poggi, prof. Enrico Catellani, Raffaele Ottolenghi, prof. Bernardino Varisco, Augusto Agabiti, prof. A. Renda, Vittore Marchi, direttore del giornale «Dio e Popolo», Ugo Janni, pastore valdese, A. Paolo Nunzio, Pietro Ridolfi Bolognesi, Nicola Toscano Stanziale, direttore della «Rassegna critica», dott. Giuseppe Gasco, Luigi Di Mattia, Ugo Perucci, maestro elementare, prof. Casimiro Tosini, direttore di Scuola Normale, Adolfo Artioli, prof. Giuseppe Morando, direttore della «Rivista Rosminiana», preside del Liceo Ginnasio di Voghera, prof. Alberto Friscia, Vittorio Nardi, Luigi Marrocco, pubblicista, G. B. Penne, Guido Piccardi, Renato Bruni, prof. Giuseppe Rensi.
Nel 2° volume: Francesco Del Greco, prof. direttore di Manicomio, Alessandro Bonucci, prof. d’Università, Francesco Cosentini, prof. d’Università, Luigi Pera, medico, Filippo Abignente, direttore del «Carattere», Giampiero Turati, Bruno Franchi, redattore‑capo della «Scuola Positiva di Diritto Criminale», Manfredi Siotto‑Pintor, prof. di Università, prof. Enrico Caporali, Giovanni Lanzalone, direttore della rivista «Arte e Morale», Leonardo Gatto‑Roissard, tenente degli alpini, Pietro Raveggi, pubblicista, Widar Cesarini‑Sforza, Leopoldo De Angelis, prof. Giovanni Predieri, Orazio Bacci, Giuseppe Benetti, pubblicista, prof. G. Capra‑Cordova, Costanza Palazzo, Pietro Romano, Giulio Carvaglio, Leone Luzzatto, Adolfo Faggi, prof. d’Università, Ercole Quadrelli, Carlo Francesco Gabba, senatore, prof. di Università, dott. Ernesto Lattes, pubblicista, Settimio Corti, prof. di filosofia, Bruno Villanova d’Ardenghi (Bruno Brunelli), pubblicista, Paolo Calvino, pastore evangelico, prof. Giuseppe Lipparini, prof. Oreste Ferrini, prof. Luigi Rossi Casè, prof. Antioco Zucca, Vittoria Fabrizi de’ Biani, prof. Guido Falorsi, prof. Benedetto De Luca, pubblicista, Giacomo Levi Minzi, bibliofilo (!) della Marciana, prof. Alessandro Arrò, Bice Sacchi, prof. Ferdinando Belloni‑Filippi, Nella Doria‑Cambon, prof. Romeo Manzoni.
Nel 3° volume: Romolo Murri, Giovanni Vidari, professore d’Università, Luigi Ambrosi, prof. d’Università, Salvatore Farina, Angelo Flavio Guidi, pubblicista, Conte Alessandro d’Aquino, Baldassarre Labanca, prof. di Storia del Cristianesimo all’Università, Giannino Antona‑Traversi, autore drammatico, prof. Mario Pilo, Alessandro Sacchi, prof. d’Università, Angelo De Gubernatis, prof. d’Università, Giuseppe Sergi, prof. d’Università, Adolfo Zerboglio, prof. d’Università, Vittorio Benini, prof. d’Università, Paolo Arcari, Andrea Lo Forte Randi, Arnaldo Cervesato, Giuseppe Cimbali, prof. d’Università, Alfredo Melani, architetto, Silvio Adrasto Barbi, prof., prof. Massimo Bontempelli, Achille Monti, prof. Università, Velleda Benetti, studentessa, Achille Loria, prof. Francesco Pietropaolo, prof. Amilcare Lauria, Eugenio Bermani, scrittore, Ugo Fortini del Giglio, avv. Luigi Puccio, Maria Nono‑Villari, scrittrice, Gian Pietro Lucini, Angelo Valdarmini, prof. Università, Teresina Bontempi, ispettrice degli asili d’infanzia nel Canton Ticino, Luigi Antonio Villari, Guido Podrecca, Alfredo Panzini, avv. Amedeo Massari, prof. Giuseppe Barone, Giulio Caprin, avv. Gabriele Morelli, Riccardo Gradassi Luzi, Torquato Zucchelli, tenente colonnello onorario (sic), Ricciotto Canudo, prof. Felice Momigliano, Attilio Begey, Antonino Anile, prof. Università, Enrico Morselli, professore Università, Francesco Di Gennaro, Ezio Maria Gray, Roberto Ardigò, Arturo Graf, Pio Viazzi, Innocenzo Cappa, duca Colonna Di Cesarò, Pasquale Villari, Antonio Cippico, Alessandro Groppali, prof. Università, Angelo Marzorati, Italo Pizzi, Angelo Crespi, E. A. Marescotti, F. Belloni‑Filippi, prof. Università, Francesco Porro, astronomo, prof. Fortunato Rizzi.
Un criterio metodico da tener presente nell’esaminare l’atteggiamento degli intellettuali italiani verso la religione (prima del Concordato) è dato da ciò che in Italia i rapporti tra Stato e Chiesa erano molto più complessi che negli altri paesi: essere patriotta significò essere anticlericale, anche se si era cattolici, sentire «nazionalmente» significava diffidare del Vaticano e delle sue rivendicazioni territoriali e politiche. Ricordare come il «Corriere della Sera» in una elezione parziale a Milano, prima del 1914, combatté la candidatura del marchese Cornaggia, temporalista, preferendo che fosse eletto il candidato socialista.
Q16 §23 Cavalieri azzurri (o principi azzurri), calabroni e scarafaggi stercorari. Luigi Galleani, verso il 1910, ha compilato uno zibaldone farragginoso, intitolato Faccia a faccia col nemico (edito dalle «Cronache Sovversive», negli Stati Uniti, a Chicago o a Pittsburg) in cui ha raccolto da giornali disparati, senza metodo e critica, i resoconti dei processi di una serie di così detti libertari individualisti (Ravachol, Henry, ecc.). La compilazione è da prendere con le molle, ma qualche spunto curioso può esserne tratto.
1) L’on. Abbo nel suo discorso di Livorno del gennaio 1921, ripeté letteralmente la dichiarazione di «principi» dell’individualìsta Etievant, riportata in appendice del libro galleanesco; anche la frase sulla «linguistica» che suscitò l’ilarità generale, è ripetuta alla lettera. Certamente l’on. Abbo sapeva a memoria il pezzo e ciò può servire a indicare quale fosse la cultura dei tipi come l’on. Abbo e come tale letteratura fosse diffusa e popolare.
2) Dalle dichiarazioni degli imputati risulta che uno dei motivi fondamentali delle azioni «individualìstiche» era il «diritto al benessere» concepito come un diritto naturale (per i francesi s’intende, che occupano la maggior parte del libro). Da vari imputati è ripetuta la frase che «una orgia dei signori consuma ciò che basterebbe a mille famiglie operaie»; manca ogni accenno alla produzione e ai rapporti di produzione. La dichiarazione di Etievant, riportata nel testo scritto integrale, è tipica, perché in essa si cerca di costruire un ingenuo e puerile sistema giustificativo delle azioni «individualistiche». Ma le stesse giustificazioni sono valide per tutti, per i gendarmi, per i giudici, per i giurati, per il carnefice: ogni individuo è chiuso in una rete deterministica di sensazioni, come un porco in una botte di ferro, e non può evaderne: l’individualista lancia la «marmitta», il gendarme arresta, il giudice condanna, il carnefice taglia la testa e nessuno può fare a meno di operare così. Non c’è via d’uscita, non può esserci punto di risoluzione. È un libertarismo e individualismo che per giustificare moralmente se stesso, si nega in modo pietosamente comico. L’analisi della dichiarazione di Etievant mostra come l’ondata di azioni individualistiche che si abbatté sulla Francia in un certo periodo erano la conseguenza episodica dello sconcerto morale e intellettuale che corrose la società francese dal 71 fino al dreyfusismo, nel quale trovò uno sfogo collettivo.
3) A proposito dell’Henry è riportata nel volume la lettera di un certo Galtey (da verificare) al «Figaro». Pare che l’Henry avesse amato la moglie del Galtey, reprimendo, «nel proprio seno», questo amore. La donna, saputo che l’Henry era stato innamorato di lei (pare non se ne fosse accorta) dichiarò a un giornalista che se avesse saputo, forse si sarebbe data. Il Galtey, nella lettera, tiene a dichiarare di non aver nulla da obbiettare alla moglie e argomenta: se un uomo non è riuscito a incarnare il sogno romantico della sua donna sul cavaliere (o principe) azzurro, peggio per lui: deve ammettere che un altro lo sostituisca. Questo miscuglio di principi azzurri, di razionalismo materialistico volgare e di furti nelle tombe alla Ravachol è tipico e da rilevare.
4) Nella sua dichiarazione al processo di Lione del 1894 (da verificare) il principe Kropotkin annunzia con tono di sicurezza che sbalordisce come qualmente entro i dieci anni successivi ci sarebbe stato lo sconvolgimento finale.
Q16 §24 Apologo del Cadì, del sacchetto smarrito al mercato, dei due Benedetti, dei cinque noccioli di oliva. Rifare la novellina delle Mille e una Notte.
Q16 §25 Il male minore o il meno peggio (da appaiare con l’altra formula scriteriata del «tanto peggio tanto meglio»). Si potrebbe trattare in forma di apologo (ricordare il detto popolare che «peggio non è mai morto»). Il concetto di «male minore» o di «meno peggio» è dei pìù relativi. Un male è sempre minore di uno susseguente maggiore e un pericolo è sempre minore di un altro susseguente possibile maggiore. Ogni male diventa minore in confronto di un altro che si prospetta maggiore e così all’infinito. La formula del male minore, del meno peggio, non è altro dunque che la forma che assume il processo di adattamento a un movimento storicamente regressivo, movimento di cui una forza audacemente efficiente guida lo svolgimento, mentre le forze antagonistiche (o meglio i capi di esse) sono decise a capitolare progressivamente, a piccole tappe e non di un solo colpo (ciò che avrebbe ben altro significato, per l’effetto psicologico condensato, e potrebbe far nascere una forza concorrente attiva a quella che passivamente si adatta alla «fatalità», o rafforzarla se già esiste). Poiché è giusto il principio metodico che i paesi pìù avanzati (nel movimento progressivo o regressivo) sono l’immagine anticipata degli altri paesi dove lo stesso svolgimento è agli inizi, la comparazione è corretta in questo campo, per ciò che può servire (servirà però sempre dal punto di vista educativo).
Q16 §26 Il movimento e il fine. È possibile mantenere vivo ed efficiente un movimento senza la prospettiva di fini immediati e mediati? L’affermazione del Bernstein secondo cui il movimento è tutto e il fine è nulla, sotto l’apparenza di una interpretazione «ortodossa» della dialettica, nasconde una concezione meccanicistica della vita e del movimento storico: le forze umane sono considerate come passive e non consapevoli, come un elemento non dissimile dalle cose materiali, e il concetto di evoluzione volgare, nel senso naturalistico, viene sostituito al concetto di svolgimento e di sviluppo. Ciò è tanto più interessante da notare in quanto il Bernstein ha preso le sue armi nell’arsenale del revisionismo idealistico (dimenticando le glosse su Feuerbach) che avrebbe dovuto portarlo invece a valutare l’intervento degli uomini (attivi, e quindi perseguenti certi fini immediati e mediati) come decisivo nello svolgimento storico (s’intende, nelle condizioni date). Ma se si analizza più a fondo, si vede che nel Bernstein e nei suoi seguaci, l’intervento umano non è escluso del tutto, almeno implicitamente (ciò che sarebbe troppo scemo) ma è ammesso solo in modo unilaterale, perché è ammesso come «tesi», ma è escluso come «antitesi»; esso, ritenuto efficiente come tesi, ossia nel momento della resistenza e della conservazione, è rigettato come antitesi, ossia come iniziativa e spinta progressiva antagonista. Possono esistere «fini» per la resistenza e la conservazìone (le stesse «resistenza e conservazione» sono fini che domandano una organizzazione speciale civile e militare, il controllo attivo dell’avversario, l’intervento tempestivo per impedire che l’avversario si rafforzi troppo, ecc.), non per il progresso e l’iniziativa innovatrice. Non si tratta di altro che di una sofistica teorizzazione della passività, di un modo «astuto» (nel senso delle «astuzie della provvidenza» vichiane) con cui la «tesi» interviene per debilitare l’«antitesi», poiché proprio l’antitesi (che presuppone il risveglio di forze latenti e addormentate da spronare arditamente) ha bisogno di prospettarsi dei fini, immediati e mediati, per rafforzare il suo movimento superatore. Senza la prospettiva di fini concreti, non può esistere movimento del tutto.
Q16 §27 Max Nordau. Grande diffusione dei libri di Max Nordau in Italia, negli strati più colti del popolo e della piccola borghesia urbana. Le menzogne convenzionalidella nostra civiltà e Degenerazione erano giunte (nel 1921‑1923) rispettivamente all’ottava e alla quinta edizione, nella pubblicazione regolare dei Fratelli Bocca di Torino; ma questi libri passarono nel dopoguerra nelle mani degli editori tipo Madella e Barion e furono lanciati dai venditori ambulanti a prezzi bassissimi in quantità molto notevole. Hanno così contribuito a introdurre nell’ideologia popolare (senso comune) una certa serie di credenze e di «canoni critici» o pregiudizi che appaiono come la più squisita espressione dell’intellettualità raffinata e dell’alta cultura, così come esse vengono concepite dal popolo, per il quale Max Nordau è un grande pensatore e scienziato.
Cfr Quaderno 9 (XIV), p. 15.
Q16 §28 Angherie. Il termine è ancora impiegato in Sicilia per indicare certe prestazioni obbligatorie alle quali è tenuto il lavoratore agricolo nei suoi rapporti contrattuali col proprietario o gabellotto o subaffittuario da cui ha ottenuto una terra a così detta mezzadria (e che non è altro che un contratto di partecipazione o di semplice affitto con pagamento in natura, fissato nella metà, o anche più, del raccolto, oltre le prestazioni speciali o «angherie»). Il termine è ancora quello dei tempi feudali, da cui è derivato nel linguaggìo comune il significato deteriore di «vessazione», che però non sembra abbia ancora in Sicilia, dove è ritenuto normale costume,
Per ciò che riguarda la Toscana, culla della mezzadria (cfr gli studi recenti in proposito fatti per impulso dell’Accademia dei Georgofili), è da citare il brano di un articolo di F. Guicciardini (nella Nuova Antologia del 16 aprile 1907: Le recenti agitazioni agrarie in Toscana e i doveri della proprietà): «Fra i patti accessori del patto colonico, non accenno ai patti che chiamerò angarici, in quanto costituiscono oneri del colono, che non hanno per corrispettivo alcun vantaggio speciale: tali sarebbero i bucati gratuiti, la tiratura dell’acqua, la segatura di legna e fascinotti per le stufe del padrone, il contributo in grasce a favore del guardiano, la somministrazione di paglia e fieno per la scuderiadi fattoria e in generale tutte le somministrazioni gratuite in favore del padrone. Io non potrei affermare se questi patti siano ultimi resti del regime feudale sopravvissuti alla distruzione dei castelli e alla liberazione dei coloni, oppure se siano incrostazioni formatesi per abuso dei padroni e ignavia dei coloni, in tempi più vicini a noi sul tronco genuino del contratto». Secondo il Guicciardini, queste prestazioni sono sparite pressoché ovunque (nel 1907), il che è dubbio anche per la Toscana. Ma oltre a queste angherie, occorre ricordarne altre, come il diritto del padrone di chiudere i coloni in casa a una certa ora della sera, l’obbligo di domandare il permesso per fidanzarsi e fare all’amore, ecc., che pare siano stati ristabiliti in molte regioni (Toscana, Umbria) dopo che erano stati aboliti in seguito ai moti agrari del primo decennio del secolo, moti diretti dai sindacalisti.
Q16 §29 Discussioni prolisse, spaccare il pelo in quattro, ecc. È atteggiamento da intellettuale quello di prendere a noia le discussioni troppo lunghe, che si sbriciolano analiticamente nei più minuti particolari e non vogliono finire se non quando tra i disputanti si è giunti a un accordo perfetto su tutto il piano di attrito o per lo meno le opinioni in contrasto si sono affrontate totalmente. L’intellettuale professionale crede sufficiente un accordo sommario sui principii generali, sulle linee direttrici fondamentali, perché presuppone che il lavorio individuale di riflessione porterà necessariamente all’accordo sulle «minuzie»; perciò nelle discussioni tra intellettuali si procede spesso per rapidi accenni: si tasta, per così dire, la formazione culturale reciproca, il «linguaggio» reciproco, e fatta la constatazione che ci si trova su un terreno comune, con un comune linguaggio, con modi comuni di ragionare, si procede oltre speditamente. Ma la quistione essenziale consiste appunto in ciò, che le discussìoni non avvengono tra intellettuali professionali, ma anzi occorre creare preventivamente un terreno comune culturale, un comune linguaggio, modi comuni di ragionare tra persone che non sono intellettuali professionali, che non hanno ancora acquisito l’abito e la disciplina mentale necessari per connettere rapidamente concetti apparentemente disparati, come viceversa per analizzare rapidamente, scomporre, intuire, scoprire differenze essenziali tra concetti apparentemente simili.
È stato già accennato, in altro paragrafo, alla intima debolezza della formazione parlata della cultura e agli inconvenienti della conversazione o dialogo rispetto allo scritto: tuttavia quelle osservazioni, giuste in sé, devono essere integrate con queste su esposte, cioè con la coscienza della necessità, per diffondere organicamente una nuova forma culturale, della parola parlata, della discussione minuziosa e «pedantesca». Giusto contemperamento della parola parlata e di quella scritta. Tutto ciò si osservi nei rapporti tra intellettuali professionali e non intellettuali formati, che poi è il caso di ogni grado di scuola, dall’elementare all’universitaria.
Il non tecnico del lavoro intellettuale, nel suo lavoro «personale» sui libri, intoppa in difficoltà che lo arrestano e spesso gli impediscono di andare oltre, perché egli è incapace di risolverle subito, ciò che invece è possibile nelle discussioni a voce immediatamente. Si osserva, a parte la malafede, come si dilunghino le discussioni per iscritto per questa ragione normale: che una incomprensione domanda dilucidazioni e nel corso della polemica si moltiplicano le difficoltà di capirsi e di doversi spiegare.
Q16 §30 Tempo. In molte lingue straniere la parola «Tempo», introdotta dall’italiano attraverso il linguaggio musicale, ha assunto un significato proprio, generale ma non perciò meno determinato, che la parola italiana «Tempo» per la sua genericità non può esprimere (né si potrebbe dire «tempo in senso musicale o come s’intende nel linguaggio musicale» perché darebbe luogo a equivoci). Occorre pertanto tradurre in italiano la parola italiana «Tempo»: «velocità del ritmo» pare sia la traduzione più esatta, e che del resto corrisponde al significato che la parola ha nella musica, e solamente «ritmo» quando la parola «Tempo» è aggettivata: «ritmo accelerato» (o tempo accelerato), «ritmo rallentato», ecc. Altre volte «velocità del ritmo» è usata in senso ellittico per «misura della velocità del ritmo».
QUADERNO 17
MISCELLANEA
Q17 §1 Umanesimo e Rinascimento. Cosa significa che il
Rinascimento abbia scoperto «l’uomo», abbia fatto dell’uomo il
centro dell’universo ecc. ecc.? Forse che prima del Rinascimento
l’«uomo» non era il centro dell’universo ecc.? Si potrà dire che
il Rinascimento ha creato una nuova cultura o civiltà in
opposizione a quelle precedenti o che sviluppano quelle
precedenti, ma occorre «limitare» ossia «precisare» in che
questa cultura consista ecc. Davvero che prima del Rinascimento
l’«uomo» era nulla ed è diventato tutto? o si è sviluppato un
processo di formazione culturale in cui l’uomo tende a diventare
tutto? Pare si debba dire che prima del Rinascimento il
trascendente formasse la base della cultura medioevale, ma
quelli che rappresentavano questa cultura erano forse «nulla»
oppure quella cultura non era il modo di essere «tutto» per
loro? Se il Rinascimento è una grande rivoluzione culturale, non
è perché dal «nulla» tutti gli uomini abbiano cominciato a
pensare di essere «tutto», ma perché questo modo di pensare si è
diffuso, è diventato un fermento universale ecc. Non è stato
«scoperto» l’uomo, ma è stata iniziata una nuova forma di
cultura, cioè di sforzo per creare un nuovo tipo di uomo nelle
classi dominanti.
Q17 §2 Passato e presente. Una definizione inglese della civiltà: «La civiltà è stata definita un sistema di controllo e di direzione che sviluppa nel modo più rigogliosamente economico la massima potenzialità di un popolo». La traduzione non pare esatta: «rigogliosamente economico» cosa significa? La definizione nel complesso dice poco perché è troppo generica. A «civiltà» può sostituirsi «regime politico», «governo», con un significato più preciso.
Q17 §3 Umanesimo e Rinascimento. Da una recensione («Nuova Antologia» del 1° agosto 1933) di Arminio Janner del libro: Ernst Walser, Gesammelte Studien zur Geistesgeschichte der Renaissance (ed. Benno Schwabe, Basilea, 1932). Secondo lo Janner l’idea che noi ci facciamo del Rinascimento è sopratutto determinata da due opere capitali: La civiltà del Rinascimento di Jacopo Burckhardt e la Storia della Letteratura Italiana del De Sanctis. Il libro del Burckhardt fu interpretato diversamente in Italia e fuori d’Italia. Uscito nel 1860 ebbe risonanza europea, influenzò le idee del Nietzsche sul superuomo e per questa via suscitò tutta una letteratura, specialmente nei paesi nordici, su artisti e condottieri del Rinascimento, letteratura in cui si proclama il diritto alla vita bella ed eroica, alla libera espansione della personalità senza riguardi a vincoli morali.
Il Rinascimento si riassume così in Sigismondo Malatesta, Cesare Borgia, Leone X, l’Aretino, con Machiavelli come teorico e a parte, solitario, Michelangelo. In Italia D’Annunzio rappresenta questa interpretazione del Rinascimento. Il libro del Burckhardt (tradotto dal Valbusa nel 1877) ebbe in Italia influenza diversa: la traduzione italiana metteva più in luce le tendenze anticuriali che il Burckhardt vide nel Rinascimento e che coincidevano con le tendenze della politica e della cultura italiana del Risorgimento. Anche l’altro elemento messo in luce dal Burckhardt nel Rinascimento, quello dell’individualismo e della formazione della mentalità moderna, fu in Italia visto come opposizione al mondo medioevale rappresentato dal papato. In Italia fu meno notata l’ammirazione per una vita energetica e di pura bellezza; i condottieri, gli avventurieri, gli immoralisti trovarono in Italia meno attenzione. (Queste osservazioni pare siano da tenere in conto: c’è una interpretazione del Rinascimento e della vita moderna che viene attribuita all’Italia come se fosse nata originariamente e nei fatti in Italia ma non è che l’interpretazione di un libro tedesco sull’Italia ecc.).
Il De Sanctis accentua nel Rinascimento i colori oscuri della corruzione politica e morale; nonostante tutti i meriti che si possono riconoscere al Rinascimento, esso disfece l’Italia e la condusse serva dello straniero.
Insomma, il Burckhardt vede il Rinascimento come punto di partenza di una nuova epoca della civiltà europea, progressiva, culla dell’uomo moderno: il De Sanctis dal punto di vista della storia italiana, e per l’Italia il Rinascimento fu il punto di partenza di un regresso ecc. Il Burckhardt e il De Sanctis però coincidono nei particolari dell’analisi del Rinascimento, sono d’accordo nel rilevare come elementi caratteristici il formarsi della nuova mentalità, il distacco da tutti i legami medioevali di fronte alla religione, all’autorità, alla patria, alla famiglia. (Queste osservazioni dello Janner sul Burckhardt e il De Sanctis sono da rivedere). Secondo lo Janner «negli ultimi dieci o quindici anni s’è però andata man mano formando una controcorrente di studiosi, per lo più cattolici, che contestano la realtà di questi (fatti risaltare dal Burckhardt e dal De Sanctis) caratteri del Rinascimento e tentano di farne risaltare altri in gran parte opposti. In Italia l’Olgiati, il Zabughin, il Toffanin, nei paesi tedeschi il Pastor, nei primi volumi della Storia dei Papi e il Walser». Del Walser è uno studio sulla religiosità del
Pulci (Lebens und Glaubensprobleme aus dem Zeitalter der Renaissance, in «Die Neueren Sprachen», 10° Beiheft). Egli (riprendendo gli studi del Volpi e di altri) analizza il tipo di eresia del Pulci e le vicende dell’abiura che ne dovette fare più tardi; ne mostra «in modo assai convincente» l’origine (averroismo e sette mistiche giudaiche) e mostra che nel Pulci non si tratta solo di stacco dai sentimenti religiosi ortodossi, ma di una sua nuova fede (intessuta di magia e di spiritismo) che più tardi si risolve in una larga comprensione e tolleranza di tutte le fedi. (È da vedere se lo spiritismo e la magia non sono necessariamente la forma che doveva prendere il naturalismo e il materialismo di quell’epoca, cioè la reazione al trascendente cattolico o la prima forma di immanenza primitiva e rozza). Nel volume che lo Janner recensisce, pare che tre studi specialmente interessino, in quanto illustrano la nuova interpretazione: «Il Cristianesimo e l’antichità nella concezione del primo Rinascimento italiano», «Studi sul pensiero del Rinascimento» e «Problemi umani e artistici del Rinascimento italiano».
Secondo il Walser l’affermazione del Burckhardt che il Rinascimento sia stato paganeggiante, critico, anticuriale e irreligioso non è esatta. Gli umanisti della prima generazione come Petrarca, Boccaccio, il Salutati, di fronte alla chiesa non si staccano dall’atteggiamento degli studiosi medioevali. Gli umanisti del Quattrocento, Poggio, il Valla, il Beccadelli sono più critici e indipendenti, ma di fronte alla verità rivelata tacciono anch’essi e accettano. In questa affermazione il Walser è d’accordo col Toffanin che nel suo libro Che cosa fu l’umanesimo? afferma che l’umanesimo, col suo culto della latinità e della romanità, fu assai più ortodosso che non la letteratura dotta in volgare del Duecento e Trecento. (Affermazione che può essere accettata, se si distingue nel moto del Rinascimento il distacco avvenuto con l’Umanesimo dalla vita nazionale che andò formandosi dopo il Mille, se si considera l’Umanesimo come un processo progressivo per le classi colte «cosmopolitiche» ma regressivo dal punto di vista della storia italiana).
(Il Rinascimento può essere considerato come l’espressione culturale di un processo storico nel quale si costituisce in Italia una nuova classe intellettuale di portata europea, classe che si divise in due rami: uno esercitò in Italia una funzione cosmopolitica, collegata al papato e di carattere reazionario, l’altro si formò all’estero, coi fuorusciti politici e religiosi, ed esercitò una funzione cosmopolita progressiva nei diversi paesi in cui si stabilì o partecipò all’organizzazione degli Stati moderni come elemento tecnico nella milizia, nella politica, nell’ingegneria ecc.).
Q17 §4 Passato e presente. Sarebbe interessante un confronto tra le concezioni monarchiche militanti proprie dell’Italia meridionale e di quella settentrionale. Per il Mezzogiorno si può risalire allo scritto di C. De Meis sul Sovrano, fino al saggio di Gino Doria pubblicato nella «Nuova Italia» qualche anno fa. Per il Settentrione le teoriche di Giuseppe Brunati, dei giornali «Il Sabaudo» e «La Monarchia». È certo che solo per l’Italia meridionale si può parlare di una ortodossia assoluta e conseguente. Nel Settentrione l’istituto della monarchia è sempre stato connesso a una ideologia generale di cui la monarchia dovrebbe essere lo strumento. In questo senso il monarchismo settentrionale può riallacciarsi al Gioberti.
Q17 §5 Argomenti di cultura. Risorgimento e Rinnovamento nel Gioberti. È da vedere la distinzione che il Gioberti fa tra Risorgimento e Rinnovamento, tra la situazione prima del 48 e dopo il 48, sia interna – rapporti tra i vari Stati italiani e le classi sociali italiane – sia internazionale, della posizione dell’Italia nel complesso dei rapporti tra gli Stati europei e le forze politiche di questi Stati.
Q17 §6 Introduzione allo studio della filosofia. In Tertulliano (De Anima, 16) si trova l’affermazione che «Il naturale è razionale» e viceversa, ciò che può essere connesso con la proposizione di Hegel: «Ciò che è reale è razionale ecc.». La proposizione di Tertulliano è riportata e commentata dal Gioberti (Rinnovamento civile, Parte II, cap. 1, p. 227 della riduzione fattane da P. A. Menzio e stampata dal Vallecchi).
È da pensare che il Gioberti abbia ricorso a Tertulliano per non ricorrere a Hegel e perciò appunto è da vedere ciò che precisamente Tertulliano vuol dire e se il Gioberti non l’abbia sforzato in senso hegeliano per non ricorrere ad Hegel per un concetto che gli era necessario.
Q17 §7 Machiavelli. La funzione degli intellettuali. Sulla funzione degli intellettuali nello sviluppo della vita politica, sui rapporti del popolo e degli intellettuali è da vedere ciò che scrive il Gioberti specialmente nel Rinnovamento. Il Gioberti non adopera il termine «intellettuali» ma parla dell’«ingegno». È da notare che il Gioberti distingue la democrazia dalla demagogia appunto dalla funzione che nella democrazia ha l’«ingegno».
Q17 §8 Umanesimo e Rinascimento (continuazione della nota riassuntiva che s’inizia alla prima pagina). (In ogni caso occorre distinguere le facezie contro il clero che sono tradizionali fin dal Trecento, dalle opinioni più o meno ortodosse sulla concezione religiosa della vita).
Il Walser, che visse a lungo in Italia, osserva che per comprendere il carattere del Rinascimento italiano è utile, in certi limiti, conoscere la psicologia degli italiani moderni. Osservazione che mi pare molto acuta, specialmente per quanto riguarda l’atteggiamento verso la religione e che pone il problema di ciò che sia lo spirito religioso in Italia modernamente, e se esso possa essere paragonato non dico allo spirito religioso dei protestanti, ma anche a quello di altri paesi cattolici, specialmente della Francia. Che la religiosità degli italiani sia molto superficiale è innegabile così come è innegabile che essa ha un carattere strettamente politico, di egemonia internazionale. A questa forma di religiosità è legato il Primato del Gioberti, che a sua volta contribuì a rassodare e sistemare ciò che esisteva già prima allo stato diffuso. Non bisogna dimenticare che dal Cinquecento in poi l’Italia contribuì alla storia mondiale specialmente perché sede del Papato e che il cattolicismo italiano era sentito come un surrogato dello spirito di nazionalità e statale, non solo, ma addirittura come una funzione egemonica mondiale, cioè come spirito imperialistico. Così è giusta l’osservazione che lo spirito anticuriale è una forma di lotta contro ceti privilegiati; e non si può negare che in Italia i ceti religiosi avessero una funzione (posizione) economica e politica molto più radicale che negli altri paesi, dove la formazione nazionale limitava la funzione ecclesiastica. L’anticurialismo degli intellettuali laici, le «facezie» anticlericali ecc. sono anche una forma di lotta tra intellettuali laici e intellettuali religiosi data la prevalenza che questi ultimi avevano.
Se lo scetticismo e il paganesimo degli intellettuali sonoin gran parte mere apparenze superficiali e possono allearsi a un certo spirito religioso, anche nel popolo (cfr il libro di Domenico Guerri sulle Correnti popolari nel Rinascimento) le manifestazioni licenziose (carri e canti carnascialeschi) che al Walser sembrano più gravi, possono spiegarsi allo stesso modo.
Come gli italiani di oggi quelli del Rinascimento, dice il Walser, sapevano «sviluppare separatamente e contemporaneamente i due fattori dell’umana capacità di comprensione, il razionale e il mistico, e in modo che il razionalismo condotto fino all’assoluto scetticismo, per un invisibile legame, inconcepibile all’uomo nordico, si riallaccia in modo saldo al più primitivo misticismo, al più cieco fatalismo, al feticismo e alla crassa superstizione». Queste sarebbero le più importanti correzioni che il Walser porta alla concezione del Rinascimento, propria del Burckhardt e del De Sanctis. Scrive lo Janner, che il Walser non riesce a distinguere l’Umanesimo dal Rinascimento, e che se forse senza l’Umanesimo non ci sarebbe stato il Rinascimento, questo però supera per importanza e per le conseguenze l’Umanesimo.
Anche questa distinzione deve essere più sottile e profonda: pare più giusta l’opinione che il Rinascimento è un movimento di grande portata, che si inizia dopo il Mille, di cui l’Umanesimo e il Rinascimento (in senso stretto) sono due momenti conclusivi, che hanno avuto in Italia la sede principale, mentre il processo storico più generale è europeo e non solo italiano. (L’Umanesimo e il Rinascimento come espressione letteraria di questo movimento storico europeo hanno avuto in Italia la sede principale, ma il movimento progressivo dopo il Mille, se ha avuto in Italia gran parte coi Comuni, proprio in Italia è decaduto e proprio coll’Umanesimo e il Rinascimento che in Italia sono stati regressivi, mentre nel resto d’Europa il movimento generale culminò negli Stati nazionali e poi nell’espansione mondiale della Spagna, della Francia, dell’Inghilterra, del Portogallo. In Italia, agli Stati nazionali di questi paesi, ha corrisposto l’organizzazione del Papato come Stato assoluto – iniziato da Alessandro VI – organizzazione che ha disgregato il resto d’Italia ecc.). Il Machiavelli è rappresentante in Italia della comprensione che il Rinascimento non può esser tale senza la fondazione di uno Stato nazionale, ma come uomo egli è il teorico di ciò che avviene fuori d’Italia, non di eventi italiani.
Q17 §9 Argomenti di cultura. Gioberti e il giacobinismo. Atteggiamento del Gioberti verso il giacobinismo prima e dopo il 48. Dopo il 48, nel Rinnovamento, non solo non c’è accenno al panico che il 93 aveva diffuso nella prima metà del secolo, ma anzi il Gioberti mostra chiaramente di avere simpatie per i giacobini (egli giustifica lo sterminio dei girondini e la lotta su due fronti dei giacobini: contro gli stranieri invasori e contro i reazionari interni, anche se, molto temperatamente, accenna ai metodi giacobini che potevano essere più dolci ecc.). Questo atteggiamento del Gioberti verso il giacobinismo francese dopo il 48 è da notare come fatto culturale molto importante: si giustifica con gli eccessi della reazione dopo il 48, che portavano a comprendere meglio e a giustificare la selvaggia energia del giacobinismo francese.
Ma oltre a questo tratto è da notare che nel Rinnovamento il Gioberti si manifesta un vero e proprio giacobino, almeno teoricamente, e nella situazione data italiana. Gli elementi di questo giacobinismo possono a grandi tratti così riassumersi: 1) Nell’affermazione dell’egemonia politica e militare del Piemonte che dovrebbe, come regione, essere quello che Parigi fu per la Francia: questo punto è molto interessante ed è da studiare nel Gioberti anche prima del 48. Il Gioberti sentì l’assenza in Italia di un centro popolare di movimento nazionale rivoluzionario come fu Parigi per la Francia e questa comprensione mostra il realismo politico del Gioberti. Prima del 48, Piemonte‑Roma dovevano essere i centri propulsori, per la politica‑milizia il primo, per l’ideologia‑religione la seconda. Dopo il 48, Roma non ha la stessa importanza, anzi: il Gioberti dice che il movimento deve essere contro il Papato. 2) Il Gioberti, sia pure vagamente, ha il concetto del «popolare‑nazionale» giacobino, dell’egemonia politica, cioè dell’alleanza tra borghesi‑intellettuali ingegno e il popolo; ciò in economia (e le idee del Gioberti in economia sono vaghe ma interessanti) e nella letteratura (cultura), in cui le idee sono più distinte e concrete perché in questo campo c’è meno da compromettersi. Nel Rinnovamento (Parte II, capitolo «Degli scrittori») scrive: «… Una letteratura non può essere nazionale se non è popolare; perché, se bene sia di pochi il crearla, universale dee esserne l’uso e il godimento. Oltre che, dovendo ella esprimere le idee e gli affetti comuni e trarre in luce quei sensi che giacciono occulti e confusi nel cuore delle moltitudini, i suoi cultori debbono non solo mirare al bene del popolo ma ritrarre del suo spirito; tanto che questo viene ad essere non solo il fine ma in un certo modo eziandio il principio delle lettere civili. E vedesi col fatto che esse non salgono al colmo della perfezione e dell’efficacia se non quando s’incorporano e fanno, come dire, una cosa colla nazione, ecc.».
In ogni modo che l’assenza di un «giacobinismo italiano» fosse sentita, appare dal Gioberti. E il Gioberti è da studiare da questo punto di vista. Ancora: è da notare come il Gioberti, sia nel Primato che nel Rinnovamento si mostri uno stratega del movimento nazionale e non solamente un tattico. Il suo realismo lo porta ai compromessi, ma sempre nella cerchia del piano strategico generale. La debolezza del Gioberti, come uomo di Stato, è da cercare nel fatto che egli fu sempre esule, non conosceva quindi gli uomini che doveva maneggiare e dirigere e non aveva amici fedeli (cioè un partito): quanto più egli fu stratega, tanto più doveva appoggiarsi su forze reali e queste non conosceva e non poteva dominare e dirigere. (Per il concetto di letteratura nazionale‑popolare bisogna studiare il Gioberti e il suo romanticismo temperato). Così occorre studiare il Gioberti per analizzare quello che in altre è indicato come «nodo storico del 48‑49» e il Risorgimento in generale, ma il punto culturale più importante mi pare sia questo di «Gioberti giacobino», giacobino teorico, s’intende, perché in pratica egli non ebbe modo di applicare le sue dottrine.
Q17 §10 Argomenti di cultura. Le discussioni sulla guerra futura. Guerra totale, importanza dell’aviazione, delle piccole armate professionali in confronto ai grandi eserciti di leva ecc. Questi argomenti sono importanti in sé e per sé e meritevoli di studio e di considerazione. La letteratura in proposito deve essere ormai imponente in tutti i paesi (vedo citato un volume: Rocco Morretta, Come sarà la guerra di domani?, Milano, Casa Ed. G. Agnelli, 1932, pp. 368, L. 18). Ma c’è un aspetto della quistione che pare anch’esso degno di considerazione: tutte queste dispute sulla guerra futura ipotetica sono il terreno di una «guerra» reale attuale: le vecchie strutture militari (stati maggiori ecc .) sono modificate per l’intervento, nell’equilibrio tra le vecchie armi, dell’aviazione e dei suoi ufficiali. Si sa che le vecchie strutture militari rappresentavano una determinata politica conservativa‑reazionaria di vecchio stile, difficile da vincere e da eliminare. Per parecchi governi attuali, l’aviazione, le discussioni sull’importanza dell’aviazione, sul modo come devono essere stabiliti i piani strategici di una guerra futura ecc., sono l’occasione per eliminare molecolarmente le vecchie personalità militari, legate a un vecchio costume politico e che potrebbero organizzare dei colpi di Stato ecc. Perciò l’importanza dell’aviazione è duplice: tecnico‑militare e politico‑immediata.
Q17 §11 Risorgimento italiano. Cfr il saggio di Gioacchino Volpe: Italia ed Europa durante il Risorgimento, nella «Nuova Antologia» del 16 agosto 1933. È un abbozzo molto «descrittivo» della politica internazionale europea nei riflessi con la situazione italiana. Utile come catalogo di fatti, ma senza studio e approfondimento dei nessi storici. Storia del tipo Rinaudo. Che l’equilibrio europeo sia stato un elemento del processo storico italiano e viceversa è appena accennato, ma quale nesso generale tra le due serie di eventi, tra i due processi? E si trattò di «due» processi o di uno solo? E se si trattò di un solo processo storico, quale peso dare all’iniziativa o alla passività italiana ecc.? (È da richiamare il libro di Omodeo L’età del Risorgimento che fin dal titolo, o almeno nel titolo, falsifica il giudizio storico e l’opera del Croce Storia d’Europa che ponendo un solo processo storico europeo, esalta la passività e tien conto solo di essa, in quanto tralascia il periodo storico «militante» ecc.). In ogni modo, lo studio del Volpe è utile perché riassume, «descrittivamente» sia pure, la situazione politica internazionale che condizionò il Risorgimento italiano.
Q17 §12 Argomenti di cultura. Filosofia della prassi ed «economismo storico». Confusione tra i due concetti. Tuttavia è da porre il problema: quale importanza ha da attribuirsi all’«economismo» nello sviluppo dei metodi di ricerca storiografica, ammesso che l’economismo non può essere confuso con la filosofia della prassi? Che un gruppo di finanzieri, che hanno interessi in un paese determinato possano guidare la politica di questo paese, attirarvi la guerra o allontanarla da esso, è indubitabile: ma l’accertamento di questo l’atto non è «filosofia della prassi», è «economismo storico» cioè è l’affermazione che «immediatamente», come «occasione», i fatti sono stati influenzati da determinati interessi di gruppo ecc. Che «l’odore del petrolio» possa attirar dei guai seri su un paese è anche certo, ecc., ecc. Ma queste affermazioni, controllate, dimostrate ecc., non sono ancora filosofia della prassi, anzi possono essere accettate e fatte da chi respinge in toto la filosofia della prassi. Si può dire che il fattore economico (inteso nel senso immediato e giudaico dell’economismo storico) non è che uno dei tanti modi con cui si presenta il più profondo processo storico (fattore di razza, religione ecc.) ma è questo più profondo processo che la filosofia della prassi vuole spiegare ed appunto perciò è una filosofia, una «antropologia», e non un semplice canone di ricerca storica.
Q17 §13 I nipotini delpadre Bresciani. G. Papini. Nell’«Italia Letteraria» del 27 agosto 1933 Luigi Volpicelli così scrive di Papini (incidentalmente, in un saggio su Problemi della letteratura d’oggi, uscito in varie puntate): «Non basta a cinquant’anni – voglia perdonare Papini la mia franchezza – non basta dire: lo scrittore dev’essere maestro, occorre poter dire almeno: ecco qui, gente ruffiana, l’arte vera, l’arte maestra. Ma limitarsi a proporre, nel cinquantesimo anno di età, o giù di lì, lo scrittore come maestro, quando maestri non si è mai stati, non vale nemmeno da mea culpa. E già, siamo alle solite, infatti! Papini ha esercitato tutti i mestieri, per poi sporcificarli tutti: il filosofo, per concludere che la filosofia è una specie di cancrena al cervelletto, il cattolico, per incenerare l’universo con un appropriato dizionario, il letterato, per sancir da ultimo che della letteratura non sappiamo che farcene. Ciò non toglie che Papini non si sia conquistato un posticino nella storia della letteratura dentro il capitolo i “polemisti”. Ma la polemica vale l’oratoria: è proprio la forma pura e vuota, è mero amor di parola e di tecnica, di gesto, un calligrafismo spirituale e congenito; insomma, la cosa più lontana possibile dallo scrittore come maestro».
Papini è sempre stato un «polemista» nel senso che dice il Volpicelli, e lo è ancor oggi, poiché non si sa se nell’espressione «polemista cattolico» a Papini interessi più il sostantivo o l’aggettivo. Col suo «cattolicismo» Papini avrebbe voluto dimostrare di non essere un puro «polemista», cioè un «calligrafo», un funambolo della parola e della tecnica, ma non c’è riuscito! Il Volpicelli ha torto nel non precisare: il polemista è polemista di una concezione del mondo, sia pure il mondo di Pulcinella, ma Papini è il polemista «puro», il boxeur di professione della parola qualsiasi: Volpicelli avrebbe dovuto giungere esplicitamente all’affermazione che il cattolicismo in Papini è un vestito da clown, non la «pelle» formata dal suo sangue «rinnovato», ecc.
Q17 §14 Argomenti di cultura. Discussioni sulla guerra futura (cfr la nota a p. 4 bis). Vedere l’articolo del generale Orlando Freri (L’agguerrimento delle nuove generazioni, nella «Gerarchia» dell’agosto 1933) che è interessante tanto più in quanto è stato pubblicato quasi simultaneamente alle dimissioni del generale Gazzera dal ministero della guerra e alla crociera Balbo in stormo da Roma a Chicago. L’articolo del Freri pone la quistione del «piccolo esercito» di pace come esercito di «graduati e specialisti» da crearsi in relazione allo svolgimento della Milizia Volontaria e per ragioni di bilancio (cioè in rapporto alle necessità moderne di un attrezzamento meccanico vasto e costoso che non può essere soddisfatto con un esercito di pace numeroso, ecc.).
Q17 §15 Umanesimo e Rinascimento. Le opere complete del Machiavelli furono stampate per l’ultima volta in Italia nel 1554, e nel 1557 il Decamerone integro: l’editore Giolito dopo il 1560 cessò di stampare anche il Petrarca. Da allora cominciano le edizioni castrate dei poeti, dei novellieri, dei romanzieri. La censura ecclesiastica infastidisce anche i pittori.
Il Pastor nella Storia dei Papi scrive: «Può essere che nei paesi cattolici il divieto generale di scritti in difesa del nuovo sistema terrestre (copernicano) ammorzasse la predilezione per l’astronomia; però in Francia i gallicani, riferendosi alla libertà della chiesa francese, non considerarono come obbligatorii i decreti dell’Indice e dell’Inquisizione e se in Italia non sorse un secondo Galilei o un Newton o un Bradley, difficilmente la colpa è da attribuire al decreto contro Copernico». Il Bruers nota però che i rigori dell’Indice suscitarono tra gli scienziati un panico spaventoso e che lo stesso Galilei nei 26 anni decorsi dal primo processo alla morte non poté liberamente approfondire e far studiare ai suoi discepoli la quistione copernicana.
Dallo stesso Pastor appare che specialmente in Italia la reazione culturale fu efficiente. I grandi editori deperiscono in Italia: Venezia resiste di più, ma infine gli autori italiani e le opere italiane (del Bruno, del Campanella, del Vanini, del Galilei) sono stampate integralmente solo in Germania, in Francia, in Olanda. Con la reazione ecclesiastica che culmina nella condanna di Galileo finisce in Italia il Rinascimento anche fra gli intellettuali.
Q17 §16 I nipotini di padre Bresciani. G. Papini. È da vedere la conferenza Carducci, alma sdegnosa, tenuta dal Papini a Forlì per l’inaugurazione della «Settimana romagnola di poesia» e pubblicata nella Nuova Antologia del 1° Settembre 1933. La falsità, l’insincerità istrionica di questa conferenza è tale da cavar gli occhi.
Sarebbe interessante, oltre che per il Papini, fare una ricerca dell’avversione contro Roma che fu di moda in Italia fino al 1919 nel movimento vociano e futurista. Discorso del Papini Contro Roma e B. Croce; del binomio odioso per il Papini del 1913 è rimasto odioso Benedetto Croce. Da confrontare l’atteggiamento verso il Croce apertamente triviale di questo discorso sul Carducci e quello untuosamente gesuitico e cristianuccio del saggio Il Croce e la Croce.
Q17 §17 Argomenti di cultura. Titolo esatto del Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco (Firenze, Le Monnier, 1881, pp. 1287).
Q17 §18 Introduzione allo studio della filosofia. Senso comune. I. I cattolici (gesuiti) chiamano «argumentum liminare» della possibilità di dimostrare l’esistenza di Dio quello che consiste nel così detto «consenso universale». Recensendo l’opera del padre Pedro Descoqs S. J. (Praelaectiones Theologiae Naturalis. Cours de Théodicée, tomo primo: De Dei cognoscibilitate, parte prima, Parigi,
Beauchesne, 1933, in 8° gr., pp. vi‑725, Franchi 100, scritto parte in latino e parte in francese e che può essere un utile repertorio di tutte le opinioni sull’esistenza di Dio), la «Civiltà Cattolica» del 2 settembre 1933 scrive: «Il fatto, ossia l’universalità morale della “credenza” in Dio, è stabilito in modo rigoroso e scientifico sulla scorta dei più accreditati studi di etnologia e di storia delle religioni. Questo accertamento, all’inizio della teodicea, ha un alto valore in quanto fa toccare con mano l’importanza e l’universalità del problema. Tuttavia il padre Descoqs non crede che esso da solo offra una prova apodittica e rigorosa dell’esistenza di Dio; sebbene l’argomento che se ne deduce abbia una forza vehementer suasiva e sia di mirabile conferma, dopo che l’esistenza di Dio sia stata provata per altre vie».
II. Federico Jodl, Critica dell’idealismo. Tradotta ed annotata da G. Rensi. Roma, Ediz. «Casa del Libro», 1932, in 16°, pp. 274, L. 10. È interessante la breve recensione della «Civiltà Cattolica» del 2 settembre 1933, perché mostra come la filosofia di S. Tommaso possa allearsi al materialismo volgare. Lo Jodl critica l’idealismo da un punto di vista meccanicistico e naturalistico (quistione della realtà del mondo esterno) e questa critica piace ai gesuiti fino al punto in cui non se ne deducono conclusioni ateistiche: «Come mai menti colte, come quelle dello Jodl e del Rensi, non riescono a percepire nella filosofia cristiana, in quella di S. Tommaso specialmente, il sistema necessario per mantenere la realtà del mondo materiale senza menomare le esigenze e il primato dello spirito? Quando lo Jodl spiega in ultima analisi il mondo come l’effetto delle leggi e del caso, non si accorge di perdersi in vuote parole? E quando, avendo sostenuto il paradosso che le mire degli idealisti siano di appoggiare la teologia chiesastica – si pensi a Croce, a Brunschvieg, a tanti altri! – finisce col proporre il suo ideale, “il Cielo sulla Terra”, non si avvede che quel motto, posto in fine del suo libro, non può significare se non la soppressione di ogni Cielo?» Giustamente la «Civiltà Cattolica» rimprovera allo Jodl di identificare «l’idealismo col platonismo», «come se da Kant a Gentile le Idee trascendenti non fossero state lo spauracchio degli idealisti». Il libro dello Jodl può essere interessante (come quelli del Rensi) per fissare la fase attuale del «materialismo volgare» che non può riuscire a sconfiggere qualsiasi forma di idealismo perché non riesce a capire che l’idealismo non è che un abbozzo di tentativo di storicizzare la filosofia. La polemica Carlini‑Olgiati Neoscolastica, idealismo e spiritualismo, Milano, «Vita e Pensiero», 1933, pp. 180, Lire 6 e l’articolo di Guido De Ruggiero sull’«Educazione Nazionale» (del Lombardo Radice) del marzo 1933 non possono servire a dimostrare che l’idealismo appoggia il clericalismo, ma che singoli idealisti non trovano nella loro filosofia un terreno solido di pensiero e di fede nella vita. (Su questa polemica cfr anche stesso numero della «Civiltà Cattolica» articolo Brancolando in cerca di una fede e articoli nei nn. sgg, della «Civiltà Cattolica»).
III. Dal cap. XI della II parte del Rinnovamento del Gioberti è da trarre questo brano di storia della filosofia: «L’umanismo si collega colle dottrine filosofiche anteriori ed è l’ultimo termine del psicologismo cartesiano, che, tenendo vie diverse in Francia e in Germania, riuscì nondimeno allo stesso esito. Imperocché, trasformato dal Locke e dal Kant in sensismo empirico e speculativo, partorì a poco andare per forza di logica l’ateismo materiale degli ultimi condillacchiani e l’ateismo raffinato dei nuovi hegelisti. Già Amedeo Fichte, movendo dai principi della scuola critica, aveva immedesimato Iddio coll’uomo; come dipoi Federico Schelling lo confuse con la natura; e Hegel, raccogliendo i loro dettati e consertandoli insieme, considerò lo spirito umano come la cima dell’assoluto; il quale, discorrendo dal punto astratto dell’idea nel concreto della natura e trapassando in quello dello spirito, acquista in esso la coscienza di se medesimo e diventa Dio. I nuovi hegelisti, accettando la conclusione, rigettano l’ipotesi insussistente dell’assoluto panteistico e l’edifizio fantastico delle premesse; onde, invece di affermare col maestro che lo spirito è Dio, insegnano che il concetto di Dio è una vana immagine e una larva chimerica dello spirito».
Pare interessante la nota del Gioberti che la filosofia classica tedesca e il materialismo francese siano la stessa cosa in linguaggio diverso ecc. Il brano è da avvicinare a quello della Sacra Famiglia dove si parla del materialismo francese. (Ricordare che nella Sacra Famiglia appunto l’espressione «umanismo» è impiegata nello stesso senso del Gioberti – non trascendenza – e che «neo‑umanismo» voleva chiamare l’autore la sua filosofia).
Q17 §19 Argomenti di cultura. Francesco Savorgnan di Brazzà ha raccolto in volume (Da Leonardo a Marconi, Milano, Hoepli, 1933, pp. VIII‑368, L. 15) una serie di suoi articoli che rivendicano a «individualità» italiane una serie di invenzioni e scoperte (termometro, barometro, dinamo, galvanoplastica, igrometro, telefono, paracadute ecc.) che pare siano state spesso «usurpate» da stranieri. In altra nota fu fatto notare come una tale «rivendicazione» sia da «italiano meschino», che in realtà riduce l’Italia alla funzione della Cina, dove, come è noto, è stato inventato «tutto». La nota riguardava anche Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America ed era connessa a una serie di osservazioni sul fatto che nel Quattrocento gli italiani perdettero lo spirito di intrapresa (come collettività), mentre singoli italiani «intraprendenti» se vollero affermarsi, dovettero porsi al servizio di Stati stranieri o di capitalisti stranieri.
Q17 §20 Giorgio Sorel. Nella «Critica Fascista» del 15 settembre 1933 Gustavo Glaesser riassume il recente libro di Michael Freund (Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus, Klostermann Verlag, Francoforte am Main, 1932) che mostra quale scempio possa fare un ideologo tedesco di un uomo come Sorel. È da notare che, se pure Sorel possa, per la varietà e incoerenza dei suoi punti di vista, essere impiegato a giustificare i più disparati atteggiamenti pratici, tuttavia è innegabile nel Sorel un punto fondamentale e costante, il suo radicale «liberalismo» (o teoria della spontaneità) che impedisce ogni conseguenza conservatrice delle sue opinioni. Bizzarrie, incongruenze, contraddizioni si trovano nel Sorel sempre e ovunque, ma egli non può essere distaccato da una tendenza costante di radicalismo popolare: il sindacalismo di Sorel non è un indistinto «associazionismo» di «tutti» gli elementi sociali di uno Stato, ma solo di uno di essi, e la sua «violenza» non è la violenza di «chiunque» ma di un solo «elemento» che il pacifismo democratico tendeva a corrompere ecc. Il punto oscuro nel Sorel è il suo antigiacobinismo e il suo economismo puro; e questo, che è, nel terreno storico francese, da connettersi col ricordo del Terrore e poi della repressione di Galliffet, oltre che con l’avversione ai Bonaparte, è il solo elemento della sua dottrina che può essere distorto e dar luogo a interpretazioni conservatrici.
Q17 §21 Argomenti di cultura. Cesare e il cesarismo. La teoria del cesarismo, che oggi predomina (cfr il discorso di Emilio Bodrero L’umanità di Giulio Cesare, nella Nuova Antologia del 16 settembre 1933) è stata immessa nel linguaggio politico da Napoleone III, il quale non fu certo un grande storico o filosofo o teorico della politica. È certo che nella storia romana la figura di Cesare non è caratterizzata solo o principalmente dal «cesarismo» in questo senso stretto. Lo sviluppo storico di cui Cesare fu l’espressione assume nella «penisola italica» ossia a Roma la forma del «cesarismo» ma ha come quadro l’intero territorio imperiale e in realtà consiste nella «snazionalizzazione» dell’Italia e nella sua subordinazione agli interessi dell’Impero. Né, come dice il Bodrero, Cesare trasformò Roma da Stato‑città in Capitale dell’Impero, tesi assurda e antistorica: la capitale nell’impero era dove risiedeva l’imperatore, un punto mobile; la cristallizzazione di una capitale portò alla scissione, all’emergere di Costantinopoli, di Milano ecc. Roma divenne una città cosmopolita, e l’Italia intera divenne centro di una cosmopoli. È da fare un paragone tra Catilina e Cesare: Catilina era più «italiano» di Cesare e la sua rivoluzione forse avrebbe, con un’altra classe al potere, conservato all’Italia la funzione egemonica del periodo repubblicano. Con Cesare la rivoluzione non è più soluzione di una lotta tra classi italiche, ma di tutto l’Impero, o almeno di classi con funzioni principalmente imperiali (militari, burocrati, banchieri, appaltatori ecc.).
Inoltre Cesare, con la conquista della Gallia aveva squilibrato il quadro dell’Impero: l’Occidente cominciò con Cesare a lottare con l’Oriente. Ciò si vede nelle lotte tra Antonio e Ottaviano e continuerà fino alla scissione della Chiesa su cui ebbe influenza il tentativo di Carlo Magno di restaurare l’Impero, così come la fondazione del potere temporale del papato romano. Dal punto di vista della cultura è interessante l’attuale mito di «Cesare» che non ha nessuna base nella storia, così come nessuna base aveva nel Settecento l’esaltazione della repubblica romana come di una istituzione democratica e popolare ecc.
Q17 §22 Introduzione allo studio della filosofia. Pragmatismo e politica. Il «pragmatismo» (di James, ecc.) non pare possa essere criticato se non si tiene conto del quadro storico anglosassone in cui è nato e si è diffuso. Se è vero che ogni filosofia è una «politica» e che ogni filosofo è essenzialmente un uomo politico, ciò tanto più si può dire per il pragmatista che costruisce la filosofia «utilitariamente» in senso immediato. Ma ciò non è pensabile (come movimento) in paesi cattolici, dove la religione e la vita culturale si sono scissi fin dal tempo del Rinascimento e della Controriforma, mentre è pensabile per i paesi anglosassoni, in cui la religione è molto aderente alla vita culturale di ogni giorno e non è centralizzata burocraticamente e dogmatizzata intellettualmente. In ogni caso il pragmatismo evade dalla sfera religiosa positiva e tende a creare una morale laica (di tipo non francese), tende a creare una «filosofia popolare» superiore al senso comune, è un «partito ideologico» immediato più che un sistema di filosofia. Se si prende il principio del pragmatista quale è esposto dal James: «il metodo migliore per discutere i punti diversi di qualche teoria si è di cominciare dal mettere in sodo quale differenza pratica risulterebbe dal fatto che l’una o l’altra delle due alternative fosse la vera» (W. James, Le varie forme della scienza religiosa. Studio sulla natura umana, trad. di G. C. Ferrari e M. Calderoni, ed. Bocca, 1904, pp. 382), si vede quale sia l’immediatezza del politicismo filosofico pragmatista. Il filosofo «individuale» tipo italiano o tedesco, è legato alla «pratica» mediatamente (e spesso la mediazione è una catena di molti anelli), il pragmatismo vi si vuole legare subito e in realtà appare così che il filosofo tipo italiano o tedesco è più «pratico» del pragmatista che giudica dalla realtà immediata, spesso volgare, mentre l’altro ha un fine più alto, pone il bersaglio più alto e quindi tende a elevare il livello culturale esistente (quando tende, si capisce). Hegel può essere concepito come il precursore teorico delle rivoluzioni liberali dell’Ottocento. I pragmatisti, tutt’al più, hanno giovato a creare il movimento del Rotary club o a giustificare tutti i movimenti conservatori e retrivi (a giustificarli di fatto e non solo per distorsione polemica come è avvenuto per Hegel e lo Stato prussiano).
Q17 §23 Saggio popolare di sociologia. Obbiezione all’empirismo: l’indagine di una serie di fatti per trovarne i rapporti presuppone un «concetto» che permetta di distinguere quella serie di fatti da altre serie possibili: come avverrà la scelta dei fatti da addurre come prova della verità del proprio assunto, se non preesiste il criterio di scelta? Ma cosa sarà questo criterio di scelta, se non qualcosa di superiore a ogni singolo fatto indagato? Una intuizione, una concezione, la cui storia è da ritenersi complessa, un processo da connettere a tutto il processo di sviluppo della cultura ecc. (Osservazione da connettere all’altra sulla «legge sociologica» in cui non si fa altro che ripetere due volte lo stesso fatto, una volta come fatto e una volta come legge. Sofisma del doppio fatto e non legge).
Q17 §24 I nipotini di padre Bresciani. G. Papini. In Papini manca la rettitudine: dilettantismo morale. Nel primo periodo della sua carriera letteraria questa deficienza non impressionava, perché Papini basava la sua autorità su se stesso, era il «partito di se stesso». Divertiva, non poteva essere preso sul serio, altro che da pochi filistei (ricordare la discussione con Annibale Pastore). Oggi Papini si è innestato in un vasto movimento da cui trae autorità: la sua attività è divenuta perciò canagliesca nel senso più spregevole, dello sparafucile, del sicario mercenario. Se un bambino rompe i vetri per divertirsi e per monelleria, sia pure artificiosa, è una cosa: ma se rompe i vetri per conto dei venditori di vetro è un’altra cosa.
Q17 §25 Argomenti di cultura. Opere di consultazione. I. E. Würzburger e E. Roesner, Hübners Geographisch-Statistiche Tabellen, Vienna, L. W. Seidel und Sohn, 1932, in 8°, pp. 564. Questa del 1932 è la 71a edizione. Indispensabile non solo per i geografi e i cultori di statistica, ma per chiunque voglia essere informato delle condizioni politiche, economiche, sociali, finanziarie, commerciali, demografiche ecc. di tutti i paesi del globo. Nella 71a edizione è aggiunta un’appendice sui partiti politici dei singoli Stati, oltre a elaborazioni più compiute di dati economici, industriali ecc.
II. A. Kriszties, Bibliographie des sciences sociales. Nel 1933 è uscito il IV volume (1927), Parigi, Giard, in 8°, pp. 1269, Frs. 170.
Q17 §26 L’Azione Cattolica. Nell’autunno del 1892 fu tenuto a Genova un Congresso cattolico italiano degli studiosi di scienze sociali; vi fu osservato che «il bisogno del momento presente, non certo unico bisogno, ma urgente quanto ogni altro, è la rivendicazione scientifica dell’idea cristiana. La scienza non può dare la fede, ma può imporre agli avversari il rispetto, e può condurre le intelligenze a riconoscere della fede la necessità sociale e l’individuale dovere (!)». Nel 1893, per impulso di tale Congresso, patrocinato da Leone XIII (l’enciclica Rerum Novarum è del 1891), fu fondata la «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», che ancora si pubblica. Nel fascicolo del gennaio 1903 della rivista si riassume l’attività del decennio.
L’attività di questa rivista, che non è mai stata molto «chiassosa», è tuttavia da studiare anche in confronto a quella della «Critica Sociale» di cui doveva essere il controaltare ecc.
Q17 §27 Machiavelli. I. Cfr ciò che scrive l’Alfieri sul Machiavelli nel libro Del principe e delle lettere. Parlando delle «massime immorali e tiranniche» che si potrebbero ricavare «qua e là» dal Principe l’Alfieri nota: «e queste dall’autore sono messe in luce (a chi ben riflette) molto più per disvelare ai popoli le ambizioni ed avvedute crudeltà dei principi che non certamente per insegnare ai principi a praticarle: poiché essi più o meno sempre le adoprano, le hanno adoperate e le adopereranno, secondo il loro bisogno, ingegno e destrezza». A parte l’interpretazione democratica, la nota è giusta: ma certo il Machiavelli non voleva «solo» insegnare ai principi le «massime» che essi conoscevano e adoperavano. Voleva invece insegnare la «coerenza» nell’arte di governo e la coerenza impiegata ad un certo fine: la creazione di uno Stato unitario italiano. Cioè il Principe non è un libro di «scienza», accademicamente inteso, ma di «passione politica immediata», un «manifesto» di partito, che si fonda su una concezione «scientifica» dell’arte politica. Il Machiavelli insegna davvero la «coerenza» dei mezzi «bestiali», e ciò è contro la tesi dell’Alderisio (di cui occorre vedere lo scritto Intorno all’arte dello Stato del Machiavelli. Discussione ulteriore dell’interpretazione di essa come «pura politica», nei «Nuovi Studi» del giugno‑ottobre 1932) ma questa «coerenza» non è una cosa meramente formale, ma la forma necessaria di una determinata linea politica attuale. Che poi dalla esposizione del Machiavelli si possano trarre elementi di una «pura politica» è altra quistione: ciò riguarda il posto che il Machiavelli occupa nel processo di formazione della scienza politica «moderna», che non è piccolo. L’Alderisio imposta male tutto il problema, e le qualche buone ragioni che può avere si perdono nella sconnessione del quadro generale sbagliato.
II. La quistione del perché il Machiavelli abbia scritto il Principe e le altre opere non è una semplice quistione di cultura o di psicologia dell’autore: essa serve a spiegare in parte il fascino di questi scritti, la loro vivacità e originalità. Non si tratta certo di «trattati» del tipo medioevale; neppure si tratta di opere di un avvocato curiale che voglia giustificare le operazioni o il modo di operare dei suoi «sostentatori» o sia pure del suo principe. Le opere del Machiavelli sono di carattere «individualistico», espressioni di una personalità che vuole intervenire nella politica e nella storia del suo paese e in tal senso sono di origine «democratica». C’è la «passione» del «giacobino» nel Machiavelli e perciò egli doveva tanto piacere ai giacobini e agli illuministi: è questo un elemento «nazionale» in senso proprio e dovrebbe essere studiato preliminarmente in ogni ricerca sul Machiavelli.
Q17 §28 Risorgimento italiano. Cfr la recensione di A. Omodeo (nella «Critica» del 20 luglio 1933) del libro di N. Rosselli su Carlo Pisacane, che è interessante per molti aspetti. L’Omodeo ha l’occhio acuto nel rilevare non solo le deficienze organiche del libro, ma anche le deficienze organiche dell’impostazione che il Pisacane dava al problema del Risorgimento. Ma questa acutezza gli viene dal fatto che egli si pone dal punto di vista «conservatore e retrivo». Non pare esatta l’affermazione dell’Omodeo che il Pisacane sia stato «un frammento del 48 francese inserito nella storia d’Italia», così come non è esatto il riaccostamento fatto dal Rosselli del Pisacane coi sindacalisti moderni (Sorel ecc., in azione). Il Pisacane è da avvicinare ai rivoluzionari russi, ai narodnichi, e perciò è interessante l’accenno fatto dal Ginzburg all’influsso di Herzen sugli emigrati italiani. Che Bakunin, più tardi, abbia avuto tanta fortuna nel Mezzogiorno e in Romagna non è senza significato per comprendere ciò che il Pisacane espresse al suo tempo, e pare strano che proprio il Rosselli non abbia visto il nesso.
Il rapporto tra Pisacane e le masse plebee non è da vedere nell’espressione socialistica né in quella sindacalistica, ma piuttosto in quelle di tipo giacobino, sia pure estremo. La critica dell’Omodeo è troppo facile all’impostazione del problema del Risorgimento su basi plebee‑socialistiche, ma non sarebbe altrettanto facile a quella su basi «giacobine - riforma agraria», né sarebbe facile smentire l’egoismo gretto, angusto, antinazionale delle classi dirigenti, che in realtà erano rappresentate in questo caso dai nobili terrieri e dalla borghesia rurale assenteista, e non dalla borghesia urbana di tipo industriale e dagli intellettuali «ideologi», i cui interessi non erano «fatalmente» legati a quelli dei terrieri, ma avrebbero dovuto essere legati a quelli dei contadini, cioè furono scarsamente nazionali.
Così non è «tutto oro» l’osservazione dell’Omodeo che avere dei programmi definiti era nel periodo del Risorgimento una debolezza, poiché non si era elaborata la «tecnica» per realizzare i programmi stessi. A parte il fatto che in Pisacane programmi definiti non ci furono, ma solo una «tendenza generale» più definita che in Mazzini (e in realtà più nazionale che in Mazzini), la teoria contro i programmi definiti è di carattere schiettamente retriva e conservatrice. Che i programmi definiti debbano essere elaborati tecnicamente per essere applicabili è certo, e che i programmi definiti senza una elaborazione del processo tecnicoIn un primo momento Gramsci aveva scritto: «elaborazione tecnica». per cui essi si realizzeranno siano una vuotaggine è anche certo, ma è anche certo che i politici come Mazzini, che non hanno «programmi definiti» lavorano solo per il re di Prussia, sono fermenti di riscossa che infallantemente sarà monopolizzata dagli elementi più retrivi che attraverso la «tecnica» finiranno col prevalere su tutti. In conclusione anche per il Pisacane è da dire che non rappresentava nel Risorgimento una tendenza «realistica» perché isolato, senza un partito, senza quadri predisposti per il futuro Stato ecc. Ma la quistione non è tanto di storia del Risorgimento, quanto di storia del passato vista con interessi contemporanei molto immediati e da questo punto di vista la recensione dell’Omodeo, come altri scritti dello stesso autore, è tendenziosa in senso conservatore e retrivo. Del resto questa recensione è interessante per l’argomento delle «ideologie» moderne suscitate dal ripensamento sulla storia del Risorgimento, che tanta importanza hanno per comprendere la cultura italiana degli ultimi decenni.
Un argomento interessante, che è stato accennato dal Gioberti (nel Rinnovamento per esempio) è quello delle possibilità tecniche della rivoluzione nazionale in Italia durante il Risorgimento: quistione della capitale rivoluzionaria (come Parigi per la Francia), della disposizione regionale delle forze insurrezionali ecc. L’Omodeo critica ilRosselli per non aver indagato l’organizzazione meridionale che non doveva essere tanto inefficiente nel 1857 se nel 1860 fu sufficiente a immobilizzare le forze borboniche, ma la critica non pare molto fondata. Nel 1860 la situazione era completamente mutata e bastò la passività per immobilizzare i Borboni, mentre nel 1857 la passività e i quadri sulla carta erano inefficienti. Non si tratta dunque di confrontare l’organizzazione del 60 con quella del 57, ma le diverse situazioni specialmente «internazionali». È probabile anzi che come organizzazione nel 60 si stesse peggio che nel 57 per la reazione avvenuta.
Dalla recensione dell’Omodeo è opportuno citare questo brano: «Il Rosselli si entusiasma della maggiore ricchezza dei programmi. Ma il programma, riferito a un’ipotetica situazione futura, è spesso un ingombrante e inutile bagaglio: ciò che sopra tutto importa è la direzione, non la materiale specificazione delle opere. Abbiam veduto tutti quel che valevano i programmi per il dopo‑guerra, studiati quando non si sapeva ancora come si sarebbe usciti dal cimento, in quali stati d’animo, con quali bisogni incalzanti! Falsa concretezza perciò, al disotto della indeterminatezza tanto rimproverata al Mazzini. Inoltre, non pochi punti delle rivendicazioni socialistiche erano (e sono) postulati senza la determinazione del processo tecnico per conseguirli, e provocavano e provocano non solo o non tanto la reazione delle classi lese, quanto la repugnanza di chi, libero dagli interessi (!) di classe, sente che non è maturo né un nuovo ordine morale né un nuovo ordine giuridico: situazione nettamente antitetica a quella della rivoluzione francese che i diversi socialismi vogliono esemplare: perché l’ordine nuovo giuridico‑morale nel 1789 era vivo nella coscienza di tutti e si presentava di piana attuazione». («Critica», 20 luglio 1933, pp. 283‑84). L’Omodeo è molto superficiale e corrivo: le sue opinioni sono da porre a confronto col saggio del Croce sul Partito come giudizio e come pregiudizio pubblicato nel 1911.
La verità è che il programma del Pisacane era altrettanto indeterminato di quello del Mazzini e anch’esso segnava solo una tendenza generale, che come tendenza era un po’ più precisa di quella del Mazzini. Ogni specificazione «concreta» di programma e ogni determinazione del processo tecnico per conseguirne i punti presuppongono un partito e un partito molto selezionato e omogeneo: il partito mancava sia al Mazzini che al Pisacane. L’assenza di programma concreto, con tendenza generale, è una forma di «mercenarismo» fluido, i cui elementi finiscono collo schierarsi col più forte, con chi paga meglio ecc. L’esempio del dopo‑guerra, invece che ragione, dà torto all’Omodeo: 1) perché programmi concreti in realtà non esistettero mai in quegli anni, ma appunto solo tendenze generali più o meno vaghe e fluttuanti; 2) perché appunto in quel periodo non esistettero partiti selezionati e omogenei ma solo bande zingaresche fluttuanti e incerte, che erano appunto simbolo dell’indeterminatezza dei programmi e non viceversa. Né il confronto con la Rivoluzione francese del 1789 è calzante, perché allora Parigi svolse un ruolo che nell’Italia del dopo 48 nessuna città poteva svolgere con qualsiasi programma.
La quistione deve essere impostata nei termini della «guerra di movimento – guerra d’assedio», cioè per cacciare gli Austriaci e i loro ausiliari italiani era necessario: 1) un forte partito italiano omogeneo e coerente: 2) che questo partito avesse un programma concreto e specificato; 3) che tale programma fosse condiviso dalle grandi masse popolari (che allora non potevano essere che agricole) e le avesse educate a insorgere «simultaneamente» su tutto il paese. Solo la profondità popolare del movimento e la simultaneità potevano rendere possibile la sconfitta dell’esercito austriaco e dei suoi ausiliari. Da questo punto di vista non tanto giova il contrapporre Pisacane al Mazzini, quanto il Pisacane al Gioberti, che aveva una visione strategica della rivoluzione italiana, strategica non nel senso strettamente militare (come il Mazzini riconosceva al Pisacane) ma politico‑militare. Ma anche al Gioberti mancava un partito, e non solo nel senso moderno della parola, ma anche nel senso che allora aveva la parola, cioè nel senso della Rivoluzione francese di movimento degli «spiriti». Del resto il programma del Mazzini politicamente era, per il tempo, troppo «determinato» e concreto in senso repubblicano e unitario, a differenza di quello del Gioberti che più si avvicina al tipo di giacobino quale era necessario all’Italia d’allora.
Anche l’Omodeo, in fondo (e ciò è il suo antistoricismo) si pone implicitamente dal punto di vista di una Italia preesistente al suo formarsi, quale esiste oggi e nella forma in cui si è costituita nel 1870. (Nonostante la sua avversione per la tendenza economico‑giuridica, l’Omodeo si pone dal punto di vista che è quello del Salvemini nel suo opuscolo sul Mazzini: la predicazione genericamente unitaria del Mazzini è il nucleo solido del mazzinianismo, il suo contributo reale al Risorgimento). Per ciò che riguarda l’atteggiamento dei «liberi dagli interessi di classe» essi nel dopoguerra si comportarono come nel Risorgimento: non seppero mai decidersi e si accodarono al vincitore che d’altronde, col non decidersi, avevano aiutato a vincere, perché si trattava di chi rappresentava la loro classe in senso angusto e meschino.
Q17 §29 Letteratura popolare. Articolo di Andrea Moufflet nel «Mercure de France» del 1° febbraio 1931 sul romanzo d’appendice. Il romanzo d’appendice, secondo il Moufflet, è nato dal bisogno di illusione, che infinite esistenze meschine provavano, e forse provano ancora, quasi a rompere la grama monotonia a cui si vedono condannate.
Osservazione generica: si può fare per tutti i romanzi e non solo d’appendice: occorre analizzare quale particolare illusione dà al popolo il romanzo d’appendice, e come questa illusione cambi coi periodi storico‑politici: c’è lo snobismo, ma c’è un fondo di aspirazioni democratiche che si riflettono nel romanzo d’appendice classico. Romanzo «tenebroso» alla Radcliffe, romanzo d’intrigo, d’avventura, poliziesco, giallo, della malavita ecc. Lo snob si vede nel romanzo d’appendice che descrive la vita dei nobili o delle classi alte in generale, ma questo piace alle donne e specialmente alle ragazze, ognuna delle quali, del resto, pensa che la bellezza può farla entrare nella classe superiore.
Esistono per il Moufflet i «classici» del romanzo d’appendice, ma ciò è inteso in un certo senso: pare che il romanzo d’appendice classico sia quello «democratico» con diverse sfumature da V. Hugo, a Sue, a Dumas. L’articolo del Moufflet sarà da leggere, ma occorre tener presente che egli esamina il romanzo d’appendice come «genere letterario», per lo stile ecc., come espressione di un’«estetica popolare» ciò che è falso. Il popolo è «contenutista», ma se il contenuto popolare è espresso da grandi artisti, questi sono preferiti. Ricordare ciò che ho scritto per l’amore del popolo per Shakespeare, per i classici greci, e modernamente per i grandi romanzieri russi (Tolstoi, Dostojevskij). Così, nella musica, Verdi.
Nell’articolo Le mercantilisme littéraire di J. H. Rosny aîné, nelle «Nouvelles Littéraires» del 4 ottobre 1930 si è detto che V. Hugo scrisse i Miserabili ispirato dai Misteri di Parigi di Eugenio Sue e dal successo che questi ebbero, tanto grande che quarant’anni dopo l’editore Lacroix ne era ancora stupefatto. Scrive il Rosny: «Le appendici, sia nell’intenzione del direttore del giornale, sia nell’intenzione dell’appendicista, furono prodotti ispirati dal gusto del pubblico e non dal gusto degli autori». Questa definizione è anch’essa unilaterale. E infatti il Rosny scrive solo una serie di osservazioni sulla letteratura «commerciale» in genere (quindi anche quella pornografica) e sul lato commerciale della letteratura. Che il «commercio» e un determinato «gusto» del pubblico si incontrino non è casuale, tanto è vero che le appendici scritte intorno al 48 avevano un determinato indirizzo politico‑sociale che ancora oggi le fa ricercare e leggere da un pubblico che vive gli stessi sentimenti del 48.
Q17 §30 Giornalismo. Mark Twain, quando era direttore di un giornale in California, pubblicò una vignetta che rappresentava un asino morto in fondo a un pozzo, con la dicitura: «Questo asino è morto per non aver ragliato». Il Twain voleva porre in evidenza l’utilità della réclame giornalistica, ma la vignetta può avere anche altri significati.
Q17 §31 Passato e presente. Discussioni sul Congresso internazionale hegeliano tenuto a Roma nel 1933 (III Congresso della Società internazionale hegeliana). Si è voluto vedere in esso un’affermazione tendenziosa dell’idealismo attualistico italiano (Gentile ecc.) nel mezzo dell’Anno Santo indetto dal Vaticano per il 1900 anniversario della morte di Cristo. Il Congresso fu così combattuto e dai cattolici e dagli epigoni del positivismo o neocriticismo.
Q17 §32 Funzione cosmopolita della letteratura italiana. Ancora del saggio di Augusto Rostagni su l’Autonomia della Letteratura romana, pubblicato in 4 puntate nell’«Italia Letteraria» del 21 maggio 1933 e sgg. Secondo il Rostagni la letteratura latina sorse al principio delle guerre puniche, come causa ed effetto dell’unificazione d’Italia, come espressione essenzialmente nazionale, «con l’istinto del progresso, della conquista, con l’impulso delle più alte e vigorose affermazioni». Concetto antistorico, perché allora non si poteva parlare di fenomeno «nazionale», ma solo di romanesimo che unifica giuridicamente l’Italia (e ancora un’Italia che non corrisponde a ciò che oggi intendiamo per Italia, poiché era esclusa l’Alta Italia, che oggi ha non poca importanza nel concetto d’Italia). Che il Rostagni abbia ragione di parlare di «autonomia» della letteratura latina, cioè di sostenere che questa è autonoma dalla letteratura greca, può accettarsi, – ma in realtà c’era più «nazionalità» nel mondo greco che in quello romano‑italico. D’altronde anche ammesso che con le prime guerre puniche qualcosa muti nei rapporti tra Roma e l’Italia, che si abbia una maggiore unità anche territoriale, ciò non toglie che questo periodo sia molto breve e abbia scarsa rilevanza letteraria: la letteratura latina fiorisce dopo Cesare, con l’Impero, cioè proprio quando la funzione dell’Italia diventa cosmopolita, quando non più si pone il problema del rapporto tra Roma e l’Italia, ma tra Roma‑Italia e l’Impero. Non si può parlare di nazionale senza il territoriale: in nessuno di questi periodi l’elemento territoriale ha importanza che non sia meramente giuridico‑militare, cioè «statale» in senso governativo, senza contenuto etico‑passionale.
Q17 §33 Umanesimo. Rinascimento. Può esser vero che l’Umanesimo nacque in Italia come studio della romanità e non del mondo classico in generale (Atene e Roma): ma occorre distinguere allora. L’Umanesimo fu «politico‑etico», non artistico, fu la ricerca delle basi di uno «Stato italiano» che avrebbe dovuto nascere insieme e parallelamente alla Francia, alla Spagna, all’Inghilterra: in questo senso l’Umanesimo e il Rinascimento hanno come esponente più espressivo il Machiavelli. Fu «ciceroniano» come sostiene il Toffanin, cioè ricercò le sue basi nel periodo che precedette l’Impero, la cosmopolis imperiale (e in tal senso Cicerone può essere un buon punto di riferimento per il suo opporsi a Catilina prima, a Cesare poi, cioè all’emergere delle nuove forze anti‑italiche, di classe cosmopolita). Il Rinascimento spontaneo italiano, che si inizia dopo il Mille e fiorisce artisticamente in Toscana, fu soffocato dall’Umanesimo e dal Rinascimento in senso culturale, dalla rinascita del latino come lingua degli intellettuali, contro il volgare, ecc. Che questo Rinascimento spontaneo (del Duecento specialmente) possa solo essere paragonato alla fioritura della letteratura greca, è innegabile, mentre il «politicismo» del Quattrocento‑Cinquecento è il Rinascimento che può essere riferito al Romanesimo.
Atene e Roma hanno la loro continuazione nelle chiese ortodossa e cattolica: anche qui è da sostenere che Roma fu continuata dalla Francia più che dall’Italia e Atene‑Bisanzio dalla Russia zarista. Civiltà occidentale e orientale. Ciò fino alla Rivoluzione francese e forse alla guerra del 1914.
Nel saggio del Rostagni molte osservazioni particolari acute, ma la prospettiva sbagliata. Il Rostagni intanto confonde la cultura libresca con quella spontanea. Che la svalutazione dei Romani sia dovuta al Romanticismo, specialmente tedesco (nel campo artistico) può essere vero; che abbia avuto motivi pratici immediati ecc., può anche essere vero. Ma il Rostagni avrebbe dovuto ricercare se tuttavia non ci fosse in questo unilateralismo una verità, sia pure unilaterale. Verità di cultura, non estetica, perché l’«autonomia» estetica è degli artisti singoli, tra l’altro, e non dei raggruppamenti culturali; e sia pure «autonomia di cultura» che certo dovrebbe esistere, come appunto dimostra il fatto della scissione culturale tra Oriente e Occidente, tra chiesa Cattolica e Ortodossismo bizantino ecc. Ma allora occorrevano non motivazioni superficiali, ma più approfondite ricerche non solo in letteratura ma nella cultura generale.
Q17 §34 Letteratura popolare. Il prigioniero che canta, di Johan Bojer (tradotto da L. Gray e G. Dauli, casa Editrice Bietti, Milano, 1930). Due aspetti culturali da osservare: 1) la concezione «pirandelliana» del protagonista, che continuamente ricrea la sua «personalità» fisica e morale, che è sempre diversa e pur sempre uguale. Può interessare per la fortuna del pirandellismo in Europa e allora occorre vedere quando il Bojer ha scritto il suo libro; 2) aspetto più strettamente popolare, contenuto nell’ultima parte del romanzo. Per esprimersi in termini «religiosi» l’autore sostiene in forma pirandelliana la vecchia concezione religiosa e riformistica del «male»: il male è nell’interno dell’uomo (in senso assoluto); in ogni uomo c’è per così dire un Caino e un Abele, che lottano tra loro: occorre, se si vuole eliminare il male dal mondo, che ognuno vinca in sé il Caino e faccia trionfare l’Abele: il problema del «male» non è dunque politico, o economico‑sociale, ma «morale» o «moralistico». Mutare il mondo esterno, l’insieme dei rapporti, non conta nulla: ciò che è importante è il problema individuale‑morale. In ognuno c’è il «giudeo» e il «cristiano», l’egoista e l’altruista: ognuno deve lottare in se stesso ecc., ammazzare il giudaismo che è in se stesso. È interessante che il pirandellismo sia servito al Bojer per cucinare questo vecchio piatto, che una teoria che passa per antireligiosa ecc. sia servita per ripresentare la vecchia impostazione cristiana del problema del male ecc.
Q17 §35 Passato e presente. «I luoghi comuni a rovescio». Per molti essere «originali» significa solo capovolgere i luoghi comuni dominanti in una certa epoca: per molti questo esercizio è il massimo dell’eleganza e dello snobismo intellettuale e morale. Ma il luogo comune rovesciato rimane sempre un luogo comune, una banalità. Forse il luogo comune rovesciato è ancora più banale del semplice luogo comune. Il bohémien è più filisteo del mercante di campagna. Da ciò quel senso di noia che viene col frequentare certi circoli che credono essere di eccezione, che si pongono come una aristocrazia distaccata dal vivere solito. Il democratico è stucchevole, ma quanto più stucchevole il sedicente reazionario che esalta il boia, e magari i roghi. Nell’ordine intellettuale Giovanni Papini è un grande fabbricatore di luoghi comuni rovesciati; nell’ordine politico erano tali i nazionalisti vecchio stile, come Coppola, Forges-Davanzati, Maraviglia e specialmente Giulio De Frenzi. Nella stessa serie intellettuale è da porre il Farinelli col suo lirismo e pateticismo che sono più stucchevolmente pedanteschi che non gli scritti dello Zumbini. (L’espressione «luogo comune a rovescio» è impiegata da Turgheniev in Padri e Figli. Bazarov ne enuncia il principio così: «È un luogo comune dire che l’istruzione pubblica è utile, è un luogo comune al rovescio dire che l’istruzione pubblica è dannosa» ecc.).
Q17 §36 Passato e presente. Dall’Enciclopedia Italiana (articolo «Guerra», p. 79): «Troppi scrittori del Secondo Impero sembrano convinti che la retorica – cui danno facile esca i grandi episodi guerrieri della Rivoluzione e del Primo Impero – basti a tener alto lo spirito militare e che l’alto spirito militare basti da solo a neutralizzare l’altrui eventuale superiorità tecnica».
Questa affermazione se è giusta nella critica militare è ancora più perentoria nella critica dell’azione politica. Forse in un solo aspetto dell’azione politica e cioè in quello elettoralistico nei regimi ultrademocratici liberali può esser vero che la retorica e «l’alto spirito» di lotta (cartacea) può sostituire la preordinazione tecnica minuziosa e organica e dare quindi «strepitose» vittorie. Questo giudizio può essere trasferito nella serie di «Machiavelli» nella parte in cui si analizzano i diversi momenti di una situazione e specialmente nel momento più immediato in cui ogni situazione culmina e si risolve effettivamente, cioè diventa storia.
Q17 §37 Machiavelli. È l’azione politica (in senso stretto) necessaria perché si possa parlare di «partito politico»? Si può osservare che nel mondo moderno in molti paesi i partiti organici e fondamentali, per necessità di lotta o per altra causa, si sono frazionati in frazioni, ognuna delle quali assume il nome di Partito e anche di Partito indipendente. Spesso perciò lo Stato Maggiore intellettuale del Partito organico non appartiene a nessuna di tali frazioni ma opera come se fosse una forza direttrice a sé stante, superiore ai partiti e talvolta è anche creduto tale dal pubblico. Questa funzione si può studiare con maggiore precisione se si parte dal punto di vista che un giornale (o un gruppo di giornali), una rivista (o un gruppo di riviste), sono anch’essi «partiti» o «frazioni di partito» o «funzione di determinati partiti». Si pensi alla funzione del «Times» in Inghilterra, a quella che ebbe il «Corriere della Sera» in Italia, e anche alla funzione della così detta «stampa d’informazione», sedicente «apolitica», e perfino alla stampa sportiva e a quella tecnica. Del resto il fenomeno offre aspetti interessanti nei paesi dove esiste un partito unico e totalitario di Governo: perché tale Partito non ha più funzioni schiettamente politiche ma solo tecniche di propaganda, di polizia, di influsso morale e culturale. La funzione politica è indiretta: poiché se non esistono altri partiti legali, esistono sempre altri partiti di fatto o tendenze incoercibili legalmente, contro i quali si polemizza e si lotta come in una partita di mosca cieca. In ogni caso è certo che in tali partiti le funzioni culturali predominano, dando luogo a un linguaggio politico di gergo: cioè le quistioni politiche si rivestono di forme culturali e come tali diventano irrisolvibili.
Ma un partito tradizionale ha un carattere essenziale «indiretto», cioè si presenta esplicitamente come puramente «educativo» (lucus ecc.), moralistico, di cultura (sic): ed è il movimento libertario: anche la cosidetta azione diretta («terroristica») è concepita come «propaganda» con l’esempio: da ciò si può ancora rafforzare il giudizio che il movimento libertario non è autonomo, ma vive al margine degli altri partiti, «per educarli», e si può parlare di un «libertarismo» inerente a ogni partito organico. (Cosa sono i «libertari intellettuali o cerebrali» se non un aspetto di tale «marginalismo» nei riguardi dei grandi partiti dei gruppi sociali dominanti?) La stessa «setta degli economisti» era un aspetto storico di questo fenomeno.
Si presentano pertanto due forme di «partito» che pare faccia astrazione (come tale) dall’azione politica immediata: quello costituito da una élite di uomini di cultura, che hanno la funzione di dirigere dal punto di vista della cultura, dell’ideologia generale, un grande movimento di partiti affini (che sono in realtà frazioni di uno stesso partito organico) e, nel periodo più recente, partito non di élite, ma di masse, che come masse non hanno altra funzione politica che quella di una fedeltà generica, di tipo militare, a un centro politico visibile o invisibile (spesso il centro visibile è il meccanismo di comando di forze che non desiderano mostrarsi in piena luce ma operare solo indirettamente per interposta persona e per «interposta ideologia»). La massa è semplicemente di «manovra» e viene «occupata» con prediche morali, con pungoli sentimentali, con miti messianici di attesa di età favolose in cui tutte le contraddizioni e miserie presenti saranno automaticamente risolte e sanate.
Q17 §38 Letteratura popolare. I. Accanto alle quistioni come: «Perché la letteratura italiana non è popolare in Italia», «Esiste un teatro italiano?» ecc. è da porre l’altra: «È necessario in Italia provocare una riforma religiosa come quella protestante» – e l’altra: «Dell’impopolarità del Risorgimento, ossia dell’indifferenza popolare nel periodo delle lotte per l’indipendenza e unità nazionali» (l’apoliticismo del popolo italiano e quindi l’astatalismo e ribellismo). Un «catalogo» esatto di tutte queste quistioni che da più di un secolo (dalla Rivoluzione francese) ossessionano gli intellettuali italiani (e infatti periodicamente si ripresentano in forme più o meno nuove: quella dell’unità della lingua, del rapporto tra arte e vita, del romanzo del teatro, del romanzo d’appendice si dibattono anche oggi e così quella di una riforma intellettuale e morale – cioè di una rivoluzione popolare – che abbia la stessa funzione della riforma protestantica e anche della popolarità del Risorgimento che sarebbe finalmente stata raggiunta con la guerra del 1915 e coi rivolgimenti posteriori, onde l’impiego a regime d’inflazione dei termini di rivoluzione e rivoluzionario) può dare la traccia migliore per ricostruire il carattere fondamentale della cultura italiana e le esigenze che da essa sono indicate e rese evidenti.
II. La parola d’ordine di Giovanni Gentile: «Torniamo al De Sanctis!» cosa significa? e cosa può e dovrebbe significare? Il De Sanctis, nell’ultima fase della sua vita e della sua attività, rivolse la sua attenzione al romanzo naturalista, che fu la forma «intellettualistica» assunta nell’Europa Occidentale dal movimento di «andare al popolo», del populismo degli intellettuali nello scorcio del secolo XIX dopo l’avvento delle grandi masse operaie per lo sviluppo dell’industria moderna e il tramonto definitivo della democrazia quarantottesca. Ricordare del De Sanctis lo studio Scienza e Vita, il suo passaggio alla Sinistra parlamentare, il suo timore di una ripresa reazionaria velata sotto forme pompose ecc. Giudizio del De Sanctis: «Manca la fibra perché manca la fede. E manca la fede perché manca la cultura». Ma cosa significa «cultura» in questo caso? Significa indubbiamente una coerente e unitaria, e di diffusione nazionale, «concezione della vita e dell’uomo», cioè una «filosofia» ma diventata appunto «cultura» cioè che ha generato un’etica, un modo di vivere, una condotta civile e individuale. Ciò domandava prima di tutto una unificazione della «classe colta» e in questo senso lavorò il De Sanctis con la fondazione del «Circolo filologico» che avrebbe dovuto determinare «l’unione di tutti gli uomini colti e intelligenti» di Napoli.
III. È interessante, da questo punto di vista, questa nota di Luigi Pirandello scritta a Bonn da studente, negli anni 1889‑90 (cfr Nuova Antologia del 1° gennaio 1934): «Noi lamentiamo che alla nostra letteratura manchi il dramma – e sul riguardo si dicono tante cose e tante altre se ne propongono – conforti, esortazioni, additamenti, progetti – opera vana: il vero marcio non si vede e non si vuol vedere. Manca la concezione della vita e dell’uomo. E pure noi abbiamo campo da dare all’epica e al dramma. Arido stupido alessandrinismo, il nostro». Forse però questo giudizio del Pirandello non fa che riecheggiare discussioni di studenti tedeschi sulla necessità generica di una Weltanschauung ed è più superficiale di quanto non paia. Del resto Pirandello si è fatta una concezione della vita e dell’uomo ma «individuale», incapace di diffusione nazionale‑popolare: come fermento critico ha avuto grande importanza culturale, come è notato altrove.
Q17 §39 Machiavelli. Il potere indiretto. Una serie di manifestazioni in cui la teoria e la pratica del potere indiretto, dalla sfera dell’organizzazione ecclesiastica e dei suoi rapporti con gli Stati, vengono applicate a rapporti tra partito e partito, tra gruppi intellettuali ed economici e partiti ecc. Caso classico quello del tentativo dell’Action Française e dei suoi capi atei e increduli che cercarono di valersi delle masse cattoliche organizzate dall’Azione Cattolica come truppa di manovra a favore della monarchia.
Q17 §40 Freudismo. Si può dire che la «libido» del Freud è lo sviluppo «medico» della Volontà di Schopenhauer? Qualche contatto tra Freud e Schopenhauer mi pare si possa identificare.
Q17 §41 Machiavelli. Scritto dal (generale) Luigi Bongiovanni nella Nuova Antologia del 16 gennaio 1934 (La Marna: giudizi in contrasto): «La guerra nel suo duro realismo avanza solo per via di fatti. Ciò che importa è vincere. La vittoria non si misura a sacrifici, ma a risultati. Di piu, la vittoria è sempre l’effetto di una superiorità: anzi, ne è la innegabile constatazione. Quando costa poco sangue, vuol dire che la superiorità era insita in uno dei due contendenti, per effetto di eventi anteriori».
Q17 §42 Passato e presente. Non esiste in Italia una traduzione dell’opera di Clausewitz sulla guerra. Né pare che Clausewitz fosse conosciuto dalla vecchia generazione: in un articolo della Nuova Antologia (16 dicembre 1933, Appunti sulla costituzione degli organi di comando in guerra) dell’ammiraglio Sirianni, il nome è sempre riferito come «Clausenwitz». Sarebbe da mettere in rapporto questo fatto con l’affermazione fatta dal Gen. De Bono (nelle sue memorie edite da Mondadori) che gli ufficiali della sua generazione non si occupavano di politica, non leggevano i giornali, non sapevano spesso neanche chi fossero i componenti del governo. Quale potesse essere il livello di cultura degli ufficiali della passata generazione è facile immaginare: un ufficiale che si disinteressa della vita politica del suo paese rassomiglia troppo a un soldato di ventura di tipo medioevale. Pare che il primo libro che riassume il pensiero militare (politico) del Clausewitz sia quello di Emilio Canevari, Clausewitz e la guerra odierna, Roma, 1934 (o 1933).
Q17 §43 Problemi di cultura. Il razzismo, Gobineau e le origini storiche della filosofia della prassi. È da leggere la Vita di Gobineau scritta da Lorenzo Gigli per vedere se il Gigli è riuscito a ricostruire esattamente la storia delle idee razziste e a inquadrarle nella cornice storica della cultura moderna. Occorre per ciò rifarsi alle tendenze storiografiche della Francia della Restaurazione e di Luigi Filippo (Thierry, Mignet, Guizot) e alla impostazione della storia francese come di una lotta secolare tra l’aristocrazia germanica (franca) e il popolo di origine gallica o gallo‑romana. La polemica su tale quistione, come è noto, non rimase ristretta al campo scientifico, ma dilagò nel campo della politica immediata e militante: qualche aristocratico rivendicò il dominio dei nobili come dovuto a un «diritto di conquista» e qualche scrittore democratico sostenne che la Rivoruzione francese e la decapitazione di Luigi XVI non furono altro che un’insurrezione dell’elemento gallico originario contro l’elemento germanico sovrappostosi alla antica nazionalità. È noto che molti e dei più popolari romanzi di Eugenio Sue (I Misteri del popolo, L’ebreo errante ecc.) drammatizzano questa lotta e che i Misteri del popolo sono intramezzati da lettere del Sue ai lettori (delle dispense) in cui tale lotta è esposta in forma storico‑politica, come il Sue poteva e sapeva fare. Alla polemica parteciparono giornali e riviste (per es. la «Revue des deux Mondes» nei primi anni di pubblicazione riassunse la quistione, in forma moderata, contro il fanatismo di qualche nobile che esagerava). La stessa quistione, nella storiografia francese, si ripresentò per i rapporti tra Galli e Romani e sono le voluminose trattazioni dello Jullian sulla storia della Gallia. È da notare che da tale discussione si originano (almeno parzialmente) due tendenze: 1) quella della filosofia della prassi, che dallo studio dei due strati della popolazione francese come strati di origine nazionale diversa passò allo studio della funzione economico‑sociale degli strati medesimi; 2) quella del razzismo e della superiorità della razza germanica, che, da elemento polemico dell’aristocrazia francese per giustificare una Restaurazione più radicale, un ritorno integrale alle condizioni del regime prerivoluzionario, divenne, attraverso Gobineau e Chamberlain, un elemento della cultura tedesca (d’importazione francese) con sviluppi nuovi e impensati.
In Italia la quistione non poteva attecchire perché la feudalità d’origine germanica fu distrutta dalle Rivoluzioni comunali (eccetto che nel Mezzogiorno e in Sicilia) dando luogo a una nuova aristocrazia d’origine mercantile e autoctona.
Che una tale quistione non sia astratta e libresca, ma abbia potuto diventare una ideologia politica militante ed efficiente è stato dimostrato dagli avvenimenti tedeschi.
Q17 §44 Letteratura popolare. Che una parte della attuale poesia sia «puro secentismo» appare per confessione spontanea di alcuni critici ortodossi di essa. Per esempio Aldo Capasso in un suo saggio su Ungaretti (brano citato in «Leonardo» del marzo 1934) scrive: «L’aura attonita non potrebbe formarsi, se il poeta fosse meno laconico». L’«aura attonita» richiama la famosa definizione che «del poeta il fine è la maraviglia». Si può notare tuttavia che il secentismo classico, purtroppo, è stato popolare e continua ad esserlo tuttora (è noto come all’uomo del popolo piacciano le acrobazie d’immagini in poesia), mentre il secentismo attuale è popolare fra gli intellettuali puri.
L’Ungaretti ha scritto che le sue poesie piacevano ai suoi compagni di trincea «del popolo», e può esser vero: piacere di carattere particolare legato al sentimento che la poesia «difficile» (incomprensibile) deve esser bella e l’autore un grande uomo appunto perché staccato dal popolo e incomprensibile: ciò avvenne anche per il futurismo ed è un aspetto del culto popolare per gli intellettuali (che in verità sono ammirati e disprezzati nello stesso tempo).
Q17 §45 Passato e presente. Il compilatore dei bollettini di guerra del Comando Supremo italiano, dal maggio 1917 al novembre 1918, compreso anche l’ultimo più famoso, fu l’attuale generale Domenico Siciliani.
Q17 §46 Passato e presente. La neutralità della Svizzera nel 1934. Il consigliere Motta, capo del Dipartimento federale degli Esteri, in un discorso tenuto a Friburgo il 22 luglio, in occasione della giornata ticinese del Tiro federale, ha detto: «Finché la Svizzera sarà risoluta a difendersi, – così diceva di recente l’insigne capo del Governo italiano al signor Wagnière, nostro ministro a Roma, ed io non credo di commettere un’indiscrezione rivelando questo detto amichevole – nessuno oserà prendersi la responsabilità di toccarla».
In ogni modo l’on. Motta ha fatto sapere che «recentemente», in confronto al 22 luglio 1934, la diplomazia svizzera ha dovuto prospettare la possibilità di una aggressione contro il suo territorio al governo italiano e ne ha ricevuto parole amichevoli.
Q17 §47 Passato e presente. Al Congresso geografico tenuto a Varsavia nell’agosto 1934 il prof. Ferdinando Milone dell’Università di Bari ha presentato uno studio delle cause e degli effetti della varia distribuzione dell’industria nelle singole parti d’Italia.
Q17 §48 Distinzioni. Nello studio dei diversi «gradi» o «momenti» delle situazioni militari o politiche non si è soliti fare le doverose distinzioni tra: «causa efficiente», che prepara l’evento storico o politico di diverso grado o significato (o estensione) e la «causa determinante» che immediatamente produce l’evento ed è la risultante generale, concreta della causa efficiente, la «precipitazione» concreta degli elementi realmente attivi e necessari della causa efficiente per produrre la determinazione.
Causa efficiente e causa sufficiente, cioè «totalmente» efficiente, o almeno sufficiente nella direttrice necessaria per produrre l’evento.
Naturalmente queste distinzioni possono avere diversi momenti o gradi: cioè occorre studiare se ogni momento è efficiente (sufficiente) e determinante per il passaggio da uno sviluppo all’altro o se può essere distrutto dall’antagonista prima della sua «produttività».
Q17 §49 Principi di metodo. Prima di giudicare (e per la storia in atto o politica il giudizio è l’azione) occorre conoscere e per conoscere occorre sapere tutto ciò che è possibile sapere. Ma cosa s’intende per «conoscere»? Conoscenza libresca, statistica, «erudizione» meccanica, – conoscenza storica –, intuizione, «contatto» reale con la realtà viva e in movimento, capacità di «simpatizzare» psicologicamente fino al singolo uomo. «Limiti» della conoscenza (non cose inutili), cioè conoscenza critica, o del «necessario»: pertanto, una «concezione generale» critica.
Q17 §50 Machiavelli. Una massima del maresciallo Caviglia: «L’esperienza della meccanica applicata che la forza si esaurisce allontanandosi dal centro di produzione si ritrova dominante nell’arte della guerra. L’attacco si esaurisce avanzando; perciò la vittoria deve essere cercata quanto più è possibile nelle vicinanze del punto di partenza» (Le tre battaglie del Piave, p. 244).
Massima simile in Clausewitz. Ma lo stesso Caviglia osserva che le truppe di rottura devono essere aiutate da truppe di manovra: le truppe di rottura tendono a fermarsi dopo ottenuta la «vittoria» immediata nel loro obbiettivo di rompere il fronte avversario. Un’azione strategica ai fini non territoriali ma decisivi ed organici può essere svolta in due momenti: con la rottura del fronte avversario e con una successiva manovra, operazioni assegnate a truppe distinte.
La massima, applicata all’arte politica, deve essere adattata alle diverse condizioni; ma rimane il punto che tra il punto di partenza e l’obbiettivo occorre una gradazione organica, cioè una serie di obbiettivi parziali. Si può avvicinare alla parola d’ordine quarantottesca.
Q17 §51 Machiavelli. Nel Mein Kampf, Hitler scrive: «La fondazione o la distruzione di una religione è gesto incalcolabilmente più rilevante che la fondazione o la distruzione di uno Stato: non dico di un partito...». Superficiale e acritico: i tre elementi: religione (o concezione del mondo «attiva»), Stato, partito, sono indissolubili e nel processo reale dello sviluppo storico‑politico si passa dall’uno all’altro necessariamente. Nel Machiavelli, nei modi e nel linguaggio del tempo, si osserva la comprensione di questa necessaria omogeneità e interferenza dei tre elementi. Perdere l’anima per salvare la patria o lo Stato, è un elemento di laicismo assoluto, di concezione del mondo positiva e negativa (contro la religione o concezione dominante). Nel mondo moderno, un partito è tale, integralmente e non, come avviene, frazione di un partito più grande, quando esso è concepito, organizzato e diretto in modi e forme tali da svilupparsi integralmente in uno Stato (integrale, e non in un governo tecnicamente inteso) e in una concezione del mondo. Lo sviluppo del partito in Stato reagisce sul partito e ne domanda una continua riorganizzazione e sviluppo, così come lo sviluppo del partito e dello Stato in concezione del mondo, cioè in trasformazione totale e molecolare (individuale) dei modi di pensare e operare, reagisce sullo Stato e sul partito, costringendoli a riorganizzarsi continuamente e ponendo loro dei problemi nuovi e originali da risolvere. È evidente che tale concezione è intralciata nello sviluppo pratico dal fanatismo cieco e unilaterale di «partito» (in questo caso di setta, di frazione di un più ampio partito, nel cui seno si lotta), cioè dall’assenza sia di una concezione statale sia di una concezione del mondo che siano capaci di sviluppo in quanto storicamente necessarie. La vita politica attuale dà una larga testimonianza di queste angustie e ristrettezze mentali, che d’altronde provocano lotte drammatiche, perché esse stesse sono il modo con cui lo sviluppo storico si verifica praticamente. Ma il passato, e il passato italiano che più interessa, da Machiavelli in poi, non è meno ricco di esperienze; perché tutta la storia è testimone del presente.
Q17 §52 Argomenti di cultura. Logica formale e mentalità scientifica. Per comprendere quanto sia superficiale e fondata su deboli basi la mentalità scientifica moderna (ma forse occorrerà fare distinzione tra paese e paese) basta ricordare la recente polemica sul così detto «homo oeconomicus», concetto fondamentale della scienza economica, altrettanto plausibile e necessario quanto tutte le astrazioni su cui si basano le scienze naturali (e anche, sebbene in forma diversa, le scienze storiche o umanistiche). Se fosse ingiustificato, per la sua astrattezza, il concetto distintivo di homo oeconomicus, altrettanto ingiustificato sarebbe il simbolo H20 per l’acqua, dato che nella realtà non esiste nessuna acqua H20 ma un’infinita quantità di «acque» individuali. L’obbiezione nominalista volgare riprenderebbe tutto il suo vigore ecc.
La mentalità scientifica è debole come fenomeno di cultura popolare, ma è debole anche nel ceto degli scienziati, i quali hanno una mentalità scientifica di gruppo tecnico, cioè comprendono l’astrazione nella loro particolare scienza, ma non come «forma mentale» e ancora: comprendono la loro particolare «astrazione», il loro particolare metodo astrattivo, ma non quello delle altre scienze (mentre è da sostenere che esistono vari tipi di astrazione e che è scientifica quella mentalità che riesce a comprendere tutti i tipi di astrazione e a giustificarli). Il conflitto più grave di «mentalità» è però tra quella delle così dette scienze esatte o matematiche, che del resto non sono tutte le scienze naturali, e quelle «umanistiche» o «storiche», cioè quelle che si riferiscono all’attività storica dell’uomo, al suo intervento attivo nel processo vitale dell’universo. (È da analizzare il giudizio di Hegel sull’economia politica e appunto sulla capacità dimostrata dagli economisti di «astrarre» in questo campo).
Q17 §53 Problemi di cultura. Disraeli. Perché Disraeli comprese, meglio di ogni altro capo di governo inglese, le necessità imperiali? Si può fare un paragone tra Disraeli e Cesare. Ma Disraeli non riuscì a impostare il problema della trasformazione dell’impero britannico e non ebbe continuatori: l’inglesismo ha impedito la fusione in una sola classe imperiale unificata dei gruppi nazionali che necessariamente si andavano formando in tutte le terre dell’impero. È evidente che l’impero inglese non poteva fondarsi sotto un’impalcatura burocratico‑militare come avvenne per quello romano: fecondità del programma di un «parlamento imperiale» pensato da Disraeli. Ma questo parlamento imperiale avrebbe dovuto legiferare anche per l’Inghilterra, cosa assurda per un inglese: solo un semita spregiudicato come Disraeli poteva essere l’espressione dell’imperialismo organico inglese. Fenomeni storici analoghi moderni.
QUADERNO 18
NICCOLÒ MACHIAVELLI II
Q18 §1 La «Rivista d’Italia» del 15 giugno 1927 è interamente
dedicata al Machiavelli in occasione del IV centenario della
morte. Eccone l’indice: 1) Charles Benoist, Le Machiavélisme
perpétuel; 2) Filippo Meda, Il machiavellismo; 3) Guido Mazzoni,
Il Machiavelli drammaturgo; 4) Michele Scherillo, Le prime
esperienze politiche del Machiavelli; 5) Vittorio Cian,
Machiavelli e Petrarca; 6) Alfredo Galletti, Niccolò Machiavelli
umanista; 7) Francesco Ercole, Il Principe; 8) Antonio Panella,
Machiavelli storico; 9) Plinio Carli, N. Machiavelli scrittore;
10) Romolo Caggese, Ciò che è vivo nel pensiero politico di
Machiavelli.
L’articolo del Mazzoni è mediocre e prolisso: erudito-storico‑divagativo. Come capita spesso a questo tipo di critici, il Mazzoni non ha ben capito il contenuto letterario della Mandragola, falsifica il carattere di messer Nicia e quindi tutto il complesso dei personaggi, che sono in funzione dell’avventura di messer Nicia; il quale non si aspettava un figlio dall’accoppiamento di sua moglie con Callimaco travestito, ma si aspettava invece di avere la moglie resa feconda per virtù dell’erba mandragola e liberata per l’accoppiamento con un estraneo dalle supposte conseguenze micidiali della pozione, che altrimenti sarebbero state subite da lui stesso. Il genere di scimunitaggine di messer Nicia è ben circoscritto e rappresentato: egli crede che la sterilità delle sue nozze non dipenda da lui stesso, vecchio, ma dalla moglie giovane ma fredda e a questa presunta infecondità della moglie vuole riparare, non col farla fecondare da un altro, ma ottenendo che da infeconda sia trasformata in feconda.
Che messer Nicia si lasci convincere a far accoppiar la moglie con uno che dovrà morire per liberarla da un presunto maleficio che altrimenti sarebbe causa di allontanamento per lui dalla moglie o di morte per lui, è un elemento comico che si trova in altre forme nella novellistica popolare dove si suol dipingere la protervia delle donne che per dare la sicurezza agli amanti si fanno possedere in presenza e col consenso del marito (motivo che, in altra forma, appare anche nel Boccaccio). Ma nella Mandragola è rappresentata la stoltezza del marito e non la protervia della donna, la cui resistenza può essere domata anzi solo con l’intervento dell’autorità materna e di quella del confessore.
L’articolo di Vittorio Cian è anche inferiore a quello del Mazzoni: la retorica stopposa del Cian trova modo di abbarbicarsi anche sul bronzo. È evidente che il Machiavelli reagisce alla tradizione petrarchesca e cerca di spiantarla, nonché di continuarla; ma il Cian vede col senno di poi infantilmente applicato, precursori da per tutto e divinazioni miracolose in ogni frasetta banale e occasionale e distende dieci pagine sull’argomento per non dire che i soliti luoghi comuni amplificati dei manuali per le scuole medie ed elementari.
Q18 §2 Pasquale Villari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, a cura di Michele Scherillo, Ed. Ulrico Hoepli, Milano, 1927, due volumi, L. 60,00. (È la ristampa della nota opera del Villari, con in meno i documenti che nell’edizione Le Monnier occupano l’intero terzo volume e parte del secondo. In questa edizione dello Scherillo i documenti sono stati elencati con cenni sommari sul loro contenuto, in modo che facilmente si può andarli a ricercare nell’edizione Le Monnier).
Q18 §3 Articolo di Luigi Cavina nella Nuova Antologia del 16 agosto 1927: Il sogno nazionale di Niccolò Machiavelli in Romagna e il governo di Francesco Guicciardini.
L’argomento del saggio è interessante, ma il Cavina non ne sa trarre tutte le conseguenze necessarie, dato il carattere superficialmente descrittivo e retorico dello scritto.
Dopo la battaglia di Pavia e la definitiva sconfitta dei Francesi, che assicurava l’egemonia spagnola nella penisola, i signori italiani sono invasi dal panico. Il Machiavelli che si era recato a Roma per consegnare personalmente a Clemente VII le Istorie Fiorentine che aveva ultimato, propone al papa di creare una milizia nazionale (significato preciso del termine) e lo convince a fare un esperimento. Il papa invia il Machiavelli in Romagna presso Francesco Guicciardini che ne era Presidente, con un breve in data 6 giugno 1525. Il Machiavelli doveva esporre al Guicciardini il suo progetto e il Guicciardini doveva dare il suo parere.
Il breve di Clemente VII deve essere tutto interessante, egli espone lo sconvolgimento in cui si trova l’Italia, così grande da indurre a cercare anche rimedi nuovi e inconsueti e conclude: «Res magna est, ut iudicamus, et salus est in ea cum status ecclesiastici, tum totius Italiae ac prope universae cristianitatis reposita», dove si vede come l’Italia era per il papa il termine medio tra lo Stato ecclesiastico e la cristianità.
Perché l’esperienza in Romagna? Oltre alla fiducia che il papa aveva nella prudenza politica del Guicciardini, occorre forse pensare ad altri elementi: i Romagnoli erano buoni soldati, avevano combattuto con valore e fedeltà ad Agnadello, sia pure da mercenari. C’era poi stato in Romagna il precedente del Valentino, che aveva reclutato tra il popolo buoni soldati, ecc.
Il Guicciardini fino dal 1512 aveva scritto che il dare le armi ai cittadini «non è cosa aliena da uno vivere di repubblica e populare, perché quando vi si dà una giustizia buona e ordinate leggi, quelle armi non si adoperano in pernizie, ma in utilità della patria» e aveva lodato anche l’istituzione dell’ordinanza ideata dal Machiavelli (tentativo di creare a Firenze una milizia cittadina, che preparò la resistenza durante l’assedio).
Ma il Guicciardini non credeva possibile fare il tentativo in Romagna per le fierissime divisioni di parte che vi dominavano (interessanti i giudizi del Guicciardini sulla Romagna): i ghibellini dopo la vittoria di Pavia sono pronti ad ogni novità; anche se non si danno le armi nascerà qualche subbuglio; non si può dare le armi per opporsi agli imperiali proprio ai fautori degli imperiali. La difficoltà inoltre è accresciuta dal fatto che lo Stato è ecclesiastico, cioè senza direttive a lunga scadenza e con facili grazie e impunità, alla più lunga ad ogni nuova elezione di papa. In altro Stato le fazioni si potrebbero domare, non nello Stato della Chiesa. Poiché Clemente VII col suo breve aveva detto che al buon risultato dell’impresa occorrevano non solo ordine e diligenza, ma anche l’impegno e l’amore del popolo, il Guicciardini dice che ciò non può essere perché «la Chiesa in effetto non ci ha amici, né quelli che desidererebbero bene vivere, né per diverse ragioni i faziosi e tristi».
Ma l’iniziativa non ebbe altro seguito, perché il papa lasciò cadere il progetto. L’episodio è tuttavia del massimo interesse, per mostrare quanto grande fosse la volontà e la virtù di persuasione del Machiavelli, per i giudizi pratici immediati del Guicciardini e anche per l’atteggiamento del papa che evidentemente rimase per qualche tempo sotto l’influsso del Machiavelli; il breve può assumersi come un compendio della concezione del Machiavelli adattata alla mentalità pontificia.
Non si conoscono le ragioni che il Machiavelli (deve) aver contrapposto alle osservazioni del Guicciardini, perché questi non ne parla nelle sue lettere e le lettere del Machiavelli a Roma non si conoscono. Si può osservare che le innovazioni militari sostenute dal Machiavelli non potevano essere improvvisate in pieno sviluppo dell’invasione spagnola e che le sue proposte al papa in quel momento non potevano avere risultati concreti.
QUADERNO 19
Q19 §1 Una doppia serie di ricerche. Una sull’Età del Risorgimento e una seconda sulla precedente storia che ha avuto luogo nella penisola italiana, in quanto ha creato elementi culturali che hanno avuto una ripercussione nell’Età del Risorgimento (ripercussione positiva e negativa) e continuano a operare (sia pure come dati ideologici di propaganda) anche nella vita nazionale italiana così come è stata formata dal Risorgimento. Questa seconda serie dovrebbe essere una raccolta di saggi su quelle epoche della storia europea e mondiale che hanno avuto un riflesso nella penisola. Per esempio:
1) I diversi significati che ha avuto la parola «Italia» nei diversi tempi, prendendo lo spunto dal noto saggio del prof. Carlo Cipolla (che dovrebbe essere completato e aggiornato).
2) Il periodo di storia romana che segna il passaggio dalla Repubblica all’Impero, in quanto crea la cornice generale di alcune tendenze ideologiche della futura nazione italiana. Non pare sia compreso che proprio Cesare ed Augusto in realtà modificano radicalmente la posizione relativa di Roma e della penisola nell’equilibrio del mondo classico, togliendo all’Italia l’egemonia «territoriale» e trasferendo la funzione egemonica a una classe «imperiale» cioè supernazionale. Se è vero che Cesare continua e conclude il movimento democratico dei Gracchi, di Mario, di Catilina, è anche vero che Cesare vince in quanto il problema, che per i Gracchi, per Mario, per Catilina si poneva come problema da risolversi nella penisola, a Roma, per Cesare si pone nella cornice di tutto l’impero, di cui la penisola è una parte e Roma la capitale «burocratica»; e ciò anche solo fino a un certo punto. Questo nesso storico è della massima importanza per la storia della penisola e di Roma, poiché è l’inizio del processo di «snazionalizzazione» di Roma e della penisola e del suo diventare un «terreno cosmopolitico». L’aristocrazia romana, che aveva, nei modi e coi mezzi adeguati ai tempi, unificato la penisola e creato una base di sviluppo nazionale, è soverchiata dalle forze imperiali e dai problemi che essa stessa ha suscitato: il nodo storico‑politico viene sciolto da Cesare con la spada e si inizia un’epoca nuova, in cui l’Oriente ha un peso talmente grande che finisce per soverchiare l’Occidente e portare a una frattura tra le due parti dell’Impero.
3) Medio Evo o Età dei Comuni, in cui si costituiscono molecolarmente i nuovi gruppi sociali cittadini, senza che il processo raggiunga la fase più alta di maturazione come in Francia, in Ispagna ecc.
4) Età del mercantilismo e delle monarchie assolute che appunto in Italia ha manifestazioni di scarsa portata nazionale perché la penisola è sotto l’influsso straniero, mentre nelle grandi nazioni europee i nuovi gruppi sociali cittadini, inserendosi potentemente nella struttura statale a tendenza unitaria, rinvigoriscono la struttura stessa e l’unitarismo, introducono un nuovo equilibrio nelle forze sociali e si creano le condizioni di uno sviluppo rapidamente progressivo.
Questi saggi devono essere concepiti per un pubblico determinato, col fine di distruggere concezioni antiquate, scolastiche, retoriche, assorbite passivamente per le idee diffuse in un dato ambiente di cultura popolaresca, per suscitare quindi un interesse scientifico per le quistioni trattate, che perciò saranno presentate come viventi e operanti anche nel presente, come forze in movimento, sempre attuali. Le pp. 5‑10 del Quaderno non sono state utilizzate.
Q19 §2 L’Età del Risorgimento di Adolfo Omodeo,(ed. Principato, Messina). Questo libro di Adolfo Omodeo pare sia fallito nel suo complesso. Esso è il rifacimento d un manuale scolastico e del manuale conserva molti caratteri. I fatti (gli eventi) sono semplicemente descritti come pure enunciazioni da catalogo, senza nessi di necessità storica. Lo stile del libro è sciatto, spesso irritante; i giudizi sono tendenziosi, talvolta pare che l’Omodeo abbia una quistione personale con certi protagonisti della storia (per esempio coi giacobini francesi). Per ciò che si riferisce alla penisola italiana, pare che l’intenzione dell’Omodeo sarebbe dovuta essere quella di mostrare che il Risorgimento è fatto essenzialmente italiano, le cui origini devono trovarsi in Italia e non solo o prevalentemente negli sviluppi europei della Rivoluzione francese e dell’invasione napoleonica. Ma questa intenzione non è attuata in altro modo che nell’iniziare la narrazione dal 1740 invece che dal 1789 o dal 1796 o dal 1815.
Il periodo delle monarchie illuminate non è in Italia un fatto autoctono e non è «originale» italiano il movimento di pensiero connesso (Giannone e i regalisti). La monarchia illuminata pare possa dirsi la più importante derivazione politica dell’età del mercantilismo, che annunzia i tempi nuovi, la civiltà moderna nazionale; ma in Italia c’è stata un’età del mercantilismo come fenomeno nazionale? Il mercantilismo avrebbe, se organicamente sviluppato, rese ancora più profonde e forse definitive, le divisioni in Stati regionali; lo stato informe e disorganico in cui le diverse parti d’Italia vennero a trovarsi dal punto di vista economico, la non formazione di forti interessi costituiti intorno a un forte sistema mercantilistico‑statale, permisero o resero più facile l’unificazione dell’età del Risorgimento.
Pare poi che nella conversione del suo lavoro da manuale scolastico a libro di cultura generale col titolo di Età del Risorgimento, l’Omodeo avrebbe dovuto mutarne tutta l’economia (la struttura), riducendo la parte europea e dilatando la parte italiana. Dal punto di vista europeo, l’età è quella della Rivoluzione francese e non del Risorgimento italiano, del liberalismo come concezione generale della vita e come nuova forma di civiltà statale e di cultura, e non solo dell’aspetto «nazionale» del liberalismo. È certo possibile parlare di un’età del Risorgimento, ma allora occorre rstringere la prospettiva e mettere a fuoco l’Italia e non l’Europa, svolgendo della storia europea e mondiale solo quei nessi che modificano la struttura generale dei rapporti di forza internazionali che si opponevano alla formazione di un grande Stato unitario nella penisola, mortificando ogni iniziativa in questo senso e soffocandola in sul nascere e svolgendo la trattazione di quelle correnti che invece dal mondo internazionale influivano in Italia, incoraggiandone le forze autonome e locali della stessa natura e rendendole più valide. Esiste cioè un’Età del Risorgimento nella storia svoltasi nella penisola italiana, non esiste nella storia dell’Europa come tale: in questa corrisponde l’Età della Rivoluzione Francese e del liberalismo (come è stata trattata dal Croce, in modo manchevole, perché nel quadro del Croce manca la premessa, la rivoluzione in Francia e le guerre successive: le derivazioni storiche sono presentate come fatti a sé, autonomi, che hanno in sé le proprie ragioni di essere e non come parte di uno stesso nesso storico, di cui la Rivoluzione francese e le guerre non possono non essere elemento essenziale e necessario).
Cosa significa o può significare il fatto che l’Omodeo inizia la sua narrazione dalla pace di Aquisgrana, che pone termine alla guerra per la successione di Spagna? L’Omodeo non «ragiona», non «giustifica» questo suo criterio metodico, non mostra che esso sia l’espressione di ciò che un determinato nesso storico europeo è nello stesso tempo nesso storico italiano, da inserire necessariamente nello sviluppo della vita nazionale italiana. Ciò invece può e deve essere «dichiarato». La personalità nazionale (come la personalità individuale) è una mera astrazione se considerata fuori dal nesso internazionale (o sociale). La personalità nazionale esprime un «distinto» del complesso internazionale, pertanto è legata ai rapporti internazionali. C’è un periodo di dominio straniero in Italia, per un certo tempo dominio diretto, posteriormente di carattere egemonico (o misto, di dominio diretto e di egemonia). La caduta della penisola sotto la dominazione straniera nel Cinquecento aveva già provocato una reazione: quella di indirizzo nazionale‑democratico del Machiavelli che esprimeva nello stesso tempo il rimpianto per la perduta indipendenza in una determinata forma (quella dell’equilibrio interno fra gli Stati italiani sotto l’egemonia della Firenze di Lorenzo il Magnifico) e la volontà iniziale di lottare per riacquistarla in una forma storicamente superiore, come principato assoluto sul tipo della Spagna e della Francia. Nel Settecento l’equilibrio europeo, Austria‑Francia, entra in una fase nuova per rispetto all’Italia: c’è un indebolimento reciproco delle due grandi potenze e sorge una terza grande potenza, la Prussia. Pertanto le origini del moto del Risorgimento, cioè del processo di formazione delle condizioni e dei rapporti internazionali che permetteranno all’Italia di riunirsi in nazione e alle forze interne nazionali di svilupparsi ed espandersi, non sono da ricercare in questo o quell’evento concreto registrato sotto una o altra data, ma appunto nello stesso processo storico per cui l’insieme del sistema europeo si trasforma. Questo processo intanto non è indipendente dagli eventi interni della penisola e dalle forze che in essa hanno la sede. Un elemento importante e talvolta decisivo dei sistemi europei era sempre stato il Papato. Nel corso del Settecento l’indebolimento della posizione del Papato come potenza europea è addirittura catastrofico. Colla Controriforma il Papato aveva modificato essenzialmente la struttura della sua potenza: si era alienato le masse popolari, si era fatto fautore di guerre sterminatrici, si era confuso con le classi dominanti in modo irrimediabile. Aveva così perduto la capacità di influire sia direttamente sia indirettamente sui governi attraverso la pressione delle masse popolari fanatiche e fanatizzate: è degno di nota che proprio mentre il Bellarmino elaborava la sua teoria del dominio indiretto della Chiesa, la Chiesa, con la sua concreta attività, distruggeva le condizioni di ogni suo dominio, anche indiretto, staccandosi dalle masse popolari. La politica regalista delle monarchie illuminate è la manifestazione di questo esautoramento della Chiesa come potenza europea e quindi italiana, e inizia anch’essa il Risorgimento, se è vero, come è vero, che il Risorgimento era possibile solo in funzione di un indebolimento del Papato sia come potenza europea che come potenza italiana, cioè come possibile forza che riorganizzasse gli Stati della penisola sotto la sua egemonia. Ma tutti questi sono elementi condizionanti; una dimostrazione, storicamente valida, che già nel Settecento si fossero costituite in Italia delle forze che tendessero concretamente a fare della penisola un organismo politico unitario e indipendente non è stata ancora fatta.
Q19 §3 Le origini del Risorgimento. Le ricerche sulle origini del moto nazionale del Risorgimento sono quasi sempre viziate dalla tendenziosità politica immediata, non solo da parte degli scrittori italiani, ma anche da parte di quelli stranieri, specialmente francesi (o sotto l’influsso della cultura francese). C’è una «dottrina» francese sulle origini del Risorgimento, secondo la quale la nazione italiana deve la sua fortuna alla Francia, specialmente ai due Napoleoni e questa dottrina ha anche il suo aspetto polemico‑negativo: i nazionalisti monarchici (Bainville) muovono ai due Napoleoni (e alle tendenze democratiche in genere suscitate dalla Rivoluzione) il rimprovero di aver indebolito la posizione relativa della Francia in Europa con la loro politica «nazionalitaria», cioè di essere stati contro la tradizione e gli interessi della nazione francese, rappresentati dalla monarchia e dai partiti di destra (clericali) sempre antitaliani e che consisterebbero nell’avere per vicini conglomerati di staterelli, come erano la Germania e l’Italia nel Settecento.
In Italia le quistioni «tendenziali e tendenziose» poste a questo proposito sono: 1) la tesi democratica francofila, secondo cui il moto è dovuto alla Rivoluzione francese e ne è una derivazione diretta, che ha determinato la tesi opposta; 2) la Rivoluzione francese col suo intervento nella penisola ha interrotto il movimento «veramente» nazionale, tesi che ha un doppio aspetto: a) quello gesuitico (per i quali i sanfedisti erano il solo elemento «nazionale» rispettabile e legittimo), e b) quello moderato che si riferisce piuttosto ai principi riformatori, alle monarchie illuminate. Qualcuno poi aggiunge: c) il movimento riformatore era stato interrotto per il panico suscitato dagli avvenimenti di Francia, quindi l’intervento degli eserciti francesi in Italia non interruppe il movimento indigeno, ma anzi ne rese possibile la ripresa e il compimento.
Molti di questi elementi sono svolti in quella letteratura a cui si accenna sotto la rubrica «Interpretazioni del Risorgimento Italiano», letteratura che se ha un significato nella storia della cultura politica, non ne ha che scarso in quello della storiografia.
In un articolo, assai notevole, di Gioacchino Volpe, Una scuola per la storia dell’Italia moderna (nel «Corriere della Sera» del 9 gennaio 1932) è scritto: «Tutti lo sanno: per capire il “Risorgimento” non basta spingersi al 1815 e neppure al 1796, l’anno in cui Napoleone irruppe nella Penisola e vi suscitò la tempesta. Il “Risorgimento”, come ripresa di vita italiana, come formazione di una nuova borghesia, come consapevolezza crescente di problemi non solo municipali e regionali ma nazionali, come sensibilità a certe esigenze ideali, bisogna cercarlo parecchio prima della Rivoluzione: è anche esso sintomo, uno dei sintomi, di una Rivoluzione in marcia, non solo francese, ma, in certo senso, mondiale. Tutti egualmente sanno che la storia del Risorgimento non si studia solo coi documenti italiani, e come fatto solamente italiano, ma nel quadro della vita europea; trattisi di correnti di cultura, di trasformazioni economiche, di situazioni internazionali nuove, che sollecitano gli italiani a nuovi pensieri, a nuove attività, a nuovo assetto politico».
In queste parole del Volpe è riassunto ciò che avrebbe voluto essere il fine dell’Omodeo nel suo libro, ma che nell’Omodeo rimane sconnesso ed esteriore. Si ha l’impressione che sia per il titolo, sia per l’impostazione cronologica, il libro dell’Omodeo abbia solo voluto rendere un omaggio «polemico» alla tendenziosità storica e non alla storia, per ragioni di «concorrenza» opportunistica poco chiare e in ogni modo poco pregevoli.
Nel Settecento, mutate le condizioni relative della penisola nel quadro dei rapporti europei, sia per ciò che riguarda la pressione egemonica delle grandi potenze che non potevano permettere il sorgere di uno Stato italiano unitario, sia per ciò che riguarda la posizione di potenza politica (in Italia) e culturale (in Europa) del Papato (e tanto meno le grandi potenze europee potevano permettere uno Stato unificato italiano sotto la supremazia del Papa, cioè permettere che la funzione culturale della Chiesa e la sua diplomazia, già abbastanza ingombranti e limitatrici del potere statale nei paesi cattolici, si rafforzassero appoggiandosi a un grande Stato territoriale e a un esercito corrispondente) muta anche l’importanza e il significato della tradizione letterario-rettorica esaltante il passato romano, la gloria dei Comuni e del Rinascimento, la funzione universale del Papato italiano. Questa atmosfera culturale italiana era rimasta fin’allora indistinta e generica; essa giovava specialmente al Papato, formava il terreno ideologico della potenza papale nel mondo, l’elemento discriminativo per la scelta e l’educazione del personale ecclesiastico e laico‑ecclesiastico, di cui il Papato aveva bisogno per la sua organizzazione pratico‑amministrativa, per centralizzare l’organismo chiesastico e il suo influsso, per tutto l’insieme dell’attività politica, filosofica, giuridica, pubblicistica, culturale che costituiva la macchina per l’esercizio del potere indiretto, dopo che, nel periodo precedente la Riforma, era servita all’esercizio del potere diretto o di quelle funzioni di potere diretto che potevano concretamente attuarsi nel sistema di rapporti di forza interni di ogni singolo paese cattolico. Nel Settecento si inizia un processo di distinzione in questa corrente tradizionale: una parte sempre più coscientemente (per programma esplicito) si connette con l’istituto del Papato come espressione di una funzione intellettuale (etico‑politica, di egemonia intellettuale e civile) dell’Italia nel mondo e finirà con l’esprimere il Primato giobertiano (e il neoguelfismo, attraverso una serie di movimenti più o meno equivoci, come il sanfedismo e il primo periodo del lamennesismo, che sono esaminati nella rubrica dell’«Azione cattolica» e le sue origini) e successivamente con il concretarsi in forma organica, sotto la direzione immediata dello stesso Vaticano, del movimento di Azione Cattolica, in cui la funzione dell’Italia come nazione è ridotta al minimo (all’opposto di quella parte del personale centrale vaticano che è italiano, ma non può mettere in prima linea, come una volta, il suo essere italiano); e si sviluppa una parte «laica», anzi in opposizione al papato, che cerca rivendicare una funzione di primato italiano e di missione italiana nel mondo indipendentemente dal Papato. Questa seconda parte, che non può mai riferirsi a un organismo ancora così potente come la Chiesa romana e manca pertanto di un punto unico di centralizzazione, non ha la stessa compattezza, omogeneità, disciplina dell’altra, ha varie linee spezzate di sviluppo e si può dire confluisca nel mazzinianismo.
Ciò che è importante storicamente è che nel Settecento questa tradizione cominci a disgregarsi per meglio concretarsi, e a muoversi con una intima dialettica: significa che tale tradizione letterario‑retorica sta diventando un fermento politico, il suscitatore e l’organizzatore del terreno ideologico in cui le forze politiche effettive riusciranno a determinare lo schieramento, sia pure tumultuario, delle più grandi masse popolari necessarie per raggiungere certi fini, riusciranno a mettere in iscacco e lo stesso Vaticano e le altre forze di reazione esistenti nella penisola accanto al Papato. Che il movimento liberale sia riuscito a suscitare la forza cattolico‑liberale e a ottenere che lo stesso Pio IX si ponesse, sia pure per poco, nel terreno del liberalismo (quanto fu sufficiente per disgregare l’apparato politico‑ideologico del cattolicismo e togliergli la fiducia in se stesso) fu il capolavoro politico del Risorgimento e uno dei punti più importanti di risoluzione dei vecchi nodi che avevano impedito fino allora di pensare concretamente alla possibilità di uno Stato unitario italiano.
(Se questi elementi della trasformazione della tradizione culturale italiana si pongono come elemento necessario nello studio delle origini del Risorgimento, e il disfacimento di tale tradizione è concepito come fatto positivo, come condizione necessaria per il sorgere e lo svilupparsi dell’elemento attivo liberale‑nazionale, allora acquistano un certo significato, non trascurabile, movimenti come quello «giansenistico», che altrimenti apparirebbero come mere curiosità da eruditi. Si tratterebbe insomma di uno studio dei «corpi catalitici» nel campo storico‑politico italiano, elementi catalitici che non lasciano traccia di sé ma hanno avuto una insostituibile e necessaria funzione strumentale nella creazione del nuovo organismo storico).
Alberto Pingaud, autore di un libro su Bonaparte, président de la République Italienne e che sta preparando un altro libro su Le premier Royaume d’Italie (che è già stato pubblicato quasi tutto sparsamente in diversi periodici), è tra quelli che «collocano nel 1814 il punto di partenza e in Lombardia il focolare del movimento politico che ebbe termine nel 1870 con la presa di Roma». Baldo Peroni, che nella Nuova Antologia del 16 agosto 1932 passa in rassegna questi scritti ancora sparsi del Pingaud, osserva: «Il nostro Risorgimento – inteso come risveglio politico – comincia quando l’amor di patria cessa di essere una vaga aspirazione sentimentale o un motivo letterario e diventa pensiero consapevole, passione che tende a tradursi in realtà mediante un’azione che si svolge con continuità e non s’arresta dinanzi ai più duri sacrifizi. Ora, siffatta trasformazione è già avvenuta nell’ultimo decennio del Settecento e non soltanto in Lombardia, ma anche a Napoli, in Piemonte, in quasi tutte le regioni d’Italia. I “patrioti” che tra l’89 e il 96 sono mandati in esilio o salgono il patibolo, hanno cospirato, oltre che per istaurare la repubblica, anche per dare all’Italia indipendenza e unità; e negli anni successivi è l’amore dell’indipendenza che ispira e anima l’attività di tutta la classe politica italiana, sia che collabori coi francesi e sia che tenti dei moti insurrezionali allorché appare evidente che Napoleone non vuole concedere la libertà solennemente promessa».
Il Peroni, in ogni modo, non ritiene che il moto italiano sia da ricercarsi prima del 1789, cioè afferma una dipendenza del Risorgimento dalla Rivoluzione francese, tesi che non è accettata dalla storiografia nazionalistica. Tuttavia appare vero quanto il Peroni afferma, se si considera il fatto specifico e di importanza decisiva, del primo aggruppamento di elementi politici che si svilupperà fino a formare l’insieme dei partiti che saranno i protagonisti del Risorgimento. Se nel corso del Settecento cominciano ad apparire e a consolidarsi le condizioni obbiettive, internazionali e nazionali, che fanno dell’unificazione nazionale un compito storicamente concreto (cioè non solo possibile, ma necessario), è certo che solo dopo l’89 questo compito diventa consapevole in gruppi di cittadini disposti alla lotta e al sacrificio. La Rivoluzione francese, cioè, è uno degli eventi europei che maggiormente operano per approfondire un movimento già iniziato nelle «cose», rafforzando le condizioni positive (oggettive e soggettive) del movimento stesso e funzionando come elemento di aggregazione e centralizzazione delle forze umane disperse in tutta la penisola e che altrimenti avrebbero tardato di più a «incentrarsi» e comprendersi tra loro.
Su questo stesso argomento è da vedere l’articolo di Gioacchino Volpe: Storici del Risorgimento a Congresso nell’«Educazione Fascista» del luglio 1932. Il Volpe informa sul Ventesimo Congresso della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento, tenuto a Roma nel maggio‑giugno 1932. La storia del Risorgimento fu prima concepita prevalentemente come «storia del patriottismo italiano». Poi essa cominciò ad approfondirsi, «ad essere vista come vita italiana del XIX secolo e quasi dissolta nel quadro di quella vita, presa tutta in un processo di trasformazione, coordinazione, unificazione, ideali e vita pratica, coltura e politica, interessi privati e pubblici». Dal secolo XIX si risalì al secolo XVIII e si videro nessi prima nascosti, ecc. Il secolo XVIII «fu visto dall’angolo visuale del Risorgimento, anzi come Risorgimento anch’esso: con la sua borghesia ormai nazionale; con il suo liberalismo che investe la vita economica e la vita religiosa e poi quella politica e che non è tanto un “principio” quanto una esigenza di produttori; con quelle prime concrete aspirazioni ad “una qualche forma di unità” (Genovesi), per la insufficienza dei singoli Stati, ormai riconosciuta, a fronteggiare, con la loro ristretta economia, la invadente economia di paesi tanto più vasti e forti. Nello stesso secolo si delineava anche una nuova situazione internazIonale. Entravano cioè nel pieno giuoco forze politiche europee interessate ad un assetto più indipendente e coerente e meno staticamente equilibrato della penisola italiana. Insomma, una «realtà nuova italiana ed europea, che dà significato e valore anche al nazionalismo dei letterati, riemerso dopo il cosmopolitismo dell’età precedente».
Il Volpe non accenna specificatamente al rapporto nazionale e internazionale rappresentato dalla Chiesa, che anch’essa subisce nel secolo XVIII una radicale trasformazione lo scioglimento della Compagnia di Gesù in cui culmina il rafforzarsi dello Stato laico contro l’ingerenza ecclesiastica ecc. Si può dire che oggi, per la storiografia del Risorgimento, dato il nuovo influsso esercitato dopo il Concordato, il Vaticano è diventato una delle maggiori, se non la maggiore, forze di remora scientifica e di «maltusianismo» metodico. Precedentemente, accanto a questa forza, che è stata sempre molto rilevante, esercitavano una funzione restrittiva dell’orizzonte storico la monarchia e la paura del separatismo. Molti lavori storici non furono pubblicati per questa ragione (per esempio, qualche libro di storia della Sardegna del barone Manno, l’episodio Bollea durante la guerra ecc.). I pubblicisti repubblicani si erano specializzati nella storia «libellistica», sfruttando ogni opera storica che ricostruisse scientificamente gli avvenimenti del Risorgimento: ne conseguì una limitazione delle ricerche, un prolungarsi della storiografia apologetica, la impossibilità di sfruttare gli Archivi ecc.; insomma, tutta la meschinità della storiografia del Risorgimento quando la si paragoni a quella della Rivoluzione francese. Oggi le preoccupazioni monarchiche e separatiste si sono andate assottigliando, ma sono cresciute quelle vaticanesche e clericali. Una gran parte degli attacchi alla Storia dell’Europa del Croce hanno avuto evidentemente questa origine: così si spiega anche l’interruzione dell’opera di Francesco Salata Per la storia diplomatica della Questione Romana il cui primo volume è del 1929 ed è rimasto senza seguito.
Nel Ventesimo Congresso della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento sono stati trattati argomenti che interessano in sommo grado questa rubrica. Lo studio di Pietro Silva: Il problema italiano nella diplomazia europea del XVIII secolo è così riassunto dal Volpe (nell’articolo citato): «Il XVIII secolo vuol dire influenza di grandi potenze in Italia ma anche loro contrasti; e perciò, progressiva diminuzione del dominio diretto straniero e sviluppo di due forti organismi statali a nord e a sud. Col trattato di Aranjuez tra Francia e Spagna, 1752, e subito dopo, col ravvicinamento Austria‑Spagna, si inizia una stasi di quarant’anni per i due regni, pur con molti sforzi di rompere il cerchio austro‑francese, tentando approcci con Prussia, Inghilterra, Russia. Ma il quarantennio segna anche lo sviluppo di quelle forze autonome che, con la Rivoluzione e con la rottura del sistema austro‑francese, scenderanno in campo per un soluzione in senso nazionale ed unitario de problema italiano. Ed ecco le riforme ed i principi riformatori, oggetto, gli ultimi tempi, di molti studi, per il regno di Napoli e di Sicilia, per la Toscana, Parma e Piacenza, Lombardia».
Carlo Morandi (Le riforme settecentesche nei risultati della recente storiografia) ha studiato la posizione delle riforme italiane nel quadro del riformismo europeo, e il rapporto tra riforme e Risorgimento.
Per il rapporto tra Rivoluzione francese e Risorgimento il Volpe scrive: «È innegabile che la Rivoluzione, vuoi come ideologie, vuoi come passioni, vuoi come forza armata, vuoi come Napoleone, immette elementi nuovi nel flusso in movimento della vita italiana. Non meno innegabile che l’Italia del Risorgimento, organismo vivo, assimilando l’assimilabile di quel che veniva dal di fuori e che, in quanto idee, era anche rielaborazione altrui di ciò che già si era elaborato in Italia, reagisce, insieme, ad esso, lo elimina e lo integra, in ogni modo lo supera. Essa ha tradizioni proprie, mentalità propria, problemi propri, soluzioni proprie: che son poi la vera e profonda radice, la vera caratteristica del Risorgimento, costituiscono la sua sostanziale continuità con l’età precedente, lo rendono capace alla sua volta di esercitare anche esso una sua azione su altri paesi; nel modo come tali azioni si possono, non miracolisticamente ma storicamente, esercitare, entro il cerchio di popoli vicini e affini».
Queste osservazioni del Volpe non sono sempre esatte: come si può parlare di «tradizioni, mentalità, problemi, soluzioni» propri dell’Italia? O almeno, cosa ciò significa concretamente? Le tradizioni, le mentalità i problemi, le soluzioni erano molteplici, contraddittori, di natura spesso solo individuale e arbitraria e non erano allora mai visti unitariamente. Le forze tendenti all’unità erano scarsissime, disperse, senza nesso tra loro e senza capacità di suscitare legami reciproci e ciò non solo nel secolo XVIII, ma si può dire fino al 1848. Le forze contrastanti a quelle unitarie (o meglio tendenzialmente unitarie) erano invece potentissime, coalizzate, e, specialmente come Chiesa, assorbivano la maggior parte delle capacità ed energie individuali che avrebbero potuto costituire un nuovo personale dirigente nazionale, dando loro invece un indirizzo e un’educazione cosmopolitico‑clericale. I fattori internazionali e specialmente la Rivoluzione francese, stremando queste forze reazionarie e logorandole, potenziano per contraccolpo le forze nazionali in se stesse scarse e insufficienti. È questo il contributo più importante della Rivoluzione francese, molto difficile da valutare e definire, ma che si intuisce di peso decisivo nel dare l’avviata al moto del Risorgimento.
Tra le altre memorie presentate al Congresso è da notare quella di Giacomo Lumbroso su La reazione popolare contro i francesi alla fine del 1700. Il Lumbroso sostiene che «le masse popolari, specialmente contadinesche, reagiscono non perché sobillate dai nobili e neppur per amor di quieto vivere (difatti, impugnarono le armi!) ma, in parte almeno, per un oscuro e confuso amor patrio o attaccamento alla loro terra, alle loro istituzioni, alla loro indipendenza (!?): donde il frequente appello al sentimento nazionale degli Italiani, che fanno i “reazionari” già nel 1799», ma la quistione è mal posta così e piena di equivoci. Intanto non si parla della «sobillazione» dei preti molto più efficace di quella dei nobili (che non erano così contrari alle nuove idee come appare dalla Repubblica partenopea); e poi cosa significa la parentesi ironica del Volpe secondo il quale pare non si possa parlare di amore del quieto vivere quando si impugnano le armi? La contraddizione è solo verbale: «quieto vivere» è inteso in senso politico di misoneismo e conservatorismo e non esclude per nulla la difesa armata delle proprie posizioni sociali. Inoltre la quistione dell’atteggiamento delle masse popolari non può essere impostata indipendentemente da quella delle classi dirigenti, perché le masse popolari possono insorgere per ragioni immediate e contingenti contro «stranieri» invasori in quanto nessuno ha loro insegnato a conoscere e seguire un indirizzo politico diverso da quello localistico e ristretto. Le reazioni spontanee (in quanto lo sono) delle masse popolari possono solo servire a indicare la «forza» di direzione delle classi alte; in Italia i liberali‑borghesi trascurarono sempre le masse popolari. Il Volpe avrebbe dovuto a questo punto prendere posizione a proposito di quella letteratura sul Risorgimento equivoca e unilaterale, di cui il Lumbroso ha dato lo specimen più caratteristico: chi è «patriota» o «nazionale» nel senso del Lumbroso, l’ammiraglio Caracciolo impiccato dagli Inglesi o il contadino che insorge contro i francesi? Domenico Cirillo o Fra Diavolo? E perché la politica filoinglese e il denaro inglese devono essere più nazionali delle idee politiche francesi?
Q19 §4 Bibliografia. Sullo sviluppo autonomo di una nuova vita civile e statale in Italia prima del Risorgimento sta preparando un lavoro Raffaele Ciasca; ne è stata pubblicata l’introduzione: Raffaele Ciasca, Germogli di vita nuova nel 700 italiano (negli «Annali della Facoltà di Filosofia e Lettere della R. Università di Cagliari, 1930‑31, estratto di pp. 21, in 8°). Il Ciasca studia le «trasformazioni che nel corso del secolo XVIII e specialmente nella seconda metà di esso si va compiendo nella vita di quasi tutte le regioni d’Italia, e che non si limita a riforme frammentarie imposte da principi illuminati e poco sentite dalla popolazione, ma investe tutta la costituzione statale, tutta la struttura economica del paese, tutti i rapporti fra le classi e si manifesta nelle correnti predominanti nel pensiero politico, sociale ed economico» («Nuova Rivista Storica» del 1931, p. 577). Le riforme amministrative e finanziarie, la politica ecclesiastica, la storia del pensiero erano già state studiate; il Ciasca porta un contributo nuovo per lo studio della vita economica del tempo.
Francesco Lemmi, Le origini del Risorgimento Italiano, Milano, Hoepli. Dello stesso Lemmi, La Bibliografia del Risorgimento Italiano, Società Anonima Romana. Carlo Merandi, Idee e formazioni politiche in Lombardia dal 1748 al 1814, Torino, Bocca. Massimo Lelj, Il Risorgimento dello spirito italiano (1725‑1861), Milano, L’Esame, Edizioni di storia moderna, 1928.
Al XII Congresso internazionale di Scienze Storiche che si doveva tenere a Varsavia dal 21 al 28 agosto 1933, dovevano essere presentate le seguenti relazioni sul Risorgimento: 1°) G. Volpe, I rapporti politici diplomatici tra le grandi potenze europee e l’Italia durante il Risorgimento; 2°) A. C. Jemolo, L’Italia religiosa del secolo XVIII; 3°) Pietro Silva, Forze e iniziative nazionali ed influenze straniere nell’opera dell’assolutismo illuminato in Italia.
Q19 §5 Interpretazioni del Risorgimento. Esiste una notevole quantità di interpretazioni, le più disparate, del Risorgimento. La stessa quantità di esse è un segno caratteristico della letteratura storico‑politica italiana e della situazione degli studi sul Risorgimento. Perché un evento o un processo di avvenimenti storici possa dar luogo a un tal genere di letteratura occorre pensare: che esso sia poco chiaro e giustificato nel suo sviluppo per la insufficienza delle forze «intime» che pare lo abbiano prodotto, per la scarsità degli elementi oggettivi «nazionali» ai quali fare riferimento, per la inconsistenza e gelatinosità dell’organismo studiato (e infatti spesso si è sentito accennare al «miracolo» del Risorgimento). Né può giustificare una simile letteratura la scarsezza dei documenti (difficoltà di ricerche negli Archivi, ecc.), poiché, in tal caso, l’intero corso dello svolgimento potrebbe essere documento di se stesso: anzi è appunto evidente che la debolezza organica di un complesso «vertebrato» in questo corso di svolgimento è la origine di questo sfrenarsi del «soggettivismo» arbitrario, spesso bizzarro e strampalato. In generale si può dire che il significato dell’insieme di queste interpretazioni è di carattere politico immediato e ideologico e non storico. Anche la loro portata nazionale è scarsa, sia per la troppa tendenziosità, sia per l’assenza di ogni apporto costruttivo, sia per il carattere troppo astratto, spesso bizzarro e romanzato. Si può notare che tale letteratura fiorisce nei momenti più caratteristici di crisi politico-sociale, quando il distacco tra governanti e governati si fa più grave e pare annunziare eventi catastrofici per la vita nazionale; il panico si diffonde tra certi gruppi intellettuali più sensibili e si moltiplicano i conati per determinare una riorganizzazione delle forze politiche esistenti, per suscitare nuove correnti ideologiche nei logori e poco consistenti organismi di partito o per esalare i sospiri e gemiti di disperazione e di nero pessimismo. Una classificazione razionale di questa letteratura sarebbe necessaria e piena di significato. Per ora si può fissare provvisoriamente qualche punto di riferimento: 1) un gruppo di interpretazioni in senso stretto, come può essere quella contenuta nella Lotta politica in Italia e negli altri scritti di polemica politico‑culturale di Alfredo Oriani, che ne ha determinato tutta una serie attraverso gli scritti di Mario Missiroli; come quelle di Piero Gobetti e di Guido Dorso; 2) un gruppo di carattere più sostanziale e serio, con pretese di serietà e rigore storiografico, come quelle del Croce, del Solmi, del Salvatorelli; 3) le interpretazioni di Curzio Malaparte (sull’Italia Barbara, sulla lotta contro la Riforma protestante ecc.), di Carlo Curcio (L’eredità del Risorgimento, Firenze, La Nuova Italia, 1931, pp. 114, L. 12) ecc.
Occorre ricordare gli scritti di E. Montefredini (cfr il saggio del Croce in proposito nella Letteratura della nuova Italia) fra le «bizzarrie» e quelli di Aldo Ferrari (in volumi e volumetti e in articoli della «Nuova Rivista Storica») come bizzarrie e romanzo nel tempo stesso; così il volumetto di Vincenzo Cardarelli, Parole all’Italia (ed. Vallecchi, 1931).
Un altro gruppo importante è rappresentato da libri come quello di Gaetano Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, pubblicato la prima volta nel 1883 e ristampato nel 1925 (Milano, Soc. An. Istituto Editoriale Scientifico, in 8°, pp. 301, L. 25); come il libro di Pasquale Turiello, Governo e governati; di Leone Carpi, L’Italia vivente; di Luigi Zini, Dei criteri e dei modi di governo; di Giorgio Arcoleo, Governo di Gabinetto; di Marco Minghetti, I partiti politici e la loro influenza nella giustizia e nell’amministrazione; libri di stranieri, come quello del Laveleye, Lettere d’Italia; del von Loher, La nuova Italia e anche del Brachet, L’Italie qu’on voit et l’Italie qu’on ne voit pas; oltre ad articoli della «Nuova Antologia» e della «Rassegna Settimanale» (del Sonnino), di Pasquale Villari, di R. Bonghi, di G. Palma ecc., fino all’articolo famoso del Sonnino nella «Nuova Antologia», Torniamo allo Statuto!.
Questa letteratura è una conseguenza della caduta della Destra storica, dell’avvento al potere della così detta Sinistra e delle innovazioni «di fatto» introdotte nel regime costituzionale per avviarlo a una forma di regime parlamentare. In gran parte sono lamentele, recriminazioni, giudizi pessimistici e catastrofici sulla situazione nazionale e a tale fenomeno accenna il Croce nei primi capitoli della sua Storia d’Italia dal 1871 al 1915; a questa manifestazione si contrappone la letteratura degli epigoni del Partito d’Azione (tipico il libro postumo dell’abate Luigi Anelli, stampato recentemente, con e commenti, da Arcangelo Ghisleri) sia in volumi che in opuscoli e in articoli di rivista, compresi i più recenti pubblicisti del partito repubblicano.
Si può notare questo nesso tra le varie epoche di fioritura di tale letteratura pseudo‑storica e pseudo‑critica: 1) letteratura dovuta ad elementi conservatori, furiosi per la caduta della Destra e della Consorteria (cioè per la diminuita importanza nella vita statale di certi gruppi di grandi proprietari terrieri e dell’aristocrazia, ché di una sostituzione di classe non si può parlare), fegatosa, biliosa, acrimoniosa, senza elementi costruttivi, senza riferimenti storici a una tradizione qualsiasi, perché nel passato non esiste nessun punto di riferimento reazionario che possa essere proposto per una restaurazione con un certo pudore e qualche dignità: nel passato ci sono i vecchi regimi regionali e le influenze del Papa e dell’Austria. L’«accusa» fatta al regime parlamentare di non essere «nazionale» ma copiato da esemplari stranieri rimane una vuota recriminazione senza costrutto, che nasconde solo il panico per un anche piccolo intervento delle masse popolari nella vita dello Stato; il riferimento a una «tradizione» italiana di governo è necessariamente vago e astratto perché una tale tradizione non ha prospettive storicamente apprezzabili: in tutto il passato non è mai esistita una unità territoriale‑statale italiana, la prospettiva dell’egemonia papale (propria del Medio Evo fino al periodo del dominio straniero) è già stata travolta col neoguelfismo ecc. (Questa prospettiva, infine, sarà trovata nell’epoca romana, con oscillazioni, secondo i partiti, tra la Roma repubblicana e la Roma cesarea, ma il fatto avrà un nuovo significato e sarà caratteristico di nuovi indirizzi impressi alle ideologie popolari).
Questa letteratura reazionaria precede quella del gruppo Oriani‑Missiroli, che ha un significato più popolare‑nazionale e quest’ultima precede quella del gruppo Gobetti‑Dorso, che ha ancora un altro significato più attuale. In ogni modo, anche queste due nuove tendenze mantengono un carattere astratto e letterario. Uno dei punti più interessanti trattati da esse è il problema della mancanza di una Riforma religiosa in Italia come quella protestante, problema che è posto in modo meccanico ed esteriore e ripete uno dei motivi che guidano il Masaryk nei suoi studi di storia russa.
L’insieme di questa letteratura ha importanza «documentaria» per i tempi in cui è apparsa. I libri dei «destri» dipingono la corruzione politica e morale nel periodo della Sinistra al potere, ma le pubblicazioni degli epigoni del Partito d’Azione non presentano come migliore il periodo di governo della Destra. Risulta che non c’è stato nessun cambiamento essenziale nel passaggio dalla Destra alla Sinistra: il marasma in cui si trova il paese non è dovuto al regime parlamentare (che rende solo pubblico e notorio ciò che prima rimaneva nascosto o dava luogo a pubblicazioni clandestine libellistiche) ma alla debolezza e inconsistenza organica della classe dirigente e alla grande miseria e arretratezza del paese. Politicamente la situazione è assurda: a destra stanno i clericali, il partito del Sillabo che nega in tronco tutta la civiltà moderna e boicotta lo Stato legale, non solo impedendo che si costituisca un vasto partito conservatore ma mantenendo il paese sotto l’impressione della precarietà e insicurezza del nuovo Stato unitario; nel centro stanno tutte le gamme liberali, dai moderati ai repubblicani, sui quali operano tutti i ricordi degli odii del tempo delle lotte e che si dilaniano implacabilmente; a sinistra il paese misero, arretrato, analfabeta esprime in forma sporadica, discontinua, isterica, una serie di tendenze sovversive‑anarcoidi, senza consistenza e indirizzo politico concreto, che mantengono uno stato febbrile senza avvenire costruttivo. Non esistono «partiti economici» ma gruppi di ideologi déclassés di tutte le classi, galli che annunziano un sole che mai vuole spuntare.
I libri del gruppo Mosca‑Turiello cominciarono a essere rimessi in voga negli anni precedenti la guerra (si può vedere nella «Voce» il richiamo continuo al Turiello) e il libro giovanile del Mosca fu ristampato nel 1925 con qualche nota dell’autore per ricordare che si tratta di idee del 1883 e che l’autore nel ’25 non è più d’accordo con lo scrittore ventiquattrenne del 1883. La ristampa del libro del Mosca è uno dei tanti episodi dell’incoscienza e del dilettantismo politico dei liberali nel primo e secondo dopoguerra. Del resto il libro è rozzo, incondito, scritto affrettatamente da un giovane che vuole «distinguersi» nel suo tempo con un atteggiamento estremista e con parole grosse e spesso triviali in senso reazionario. I concetti politici del Mosca sono vaghi e ondeggianti, la sua preparazione filosofica è nulla (e tale è rimasta in tutta la carriera letteraria del Mosca), i suoi principii di tecnica politica sono anch’essi vaghi e astratti e hanno carattere piuttosto giuridico. Il concetto di «classe politica», la cui affermazione diventerà il centro di tutti gli scritti di scienza politica del Mosca, è di una labilità estrema e non è ragionato né giustificato teoricamente. Tuttavia il libro del Mosca è utile come documento. L’autore vuole essere spregiudicato per programma, non avere peli sulla lingua e così finisce per mettere in vista molti aspetti della vita italiana del tempo che altrimenti non avrebbero trovato documentazione. Sulla burocrazia civile e militare, sulla polizia ecc., il Mosca offre dei quadri talvolta di maniera, ma con una sostanza di verità (per esempio, sui sottufficiali dell’esercito, sui delegati di pubblica sicurezza ecc.). Le sue osservazioni sono specialmente valevoli per la Sicilia, per l’esperienza diretta del Mosca di quell’ambiente. Nel 1925 il Mosca aveva mutato punto di vista e prospettive, il suo materiale era sorpassato, tuttavia egli ristampò il libro per vanità letteraria, pensando di immunizzarlo con qualche rella palinodica.
Sulla situazione politica italiana proprio nel 1883 e sull’atteggiamento dei clericali si può trovare qualche spunto interessante nel libro del Maresciallo Lyautey, Lettres de Jeunesse (Parigi, Grasset, 1931). Secondo il Lyautey molti italiani, tra i più devoti al Vaticano, non credevano nell’avvenire del regno; ne prevedevano la decomposizione, da cui sarebbe nata un’Alta Italia con Firenze capitale, un’Italia Meridionale con capitale Napoli, e Roma in mezzo, con sbocco al mare. Sull’esercito italiano d’allora, che in Francia era poco apprezzato, il Lyautey riferisce il giudizio del conte di Chambord: «Ne vous y trompez pas. Tout ce que j’en sais, me la (l’armée italiana) fait juger très sérieuse, très digne d’attention. Sous leurs façons un peu théâtrales et leurs plumets, les officiers y sont fort instruits, fort appliqués. C’est d’ailleurs l’opinion de mon neveu de Parme qui n’est pas payé pour les aimer».
Tutto il lavorio di interpretazione del passato italiano e la serie di costruzioni ideologiche e di romanzi storici che ne sono derivati è prevalentemente legato alla «pretesa» di trovare una unità nazionale, almeno di fatto, in tutto il periodo da Roma ad oggi (e spesso anche prima di Roma, come nel caso dei «Pelasgi» del Gioberti e in altri più recenti). Come è nata questa pretesa, come si è mantenuta e perché persiste tuttora? È un segno di forza o di debolezza? È il riflesso di formazioni sociali nuove, sicure di sé e che cercano e si creano titoli di nobiltà nel passato, oppure è invece il riflesso di una torbida «volontà di credere», un elemento di fanatismo (e di fanatizzazione) ideologico, che deve appunto «risanare» le debolezze di struttura e impedire un temuto tracollo? Quest’ultima pare la giusta interpretazione, unita al fatto della eccessiva importanza (relativamente alle formazioni economiche) degli intellettuali, cioè dei piccoli borghesi in confronto delle classi economiche arretrate e politicamente incapaci. Realmente l’unità nazionale è sentita come aleatoria, perché forze «selvagge», non conosciute con precisione, elementarmente distruttive, si agitano continuamente alla sua base. La dittatura di ferro degli intellettuali e di alcuni gruppi urbani con la proprietà terriera mantiene la sua compattezza solo sovraeccitando i suoi elementi militanti con questo mito di fatalità storica, più forte di ogni manchevolezza e di ogni inettitudine politica e militare. È su questo terreno che all’adesione organica delle masse popolari‑nazionali allo Stato si sostituisce una selezione di «volontari» della «nazione» concepita astrattamente. Nessuno ha pensato che appunto il problema posto dal Machiavelli col proclamare la necessità di sostituire milizie nazionali ai mercenari avventizi e infidi, non è risolto finché anche il «volontarismo» non sarà superato dal fatto «popolare‑nazionale» di massa, poiché il volontarismo è soluzione intermedia, equivoca, altrettanto pericolosa che il mercenarismo.
Il modo di rappresentare gli avvenimenti storici nelle interpretazioni ideologiche della formazione italiana si potrebbe chiamare «storia feticistica»: per essa infatti diventano protagonisti della storia «personaggi» astratti e mitologici. Nella Lotta politica dell’Oriani si ha il più popolare di questi schemi mitologici, quello che ha partorito una più lunga serie di figli degeneri. Vi troviamo la Federazione, l’Unità, la Rivoluzione, l’Italia ecc. Nell’Oriani è chiara una delle cause di questo modo di concepire la storia per figure mitologiche. Il canone critico che tutto lo sviluppo storico è documento di se stesso, che il presente illumina e giustifica il passato, viene meccanicizzato ed esteriorizzato e ridotto a una legge deterministica di rettilineità e di «unilinearità» (anche perché l’orizzonte storico viene ristretto ai confini geografici nazionali e l’evento avulso dal complesso della storia universale, dal sistema dei rapporti internazionali cui invece è necessariamente saldato). Il problema di ricercare le origini storiche di un evento concreto e circostanziato, la formazione dello Stato moderno italiano nel secolo XIX, viene trasformato in quello di vedere questo Stato, come Unità o come Nazione o genericamente come Italia, in tutta la storia precedente così come il pollo deve esistere nell’uovo fecondato.
Per la trattazione di questo argomento, sono da vedere le osservazioni critiche di Antonio Labriola negli Scritti vari (pp. 487‑90, pp. 317-442 passim, e nel primo dei suoi Saggi a pp. 50‑52). Su questo punto è anche da vedere il Croce nella Storia della Storiografia, II, pp. 227‑28 della Ia edizione e in tutta questa opera lo studio dell’origine «sentimentale e pratica» e la «critica impossibilità» di una «storia generale d’Italia». Altre osservazioni connesse a queste sono quelle di Antonio Labriola a proposito di una storia generale del Cristianesimo, che al Labriola sembrava inconsistente come tutte le costruzioni storiche che assumono a soggetto «enti» inesistenti (cfr III Saggio, p. 113).
Una reazione concreta nel senso indicato dal Labriola si può studiare negli scritti storici (e anche politici) del Salvemini, il quale non vuol sapere di «guelfi» e «ghibellini», uno partito della nobiltà e dell’Impero e l’altro del popolo e del Papato, perché egli dice di conoscerli solo come «partiti locali», combattenti per ragioni affatto locali, che non coincidevano con quelle del Papato e dell’Impero. Nella prefazione al suo volume sulla Rivoluzione francese si può vedere teorizzato questo atteggiamento del Salvemini con tutte le esagerazioni antistoriche che porta con sé (il volume sulla Rivoluzione francese è criticabile anche da altri punti di vista: che la Rivoluzione possa dirsi compiuta con la battaglia di Valmy è affermazione non sostenibile): «L’innumerevole varietà degli eventi rivoluzionari» si suole attribuire in blocco a un ente «Rivoluzione», invece di «assegnare ciascun fatto all’individuo o ai gruppi di individui reali, che ne furono autori». Ma se la storia si riducesse solo a questa ricerca, sarebbe ben misera cosa e diventerebbe, tra l’altro, incomprensibile. Sarà da vedere come il Salvemini concretamente risolve le incongruenze che risultano dalla sua impostazione troppo unilaterale del problema metodologico, tenendo conto di questa cautela critica: se non si conoscesse da altre opere la storia qui raccontata, e avessimo solo questo libro, ci sarebbe comprensibile la serie degli eventi descritta? Cioè si tratta di una storia «integrale» o di una storia «polemica» e polemicamente complementare che si propone solo (od ottiene senza proporselo, necessariamente) di aggiungere qualche pennellata a un quadro già abbozzato da altri? Questa cautela dovrebbe sempre essere presente in ogni critica, poiché infatti spesso si ha da fare con opere che da «sole» non sarebbero soddisfacenti, ma che possono essere molto utili nel quadro generale di una determinata cultura, come «integrative e complementari» di altri lavori o ricerche.
Scrive Adolfo Omodeo nella «Critica» del 20 luglio 1932, p. 280: «Ai patrioti offriva la tesi che allora aveva rimessa in circolazione il Salvemini: della storia del Risorgimento come piccola storia, non sufficientemente irrorata di sangue; dell’unità, dono più di una propizia fortuna che meritato acquisto degli italiani; del Risorgimento, opera di minoranze contro l’apatia della maggioranza. Questa tesi generataNel testo dell’Omodeo: «germinata». dall’incapacità del materialismo storico di apprezzare in sé la grandezza morale, senza la statistica empirica delle bigonce di sangue versato e il computo degli interessi (aveva una speciosità facile ed era destinata a correre fra tutte le riviste e i giornali e a far denigrare dagli ignoranti l’opera dura del Mazzini e del Cavour), questa tesi serviva di base al Marconi per un’argomentazione moralistica di stile vociano». (L’Omodeo scrive di Piero Marconi, morto nella guerra, e della sua pubblicazione Io udii il comandamento, Firenze, senza data).
Ma l’Omodeo stesso, nel suo libro L’Età del Risorgimento non è riuscito a dare una interpretazione e una ricostruzione che non sia estrinseca e di parata. Che il Risorgimento sia stato l’apporto italiano al grande movimento europeo del secolo XIX non significa senz’altro che l’egemonia del movimento fosse in Italia, e non significa neanche che anche dalla «maggioranza della minoranza» attiva il movimento stesso non sia stato seguito con riluttanza e obtorto collo. La grandezza individuale del Cavour e del Mazzini spicca ancor più grande nella prospettiva storica come la palma nel deserto. Le osservazioni critiche dell’Omodeo alla concezione del Risorgimento come «piccola storia» sono malevole e triviali, né egli riesce a comprendere come tale concezione sia stata l’unico tentativo un po’ serio di «nazionalizzare» le masse popolari, cioè di creare un movimento democratico con radici italiane e con esigenze italiane (è strano che il Salvatorelli, accennando in una nota della «Cultura» alla Storia d’Europa del Croce e all’Età del Risorgimento dell’Omodeo, trovi questa l’espressione di un indirizzo democratico e la storia crociana di un indirizzo più strettamente liberale conservatore).
Del resto si può osservare: se la storia del passato non si può non scrivere con gli interessi e per gli interessi attuali, la formula critica che bisogna fare la storia di ciò che il Risorgimento è stato concretamente (se non significa un richiamo al rispetto e alla completezza della documentazione) non è insufficiente e troppo ristretta? Spiegare come il Risorgimento si è fatto concretamente, quali sono le fasi del processo storico necessario che hanno culminato in quel determinato evento può essere solo un nuovo modo di ripresentare la così detta «obbiettività» esterna e meccanica. Si tratta spesso di una rivendicazione «politica» di chi è soddisfatto e nel processo al passato vede giustamente un processo al presente, una critica al presente e un programma per l’avvenire. E gruppo Croce‑Omodeo e C. sta santificando untuosamente (l’untuosità è specialmente dell’Omodeo) il periodo liberale e lo stesso libro dell’Omodeo Momenti di guerra ha questo significato: mostrare come il periodo giolittiano, tanto «diffamato», covasse nel suo intimo un «insuperabile» tesoro di idealismo e di eroismo.
Del resto queste discussioni, in quanto sono puramente di metodologia empirica, sono inconcludenti. E se scrivere storia significa fare storia del presente, è grande libro di storia quello che nel presente aiuta le forze in isviluppo a di venire più consapevoli di se stesse e quindi più concretamente attive e fattive.
Il difetto massimo di tutte queste interpretazioni ideologiche del Risorgimento consiste in ciò che esse sono state meramente ideologiche, cioè che non si rivolgevano a suscitare forze politiche attuali. Lavori di letterati, di dilettanti, costruzioni acrobatiche di uomini che volevano fare sfoggio di talento se non d’intelligenza; oppure rivolte a piccole cricche intellettuali senza avvenire, oppure scritte per giustificare forze reazionarie in agguato, imprestando loro intenzioni che non avevano e fini immaginari, e, pertanto, piccoli servizi da lacché intellettuali (il tipo più compiuto di questi lacché è Mario Missiroli) e da mercenari della scienza.
Queste interpretazioni ideologiche della formazione nazionale e statale italiana sono anche da studiare da un altro punto di vista: il loro succedersi «acritico», per spinte individuali di persone più o meno «geniali», è un documento della primitività dei vecchi partiti politici, dell’empirismo immediato di ogni azione costruttiva (compresa quella dello Stato), dell’assenza nella vita italiana di ogni movimento «vertebrato» che abbia in sé possibilità di sviluppo permanente e continuo. La mancanza di prospettiva storica nei programmi di partito, prospettiva costruita «scientificamente» cioè con serietà scrupolosa, per basare su tutto il passato i fini da raggiungere nell’avvenire e da proporre al popolo come una necessità cui collaborare consapevolmente, ha permesso appunto il fiorire di tanti romanzi ideologici, che sono in realtà la premessa (il manifesto) di movimenti politici che sono astrattamente supposti necessari, ma per suscitare i quali non si fa poi niente di pratico.
È questo un modo di procedere molto utile per facilitare le «operazioni» di quelle che sono spesso chiamate le «forze occulte» o «irresponsabili» che hanno per portavoce i «giornali indipendenti»: esse hanno bisogno ogni tanto di creare movimenti occasionali di opinione pubblica, da mantenere accesi fino al raggiungimento di determinati scopi e da lasciar poi illanguidire e morire. Sono manifestazioni come «le compagnie di ventura», vere e proprie compagnie di ventura ideologiche, pronte a servire i gruppi plutocratici o d’altra natura, spesso appunto fingendo di lottare contro la plutocrazia ecc. Organizzatore tipico di tali «compagnie» è stato Pippo Naldi, discepolo anch’egli di Oriani e regista di Mario Missiroli e delle sue improvvisazioni giornalistiche.
Sarebbe utile compilare una bibliografia completa di Mario Missiroli. Alcuni dei suoi libri: La Monarchia socialista (del 1913), Polemica liberale, Opinioni, Il colpo di Stato (del 1925), Una battaglia perduta, Italia d’oggi (del 1932), La repubblica degli accattoni (su Molinella), Amore e Faine, Date a Cesare… (1929). Un libro sul Papa, del 1917 ecc.
I motivi principali posti in circolazione dal Missiroli sono: 1°) che il Risorgimento è stato una conquista regia e non un movimento popolare; 2°) che il Risorgimento non ha risolto il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, motivo che è legato al primo, poiché «un popolo che non aveva sentito la libertà religiosa non poteva sentire la libertà politica. L’ideale dell’indipendenza e della libertà diventò patrimonio e programma di una minoranza eroica, che concepì l’unità contro l’acquiescenza delle moltitudini popolari». La mancanza della Riforma protestante in Italia spiegherebbe in ultima analisi tutto il Risorgimento e la storia moderna nazionale. Il Missiroli applica all’Italia il criterio ermeneutico applicato dal Masaryk alla storia russa (sebbene il Missiroli abbia detto di accettare la critica di Antonio Labriola contro il Masaryk storico). Come il Masaryk, Missiroli (nonostante le sue relazioni con G. Sorel) non comprende che la «riforma» intellettuale e morale (cioè «religiosa») di portata popolare nel mondo moderno c’è stata in due tempi: nel primo tempo con la diffusione dei principi della Rivoluzione francese, nel secondo tempo con la diffusione di una serie di concetti ricavati dalla filosofia della prassi e spesso contaminati con la filosofia dell’illuminismo e poi dell’evoluzionismo scientifista. Che una tale «riforma» sia stata diffusa in forme grossolane e sotto forma di opuscoletti non è istanza valevole contro il suo significato storico: non è da credere che le masse popolari influenzate dal calvinismo assorbissero concetti relativamente più elaborati e raffinati di quelli offerti da questa letteratura di opuscoli: si presenta invece la quistione dei dirigenti di tale riforma, della loro inconsistenza e assenza di carattere forte ed energico.
Né il Missiroli tenta di analizzare il perché la minoranza che ha guidato il moto del Risorgimento non sia «andata al popolo», né «ideologicamente» assumendo in proprio il programma democratico che pure giungeva al popolo attraverso le traduzioni dal francese, né «economicamente» con la riforma agraria. Ciò che «poteva» avvenire, poiché il contadiname era quasi tutto il popolo d’allora e la riforma agraria era un’esigenza fortemente sentita, mentre la Riforma protestante coincise appunto con una guerra di contadini in Germania e con conflitti tra nobili e borghesi in Francia ecc. (non bisogna dimenticare che sulla riforma agraria speculò invece l’Austria per aizzare i contadini contro i patrioti latifondisti e che i liberali conservatori, con le scuole di mutuo insegnamento e con istituzioni di mutuo soccorso o di piccolo credito su pegni popolari, cercarono solo di acquistarsi la simpatia degli artigiani e degli scarsi nuclei operai di città: l’Associazione generale degli operai di Torino ebbe tra i fondatori il Cavour). «L’unità non aveva potuto attuarsi col Papato, di sua natura universale ed organicamente ostile a tutte le libertà moderne; ma non era neppure riuscita a trionfare del Papato, contrapponendo all’idea cattolica un’idea altrettanto universale che rispondesse ugualmente alla coscienza individuale e alla coscienza del mondo rinnovato dalla Riforma e dalla Rivoluzione». Affermazioni astratte e in gran parte prive di senso.
Quale idea universale contrappose al cattolicismo la Rivoluzione francese? Perché dunque in Francia il moto fu popolare e in Italia no? La famosa minoranza italiana, «eroica» per definizione (in questi scrittori l’espressione «eroico» ha un significato puramente «estetico» o retorico e si applica a don Tazzoli come ai nobili milanesi che strisciarono dinanzi all’imperatore d’Austria, tanto che fu anche scritto un libro sul Risorgimento come di rivoluzione «senza eroi» con senso altrettanto letterario e cartaceo), che condusse il moto unitario, in realtà si interessava di interessi economici più che di formule ideali e combatté più per impedire che il popolo intervenisse nella lotta e la facesse diventare sociale (nel senso di una riforma agraria) che non contro i nemici dell’unità. Il Missiroli scrive che il nuovo fattore apparso nella storia italiana dopo l’unità, il socialismo, è stato la forma più potente assunta dalla reazione antiunitaria e antiliberale (ciò che è una sciocchezza, e non coincide con altri giudizi dello stesso Missiroli, secondo i quali il socialismo avrebbe immesso nello Stato le forze popolari prima assenti e indifferenti). Come il Missiroli stesso scrive: «Il socialismo non solo non ringagliardì la passione politica (!?), ma aiutò potentemente ad estinguerla; fu il partito dei poveri e delle plebi affamate: le quistioni economiche dovevano prendere rapidamente il sopravvento, i principi politici cedere il campo (!?) agli interessi materiali»; veniva creata una «remora, lanciando le masse alle conquiste economiche ed evitando tutte le quistioni istituzionali». Il socialismo, cioè, fece l’errore (alla rovescia) della famosa minoranza: questa parlava solo di idee astratte e di istituzioni politiche, quello trascurò la politica per la mera economia. È vero che altrove il Missiroli, proprio per ciò, loda i capi riformisti ecc.; questi motivi sono di origine orianesca e repubblicana, assunti superficialmente e senza senso di responsabilità.
Il Missiroli è, in realtà, solo quello che si chiama uno scrittore brillante; si ha l’impressione fondata che egli si infischi delle sue idee, dell’Italia e di tutto: lo interessa solo il gioco momentaneo di alcuni concetti astratti e lo interessa di cadere sempre in piedi con una nuova coccarda in petto. (Missiroli il misirizzi).
Il moto politico che condusse all’unificazione nazionale e alla formazione dello Stato italiano deve necessariamente sboccare nel nazionalismo e nell’imperialismo militaristico? Si può sostenere che questo sbocco è anacronistico e antistorico (cioè artificioso e di non lungo respiro); esso è realmente contro tutte le tradizioni italiane, romane prima, cattoliche poi. Le tradizioni sono cosmopolitiche. Che il moto politico dovesse reagire contro le tradizioni e dar luogo a un nazionalismo da intellettuali può essere spiegato, ma non si tratta di una reazione organico‑popolare. D’altronde, anche nel Risorgimento, Mazzini‑Gioberti cercano di innestare il moto nazionale nella tradizione cosmopolitica, di creare il mito di una missione dell’Italia rinata in una nuova Cosmopoli europea e mondiale, ma si tratta di un mito verbale e retorico, fondato sul passato e non sulle condizioni del presente, già formate o in processo di sviluppo (tali miti sono sempre stati un fermento di tutta la storia italiana, anche la più recente, da Q. Sella a Enrico Corradini, a D’Annunzio). Poiché un evento si è prodotto nel passato non significa che debba riprodursi nel presente e nell’avvenire; le condizioni di una espansione militare nel presente e nell’avvenire non esistono e non pare siano in processo di formazione. L’espansione moderna è di ordine finanziario‑capitalistico.
Nel presente italiano l’elemento «uomo» o è l’«uomo‑capitale» o è l’«uomo‑lavoro». L’espansione italiana può essere solo dell’uomo‑lavoro e l’intellettuale che rappresenta l’uomo-lavoro non è quello tradizionale, gonfio di retorica e di ricordi cartacei del passato. Il cosmopolitismo tradizionale italiano dovrebbe diventare un cosmopolitismo di tipo moderno, cioè tale da assicurare le condizioni migliori di sviluppo all’uomo‑lavoro italiano, in qualsiasi parte del mondo egli si trovi. Non il cittadino del mondo in quanto civis romanus o in quanto cattolico, ma in quanto produttore di civiltà. Perciò si può sostenere che la tradizione italiana si continua dialetticamente nel popolo lavoratore e nei suoi intellettuali, non nel cittadino tradizionale e nell’intellettuale tradizionale.
Il popolo italiano è quel popolo che «nazionalmente» è più interessato a una moderna forma di cosmopolitismo. Non solo l’operaio, ma il contadino e specialmente il contadino meridionale. Collaborare a ricostruire il mondo economicamente in modo unitario è nella tradizione del popolo italiano e della storia italiana, non per dominarlo egemonicamente e appropriarsi il frutto del lavoro altrui, ma per esistere e svilupparsi appunto come popolo italiano: si può dimostrare che Cesare è all’origine di questa tradizione. Il nazionalismo di marca francese è una escrescenza anacronistica nella storia italiana, propria di gente che ha la testa volta all’indietro come i dannati danteschi. La «missione» del popolo italiano è nella ripresa del cosmopolitismo romano e medioevale, ma nella sua forma più moderna e avanzata. Sia pure nazione proletaria, come voleva il Pascoli; proletaria come nazione perché è stata l’esercito di riserva dei capitalismi stranieri, perché ha dato maestranze a tutto il mondo insieme ai popoli slavi. Appunto perciò deve inserirsi nel fronte moderno di lotta per riorganizzare il mondo anche non italiano, che ha contribuito a creare col suo lavoro, ecc.
Q19 §6 La quistione italiana. Sono da vedere i discorsi tenuti dal Ministro degli Esteri Dino Grandi al Parlamento nel 1932 e le discussioni che da quei discorsi derivarono nella stampa italiana e internazionale. L’on. Grandi impostò la quistione italiana come quistione mondiale, da risolversi necessariamente insieme alle altre che costituiscono l’espressione politica della crisi generale del dopoguerra, intensificatasi nel 1929 in modo quasi catastrofico, e cioè: il problema francese della sicurezza, il problema tedesco della parità di diritti, il problema di un nuovo assetto degli Stati danubiani e balcanici. L’impostazione dell’on. Grandi è un abile tentativo di costringere ogni possibile Congresso mondiale chiamato a risolvere questi problemi (e ogni tentativo della normale attività diplomatica) ad occuparsi della «questione italiana» come elemento fondamentale della ricostruzione e pacificazione europea e mondiale. In che consiste la questione italiana secondo questa impostazione? Consiste in ciò che l’incremento demografico è in contrasto con la relativa povertà del paese, e cioè nell’esistenza di un superpopolamento. Occorrerebbe pertanto che all’Italia fosse data la possibilità di espandersi, sia economicamente, sia demograficamente ecc. Ma non pare che la quistione così impostata sia di facile soluzione e non possa dar luogo ad obbiezioni fondamentali. Se è vero che i rapporti generali internazionali, così come si vengono sempre più irrigidendo dopo il 1929, sono molto sfavorevoli all’Italia (specialmente il nazionalismo economico ed il «razzismo» che impediscono la libera circolazione non solo delle merci e dei capitali ma soprattutto del lavoro umano), può anche essere domandato se a suscitare e irrigidire tali nuovi rapporti non abbia contribuito e contribuisca tuttora la stessa politica italiana. La ricerca principale pare debba essere in questo senso: il basso saggio individuale di reddito nazionale è dovuto alla povertà «naturale» del paese oppure a condizioni storico‑sociali create e mantenute da un determinato indirizzo politico che fanno dell’economia nazionale una botte delle Danaidi? Lo Stato, cioè, non costa troppo caro, intendendo per Stato, come è necessario, non solo l’amministrazione dei servizi statali, ma anche l’insieme delle classi che lo compongono in senso stretto e lo dominano? Pertanto è possibile pensare che senza un mutamento di questi rapporti interni, la situazione possa mutare in meglio anche se internazionalmente i rapporti migliorassero? Può anche essere osservato che la proiezione nel campo internazionale della questione può essere un alibi politico di fronte alle masse del paese.
Che il reddito nazionale sia basso, può concedersi, ma non viene poi esso distrutto (divorato) dalla troppa popolazione passiva, rendendo impossibile ogni capitalizzazione progressiva, sia pure con ritmo rallentato? Dunque la quistione demografica deve essere a sua volta analizzata, e occorre stabilire se la composizione demografica sia «sana» anche per un regime capitalistico e di proprietà. La povertà relativa «naturale» dei singoli paesi nella civiltà moderna (e in tempi normali) ha una importanza anch’essa relativa; tutt’al più impedirà certi profitti marginali di «posizione» geografica. La ricchezza nazionale è condizionata dalla divisione internazionale del lavoro e dall’aver saputo scegliere, tra le possibilità che questa divisione offre, la più razionale e redditizia per ogni paese dato. Si tratta dunque essenzialmente di «capacità direttiva» della classe economica dominante, del suo spirito d’iniziativa e di organizzazione. Se queste qualità mancano, e l’azienda economica è fondata essenzialmente sullo sfruttamento di rapina delle classi lavoratrici e produttrici, nessun accordo internazionale può sanare la situazione.
Non si ha esempio, nella storia moderna, di colonie di «popolamento»; esse non sono mai esistite. L’emigrazione e la colonizzazione seguono il flusso dei capitali investiti nei vari paesi e non viceversa. La crisi attuale che si manifesta specialmente come caduta dei prezzi delle materie prime e dei cereali mostra che il problema appunto non è di ricchezza «naturale» per i vari paesi del mondo, ma di organizzazione sociale e di trasformazione delle materie prime per certi fini e non per altri. Che si tratti di organizzazione e di indirizzo politico‑economico appare anche dal fatto che ogni paese a civiltà moderna ha avuto «emigrazione» in certe fasi del suo sviluppo economico, ma tale emigrazione è cessata e spesso è stata riassorbita.
Che non si vogliano (o non si possa) mutare i rapporti intemi (e neppure rettificarli razionalmente) appare dalla politica del debito pubblico, che aumenta continuamente il peso della passività «demografica», proprio quando la parte attiva della popolazione è ristretta dalla disoccupazione e dalla crisi. Diminuisce il reddito nazionale, aumentano i parassiti, il risparmio si restringe ed è disinvestito dal processo produttivo e viene riversato nel debito pubblico, cioè fatto causa di nuovo parassitismo assoluto e relativo.
Q19 §7 Sulla struttura economica nazionale. Nella«Riforma Sociale» del maggio giugno 1932 è stata pubblicata una recensione del libro di Rodolfo Morandi (Storia della grande industria in Italia, ed. Laterza, Bari, 1931) recensione che contiene alcuni spunti metodici di un certo interesse (la recensione è anonima, ma l’autore potrebbe essere identificato nel prof. De Viti De Marco).
Si obbietta prima di tutto al Morandi di non tener conto di ciò che è costata l’industria italiana: «All’economista non basta che gli vengano mostrate fabbriche che danno lavoro a migliaia di operai, bonifiche che creano terre coltivabili ed altri simili fatti di cui il pubblico generalmente si contenta nei suoi giudizi su un paese, su un’epoca. L’economista sa bene che lo stesso risultato può rappresentare un miglioramento o un peggioramento di una certa situazione economica, a seconda che sia ottenuto con un complesso di sacrifici minori o maggiori».
È giusto il criterio generale che occorra esaminare il costo dell’introduzione di una certa industria nel paese, chi ne ha fatto le spese, chi ne ha ricavato vantaggi e se i sacrifizi fatti non potevano esserlo in altra direzione più utilmente, ma tutto questo esame deve esser fatto con una prospettiva non immediata, ma di larga portata. D’altronde il solo criterio dell’utilità economica non è sufficiente per esaminare il passaggio da una forma di organizzazione economica ad un’altra; occorre tener conto anche del criterio politico, cioè se il passaggio sia stato obbiettivamente necessario e corrispondente a un interesse generale certo, anche se a scadenza lunga. Che l’unificazione della penisola dovesse costare sacrifizi a una parte della popolazione per le necessità inderogabili di un grande Stato moderno è da ammettere; però occorre esaminare se tali sacrifizi sono stati distribuiti equamente e in che misura potevano essere risparmiati e se sono stati applicati in una direzione giusta. Che l’introduzione e lo sviluppo del capitalismo in Italia non sia avvenuto da un punto di vista nazionale, ma da angusti punti di vista regionali e di ristretti gruppi e che abbia in gran parte fallito ai suoi compiti, determinando un’emigrazione morbosa, mai riassorbita e di cui mai è cessata la necessità, e rovinando economicamente intere regioni, è certissimo. L’emigrazione infatti deve essere considerata come un fenomeno di disoccupazione assoluta da una parte, e dall’altra come manifestazione del fatto che il regime economico interno non assicurava uno standard di vita che si avvicinasse a quello internazionale tanto da non far preferire i rischi e i sacrifizi connessi con l’abbandono del proprio paese a lavoratori già occupati).
Il Morandi non riesce a valutare il significato del protezionismo nello sviluppo della grande industria italiana. Così il Morandi rimprovera assurdamente alla borghesia «il proposito deliberato e funestissimo di non aver tentato l’avventura salutare del sud dove malamente la produzione agricola può ripagare i grandi sforzi che all’uomo richiede». Il Morandi non si domanda se la miseria del Sud non fosse determinata dalla legislazione protezionistica che ha consentito lo sviluppo industriale del Nord e come poteva esistere un mercato interno da sfruttare coi dazi e altri privilegi, se il sistema protettivo si fosse esteso a tutta la penisola, trasformando l’economia rurale del Sud in economia industriale (tuttavia si può pensare a un tale regime protezionistico panitaliano, come un sistema per assicurare determinati redditi a certi gruppi sociali, cioè come un «regime salariale»; e si può vedere qualcosa del genere nella protezione cerealicola, connessa alla protezione industriale, che funziona solo a favore dei grandi proprietari e dell’industria molitoria ecc.). Si rimprovera al Morandi l’eccessiva severità con cui giudica e condanna uomini e cose del passato, poiché basta fare un confronto tra le condizioni prima e dopo l’indipendenza per vedere che qualcosa si è pur fatta.
Pare dubbio che si possa fare una storia della grande industria astraendo dai principali fattori (sviluppo demografico, politica finanziaria e doganale, ferrovie ecc.) che hanno contribuito a determinare le caratteristiche economiche del periodo considerato (critica molto giusta; una gran parte dell’attività della Destra storica da Cavour al 1876 fu dedicata infatti a creare le condizioni tecniche generali in cui una grande industria fosse possibile e un grande capitalismo potesse diffondersi e prosperare; solo con l’avvento della Sinistra e specialmente con Crispi si ha la «fabbricazione dei fabbricanti» attraverso il protezionismo e i privilegi d’ogni genere. La politica finanziaria della Destra rivolta al pareggio rende possibile la politica «produttivistica» successiva). «Così, ad esempio, non si riesce a capire come mai vi fosse tanta abbondanza di mano d’opera in Lombardia nei primi decenni dopo l’unificazione, e quindi il livello dei salari rimanesse tanto basso, se si rappresenta il capitalismo come una piovra che allunga i suoi tentacoli per far sempre nuove prede nelle campagne, invece di tener conto della trasformazione che contemporaneamente avviene nei contratti agrari ed in genere nell’economia rurale. Ed è facile concludere semplicisticamente sulla caparbietà e sulla ristrettezza di mente delle classi padronali osservando la resistenza che esse fanno ad ogni richiesta di miglioramento delle condizioni delle classi operaie, se non si tiene anche presente quello che è stato l’incremento della popolazione rispetto alla formazione di nuovi capitali». (La quistione però non è così semplice. Il saggio del risparmio o di capitalizzazione era basso perché i capitalisti avevano voluto mantenere tutta l’eredità di parassitismo del periodo precedente, affinché non venisse meno la forza politica della loro classe e dei loro alleati).
Critica della definizione di «grande industria» data dal Morandi, il quale, non si sa perché, ha escluso dal suo studio molte delle più importanti attività industriali (trasporti, industrie alimentari ecc.). Eccessiva simpatia del Morandi per i colossali organismi industriali, considerati troppo spesso, senz’altro, come forme superiori di attività economica, malgrado siano ricordati i crolli disastrosi dell’Ilva, dell’Ansaldo, della Banca di Sconto, della Snia Viscosa, dell’Italgas. «Un altro punto di dissenso, il quale merita di essere rilevato, perché nasce da un errore molto diffuso, è quello in cui l’A. considera che un paese debba necessariamente rimaner soffocato dalla concorrenza degli altri paesi se inizia dopo di essi la propria organizzazione industriale. Questa inferiorità economica, a cui sarebbe condannata anche l’Italia, non sembra affatto dimostrata, perché le condizioni del mercato, della tecnica, degli ordinamenti politici, sono in continuo movimento e quindi le mète da raggiungere e le strade da percorrere si spostano tanto spesso e subitamente che possono trovarsi in vantaggio individui e popoli che erano rimasti più indietro o quasi non s’erano mossi. Se ciò non fosse si spiegherebbe male come continuamente possono sorgere e prosperare nuove industrie accanto alle più vecchie nello stesso paese e come abbia potuto realizzarsi l’enorme sviluppo industriale del Giappone alla fine del secolo scorso». (A questo proposito sarebbe da ricercare se molte industrie italiane, invece di nascere sulla base della tecnica più progredita nel paese più progredito, come sarebbe stato razionale, non siano nate con le macchine fruste di altri paesi, acquistate a buon prezzo sì, ma ormai superate, e se questo fatto non si presentasse «più utile» per gli industriali che speculavano sul basso prezzo della mano d’opera e sui privilegi governativi più che su una produzione tecnicamente perfezionata).
Nel fare l’analisi della relazione della Banca Commerciale italiana all’assemblea sociale per l’esercizio 1931, Attilio Cabiati (nella Riforma Sociale luglio‑agosto 1932, p. 464) scrive: «Risalta da queste considerazioni il vizio fondamentale che ha sempre afflitto la vita economica italiana: la creazione e il mantenimento di una impalcatura industriale troppo superiore sia alla rapidità di formazione di risparmio nel paese, che alla capacità di assorbimento dei consumatori interni; vivente quindi per una parte cospicua solo per la forza del protezionismo e di aiuti statali di svariate forme. Ma il patrio protezionismo che in taluni casi raggiunge e supera il cento per cento del valore internazionale del prodotto, rincarando la vita rallentava a sua volta la formazione del risparmio, che per di più veniva conteso all’industria dallo Stato stesso, spesso stretto dai suoi bisogni, sproporzionati alla nostra impalcatura. La guerra, allargando oltre misura tale impalcatura, costrinse le nostre banche, come scrive la relazione precitata, “ad una politica di tesoreria coraggiosa e pertinace”, la quale consisté nel prendere a prestito “a rotazione” all’estero, per prestare a più lunga scadenza all’interno. “Una tale politica di tesoreria aveva però – dice la relazione – il suo limite naturale nella necessità per le banche di conservare ad ogni costo congrue riserve di investimenti liquidi o di facile realizzo”. Quando scoppiò la crisi mondiale, gli “investimenti liquidi” non si potevano realizzare se non ad uno sconto formidabile: il risparmio estero arrestò il suo flusso: le industrie nazionali non poterono ripagare. Sicché, exceptis excipiendis, il sistema bancario italiano si trovò in una situazione per più aspetti identica a quella del mercato finanziario inglese nella metà del 1931… (l’errore) antico consisteva nell’aver voluto dare vita ad un organismo industriale sproporzionato alle nostre forze, creato con lo scopo di renderci “indipendenti dall’estero”: senza riflettere che, a mano a mano che non “dipendevamo” dall’estero per i prodotti, si rimaneva sempre più dipendenti per il capitale».
Si pone il problema se in un altro stato di cose si potrà allargare la base industriale del paese senza ricorrere all’estero per i capitali. L’esempio di altri paesi (per esempio il Giappone) mostra che ciò è possibile: ogni forma di società ha una sua legge di accumulazione del risparmio ed è da ritenere che anche in Italia si può ottenere una più rapida accumulazione. L’Italia è il paese, che, nelle condizioni create dal Risorgimento e dal suo modo di svolgimento, ha il maggior peso di popolazione parassitaria, che vive cioè senza intervenire per nulla nella vita produttiva, è il paese di maggior quantità di piccola e media borghesia rurale e urbana che consuma una frazione grande del reddito nazionale per risparmiarne una frazione insufficiente alle necessità nazionali.
Q19 §8 Le sètte nel Risorgimento. Cfr Pellegrino Nicolli, La Carboneria in Italia, Vicenza, Edizioni Cristofari, 1931. Il Nicolli cerca di distinguere nella Carboneria le diverse correnti, che spesso la componevano, e di dare un quadro delle diverse sètte che pullularono in Italia nella prima parte del secolo XIX. Da una recensione del libro del Nicolli pubblicata nel «Marzocco» del 25 ottobre 1931 si estrae questo brano: «È un groviglio di nomi strani, di emblemi, di riti, di cui si ignorano il più delle volte le origini; un confuso mescolarsi di propositi disparati, che variano non soltanto da società a società, ma nella stessa società, la quale, secondo i tempi e le circostanze, muta metodi e programmi. Dal vago sentimento nazionale si arriva alle aberrazioni del comunismo e, per converso, si hanno sètte che, ispirandosi agli stessi sistemi dei rivoluzionari, assumono la difesa del trono e dell’altare. Sembra che rivoluzione e reazione abbiano bisogno di battersi in un campo chiuso, dove non penetra occhio profano, tramando congiure al lume di fiaccole fumose e maneggiando pugnali. Un filo che ci guidi in mezzo a questo labirinto non c’è ed è vano chiederlo al Nicolli, che pure ha fatto del suo meglio per trovarlo. Si tenga anche soltanto presente la Carboneria, che è in un certo modo il gran fiume nel quale convogliano tutte le altre società segrete». Il Nicolli si è proposto di «raccogliere sinteticamente quanto da valenti storici è stato finora scritto» sulle società segrete nel Risorgimento.
Si può osservare: 1°) che la molteplicità delle sètte, dei programmi e dei metodi, oltre all’essere dovuta al carattere clandestino del movimento settario, è certamente dovuta anche alla primitività del movimento stesso, cioè all’assenza di tradizioni forti e radicate, e quindi all’assenza di un organismo «centrale» saldo e con indirizzo fermo; 2°) la molteplicità può sembrare più «morbosa» di quanto fosse realmente per la soverchia pedanteria erudita del ricercatore: realmente, in ogni tempo, esistono movimenti «settari» bizzarri e curiosi, ai quali non si bada neanche, in maggior misura di quanto non si supponga comunemente.
Q19 §9 Correnti popolari nel Risorgimento. Carlo Bini (cfr Le più belle pagine di Carlo Bini, raccolte da Dino Provenzal). Giovanni Rabizzani, in uno studio su Lorenzo Sterne in Italia (forse nella collezione «L’Italia negli scrittori stranieri» dell’editore Rocco Carabba) ricorda il Bini e rileva un notevole contrasto tra i due: lo Sterne più incline alle analisi sentimentali e meno scettico, il Bini più attento ai problemi sociali, tanto che il Rabizzani lo chiama addirittura socialista. In ogni caso è da notare che Livorno fu delle pochissime città che nel 1848‑49 vide un profondo movimento popolare, un intervento di masse plebee che ebbe vasta ripercussione in tutta la Toscana e che mosse a spavento i gruppi moderati e conservatori (ricordare le Memorie di G. Giusti). Il Bini è da vedere perciò, accanto al Montanelli, nel quadro del 1849 toscano.
Q19 §10 Gli scritti del padre Carlo Maria Curci. Gli scritti del padre Curci, dopo la sua conversione al cattolicismo liberale, sono utili per ricostruire la situazione italiana intorno al 1880. La conversione del Curci, celebre e battagliero gesuita della «Civiltà Cattolica», rappresenta, dopo il 1870, uno dei maggiori colpi ricevuti dalla politica vaticana di boicottaggio del nuovo Stato unitario e l’inizio di quel processo molecolare che trasformerà il mondo cattolico fino alla fondazione del Partito Popolare. Alcuni scritti del padre Curci dopo la conversione: Il moderno dissidio tra la Chiesa e l’Italia, considerato per occasione di un fatto particolare, IIa ediz. migliorata ed accresciuta, in 8°, pp. XII-276, 1878, L. 4,50; La nuova Italia e i vecchi zelanti. Studi utili ancora all’ordinamento dei partiti parlamentari, in 8°, pp. VIII‑256, 1881, L. 5,25; Il Vaticano Regio, tarlo superstite della Chiesa Cattolica. Studi dedicati al giovane clero ed al laicato credente, in 8°, pp. VIII‑336, 1883, L. 4,50; Lo scandalo del Vaticano Regio, duce la Provvidenza, buono a qualche cosa, in 8°, pp. XVI‑136, 1884, L. 2,25. (Questi volumi sono ancora in vendita presso l’Utet di Torino, secondo il catalogo del 1928).
Q19 §11 Caratteri popolareschi del Risorgimento. Volontari e intervento popolare. Nel numero del 24 maggio di «Gioventù Fascista» (riportato dal «Corriere della Sera» del 21 maggio 1932) è pubblicato questo messaggio dell’on. Balbo: «Le creazioni originali della storia e della civiltà italiana, dal giorno in cui risorse dal letargo secolare ad oggi, sono dovute al volontariato della giovinezza. La santa canaglia di Garibaldi, l’eroico interventismo del ’15, le Camicie Nere della Rivoluzione Fascista hanno dato unità e potenza all’Italia, hanno fatto, di un popolo disperso, una nazione. Alle generazioni che oggi si affacciano alla vita sotto il segno del Littorio, il compito di dare al secolo nuovo il nome di Roma». L’affermazione che l’Italia moderna è stata caratterizzata dal volontariato è giusta (si può aggiungere l’arditismo di guerra), ma occorre notare che il volontariato, pur nel suo pregio storico, che non può essere diminuito, è stato un surrogato dell’intervento popolare, e in questo senso è una soluzione di compromesso con la passività delle masse nazionali. Volontariato‑passività, vanno insieme più di quanto si creda. La soluzione col volontariato è una soluzione d’autorità, dall’alto, legittimata formalmente dal consenso, come suol dirsi, dei «migliori». Ma per costruire storia duratura non bastano i «migliori», occorrono le più vaste e numerose energie nazionali‑popolari.
Q19 §12 La posizione geopolitica dell’Italia. La possibilità dei blocchi. Nella sesta seduta della Conferenza di Washington (23 dicembre 1921) il delegato inglese Balfour disse, parlando dell’Italia: «L’Italia non è un’isola, ma può considerarsi come un’isola. Mi ricordo dell’estrema difficoltà che abbiamo avuto a rifornirla anche con il minimo di carbone necessario per mantenere la sua attività, i suoi arsenali e le sue officine, durante la guerra. Dubito che essa possa nutrirsi e approvvigionarsi, o continuare ad essere una effettiva unità di combattimento, se fosse realmente sottomessa ad un blocco e se il suo commercio marittimo fosse arrestato. L’Italia ha cinque vicini nel Mediterraneo. Spero e credo che la pace, pace eterna, possa regnare negli antichi focolari della civiltà. Ma noi facciamo un esame freddo e calcolatore come quello di un membro qualsiasi dello Stato Maggiore Generale. Questi, considerando il problema senza alcun pregiudizio politico e soltanto come una questione di strategia, direbbe all’Italia: voi avete cinque vicini, ciascuno dei quali può, se vuole, stabilire un blocco delle vostre coste senza impiegare una sola nave di superficie. Non sarebbe necessario che sbarcasse truppe e desse battaglia. Voi perireste senza essere conquistati». (Balfour parlava specialmente sotto l’impressione della guerra sottomarina e prima dei grandi progressi realizzati dall’aviazione di bombardamento, che non pare possa permettere un blocco immune da rappresaglie; tuttavia per alcuni aspetti la sua analisi è abbastanza giusta).
Q19 §13 Pubblicazione ed esame dei libri e delle memorie degli antiliberali e antifrancesi nel periodo della Rivoluzione francese e di Napoleone e reazionari nel periodo del Risorgimento. Sono necessari, in quanto anche le forze avverse al moto liberale italiano furono una parte e un aspetto non trascurabile della realtà, ma in essi occorre tener presenti alcuni criteri metodici: 1°) alcune ristampe, come quella del Memorandum del Solaro della Margarita e forse anche i volumi curati dal Lovera di Castiglione e dal gesuita Ilario Rinieri o hanno uno scopo attuale, di rafforzare certe tendenze reazionarie nell’interpretazione del Risorgimento (rappresentate dai gesuiti della «Civiltà Cattolica») o sono presentati come testi per l’azione attuale (il Papa di De Maistre e lo stesso Memorandum del Solaro ecc.). 2°) Le descrizioni degli interventi francesi nelle varie regioni italiane sotto il Direttorio e successivamente, sono dovute molto spesso solo ai reazionari: i «giacobini» si arruolavano e quindi avevano altro da fare che scrivere memorie: i quadri pertanto sono sempre tendenziosi e sarebbe molto ingenuo ricostruire la verità su tale letteratura. Fra queste pubblicazioni cfr Ranuccio Ranieri, L’invasione francese degli Abruzzi nel 1798‑99 e una memoria del tempo inedita di Giovanni Battista Simone, Pescara, Edizioni dell’«Adriatico», 1931. Dalla narrazione del Simone, antigiacobino e legittimista, appare che in Chieti città la forza giacobina era di una certa efficienza, ma nella campagna (salvo eccezioni dovute a rivalità municipali e al desiderio di aver l’occasione di fare delle vendette) prevalevano le forze reazionarie nella lotta contro Chieti. Pare che più della memoria del Simone, enfatica e verbosa, sia interessante l’esposizione del Ranieri che ricostruisce la situazione dell’Abruzzo in quel periodo di storia.
Q19 §14 Carlo Felice. È da leggere la biografia scrittane da Francesco Lemmi per la «Collana storica sabauda» dell’Ed. Paravia. Alcuni punti rilevanti della biografia del Lemmi. l’avversione di Carlo Felice contro il ramo dei Carignano: in alcune lettere scritte da Carlo Felice al fratello Vittorio Emanuele nel 1804 si leggono contro i genitori di Carlo Alberto parole «roventi», dettate da non si sa quale risentimento e che giungono fino a scongiurare come una vergogna quella non desiderata successione; Carlo Felice e i moti del 1821. Nota il Lemmi che Carlo Felice non fece mai una politica italiana ma mirò solo ad estendere i suoi possessi
Q19 §15 La Rivoluzione del 1831. Nell’«Archiginnasio» (4‑6, anno XXVI, 1932) Albano Sorbelli pubblica e commenta il testo del Piano politico costitutivo della Rivoluzione del 1831 scritto da Ciro Menotti. Il documento era già stato pubblicato da Enrico Ruffini nel 1909 (?) nell’«Archivio Emiliano del Risorgimento Nazionale», fasc. 10 e 11. Anche il volume di Arrigo Solmi sui fatti del 31 si basa su questo piano. Ora si è potuto, con un reagente, far rivivere lo scritto del Menotti e fotografarlo per l’«Archiginnasio».
Q19 §16 Prospero Merimée e il ’48 italiano. Nella «Revue des deux mondes» (fasc. del 15 maggio 1932) è pubblicato un manipolo di lettere di Prospero Merimée alla contessa De Boigne (autrice di Memorie famose). Sul ’48 in Italia: «i Piemontesi non si preoccupano affatto del nostro aiuto e noi impediamo gli Italiani di aiutarli col promettere il rinforzo. del nostro invincibile esercito: un viaggiatore che viene di Lombardia racconta che il paese, come in pieno Medio Evo, è diviso in tante piccole repubbliche quanti sono i borghi e i villaggi, ostili l’uno all’altro nell’attesa di prendere le armi». Il Merimée era fautore dell’unità italiana.
(Racconta aneddoti piccanti sulla situazione francese: per esempio, i contadini, votando per Luigi Napoleone, credevano di votare per Napoleone I. Inutilmente si cercava di spiegar loro che la salma dell’Imperatore è sepolta agli Invalidi).
Che la speranza di un possibile aiuto dell’esercito francese abbia nel ’48 influito a restringere il movimento di volontari, ecc. è possibile, tuttavia non spiega il fatto che i volontari presentatisi furono male impiegati e male trattati, non spiega l’inerzia militare dello stesso Piemonte e l’assenza di una chiara direzione politico‑militare, nel senso spiegato nelle successive; non spiega neanche il motto dell’«Italia farà da sé».
Q19 §17 Martino Beltrani Scalia: Giornali di Palermo nel 1848‑1849, con brevi accenni a quelli delle altre principali città d’Italia nel medesimo periodo, a cura del figlio Vito Beltrani, Palermo, Sandron, 1931. Si tratta di una esposizione condensata in poche linee del contenuto dei singoli periodici pubblicati a Palermo nel 1848 e 1849 e anche dell’anno precedente, nonché di numerosi giornali del continente (di Napoli, di Roma, della Toscana, del Piemonte e della Svizzera, cioè dell’«Italia del Popolo» di Mazzini), esposizione fatta generalmente giorno per giorno. Per i giornali non siciliani si dà importanza a ciò che riguarda la Sicilia. Nel 1847 i giornali palermitani erano appena sei; nel ’48‑49 il Beltrani Scalia ne annovera centoquarantuno e non è da escludere che gliene sia sfuggito qualcuno. Dai sunti del B. S. appare l’assenza dei partiti permanenti: si tratta per lo più di opinioni personali, spesso contraddittorie nello stesso foglio. Pare che il saggio del B. S. dimostri che aveva ragione il La Farina quando nella Storia documentata della rivoluzione siciliana scrisse che «la stampa periodica, salvo scarse e onorevoli eccezioni, non rispose mai all’altezza del suo ministero: fu scandalo, non forza».
Q19 §18 Il 1849 a Firenze. Nella «Rassegna Nazionale» (riportato dal «Marzocco» del 21 febbraio 1932) Aldo Romano pubblica una lettera di Ruggero Bonghi e una di Cirillo Monzani scritte a Silvio Spaventa nel 1849 da Firenze, durante il periodo della dittatura Guerrazzi‑Montanelli, lettere che sono interessanti per giudicare quale fosse l’atteggiamento dei moderati verso la fase democratica del moto rivoluzionario del ’48‑49. Colpisce il fatto come questi due moderati si mostrino estranei agli avvenimenti, spettatori solo incuriositi ma malevoli e non attori interessati. Ecco un brano del Bonghi, scritto quindici giorni dopo la fuga del Granduca e di stile brescianesco: «La fazione repubblicana intende a rizzare dovunque quell’albero con così poco concorso rizzato a Firenze, insino dalla sera che si seppe il proclama di De Laugier e mediante l’opera di alcuni livornesi fatti venire a bella posta. Questo rizzamento ha poco o nessun contrasto nelle città principali o più popolose; ma ne ha molto nelle più piccole e moltissimo nelle campagne. Ier sera si voleva rizzare fuori Porta Romana; furon grida di evviva; poi contrasto di chi voleva e di chi non voleva; poi colpi di coltello e fucilate; infine un grande sconquasso. I contadini dei dintorni, credendo che fosse una baldoria che si facesse per il ritorno del granduca, o che fossero già istigati e preparati alla reazione, o comechessia, cominciarono anch’essi a fare gli evviva a Leopoldo II, a tirar fucilate, a cavar bandiere, ad agitar fazzoletti, a sparar mortaletti e cose simili». Più sintomatico ancora è lo scritto del Monzani, che dà uno scampolo di quella che doveva essere la propaganda disfattista dei moderati: «La cecità e, quel che è peggio, la mala fede, l’astuzia, il raggiro, mi paiono giunti al colmo. Si parla molto di patria, di libertà, ma pochi hanno in cuore la patria e saprebbero fare estremi sacrifizi ed esporre le vite a salvamento di essa. Questi santissimi nomi sono purtroppo profanati, ed i più se ne servono come pala (!) ad ottenere o potenza o ricchezza. Forse mi ingannerò, ma l’aspettarsi salvezza da costoro mi parrebbe il medesimo che aspettarla dal turco. Io non sono avvezzo ad illudermi, né a correr dietro ai fantasmi, ché troppo gli italiani si sono lasciati prendere al laccio dalle chimere e dalle utopie di certi apostoli, i quali ormai sono troppo dannosi alla nostra disgraziata patria».
Le due lettere furono sequestrate allo Spaventa al momento dell’arresto. I Borboni erano troppo angusti di mente per servirsene contro i liberali, facendole pubblicare e commentare dai loro pennaioli (odiavano troppo i pennaioli per averne al proprio servizio), si limitarono a passarle agli atti del processo Spaventa. (Tutta la spiritosaggine del Bonghi è concentrata in quel continuo ripetere «rizzare» e «rizzamento» alla napoletana).
Q19 §19 Momenti di vita intensamente collettiva e unitaria nello sviluppo nazionale del popolo italiano. Esaminare nello svolgimento della vita nazionale dal 1800 in poi tutti i momenti in cui al popolo italiano si è posto da risolvere un compito almeno potenzialmente comune, in cui avrebbero potuto verificarsi perciò un’azione o un moto di carattere collettivo (in profondità e in estensione) e unitario. Questi momenti, nelle diverse fasi storiche, possono essere stati di diversa natura e di diversa importanza nazionale‑popolare. Ciò che importa nella ricerca è il carattere potenziale (e quindi la misura in cui la potenzialità si è tradotta in atto) di collettività e di unitarietà, cioè la diffusione territoriale (la regione risponde a questa esigenza, se non addirittura la provincia) e la intensità di massa (cioè la maggiore o minore moltitudine di partecipanti, la maggiore o minore ripercussione positiva e anche attivamente negativa che il moto ha avuto nei diversi strati della popolazione).
Questi momenti possono aver avuto carattere e natura diversi: guerre, rivoluzioni, plebisciti, elezioni generali di particolare significato. Guerre: 1848‑49, 1859, 1860, 1866, 1870, guerre d’Africa (Eritrea e Libia), guerra mondiale.
Rivoluzioni: 1820‑21, 1831, 1848‑49, 1860, fasci siciliani, 1898, 1904, 1914, 1919‑20, 1924‑25. Plebisciti per la formazione del Regno: 1859‑60, 1866, 1870. Elezioni generale con diversa estensione di suffragio. Elezioni tipiche: quella che porta la Sinistra al potere nel 1876, quella dopo l’allargamento del suffragio dopo il 1880, quella dopo il 1898. L’elezione del 1913 è la prima con caratteri popolari spiccati per la larghissima partecipazione dei contadini; quella del 1919 è la più importante di tutte per il carattere proporzionale e provinciale del voto che obbliga i partiti a raggrupparsi e perché in tutto il territorio, per la prima volta, si presentano gli stessi partiti con gli stessi (all’ingrosso) programmi. In misura molto maggiore e più organica che nel 1913 (quando il collegio uninominale restringeva le possibilità e falsificava le posizioni politiche di massa per l’artificiosa delimitazione dei collegi) nel 1919 in tutto il territorio, in uno stesso giorno, tutta la parte più attiva del popolo italiano si pone le stesse quistioni e cerca di risolverle nella sua coscienza storico‑politica. Il significato delle elezioni del 1919 è dato dal complesso di elementi «unificatori», positivi e negativi, che vi confluiscono: la guerra era stata un elemento unificatore di primo ordine in quanto aveva dato la coscienza alle grandi masse dell’importanza che ha anche per il destino di ogni singolo individuo la costruzione dell’apparato governativo, oltre all’aver posto una serie di problemi concreti, generali e particolari, che riflettevano l’unità popolare‑nazionale. Si può affermare che le elezioni del 1919 ebbero per il popolo un carattere di Costituente (questo carattere lo ebbero anche le elezioni del 1913, come può ricordare chiunque abbia assistito alle elezioni nei centri regionali dove maggiore era stata la trasformazione del corpo elettorale e come fu dimostrato dall’alta percentuale di partecipazione al voto: era diffusa la convinzione mistica che tutto sarebbe cambiato dopo il voto, di una vera e propria palingenesi sociale: così almeno in Sardegna) sebbene non l’abbiano avuto per «nessun» partito del tempo: in questa contraddizione e distacco tra il popolo e i partiti è consistito il dramma storico del 1919, che fu capito immediatamente solo da alcuni gruppi dirigenti più accorti e intelligenti (e che avevano più da temere per il loro avvenire). È da notare che proprio il partito tradizionale della costituente in Italia, il repubblicano, dimostrò il minimo di sensibilità storica e di capacità politica e si lasciò imporre il programma e l’indirizzo (cioè una difesa astratta e retrospettiva dell’intervento in guerra) dai gruppi dirigenti di destra. Il popolo, a suo modo, guardava all’avvenire (anche nella quistione dell’intervento in guerra) e in ciò è il carattere implicito di costituente che il popolo diede alle elezioni del 1919; i partiti guardavano al passato (solo al passato) concretamente e all’avvenire «astrattamente», «genericamente», come «abbiate fiducia nel vostro partito» e non come concezione storico‑politica costruttiva. Tra le altre differenze tra il 1913 e il 1919 occorre ricordare la partecipazione attiva dei cattolici, con uomini proprii, con un proprio partito, con un proprio programma. Anche nel 1913 i cattolici avevano partecipato alle elezioni, ma attraverso il patto Gentiloni, in modo sornione e che falsificava il significato dello schieramento e dell’influsso delle forze politiche tradizionali. Per il 1919 è da ricordare il discorso tenuto da Giolitti di intonazione costituentistica (retrospettiva) e l’atteggiamento dei giolittiani verso i cattolici quale risulta dagli articoli di Luigi Ambrosini nella «Stampa». In realtà i giolittiani furono i vincitori delle elezioni, nel senso che essi impressero il carattere di costituente senza costituente alle elezioni stesse e riuscirono ad attrarre l’attenzione dall’avvenire al passato.
Q19 §20 Risorgimento e quistione orientale. In tutta una serie di scritti (tendenziosi a favore dei moderati) si dà un significato trascendentale alle manifestazioni letterarie del periodo del Risorgimento, in cui la quistione orientale è prospettata in funzione dei problemi italiani: disegni di inorientamento e balcanizzazione dell’Austria per compensarla del Lombardo‑Veneto ceduto pacificamente a profitto della rinascita nazionale italiana, ecc. Non pare che tali disegni siano prova di grande capacità politica, come si pretende: pare piuttosto debbano essere interpretati come espressione di passività politica e di scoramento dinanzi alle difficoltà dell’impresa nazionale, scoramento che si vela di disegni tanto più grandiosi quanto più astratti e vaghi in quanto non dipendeva dalle forze italiane il portarli a compimento. «Balcanizzare» l’Austria significava infatti creare una situazione politico‑diplomatica europea (e implicitamente militare) in forza della quale l’Austria si fosse lasciata «balcanizzare»; significava avere l’egemonia politica e diplomatica dell’Europa, una cosa da nulla! Non si comprende perché l’Austria non potesse, conservando il Lombardo‑Veneto, cioè la supremazia in Italia e una posizione dominante nel Mediterraneo centrale, conquistare anche una maggiore influenza nei Balcani e quindi nel Mediterraneo orientale: questo anzi sarebbe stato l’interesse dell’Inghilterra, che fondava sull’Austria un sistema di equilibrio contro la Francia e contro la Russia. Lo stesso scarso sentimento di iniziativa politica autonoma e la sfiducia nelle proprie forze, – che erano impliciti nel disegno del Balbo – dovevano rendere sorda l’Inghilterra a tali suggerimenti.
Solo un forte Stato italiano che avesse potuto sostituire l’Austria nella sua funzione antifrancese nel Mediterraneo centrale avrebbe potuto muovere l’Inghilterra a simpatie verso l’Italia, come avvenne infatti dopo le annessioni nell’Italia centrale e l’impresa dei Mille contro i Borboni; prima di questi fatti reali, solo un grande partito pieno di decisione e di audacia e sicuro delle proprie mosse perché radicato nelle grandi masse popolari, avrebbe ottenuto forse lo stesso risultato, ma ciò appunto non esisteva e anzi il Balbo coi suoi amici non volevano si formasse. La balcanizzazione dell’Austria dopo la perdita dell’egemonia nella penisola e rimanendo i Borboni a Napoli (secondo il piano neoguelfo) avrebbe avuto conseguenze gravi per la politica inglese nel Mediterraneo. Lo Stato napoletano sarebbe diventato un feudo russo, cioè la Russia avrebbe avuto la possibilità di un’azione militare proprio nel centro del Mediterraneo. (La quistione dei rapporti tra i Borboni di Napoli e lo Zarismo è tutto un aspetto della storia dal 1799 al 1860 da esaminare e approfondire: dal libro del Nitti sul Capitale straniero in Italia, stampato nel 1915 da Laterza, si vede che ancora esistevano nell’Italia Meridionale per circa 150 milioni di obbligazioni statali russe, residuo non trascurabile della connessione che si era venuta formando tra Napoli e la Russia prima del 1860, contro l’Inghilterra).
Non bisogna dimenticare che la Quistione orientale, se aveva il suo nodo strategico nei Balcani e nell’Impero turco, era specialmente la forma politico‑diplomatica della lotta tra Russia e Inghilterra: era cioè la quistione del Mediterraneo, dell’Asia prossima e centrale, dell’India, dell’Impero inglese. Il libro in cui il Balbo sostenne la sua tesi: Le Speranze d’Italia fu pubblicato nel 1844 e la tesi stessa non ebbe altra efficacia se non quella di far conoscere la quistione orientale attirando l’attenzione su di essa e quindi di facilitare (forse) la politica di Cavour a proposito della guerra di Crimea. Non ebbe nessuna efficacia nel ’59 (quando il Piemonte e la Francia pensarono di suscitare nemici all’Austria nei Balcani per illanguidirne le forze militari) perché una tale azione fu circoscritta, di poco respiro e in ogni caso si ridusse a un episodio di organizzazione dell’attività militare franco‑piemontese: lo stesso si dica per il 1866, quando una simile diversione fu pensata dal governo italiano e da Bismark per la guerra contro l’Austria. Cercare, in tempo di guerra, di indebolire il nemico suscitandogli nemici all’interno e su tutto il perimetro dei confini politico‑militari non è elemento di un piano politico per l’Oriente ma fatto di ordinaria amministrazione della condotta bellica. Del resto, dopo il 60 e la formazione di uno Stato italiano di notevole importanza, l’inorientamento dell’Austria aveva un ben diverso significato internazionale e trovava consenzienti tanto l’Inghilterra che la Francia.
Qualche pubblicazione recente si è occupata dei progetti borbonici, rimasti progetti, di espansione in Oriente, per trarne argomento di riabilitazione del governo napoletano; tali progetti saranno stati visti volentieri dalla Russia e impediti dall’Inghilterra, che sulla quistione di Malta fu intrattabile verso Napoli. (Sarà da vedere il volume di Pietro Silva sul Mediterraneo).
Q19 §21 Il «mutuo insegnamento». Per l’importanza che ha avuto nel moto liberale del Risorgimento il principio e la diffusione pratica del «mutuo insegnamento», cfr i due volumi di Arturo Linacher su Enrico Mayer, che fu uno dei maggiori collaboratori dell’«Antologia» e del Vieusseux e uno dei maggiori divulgatori del nuovo metodo pedagogico.
Q19 §22 Correnti popolaresche. Per i movimenti popolari di sinistra del ’48‑49 è da vedere: Nicola Valdimiro Testa, Gli Irpini nei moti politici e nella reazione del 1848‑49, Napoli, R. Contessa e Fratelli, 1932, in 8°, pp. 320, L. 15
Q19 §23 E. De Amicis e G. C. Abba. Significato della Vita Militare del De Amicis. La Vita Militare è da porre accanto ad alcune pubblicazioni di G. C. Abba, nonostante il contrasto intimo e il diverso atteggiamento. G. C. Abba è più «educatore» e più «nazionale‑popolare»: egli è certamente più concretamente democratico del De Amicis perché politicamente più robusto ed eticamente più austero. Il De Amicis, nonostante le apparenze superficiali, è più servile verso i gruppi dirigenti in forme paternalistiche.
Nella Vita Militare è da vedere il capitolo: «L’Esercito Italiano durante il colera del 1867» perché ritrae l’atteggiamento del popolo siciliano verso il governo e gli «italiani» dopo la sommossa del settembre 1866. Guerra del 1866, sommossa di Palermo, colera: tre fatti che non possono essere staccati. Sarà da vedere l’altra letteratura sul colera in tutto il Mezzogiorno nel 1866‑67. Non si può giudicare il livello civile della vita popolare di quel tempo senza trattare questo argomento. (Esistono pubblicazioni ufficiali sui reati contro le autorità – soldati, ufficiali, ecc. – durante il colera?)
Al momento della sommossa era prefetto a Palermo Luigi Torelli, sul quale cfr Antonio Monti, Il conte Luigi Torelli, Milano, R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 1931, in 8°, pp. 513, L. 30. Dopo la repressione il Torelli ebbe la medaglia d’oro al valor civile. Il libro è da vedere anche perché il Torelli ebbe in tutto il Risorgimento una funzione abbastanza significativa.
Q19 §24 Il problema della direzione politica nella formazione e nello sviluppo della nazione e dello Stato moderno in Italia. Tutto il problema della connessione tra le varie correnti politiche del Risorgimento, cioè dei loro rapporti reciproci e dei loro rapporti con i gruppi sociali omogenei o subordinati esistenti nelle varie sezioni (o settori) storiche del territorio nazionale, si riduce a questo dato di fatto fondamentale: i moderati rappresentavano un gruppo sociale relativamente omogeneo, per cui la loro direzione subì oscillazioni relativamente limitate (e in ogni caso secondo una linea di sviluppo organicamente progressivo), mentre il così detto Partito d'Azione non si appoggiava specificamente a nessuna classe storica e le oscillazioni subite dai suoi organi dirigenti in ultima analisi si componevano secondo gli interessi dei moderati: cioè storicamente il Partito d’Azione fu guidato dai moderati: l’affermazione attribuita a Vittorio Emanuele II di «avere in tasca» il Partito d'Azione o qualcosa di simile è praticamente esatta e non solo per i contatti personali del Re con Garibaldi ma perché di fatto il Partito d'Azione fu diretto «indirettamente» da Cavour e dal Re.
Il criterio metodologico su cui occorre fondare il proprio esame è questo: che la supremazia di un gruppo sociale si manifesta in due modi, come «dominio» e come «direzione intellettuale e morale». Un gruppo sociale è dominante dei gruppi avversari che tende a «liquidare» o a sottomettere anche con la forza armata ed è dirigente dei gruppi affini e alleati. Un gruppo sociale può e anzi deve essere dirigente già prima di conquistare il potere governativo (è questa una delle condizioni principali per la stessa conquista del potere); dopo, quando esercita il potere e anche se lo tiene fortemente in pugno, diventa dominante ma deve continuare ad essere anche «dirigente». I moderati continuarono a dirigere il Partito d'Azione anche dopo il 1870 e il 1876 e il così detto «trasformismo» non è stato che l’espressione parlamentare di questa azione egemonica intellettuale, morale e politica. Si può anzi dire che tutta la vita statale italiana dal 1848 in poi è caratterizzata dal trasformismo, cioè dall’elaborazione di una sempre più larga classe dirigente nei quadri fissati dai moderati dopo il 1848 e la caduta delle utopie neoguelfe e federalistiche, con l’assorbimento graduale, ma continuo e ottenuto con metodi diversi nella loro efficacia, degli elementi attivi sorti dai gruppi alleati e anche da quelli avversari e che parevano irreconciliabilmente nemici. In questo senso la direzione politica è diventata un aspetto della funzione di dominio, in quanto l’assorbimento delle élites dei gruppi nemici porta alla decapitazione di questi e al loro annichilimento per un periodo spesso molto lungo. Dalla politica dei moderati appare chiaro che ci può e ci deve essere una attività egemonica anche prima dell’andata al potere e che non bisogna contare solo sulla forza materiale che il potere dà per esercitare una direzione efficace: appunto la brillante soluzione di questi problemi ha reso possibile il Risorgimento nelle forme e nei limiti in cui esso si è effettuato, senza «Terrore», come «rivoluzione senza rivoluzione» ossia come «rivoluzione passiva» per impiegare un’espressione del Cuoco in un senso un po’ diverso da quello che il Cuoco vuole dire.
In quali forme e con quali mezzi i moderati riuscirono a stabilire l’apparato (il meccanismo) della loro egemonia intellettuale, morale e politica? In forme e con mezzi che si possono chiamare «liberali», cioè attraverso l’iniziativa individuale, «molecolare», «privata» (cioè non per un programma di partito elaborato e costituito secondo un piano precedentemente all’azione pratica e organizzativa). D’altronde, cioè era «normale», date la struttura e la funzione dei gruppi sociali rappresentati dai moderati dei quali i moderati erano il ceto dirigente, gli intellettuali in senso organico. Per il Partito d’Azione il problema si poneva in modo diverso e diversi sistemi organizzativi avrebbero dovuto essere impiegati. I moderati erano intellettuali «condensati» già naturalmente dall’organicità dei loro rapporti con i gruppi sociali di cui erano l’espressione (per tutta una serie di essi si realizzava l’identità di rappresentato e rappresentante, cioè i moderati erano un’avanguardia reale, organica delle classi alte, perché essi stessi appartenevano economicamente alle classi alte: erano intellettuali e organizzatori politici e insieme capi d’azienda, grandi agricoltori o amministratori di tenute, imprenditori commerciali e industriali, ecc.). Data questa condensazione o concentrazione organica, i moderati esercitavano una potente attrazione, in modo «spontaneo», su tutta la massa d’intellettuali d’ogni grado esistenti nella penisola allo stato «diffuso», «molecolare», per le necessità, sia pure elementarmente soddisfatte, della istruzione e dell’amministrazione. Si rileva qui la consistenza metodologica di un criterio di ricerca storico‑politica: non esiste una classe indipendente di intellettuali, ma ogni gruppo sociale ha un proprio ceto di intellettuali o tende a formarselo; però gli intellettuali della classe storicamente (e realisticamente) progressiva, nelle condizioni date, esercitano un tale potere d’attrazione che finiscono, in ultima analisi, col subordinarsi gli intellettuali degli altri gruppi sociali e quindi col creare un sistema di solidarietà fra tutti gli intellettuali con legami di ordine psicologico (vanità ecc.) e spesso di casta (tecnico‑giuridici, corporativi, ecc.).
Questo fatto si verifica «spontaneamente» nei periodi storici in cui il gruppo sociale dato è realmente progressivo, cioè fa avanzare realmente l’intera società, soddisfacendo non solo alle sue esigenze esistenziali, ma ampliando continuamente i propri quadri per la continua presa di possesso di nuove sfere di attività economico‑produttiva. Appena il gruppo sociale dominante ha esaurito la sua funzione, il blocco ideologico tende a sgretolarsi e allora alla «spontaneità» può sostituirsi la «costrizione» in forme sempre meno larvate e indirette, fino alle misure vere e proprie di polizia e ai colpi di Stato.
Il Partito d'Azione non solo non poteva avere, data la sua natura, un simile potere di attrazione, ma era esso stesso attratto e influenzato, sia per l’atmosfera di intimidazione (panico di un 93 terroristico rinforzato dagli avvenimenti francesi del 48‑49) che lo rendeva esitante ad accogliere nel suo programma determinate rivendicazioni popolari (per esempio la riforma agraria), sia perché alcune delle sue maggior, personalità (Garibaldi) erano, sia pure saltuariamente (oscillazioni), in rapporto personale di subordinazione coi capi dei moderati. Perché il Partito d'Azione fosse diventato una forza autonoma e, in ultima analisi, fosse riuscito per lo meno a imprimere al moto del Risorgimento un carattere più marcatamente popolare e democratico (più in là non poteva forse giungere date le premesse fondamentali del moto stesso), avrebbe dovuto contrapporre all’attività «empirica» dei moderati (che era empirica solo per modo di dire poiché corrispondeva perfettamente al fine) un programma organico di governo che riflettesse le rivendicazioni essenziali delle masse popolari, in primo luogo dei contadini: all’«attrazione spontanea» esercitata dai moderati avrebbe dovuto contrapporre una resistenza e una controffensiva «organizzate» secondo un piano.
Come esempio tipico di attrazione spontanea dei moderati è da ricordare il formarsi e lo sviluppo del movimento «cattolico‑liberale», che tanto impressionò il papato e in parte riuscì a paralizzarne le mosse, demoralizzandolo, in un primo tempo spingendolo troppo a sinistra – con le manifestazioni liberaleggianti di Pio IX – e in un secondo tempo cacciandolo in una posizione più destra di quella che avrebbe potuto occupare e in definitiva determinandone l’isolamento nella penisola e in Europa. Il papato ha dimostrato successivamente di aver appreso la lezione e ha saputo nei tempi più recenti manovrare brillantemente: il modernismo prima e il popolarismo poi sono movimenti simili a quello cattolico‑liberale del Risorgimento, dovuti in gran parte al potere di attrazione spontanea esercitata dallo storicismo moderno degli intellettuali laici delle classi alte da una parte e dall’altra dal movimento pratico della filosofia della prassi. Il papato ha colpito il modernismo come tendenza riformatrice della Chiesa e della religione cattolica, ma ha sviluppato il popolarismo, cioè la base economico sociale del modernismo e oggi con Pio XI fa di esso il fulcro della sua politica mondiale.
Invece il Partito d'Azione mancò addirittura di un programma concreto di governo. Esso, in sostanza, fu sempre, più che altro, un organismo di agitazione e propaganda al servizio dei moderati. I dissidi e i conflitti interni del Partito d’Azione, gli odii tremendi che Mazzini suscitò contro la sua persona e la sua attività da parte dei più gagliardi uomini d’azione (Garibaldi, Felice Orsini, ecc.) furono determinati dalla mancanza di una ferma direzione politica. Le polemiche interne furono in gran parte tanto astratte quanto lo era la predicazione del Mazzini, ma da esse si possono trarre utili indicazioni storiche (valgano per tutti gli scritti del Pisacane, che d’altronde commise errori politici e militari irreparabili, come l’opposizione alla dittatura militare di Garibaldi nella Repubblica Romana). Il Partito d'Azione era imbevuto della tradizione retorica della letteratura italiana: confondeva l’unità culturale esistente nella penisola – limitata però a uno strato molto sottile della popolazione e inquinata dal cosmopolitismo vaticano – con l’unità politica e territoriale delle grandi masse popolari che erano estranee a quella tradizione culturale e se ne infischiavano dato che ne conoscessero l’esistenza stessa. Si può fare un confronto tra i giacobini e il Partito d'Azione. I giacobini lottarono strenuamente per assicurare un legame tra città e campagna e ci riuscirono vittoriosamente. La loro sconfitta come partito determinato fu dovuta al fatto che a un certo punto si urtarono contro le esigenze degli operai parigini, ma essi in realtà furono continuati in altra forma da Napoleone e oggi, molto miseramente, dai radico‑socialisti di Herriot e Daladier.
Nella letteratura politica francese la necessità di collegare la città (Parigi) con la campagna era sempre stata vivamente sentita ed espressa; basta ricordare la collana di romanzi di Eugenio Sue, diffusissimi anche in Italia (il Fogazzaro nel Piccolo mondo antico mostra come Franco Maironi ricevesse clandestinamente dalla Svizzera le dispense dei Misteri del Popolo che furono bruciati per mano del carnefice in alcune città europee, per esempio a Vienna) e che insistono con particolare costanza sulla necessità di occuparsi dei contadini e di legarli a Parigi; e il Sue fu il romanziere popolare della tradizione politica giacobina e un «incunabolo» di Herriot e Daladier per tanti punti di vista (leggenda napoleonica, anticlericalismo e antigesuitismo, riformismo piccolo‑borghese, teorie penitenziarie, ecc.). È vero che il Partito d'Azione fu sempre implicitamente antifrancese per l’ideologia mazziniana (cfr nella «Critica»,anno 1929, pp. 223 sgg., il saggio dell’Omodeo su Primato francese e iniziativa italiana), ma aveva nella storia della penisola la tradizione a cui risalire e ricollegarsi. La storia dei Comuni è ricca di esperienze in proposito: la borghesia nascente cerca alleati nei contadini contro l’Impero e contro il feudalismo locale (è vero che la quistione è resa complessa dalla lotta tra borghesi e nobili per contendersi la mano d’opera a buon mercato: i borghesi hanno bisogno di mano d’opera abbondante ed essa può solo essere data dalle masse rurali, ma i nobili vogliono legati al suolo i contadini: fuga di contadini in città, dove i nobili non possono catturarli. In ogni modo, anche in situazione diversa, appare, nello sviluppo della civiltà comunale, la funzione della città come elemento direttivo, della città che approfondisce i conflitti interni nella campagna e se ne serve come strumento politico‑militare per abbattere il feudalismo). Ma il più classico maestro di arte politica per i gruppi dirigenti italiani, il Machiavelli, aveva anch’egli posto il problema, naturalmente nei termini e con le preoccupazioni del tempo suo; nelle scritture politico‑militari del Machiavelli è vista abbastanza bene la necessità di subordinare organicamente le masse popolari ai ceti dirigenti per creare una milizia nazionale capace di eliminare le compagnie di ventura.
A questa corrente del Machiavelli deve forse essere legato Carlo Pisacane, per il quale il problema di soddisfare le rivendicazioni popolari (dopo averle suscitate con la propaganda) è visto prevalentemente dal punto di vista militare. A proposito del Pisacane occorre analizzare alcune antinomie della sua concezione: il Pisacane, nobile napoletano, era riuscito a impadronirsi di una serie di concetti politico-militari posti in circolazione dalle esperienze guerresche della rivoluzione francese e di Napoleone, trapiantati a Napoli sotto i regni di Giuseppe Buonaparte e di Gioacchino Murat, ma specialmente per l’esperienza viva degli ufficiali napoletani che avevano militato con Napoleone (nella commemorazione di Cadorna fatta da M. Missiroli nella «Nuova Antologia» si insiste sull’importanza che tale esperienza e tradizione militare napoletana, attraverso il Pianell, per esempio, ebbe nella riorganizzazione dell’esercito italiano dopo il 1870); Pisacane comprese che senza una politica democratica non si possono avere eserciti nazionali a coscrizione obbligatoria, ma è inspiegabile la sua avversione contro la strategia di Garibaldi e la sua diffidenza contro Garibaldi; egli ha verso Garibaldi lo stesso atteggiamento sprezzante che avevano verso Napoleone gli Stati Maggiori dell’antico regime.
L’individualità che più occorre studiare per questi problemi del Risorgimento è Giuseppe Ferrari, ma non tanto nelle sue opere così dette maggiori, veri zibaldoni farraginosi e confusi, quanto negli opuscoli d’occasione e nelle lettere. Il Ferrari però era in gran parte fuori della concreta realtà italiana: si era troppo infranciosato. Spesso i suoi giudizi paiono più acuti di ciò che realmente sono, perché egli applicava all’Italia schemi francesi, i quali rappresentavano situazioni ben più avanzate di quelle italiane. Si può dire che il Ferrari si trovava, nei confronti con l’Italia, nella posizione di un «postero» e che il suo fosse in un certo senso un «senno del poi». Il politico invece deve essere un realizzatore effettuale ed attuale; il Ferrari non vedeva che tra la situazione italiana e quella francese mancava un anello intermedio e che proprio questo anello importava saldare per passare a quello successivo. Il Ferrari non seppe «tradurre» il francese in italiano e perciò la sua stessa «acutezza» diventava un elemento di confusione, suscitava nuove sette e scolette ma non incideva nel movimento reale.
Se si approfondisce la quistione appare che, per molti riguardi, la differenza tra molti uomini del Partito d’Azione e i moderati era più di «temperamento» che di carattere organicamente politico. Il termine di «giacobino» ha finito per assumere due significati: uno è quello proprio, storicamente caratterizzato, di un determinato partito della rivoluzione francese, che concepiva lo svolgimento della vita francese in un modo determinato, con un programma determinato, sulla base di forze sociali determinate e che esplicò la sua azione di partito e di governo con un metodo determinato che era caratterizzato da una estrema energia, decisione e risolutezza, dipendente dalla credenza fanatica della bontà e di quel programma e di quel metodo.
Nel linguaggio politico i due aspetti del giacobinismo furono scissi e si chiamò giacobino l’uomo politico energico, risoluto e fanatico, perché fanaticamente persuaso delle virtù taumaturgiche delle sue idee, qualunque esse fossero: in questa definizione prevalsero gli elementi distruttivi derivati dall’odio contro gli avversari e i nemici, più che quelli costruttivi, derivati dall’aver fatto proprie le rivendicazioni delle masse popolari, l’elemento settario, di conventicola, di piccolo gruppo, di sfrenato individualismo, più che l’elemento politico nazionale. Così quando si legge che Crispi fu un giacobino, è in questo significato deteriore che occorre intendere l’affermazione.
Per il suo programma Crispi fu un moderato puro e semplice. La sua «ossessione» giacobina più nobile fu l’unità politico‑territoriale del paese. Questo principio fu sempre la sua bussola d’orientamento, non solo nel periodo del Risorgimento, in senso stretto, ma anche nel periodo successivo, della sua partecipazione al governo. Uomo fortemente passionale, egli odia i moderati come persone: vede nei moderati gli uomini dell’ultima ora, gli eroi della sesta giornata, gente che avrebbe fatto la pace coi vecchi regimi se essi fossero divenuti costituzionali, gente, come i moderati toscani, che si erano aggrappati alla giacca del granduca per non farlo scappare; egli si fidava poco di una unità fatta da non‑unitari. Perciò si lega alla monarchia che egli capisce sarà risolutamente unitaria per ragioni dinastiche e abbraccia il principio dell’egemonia piemontese con una energia e una foga che non avevano gli stessi politici piemontesi. Cavour aveva avvertito di non trattare il Mezzogiorno con gli stati d’assedio: Crispi invece subito stabilisce lo stato d’assedio e i tribunali marziali in Sicilia per il movimento dei Fasci e accusa i dirigenti dei Fasci di tramare con l’Inghilterra per il distacco della Sicilia (pseudo‑trattato di Bisacquino). Si lega strettamente ai latifondisti siciliani, perché il ceto più unitario per paura delle rivendicazioni contadine, nello stesso tempo in cui la sua politica generale tende a rafforzare l’industrialismo settentrionale con la guerra di tariffe contro la Francia e col protezionismo doganale: egli non esita a gettare il Mezzogiorno e le isole in una crisi commerciale paurosa, pur di rafforzare l’industria che poteva dare al paese una indipendenza reale e avrebbe allargato i quadri del gruppo sociale dominante; è la politica di fabbricare il fabbricante.
Il governo della destra dal ’61 al ’76 aveva solo e timidamente creato le condizioni generali esterne per lo sviluppo economico: sistemazione dell’apparato governativo, strade, ferrovie, telegrafi e aveva sanato le finanze oberate dai debiti per le guerre del Risorgimento. La Sinistra aveva cercato di rimediare all’odio suscitato nel popolo dal fiscalismo unilaterale della Destra, ma non era riuscita che ad essere una valvola di sicurezza: aveva continuato la politica della Destra con uomini e frasi di sinistra. Crispi invece dette un reale colpo in avanti alla nuova società italiana, fu il vero uomo della nuova borghesia. La sua figura è caratterizzata tuttavia dalla sproporzione tra i fatti e le parole, tra le repressioni e l’oggetto da reprimere, tra lo strumento e il colpo vibrato; maneggiava una colubrina arrugginita come fosse stato un moderno pezzo d’artiglieria. Anche la politica coloniale di Crispi è legata alla sua ossessione unitaria e in ciò seppe comprendere l’innocenza politica del Mezzogiorno; il contadino meridionale voleva la terra e Crispi che non gliela voleva (e poteva) dare in Italia stessa, che non voleva fare del «giacobinismo economico», prospettò il miraggio delle terre coloniali da sfruttare. L’imperialismo di Crispi fu un imperialismo passionale, oratorio, senza alcuna base economico‑finanziaria. L’Europa capitalistica, ricca di mezzi e giunta al punto in cui il saggio del profitto cominciava a mostrare la tendenza alla caduta, aveva la necessità di ampliare l’area di espansione dei suoi investimenti redditizi: così furono creati dopo il 1890 i grandi imperi coloniali. Ma l’Italia ancora immatura, non solo non aveva capitali da esportare, ma doveva ricorrere al capitale estero per i suoi stessi strettissimi bisogni. Mancava dunque una spinta reale all’imperialismo italiano e ad essa fu sostituita la passionalità popolare dei rurali ciecamente tesi verso la proprietà della terra: si trattò di una necessità di politica interna da risolvere, deviandone la soluzione all’infinito. Perciò la politica di Crispi fu avversata dagli stessi capitalisti (settentrionali) che più volentieri avrebbero visto impiegate in Italia le somme ingenti spese in Africa; ma nel Mezzogiorno Crispi fu popolare per aver creato il «mito» della terra facile.
Crispi ha dato una forte impronta a un vasto gruppo di intellettuali siciliani (specialmente, poiché ha influenzato tutti gli intellettuali italiani, creando le prime cellule di un socialismo nazionale che doveva svilupparsi più tardi impetuosamente), ha creato quel fanatismo unitario che ha determinato una permanente atmosfera di sospetto contro tutto ciò che può arieggiare a separatismo. Ciò però non ha impedito (e si comprende) che nel 1920 i latifondisti siciliani si riunissero a Palermo e pronunziassero un vero ultimatum contro il governo «di Roma», minacciando la separazione, come non ha impedito che parecchi di questi latifondisti abbiano continuato a mantenere la cittadinanza spagnola e abbiano fatto intervenire diplomaticamente il governo di Madrid (caso del duca di Bivona nel 1919) per la tutela dei loro interessi minacciati dall’agitazione dei contadini ex‑combattenti. L’atteggiamento dei vari gruppi sociali del Mezzogiorno dal ’19 al ’26 serve a mettere in luce e in rilievo alcune debolezze dell’indirizzo ossessionatamente unitario di Crispi e a mettere in rilievo alcune correzioni apportatevi da Giolitti (poche in realtà, perché Giolitti si mantenne essenzialmente nel solco di Crispi; al giacobinismo di temperamento del Crispi, Giolitti sostituì la solerzia e la continuità burocratica; mantenne il «miraggio della terra» nella politica coloniale, ma in più sorresse questa politica con una concezione «difensiva» militare e con la premessa che occorre creare le condizioni di libertà d’espansione per il futuro).
L’episodio dell’ultimatum dei latifondisti siciliani nel 1920 non è isolato e di esso potrebbe darsi altra interpretazione, per il precedente delle alte classi lombarde che in qualche occasione avevano minacciato «di far da sé» ricostituendo l’antico ducato di Milano (politica di ricatto momentaneo verso il governo), se non trovasse una interpretazione autentica nelle campagne fatte dal «Mattino» dal 1919 fino alla defenestrazione dei fratelli Scarfoglio, che sarebbe troppo semplicistico ritenere del tutto campate in aria, cioè non legate in qualche modo a correnti d’opinione pubblica e a stati d’animo rimasti sotterranei, latenti, potenziali per l’atmosfera d’intimidazione creata dall’unitarismo ossessionato. Il «Mattino» a due riprese sostenne questa tesi: che il Mezzogiorno è entrato a far parte dello Stato italiano su una base contrattuale, lo Statuto albertino, ma che (implicitamente) continua a conservare una sua personalità reale, di fatto, e ha il diritto di uscire dal nesso statale unitario se la base contrattuale viene, in qualsiasi modo, menomata, se cioè viene mutata la costituzione del ’48. Questa tesi fu svolta nel ’19‑20 contro un mutamento costituzionale in un certo senso, e fu ripresa nel ’24‑25 contro un mutamento in altro senso. Bisogna tener presente l’importanza che aveva il «Mattino» nel Mezzogiorno (era intanto il giornale più diffuso); il «Mattino» fu sempre crispino, espansionista, dando il tono all’ideologia meridionale, creata dalla fame di terra e dalle sofferenze dell’emigrazione, tendente verso ogni vaga forma di colonialismo di popolamento. Del «Mattino» occorre ricordare inoltre: 1°) la violentissima campagna contro il Nord a proposito del tentativo di manomissione da parte dei tessili lombardi di alcune industrie cotoniere meridionali, giunto fino al punto in cui si stava per trasportare le macchine in Lombardia, truccate da ferro vecchio per eludere la legislazione sulle zone industriali, tentativo sventato appunto dal giornale che giunse fino a fare una esaltazione dei Borboni e della loro politica economica (ciò avvenne nel 1923); 2) la commemorazione «accorata» e «nostalgica» di Maria Sofia fatta nel 1925 e che destò scalpore e scandalo.
È certo che per apprezzare questo atteggiamento del «Mattino» occorre tener conto di alcuni elementi di controllo metodico: il carattere avventuroso e la venalità degli Scarfoglio (è da ricordare che Maria Sofia cercò continuamente di intervenire nella politica interna italiana, per spirito di vendetta se non con la speranza di restaurare il regno di Napoli, spendendo anche quattrini come non pare dubbio: nell’«Unità» del 1914 o 15 fu pubblicato un trafiletto contro Errico Malatesta in cui si affermava che gli avvenimenti del giugno 1914 potevano essere stati patrocinati e sussidiati dallo Stato Maggiore austriaco per il tramite di Zita di Borbone, dati i rapporti di «amicizia», pare non interrotta mai, tra il Malatesta e Maria Sofia; nell’opera Uomini e cose della vecchia Italia, B. Croce ritorna su tali rapporti a proposito di un tentativo per far evadere un anarchico che aveva commesso un attentato, seguito da un passo diplomatico del governo italiano presso il governo francese per far cessare queste attività di Maria Sofia; ricordare inoltre gli aneddoti su Maria Sofia raccontati dalla signora B. che nel 1919 frequentò l’ex regina per farle il ritratto; infine Malatesta non rispose mai a queste accuse, come era suo obbligo, a meno non sia vero che egli vi abbia risposto in una lettera a un giornaletto clandestino, stampato in Francia da P. Schicchi e intitolato «Il Picconiere», cosa molto dubbia), il dilettantismo politico e ideologico degli Scarfoglio. Ma occorre insistere sul fatto che il «Mattino» era il giornale più diffuso del Mezzogiorno e che gli Scarfoglio erano dei giornalisti nati, cioè possedevano quell’intuizione rapida e «simpatica» delle correnti passionali popolari più profonde che rende possibile la diffusione della stampa gialla.
Un altro elemento per saggiare la portata reale della politica
unitaria ossessionata di Crispi è il complesso di sentimenti
creatosi nel Settentrione per riguardo al Mezzogiorno. La
«miseria» del Mezzogiorno era «inspiegabile» storicamente per le
masse popolari del Nord; esse non capivano che l’unità non era
avvenuta su una base di uguaglianza, ma come egemonia del Nord
sul Mezzogiorno nel rapporto territoriale di città‑campagna,
cioè che il Nord concretamente era una «piovra» che si
arricchiva alle spese del Sud e che il suo incremento
economico‑industriale era in rapporto diretto con
l’impoverimento dell’economia e dell’agricoltura meridionale. Il
popolano dell’Alta Italia pensava invece che se il Mezzogiorno
non progrediva dopo essere stato liberato dalle pastoie che allo
sviluppo moderno opponeva il regime borbonico, ciò significava
che le cause della miseria non erano esterne, da ricercarsi
nelle condizioni economico‑politiche obiettive, ma interne,
innate nella popolazione meridionale, tanto più che era radicata
la persuasione della grande ricchezza naturale del terreno: non
rimaneva che una spiegazione, l’incapacità organica degli
uomini, la loro barbarie, la loro inferiorità biologica.
Queste opinioni già diffuse (il lazzaronismo napoletano era una
leggenda di vecchia data) furono consolidate e addirittura
teorizzate dai sociologhi del positivismo (Niceforo, Sergi,
Ferri, Orano, ecc.) assumendo la forza di «verità scientifica»
in un tempo di superstizione della scienza. Si ebbe così una
polemica Nord‑Sud sulle razze e sulla superiorità e
inferiorità del Nord e del Sud (cfr i libri di N.
Colajanni in difesa del Mezzogiorno da questo punto di vista, e
la collezione della «Rivista popolare»). Intanto rimase nel Nord
la credenza che il Mezzogiorno fosse una «palla di piombo» per
l’Italia, la persuasione che più grandi progressi la civiltà
industriale moderna dell’Alta Italia avrebbe fatto senza questa
«palla di piombo», ecc.
Nei principii del secolo si inizia una forte reazione meridionale anche su questo terreno. Nel Congresso Sardo del 1911, tenuto sotto la presidenza del generale Rugiu, si calcola quante centinaia di milioni siano stati estorti alla Sardegna nei primi 50 anni di Stato unitario, a favore del continente. Campagne del Salvemini, culminate nella fondazione dell’«Unità», ma condotte già nella «Voce» (cfr numero unico della «Voce» sulla «Quistione meridionale» ristampato poi in opuscolo): in Sardegna si inizia un movimento autonomistico, sotto la direzione di Umberto Cau, che ebbe anche un giornale quotidiano «Il Paese». In questo inizio di secolo si realizza anche un certo «blocco intellettuale», «panitaliano» con a capo B. Croce e Giustino Fortunato, che cerca di imporre la quistione meridionale come problema nazionale capace di rinnovare la vita politica e parlamentare. In ogni rivista di giovani che abbiano tendenze liberali democratiche e in generale si propongano di svecchiare e sprovincializzare la vita e la cultura nazionale, in tutti i campi, nell’arte, nella letteratura, nella politica, appare non solo l’influsso del Croce e del Fortunato, ma la loro collaborazione; così nella «Voce» e nell’«Unità», ma anche nella «Patria» di Bologna, nell’«Azione Liberale» di Milano, nel movimento giovane liberale guidato da Giovanni Borelli ecc. L’influsso di questo blocco si fa strada nel fissare la linea politica del «Corriere della Sera» di Albertini, e nel dopoguerra, data la nuova situazione, appare nella «Stampa» (attraverso Cosmo, Salvatorelli, e anche Ambrosini) e nel giolittismo, con l’assunzione del Croce nell’ultimo governo Giolitti.
Di questo movimento, certo molto complesso e multilaterale, viene data oggi una interpretazione tendenziosa anche da G. Prezzolini che pure ne fu una tipica incarnazione; ma rimane la prima edizione della Cultura italiana dello stesso Prezzolini (1923) specialmente con le sue omissioni, come documento autentico.
Il movimento si sviluppa fino al suo maximum che è anche il suo punto di dissoluzione: questo punto è da identificare nella particolare presa di posizione di P. Gobetti e nelle sue iniziative culturali: la polemica di Giovanni Ansaldo (e dei suoi collaboratori come «Calcante» ossia Francesco Ciccotti) contro Guido Dorso è il documento più espressivo di tale punto d’approdo e di risoluzione, anche per la comicità che ormai appare evidente negli atteggiamenti gladiatori e di intimidazione dell’unitarismo ossessionato (che l’Ansaldo, nel ’25‑26, credesse di poter far credere a un ritorno dei Borboni a Napoli, sembrerebbe inconcepibile senza la conoscenza di tutti gli antecedenti della quistione e delle vie sotterranee attraverso cui avvenivano le polemiche, per sottinteso e per riferimento enigmistico ai non «iniziati»: tuttavia è notevole che anche in alcuni elementi popolari, che avevano letto Oriani, esisteva allora la paura che a Napoli fosse possibile una restaurazione borbonica e quindi una dissoluzione più estesa del nesso statale unitario).
Da questa serie di osservazioni e di analisi di alcuni elementi della storia italiana dopo l’unità si possono ricavare alcuni criteri per apprezzare la posizione di contrasto tra i moderati e il Partito d'Azione, e per ricercare la diversa «saggezza» politica di questi due partiti e delle diverse correnti che si contesero la direzione politica e ideologica dell’ultimo di essi. È evidente che per contrapporsi efficacemente ai moderati, il Partito d'Azione doveva legarsi alle masse rurali, specialmente meridionali, essere «giacobino» non solo per la «forma» esterna, di temperamento, ma specialmente per il contenuto economico‑sociale: il collegamento delle diverse classi rurali che si realizzava in un blocco reazionario attraverso i diversi ceti intellettuali legittimisti‑clericali poteva essere dissolto per addivenire ad una nuova formazione liberale‑nazionale solo se si faceva forza in due direzioni: sui contadini di base, accettandone le rivendicazioni elementari e facendo di esse parte integrante del nuovo programma di governo, e sugli intellettuali degli strati medi e inferiori, concentrandoli e insistendo sui motivi che più li potevano interessare (e già la prospettiva della formazione di un nuovo apparato di governo, con le possibilità di impiego che offre, era un elemento formidabile di attrazione su di essi, se la prospettiva si fosse presentata come concreta perché poggiata sulle aspirazioni dei rurali). Il rapporto tra queste due azioni era dialettico e reciproco: l’esperienza di molti paesi, e prima di tutto della Francia nel periodo della grande rivoluzione, ha dimostrato che se i contadini si muovono per impulsi «spontanei», gli intellettuali cominciano a oscillare e, reciprocamente, se un gruppo di intellettuali si pone sulla nuova base di una politica filocontadina concreta, esso finisce col trascinare con sé frazioni di massa sempre più importanti. Si può dire però che, data la dispersione e l’isolamento della popolazione rurale e la difficoltà quindi di concentrarla in solide organizzazioni, conviene iniziare il movimento dai gruppi intellettuali; in generale però è il rapporto dialettico tra le due azioni che occorre tener presente. Si può anche dire che partiti contadini nel senso stretto della parola è quasi impossibile crearne: il partito contadino si realizza in generale solo come forte corrente di opinioni, non già in forme schematiche d’inquadramento burocratico; tuttavia l’esistenza anche solo di uno scheletro organizzativo è di utilità immensa, sia per una certa selezione di uomini, sia per controllare i gruppi intellettuali e impedire che gli interessi di casta li trasportino impercettibilmente in altro terreno.
Questi criteri devono essere tenuti presenti nello studio della personalità di Giuseppe Ferrari che fu lo «specialista» inascoltato di quistioni agrarie nel Partito d'Azione. Nel Ferrari occorre anche studiare bene l’atteggiamento verso il bracciantato agricolo, cioè i contadini senza terra e viventi alla giornata, sui quali egli fonda una parte cospicua delle sue ideologie, per le quali egli è ancora ricercato e letto da determinate correnti (opere del Ferrari ristampate dal Monanni con prefazioni di Luigi Fabbri). Occorre riconoscere che il problema del bracciantato è difficilissimo e anche oggi di ardua soluzione. In generale occorre tener presenti questi criteri: i braccianti sono ancora oggi, nella maggior parte, ed erano quindi tanto più nel periodo del Risorgimento, dei semplici contadini senza terra, non degli operai di una industria agricola sviluppata con capitale concentrato e con la divisione del lavoro; nel periodo del Risorgimento era più diffuso, in modo rilevante, il tipo dell’obbligato in confronto a quello dell’avventizio. La loro psicologia perciò è, con le dovute eccezioni, la stessa del colono e del piccolo proprietario (è da ricordare la polemica tra i senatori Tanari e Bassini nel «Resto del Carlino» e nella «Perseveranza» avvenuta verso la fine del 1917 o ai primi del ’18 a proposito della realizzazione della formula la «terra ai contadini» lanciata in quel torno di tempo: il Tanari era pro, il Bassini contro e il Bassini si fondava sulla sua esperienza di grande industriale agricolo, di proprietario di aziende agricole in cui la divisione del lavoro era già talmente progredita da rendere indivisibile la terra per la sparizione del contadino‑artigiano e l’emergere dell’operaio moderno). La quistione si poneva in forma acuta non tanto nel Mezzogiorno dove il carattere artigianesco del lavoro agricolo era troppo evidente, ma nella valle padana dove esso è più velato. Anche in tempi recenti però l’esistenza di un problema acuto dei bracciantato nella valle padana era dovuta in parte a cause «extraeconomiche»: 1) sovrapopolazione che non trovava uno sbocco nell’emigrazione come nel Sud ed era mantenuta artificialmente con la politica dei lavori pubblici; 2) politica dei proprietari che non volevano consolidare in un’unica classe di braccianti e di mezzadri la popolazione lavoratrice, alternando alla mezzadria la conduzione ad economia servendosi di questo alternare per determinare una migliore selezione di mezzadri privilegiati che fossero i loro alleati (in ogni Congresso di agrari della regione padana si discuteva sempre se conveniva meglio la mezzadria o la conduzione diretta ed era chiaro che la scelta veniva fatta per motivi di ordine politico‑sociale). Durante il Risorgimento il problema del bracciantato padano appariva sotto la forma di un fenomeno pauroso di pauperismo. Così è visto dall’economista Tullio Martollo nella sua Storia dell’Internazionale, scritta nel 1871‑72, lavoro che occorre tener presente perché riflette le posizioni politiche e le preoccupazioni sociali del periodo precedente.
La posizione del Ferrari è indebolita poi dal suo «federalismo» che, specialmente in lui, vivente in Francia, appariva ancora più come un riflesso degli interessi nazionali e statali francesi. È da ricordare il Proudhon e i suoi libelli contro l’unità italiana combattuta dal confessato punto di vista degli interessi statali francesi e della democrazia. In realtà le principali correnti della politica francese erano aspramente contrarie all’unità italiana. Ancora oggi i monarchici (Bainville e C.) «rimproverano» retrospettivamente ai due Napoleoni di aver creato il mito nazionalitario e di aver contribuito a farlo realizzare in Germania e in Italia, abbassando così la statura relativa della Francia che «dovrebbe» essere circondata da un pulviscolo di staterelli tipo Svizzera per essere «sicura».
Ora è proprio sulla parola d’ordine di «indipendenza e unità», senza tener conto del concreto contenuto politico di tali formule generiche, che i moderati dopo il 48 formarono il blocco nazionale sotto la loro egemonia, influenzando i due capi supremi del Partito d'Azione, Mazzini e Garibaldi, in diversa forma e misura. Come i moderati fossero riusciti nel loro intento di deviare l’attenzione dal nocciolo alla buccia dimostra, tra le tante altre, questa espressione del Guerrazzi in una lettera a uno studente siciliano (pubblicata nell’«Archivio Storico Siciliano» da Eugenio de Carlo – Carteggio di F. D. Guerrazzi col notaio Francesco Paolo Sardofontana di Riella, riassunto nel «Marzocco» del 29 novembre 1929): «Sia che vuolsi – o dispotismo, o repubblica o che altro – non cerchiamo di dividerci; con questo cardine, caschi il mondo, ritroveremo la via». Del resto tutta l’operosità di Mazzini è stata concretamente riassunta nella continua e permanente predicazione dell’unità.
A proposito del giacobinismo e del Partito d'Azione un elemento da porre in primo piano è questo: che i giacobini conquistarono con la lotta senza quartiere la loro funzione di partito dirigente; essi in realtà si «imposero» alla borghesia francese, conducendola in una posizione molto più avanzata di quella che i nuclei borghesi primitivamente più forti avrebbero voluto «spontaneamente» occupare e anche molto più avanzata di quella che le premesse storiche dovevano consentire, e per ciò i colpi di ritorno e la funzione di Napoleone I. Questo tratto, caratteristico del giacobinismo (ma prima anche di Cromwell e delle «teste rotonde») e quindi di tutta la grande rivoluzione, del forzare la situazione (apparentemente) e del creare fatti compiuti irreparabili, cacciando avanti i borghesi a calci nel sedere, da parte di un gruppo di uomini estremamente energici e risoluti, può essere così «schematizzata»: il terzo stato era il meno omogeneo degli stati; aveva una élite intellettuale molto disparata e un gruppo economicamente molto avanzato ma politicamente moderato. Lo sviluppo degli avvenimenti segue un processo dei più interessanti. I rappresentanti del terzo stato inizialmente pongono solo le quistioni che interessano i componenti fisici attuali del gruppo sociale, i loro interessi «corporativi» immediati (corporativi, nel senso tradizionale, di immediati ed egoistici in senso gretto di una determinata categoria): i precursori della rivoluzione sono infatti dei riformatori moderati, che fanno la voce grossa ma in realtà domandano ben poco. A mano a mano si viene selezionando una nuova élite che non si interessa unicamente di riforme «corporative» ma tende a concepire la borghesia come il gruppo egemone di tutte le forze popolari e questa selezione avviene per l’azione di due fattori: la resistenza delle vecchie forze sociali e la minaccia internazionale. Le vecchie forze non vogliono cedere nulla e se cedono qualche cosa lo fanno con la volontà di guadagnare tempo e preparare una controffensiva. Il terzo stato sarebbe caduto in questi «tranelli» successivi senza l’azione energica dei giacobini, che si oppongono ad ogni sosta «intermedia» del processo rivoluzionario e mandano alla ghigliottina non solo gli elementi della vecchia società dura a morire, ma anche i rivoluzionari di ieri, oggi diventati reazionari. I giacobini pertanto furono il solo partito della rivoluzione in atto, in quanto non solo essi rappresentavano i bisogni e le aspirazioni immediate delle persone fisiche attuali che costituivano la borghesia francese, ma rappresentavano il movimento rivoluzionario nel suo insieme, come sviluppo storico integrale, perché rappresentavano i bisogni anche futuri e, di nuovo, non solo di quelle determinate persone fisiche, ma di tutti i gruppi nazionali che dovevano essere assimilati al gruppo fondamentale esistente.
Occorre insistere, contro una corrente tendenziosa e in fondo antistorica, che i giacobini furono dei realisti alla Machiavelli e non degli astrattisti. Essi erano persuasi dell’assoluta verità delle formule sull’uguaglianza, la fraternità, la libertà e, ciò che importa di più, di tale verità erano persuase le grandi masse popolari che i giacobini suscitavano e portavano alla lotta. Il linguaggio dei giacobini, la loro ideologia, i loro metodi d’azione, riflettevano perfettamente le esigenze dell’epoca, anche se «oggi», in una diversa situazione e dopo più di un secolo di elaborazione culturale, possono parere «astrattisti» e «frenetici». Naturalmente le riflettevano secondo la tradizione culturale francese e di ciò è una prova l’analisi che del linguaggio giacobino si ha nella Sacra Famiglia e l’ammissione di Hegel che pone come paralleli e reciprocamente traducibili il linguaggio giuridico‑politico dei giacobini e i concetti della filosofia classica tedesca, alla quale invece oggi si riconosce il massimo di concretezza e che ha originato lo storicismo moderno.
La prima esigenza era quella di annientare le forze avversarie o almeno ridurle all’impotenza per rendere impossibile una controrivoluzione; la seconda esigenza era quella di allargare i quadri della borghesia come tale e di porla a capo di tutte le forze nazionali, identificando gli interessi e le esigenze comuni a tutte le forze nazionali e mettere in moto queste forze e condurle alla lotta ottenendo due risultati: a) di opporre un bersaglio più largo ai colpi degli avversari, cioè di creare un rapporto politico‑militare favorevole alla rivoluzione; b) di togliere agli avversari ogni zona di passività in cui fosse possibile arruolare eserciti vandeani. Senza la politica agraria dei giacobini Parigi avrebbe avuto la Vandea già alle sue porte. La resistenza della Vandea propriamente detta è legata alla quistione nazionale inasprita nelle popolazioni brettoni, e in generale allogene, dalla formula della «repubblica una e indivisibile» e dalla politica di accentramento burocratico-militare, alle quali i giacobini non potevano rinunziare senza suicidarsi. I girondini cercarono di far leva sul federalismo per schiacciare Parigi giacobina, ma le truppe provinciali condotte a Parigi passarono ai rivoluzionari. Eccetto alcune zone periferiche, dove la distinzione nazionale (e linguistica) era grandissima, la quistione agraria ebbe il sopravvento su le aspirazioni all’autonomia locale: la Francia rurale accettò l’egemonia di Parigi, cioè comprese che per distruggere definitivamente il vecchio regime doveva far blocco con gli elementi più avanzati del terzo stato, e non con i moderati girondini. Se è vero che i giacobini «forzarono» la mano, è anche vero che ciò avvenne sempre nel senso dello sviluppo storico reale, perché non solo essi organizzarono un governo borghese, cioè fecero della borghesia la classe dominante, ma fecero di più, crearono lo Stato borghese, fecero della borghesia la classe nazionale dirigente, egemone, cioè dettero allo Stato nuovo una base permanente, crearono la compatta nazione moderna francese.
Che, nonostante tutto, i giacobini siano sempre rimasti sul terreno della borghesia, è dimostrato dagli avvenimenti che segnarono la loro fine come partito di formazione troppo determinata e irrigidita e la morte di Robespierre: essi non vollero riconoscere agli operai il diritto di coalizione, mantenendo la legge Chapelier, e come conseguenza dovettero promulgare la legge del «maximum». Spezzarono così il blocco urbano di Parigi: le loro forze d’assalto, che si raggruppavano nel comune, si dispersero, deluse, e il Termidoro ebbe il sopravvento. La rivoluzione aveva trovato i limiti più larghi di classe; la politica delle alleanze e della rivoluzione permanente aveva finito col porre quistioni nuove che allora non potevano essere risolte, aveva scatenato forze elementari che solo una dittatura militare sarebbe riuscita a contenere.
Nel Partito d'Azione non si trova niente che rassomigli a questo indirizzo giacobino, a questa inflessibile volontà di diventare il partito dirigente. Certo occorre tener conto delle differenze: in Italia la lotta si presentava come lotta contro i vecchi trattati e l’ordine internazionale vigente e contro una potenza straniera, l’Austria, che li rappresentava e li sosteneva in Italia, occupando una parte della penisola e controllando il resto. Anche in Francia questo problema si presentò, almeno in un certo senso, perché ad un certo punto la lotta interna divenne lotta nazionale combattuta alla frontiera, ma ciò avvenne dopo che tutto il territorio era conquistato alla rivoluzione e i giacobini seppero dalla minaccia esterna trarre elementi per una maggiore energia all’interno: essi compresero bene che per vincere il nemico esterno dovevano schiacciare all’interno i suoi alleati e non esitarono a compiere i massacri di settembre. In Italia questo legame che pur esisteva, esplicito ed implicito, tra l’Austria e una parte almeno degli intellettuali, dei nobili e dei proprietari terrieri, non fu denunziato dal Partito d'Azione o almeno non fu denunziato con la dovuta energia e nel modo praticamente più efficace, non divenne elemento politico attivo. Si trasformò «curiosamente», in una quistione di maggiore o minore dignità patriottica e dette poi luogo a uno strascico di polemiche acrimoniose e sterili fin dopo il 1898 (cfr gli articoli di «Rerum Scriptor» nella «Critica Sociale», dopo la ripresa delle pubblicazioni, e il libro di Romualdo Bonfadini, Cinquanta anni di patriottismo).
È da ricordare a questo proposito la quistione dei «costituti» di Federico Confalonieri: il Bonfadini, nel libro su citato, afferma in una nota di aver visto la raccolta dei «costituti» nell’Archivio di Stato di Milano e accenna a circa 80 fascicoli. Altri hanno sempre negato che la raccolta dei costituti esistesse in Italia e così ne spiegavano la non pubblicazione; in un articolo del senatore Salata, incaricato di far ricerche negli archivi di Vienna sui documenti riguardanti l’Italia, articolo pubblicato nel 1925 (?), si diceva che i costituti erano stati rintracciati e sarebbero stati pubblicati. Ricordare il fatto che in un certo periodo la «Civiltà Cattolica» sfidò i liberali a pubblicarli, affermando che essi, conosciuti, avrebbero, nientemeno, fatto saltare in aria l’unità dello Stato. Nella quistione Confalonieri il fatto più notevole consiste in ciò, che a differenza di altri patriotti graziati dall’Austria, il Confalonieri, che pure era un rimarchevole uomo politico, si ritirò dalla vita attiva e mantenne dopo la sua liberazione, un contegno molto riservato. Tutta la quistione Confalonieri è da riesaminare criticamente, insieme con l’atteggiamento tenuto da lui e dai suoi compagni, con un esame approfondito delle memorie scritte dai singoli, quando le scrissero: per le polemiche che suscitò sono interessanti le memorie del francese Alessandro Andryane che tributa molto rispetto e ammirazione per il Confalonieri, mentre attacca G. Pallavicino per la sua debolezza.
A proposito delle difese fatte anche recentemente dell’atteggiamento tenuto dall’aristocrazia lombarda verso l’Austria, specialmente dopo il tentativo insurrezionale di Milano del febbraio 1853 e durante il viceregno di Massimiliano, è da ricordare che Alessandro Luzio, la cui opera storica è sempre tendenziosa e acrimoniosa contro i democratici, giunge fino a legittimare i fedeli servizi resi all’Austria dal Salvotti: altro che spirito giacobino!. La nota comica in argomento è data da Alfredo Panzini, che, nella Vita di Cavour fa tutta una variazione altrettanto leziosa quanto stomachevole e gesuitica su una «pelle di tigre» esposta da una finestra aristocratica durante una visita a Milano di Francesco Giuseppe!
Da tutti questi punti di vista devono essere considerate le concezioni di Missiroli, Gobetti, Dorso ecc. sul Risorgimento italiano come «conquista regia» .
Se in Italia non si formò un partito giacobino ci sono le sue ragioni da ricercare nel campo economico, cioè nella relativa debolezza della borghesia italiana e nel clima storico diverso dell’Europa dopo il 1815. Il limite trovato dai giacobini, nella loro politica di forzato risveglio delle energie popolari francesi da alleare alla borghesia, con la legge Chapelier e quella sul «maximum», si presentava nel 48 come uno «spettro» già minaccioso, sapientemente utilizzato dall’Austria, dai vecchi governi e anche dal Cavour (oltre che dal papa). La borghesia non poteva (forse) più estende. re la sua egemonia sui vasti strati popolari che invece poté abbracciare in Francia (non poteva per ragioni soggettive, non oggettive), ma l’azione sui contadini era certamente sempre possibile.
Differenze tra la Francia, la Germania e l’Italia nel processo di presa del potere da parte della borghesia (e Inghilterra). In Francia si ha il processo più ricco di sviluppi e di elementi politici attivi e positivi. In Germania il processo si svolge per alcuni aspetti in modi che rassomigliano a quelli italiani, per altri a quelli inglesi. In Germania il movimento del 48 fallisce per la scarsa concentrazione borghese (la parola d’ordine di tipo giacobino fu data dall’estrema sinistra democratica: «rivoluzione in permanenza») e perché la quistione del rinnovamento statale è intrecciata con la quistione nazionale; le guerre del 64, del 66 e del 70 risolvono insieme la quistione nazionale e quella di classe in un tipo intermedio: la borghesia ottiene il governo economico‑industriale, ma le vecchie classi feudali rimangono come ceto governativo dello Stato politico con ampi privilegi corporativi nell’esercito, nell’amministrazione e sulla terra: ma almeno, se queste vecchie classi conservano in Germania tanta importanza e godono di tanti privilegi, esse esercitano una funzione nazionale, diventano gli «intellettuali» della borghesia, con un determinato temperamento dato dall’origine di casta e dalla tradizione. In Inghilterra, dove la rivoluzione borghese si è svolta prima che in Francia, abbiamo un fenomeno simile a quello tedesco di fusione tra il vecchio e il nuovo, nonostante l’estrema energia dei «giacobini» inglesi, cioè le «teste rotonde» di Cromwell; la vecchia aristocrazia rimane come ceto governativo, con certi privilegi, diventa anch’essa il ceto intellettuale della borghesia inglese (del resto l’aristocrazia inglese è a quadri aperti e si rinnova continuamente con elementi provenienti dagli intellettuali e dalla borghesia). In proposito sono da vedere alcune osservazioni contenute nella prefazione alla traduzione inglese di Utopia e Scienza che occorre ricordare per la ricerca sugli intellettuali e le loro funzioni storico‑sociali.
La spiegazione data da Antonio Labriola sulla permanenza al potere in Germania degli Junker e del kaiserismo nonostante il grande sviluppo capitalistico, adombra la giusta spiegazione: il rapporto di classi creato dallo sviluppo industriale col raggiungimento del limite dell’egemonia borghese e il rovesciamento delle posizioni delle classi progressive, ha indotto la borghesia a non lottare a fondo contro il vecchio regime, ma a lasciarne sussistere una parte della facciata dietro cui velare il proprio dominio reale.
Questa differenza di processo nel manifestarsi dello stesso sviluppo storico nei diversi paesi è da legare non solo alle diverse combinazioni dei rapporti interni alla vita delle diverse nazioni, ma anche ai diversi rapporti internazionali (i rapporti internazionali sono di solito sottovalutati in questo ordine di ricerche). Lo spirito giacobino, audace, temerario, è certamente legato all’egemonia esercitata così a lungo dalla Francia in Europa, oltre che all’esistenza di un centro urbano come Parigi e all’accentramento conseguito in Francia per opera della monarchia assoluta. Le guerre di Napoleone, invece, con l’enorme distruzione di uomini, tra i più audaci e intraprendenti, hanno indebolito non solo l’energia politica militante francese, ma anche quella delle altre nazioni, sebbene intellettualmente siano state così feconde per la rinnovazione dell’Europa.
I rapporti internazionali hanno certo avuto una grande importanza nel determinare la linea di sviluppo del Risorgimento italiano, ma essi sono stati esagerati dal partito moderato e da Cavour a scopo di partito. È notevole, a questo proposito, il fatto di Cavour che teme come il fuoco l’iniziativa garibaldina prima della spedizione di Quarto e del passaggio dello Stretto, per le complicazioni internazionali che poteva creare e poi è spinto egli stesso dall’entusiasmo creato dai Mille nell’opinione europea fino a vedere come fattibile una immediata nuova guerra contro l’Austria. Esisteva in Cavour una certa deformazione professionale dei diplomatico, che lo portava a vedere «troppe» difficoltà e lo induceva a esagerazioni «cospirative» e a prodigi, che sono in buona parte funamboleschi, di sottigliezza e di intrigo. In ogni caso il Cavour operò egregiamente come uomo di partito: che poi il suo partito rappresentasse i più profondi e duraturi interessi nazionali, anche solo nel senso della più vasta estensione da dare alla comunità di esigenze della borghesia con la massa popolare, è un’altra quistione.
A proposito della parola d’ordine «giacobina» formulata nel 48‑49 è da studiarne la complicata fortuna. Ripresa, sistematizzata, elaborata, intellettualizzata dal gruppo Parvus‑Bronstein [Trotzky ndc], si manifestò inerte e inefficace nel 1905, e in seguito: era diventata una cosa astratta, da gabinetto scientifico. La corrente che la avversò in questa sua manifestazione letteraria, invece, senza impiegarla «di proposito», la applicò di fatto in una forma aderente alla storia attuale, concreta, vivente, adatta al tempo e al luogo, come scaturiente da tutti i pori della determinata società che occorreva trasformare, come alleanza di due gruppi sociali, con l’egemonia del gruppo urbano.
Nell’un caso si ebbe il temperamento giacobino senza un contenuto politico adeguato; nel secondo, temperamento e contenuto «giacobino» secondo i nuovi rapporti storici, e non secondo un’etichetta letteraria e intellettualistica.
Q19 §25 Antisemitismo nel Risorgimento. Nelle Confessioni e professioni di fede di Letterati, Filosofi, uomini politici, ecc. (in 3 voll., Bocca, Torino, 1921) è pubblicata una scorribanda lirico‑sentimentale di Raffaele Ottolenghi che riferisce alcuni suoi ricordi di «ebreo» piemontese, da cui possono estrarsi alcune notizie sulla condizione degli ebrei nel periodo del primo Risorgimento.
Un ebreo, veterano di Napoleone, ritornò al suo paese con una donna francese: il vescovo, saputo che la donna era cristiana, contro la sua volontà, la fece portar via dai gendarmi. Il vescovo si impadroniva, manu militari, dei fanciulli ebrei che, durante qualche litigio coi genitori, avessero minacciato di farsi cristiani (il Brofferio registra una serie di questi fatti nella sua storia).
Dopo il 1815 gli ebrei furono cacciati dalle Università e quindi dalle professioni liberali.
Nel 1799, durante l’invasione austro‑russa, avvennero dei pogrom; ad Acqui solo l’intervento del vescovo riuscì a salvare il bisavolo dell’Ottolenghi dai fucili della folla. A Siena, durante un pogrom, degli ebrei furono mandati al rogo, senza che il vescovo volesse intervenire a loro favore.
Nel 48 il padre dell’Ottolenghi tornò ad Acqui da Torino, vestito da guardia nazionale: irritazione dei reazionari che sparsero la voce del sacrifizio rituale di un bambino cristiano da parte dell’Ottolenghi; campane a stormo, venuta dei villani dalla campagna per saccheggiare il Ghetto. Il vescovo si rifiutò di intervenire e l’Ottolenghi fu salvato dal sindaco con un simulato arresto fino all’arrivo delle truppe. I reazionari e i clericali volevano fare apparire le innovazioni liberali del 48 come una invenzione degli ebrei. (Bisognerebbe ricostruire la storia del fanciullo Mortara che ebbe tanta clamorosa eco nelle polemiche contro il clericalismo).
Q19 §26 Il rapporto città‑campagna nel Risorgimento e nella struttura nazionale italiana. I rapporti tra popolazione urbana e popolazione rurale non sono di un solo tipo schematico, specialmente in Italia. Occorre pertanto stabilire cosa si intende per «urbano» e per «rurale» nella civiltà moderna e quali combinazioni possono risultare dalla permanenza di forme antiquate e retrive nella composizione generale della popolazione, studiata dal punto di vista del suo maggiore o minore agglomerarsi. Talvolta si paradosso che un tipo rurale sia più progressivo sedicente urbano.
Una città «industriale» è sempre più progressiva della campagna che ne dipende organicamente. Ma in Italia non tutte le città sono «industriali» e ancor più poche sono le città tipicamente industriali. Le «cento» città italiane sono città industriali, l’agglomeramento della popolazione in centri non rurali, che è quasi doppio di quello francese, dimostra che esiste in Italia una industrializzazione doppia che in Francia? In Italia l’urbanesimo non è solo, e neppure «specialmente», un fenomeno di sviluppo capitalistico e della grande industria. Quella che fu per molto tempo la più grande città italiana e continua ad essere delle più grandi, Napoli, non è una città industriale: neppure Roma, l’attuale maggiore città italiana, è industriale. Tuttavia anche in queste città, di un tipo medioevale, esistono forti nuclei di popolazione del tipo urbano moderno; ma qual è la loro posizione relativa? Essi sono sommersi, premuti, schiacciati dall’altra parte, che non è di tipo moderno ed è la grandissima maggioranza. Paradosso delle «città del silenzio».
In questo tipo di città esiste, tra tutti i gruppi sociali, una unità ideologica urbana contro la campagna, unità alla quale non sfuggono neppure i nuclei più moderni per funzione civile, che pur vi esistono: c’è l’odio e il disprezzo contro il «villano», un fronte unico implicito contro le rivendicazioni della campagna, che, se realizzate, renderebbero impossibile l’esistenza di questo tipo di città. Reciprocamente esiste una avversione «generica» ma non perciò meno tenace e appassionata della campagna contro la città, contro tutta la città, tutti i gruppi che la costituiscono. Questo rapporto generale, che in realtà è molto complesso e si manifesta in forme che apparentemente sembrano contraddittorie, ha avuto una importanza primordiale nello svolgersi delle lotte per il Risorgimento, quando esso era ancor più assoluto e operante che non sia oggi. Il primo esempio clamoroso di queste apparenti contraddizioni è da studiare nell’episodio della Repubblica Partenopea del 1799: la città fu schiacciata dalla campagna organizzata nelle orde del cardinale Ruffo, perché la Repubblica, sia nella sua prima fase aristocratica, che nella seconda borghese, trascurò completamente la campagna da una parte, ma dall’altra, prospettando la possibilità di un rivolgimento giacobino per il quale la proprietà terriera, che spendeva la rendita agraria a Napoli, poteva essere spossessata, privando la grande massa popolare dei suoi cespiti di entrata e di vita, lasciò freddi se non avversi i popolani napoletani. Nel Risorgimento inoltre si manifesta già, embrionalmente, il rapporto storico tra Nord e Sud come un rapporto simile a quello di una grande città e una grande campagna: essendo questo rapporto non già quello organico normale di provincia e capitale industriale, ma risultando tra due vasti territori di tradizione civile e culturale molto diversa, si accentuano gli aspetti e gli elementi di un conflitto di nazionalità. Ciò che nel periodo del Risorgimento è specialmente notevole è il fatto che nelle crisi politiche, il Sud ha l’iniziativa dell’azione: 1799 Napoli, 20‑21 Palermo, 47 Messina e la Sicilia, 47‑48 Sicilia e Napoli. Altro fatto notevole è l’aspetto particolare che ogni movimento assume nell’Italia Centrale, come una via di mezzo tra Nord e Sud: il periodo delle iniziative popolari (relative) va dal 1815 al 1849 e culmina in Toscana e negli Stati del Papa (la Romagna e la Lunigiana occorre sempre considerarle come appartenenti al Centro). Queste peculiarità hanno un riscontro anche successivamente: gli avvenimenti del giugno 1914 hanno culminato in alcune regioni del Centro (Romagna e Marche); la crisi che si inizia nel 1893 in Sicilia e si ripercuote nel Mezzogiorno e in Lunigiana, culmina a Milano nel 1898; nel 1919 si hanno le invasioni di terre nel Mezzogiorno e in Sicilia, nel 1920 l’occupazione delle fabbriche nel Settentrione. Questo relativo sincronismo e simultaneità mostra l’esistenza già dopo il 1815 di una struttura economico‑politica relativamente omogenea, da una parte, e dall’altra mostra come nei periodi di crisi sia la parte più debole e periferica a reagire per la prima.
La relazione di città e campagna tra Nord e Sud può anche essere studiata nelle diverse concezioni culturali e atteggiamenti mentali. Come è stato accennato, B. Croce e G. Fortunato, all’inizio del secolo, sono stati a capo di un movimento culturale, che, in un modo o nell’altro, si contrapponeva al movimento culturale del Nord (idealismo contro positivismo, classicismo o classicità contro futurismo). È da rilevare il fatto che la Sicilia si stacca dal Mezzogiorno anche per il rispetto culturale: se Crispi è l’uomo dell’industrialismo settentrionale, Pirandello nelle linee generali è più vicino al futurismo, Gentile e l’attualismo sono anch’essi più vicini al movimento futurista (inteso in senso largo, come opposizione al classicismo tradizionale, come forma di un romanticismo contemporaneo). Diversa è la struttura e l’origine dei ceti intellettuali: nel Mezzogiorno predomina ancora il tipo del «paglietta», che pone a contatto la massa contadina con quella dei proprietari e con l’apparato statale; nel Nord domina il tipo del «tecnico» d’officina che serve di collegamento tra la massa operaia e gli imprenditori: il collegamento con lo Stato era funzione delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici, diretti da un ceto intellettuale completamente nuovo (l’attuale sindacalismo di Stato, con la conseguenza della diffusione sistematica su scala nazionale di questo tipo sociale, in modo più coerente e conseguente che non fosse possibile al vecchio sindacalismo, è fino a un certo punto e in un certo senso uno strumento di unificazione morale e politica).
Questo complesso rapporto città‑campagna può essere studiato nei programmi politici generali che cercavano di affermarsi prima dell’avvento fascista al governo: il programma di Giolitti e dei liberali democratici tendeva a creare nel Nord un blocco «urbano» (di industriali e operai) che fosse la base di un sistema protezionistico e rafforzasse l’economia e l’egemonia settentrionale. Il Mezzogiorno era ridotto a un mercato di vendita semicoloniale, a una fonte di risparmio e di imposte ed era tenuto «disciplinato» con due serie di misure: misure poliziesche di repressione spietata di ogni movimento di massa con gli eccidi periodici di contadini (nella commemorazione di Giolitti, scritta da Spectator – Missiroli – nella «Nuova Antologia» si fa le meraviglie perché Giolitti si sia sempre strenuamente opposto a ogni diffusione del socialismo e del sindacalismo nel Mezzogiorno, mentre la cosa è naturale e ovvia, poiché un protezionismo operaio – riformismo, cooperative, lavori pubblici – è solo possibile se parziale; cioè ogni privilegio presuppone dei sacrificati e spogliati); misure poliziesche‑politiche: favori personali al ceto degli «intellettuali» o paglietta, sotto forma di impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di permessi di saccheggio impunito delle amministrazioni locali, di una legislazione ecclesiastica applicata meno rigidamente che altrove, lasciando al clero la disponibilità di patrimoni voli ecc., cioè incorporamento a «titolo personale» degli elementi più attivi meridionali nel personale dirigente statale, con particolari privilegi «giudiziari», burocratici ecc. Così lo strato sociale che avrebbe potuto organizzare l’endemico malcontento meridionale, diventava invece uno strumento della politica settentrionale, un suo accessorio di polizia privata. Il malcontento non riusciva, per mancanza di direzione, ad assumere una forma politica normale e le sue manifestazioni, esprimendosi solo in modo caotico e tumultuario, venivano presentate come «sfera di polizia» giudiziaria. In realtà a questa forma di corruzione aderivano sia pure passivamente e indirettamente uomini come il Croce e il Fortunato per la concezione feticistica dell’«Unità» (cfr episodio Fortunato‑Salvemini a proposito dell’«Unità», raccontato dal Prezzolini nella prima edizione della Cultura italiana).
Non bisogna dimenticare il fattore politico‑morale della campagna di intimidazione che si faceva contro ogni anche obbiettivissima constatazione di motivi di contrasto tra Nord e Sud. È da ricordare la conclusione dell’inchiesta Pais‑Serra sulla Sardegna dopo la crisi commerciale del decennio 90-900 e l’accusa già ricordata, mossa da Crispi ai fasci siciliani di essere venduti agli inglesi. Specialmente tra gli intellettuali siciliani esisteva questa forma di esasperazione unitaria (conseguenza della formidabile pressione contadina sulla terra signorile e della popolarità regionale di Crispi) che si è manifestata anche di recente nell’attacco del Natoli contro il Croce per un accenno innocuo al separatismo siciliano dal Regno di Napoli (cfr risposta del Croce nella «Critica»). Il programma di Giolitti fu «turbato» da due fattori: 1) l’affermarsi degli intransigenti nel partito socialista sotto la direzione di Mussolini e il loro civettare coi meridionalisti (libero scambio, elezioni di Molfetta ecc.), che distruggeva il blocco urbano settentrionale; 2) l’introduzione del suffragio universale che allargò in modo inaudito la base parlamentare del Mezzogiorno e rese difficile la corruzione individuale (troppi da corrompere alla liscia e quindi apparizione dei mazzieri).
Giolitti mutò «partenaire», al blocco urbano sostituì (o meglio contrappose per impedirne il completo sfacelo) il «patto Gentiloni», cioè, in definitiva, un blocco tra l’industria settentrionale e i rurali della campagna «organica e normale» (le forze elettorali cattoliche coincidevano con quelle socialiste geograficamente: erano diffuse cioè nel Nord e nel Centro) con estensione degli effetti anche nel Sud, almeno nella misura immediatamente sufficiente per «rettificare» utilmente le conseguenze dell’allargamento della massa elettorale.
L’altro programma o indirizzo politico generale è quello che si può chiamare del «Corriere della Sera» o di Luigi Albertini e può identificarsi in una alleanza tra una parte degli industriali del Nord (con a capo i tessili, cotonieri, setaioli, esportatori e quindi libero scambisti) col blocco rurale del Mezzogiorno: il «Corriere» sostenne Salvemini contro Giolitti nelle elezioni di Molfetta del 1913 (campagna di Ugo Ojetti), sostenne il ministero Salandra prima e quello Nitti in seguito, cioè i primi due governi formati da statisti meridionali (i siciliani sono da considerarsi a parte: essi hanno sempre avuto una parte leonina in tutti i ministeri dal ’60 in poi, e hanno avuto parecchi presidenti del Consiglio, a differenza del Mezzogiorno, il cui primo leader fu Salandra; questa «invadenza» siciliana è da spiegarsi con la politica di ricatto dei partiti dell’isola, che sottomano hanno sempre mantenuto uno spirito «separatista» a favore dell’Inghilterra: l’accusa di Crispi era, in forma avventata, la manifestazione di una preoccupazione che ossessionava realmente il gruppo dirigente nazionale più responsabile e sensibile).
L’allargamento del suffragio nel 1913 aveva già suscitato i primi accenni di quel fenomeno che avrà la massima espressione nel 19‑20‑21 in conseguenza dell’esperienza politico‑organizzativa acquistata dalle masse contadine in guerra, cioè la rottura relativa del blocco rurale meridionale e il distacco dei contadini, guidati da una parte degli intellettuali (ufficiali in guerra), dai grandi proprietari: si ha Così il sardismo, il partito riformista siciliano (il così detto gruppo parlamentare Bonomi era costituito dal Bonomi e da 22 deputati siciliani) con l’ala estrema separatista rappresentata da «Sicilia Nuova», il gruppo del «Rinnovamento» nel Mezzogiorno costituito da combattenti che tentò costituire partiti regionali d’azione sul tipo sardo (cfr la rivista «Volontà» del Torraca, la trasformazione del «Popolo Romano» ecc.). In questo movimento l’importanza autonoma delle masse contadine è graduata dalla Sardegna al Mezzogiorno alla Sicilia, a seconda della forza organizzata, del prestigio e della pressione ideologica esercitata dai grandi proprietari, che hanno in Sicilia un massimo di organizzazione e di compattezza e hanno invece un’importanza relativamente piccola in Sardegna. Altrettanto graduata è l’indipendenza relativa dei rispettivi ceti intellettuali, naturalmente in senso inverso a quello dei proprietari. (Per intellettuali occorre intendere non solo quei ceti comunemente intesi con questa denominazione, ma in generale tutto lo strato sociale che esercita funzioni organizzative in senso lato, sia nel campo della produzione, sia in quello della cultura, e in quello politico‑amministrativo: corrispondono ai sotto‑ufficiali e ufficiali subalterni nell’esercito e anche in parte agli ufficiali superiori di origine subalterna). Per analizzare la funzione politico‑sociale degli intellettuali occorre ricercare ed esaminare il loro atteggiamento psicologico verso le classi fondamentali che essi mettono a contatto nei diversi campi: hanno un atteggiamento «paternalistico» verso le classi strumentali? o credono di esserne una espressione organica? hanno un atteggiamento «servile» verso le classi dirigenti o si credono essi stessi dirigenti, parte integrante delle classi dirigenti?
Nello sviluppo del Risorgimento, il così detto Partito d’Azione aveva un atteggiamento «paternalistico», perciò non è riuscito che in misura molto limitata a mettere le grandi masse popolari a contatto dello Stato. Il così detto «trasformismo» non è che l’espressione parlamentare dei fatto che il Partito d'Azione viene incorporato molecolarmente dai moderati e le masse popolari vengono decapitate, non assorbite nell’ambito del nuovo Stato.
Dal rapporto città‑campagna deve muovere l’esame delle forze motrici fondamentali della storia italiana e dei punti programmatici da cui occorre studiare e giudicare l’indirizzo del Partito d'Azione nel Risorgimento. Schematicamente si può avere questo quadro: 1) la forza urbana settentrionale; 2) la forza rurale meridionale; 3) la forza rurale settentrionale‑centrale; 4‑5) la forza rurale della Sicilia e della Sardegna.
Restando ferma la funzione di «locomotiva» della prima forza, occorre esaminare le diverse combinazioni «più utili» atte a costruire un «treno» che avanzi il più speditamente nella storia. Intanto la prima forza comincia con l’avere dei problemi proprii, interni, di organizzazione, di articolazione per omogeneità, di direzione politico‑militare (egemonia piemontese, rapporto tra Milano e Torino ecc.); ma rimane fissato che, già «meccanicamente», se tale forza ha raggiunto un certo grado di unità e di combattività, essa esercita una funzione direttiva «indiretta» sulle altre. Nei diversi periodi del Risorgimento appare che il porsi di questa forza in una posizione di intransigenza e di lotta contro il dominio straniero, determina un’esaltazione delle forze progressive meridionali: da ciò il sincronismo relativo, ma non la simultaneità, nei movimenti del 20‑21, del 31, del 48. Nel 59‑60 questo «meccanismo» storico‑politico agisce con tutto il rendimento possibile, poiché il Nord inizia la lotta, il Centro aderisce pacificamente o quasi e nel Sud lo Stato borbonico crolla sotto la spinta dei garibaldini, spinta relativamente debole. Questo avviene perché il Partito d'Azione (Garibaldi) interviene tempestivamente, dopo che i moderati (Cavour) avevano organizzato il Nord e il Centro; non è cioè la stessa direzione politico‑militare (moderati o Partito d'Azione) che organizza la simultaneità relativa, ma la collaborazione (meccanica) delle due direzioni, che si integrano felicemente.
La prima forza doveva quindi porsi il problema di organizzare intorno a sé le forze urbane delle altre sezioni nazionali e specialmente del Sud. Questo problema era il più difficile, irto di contraddizioni e di motivi che scatenavano ondate di passioni (una soluzione burletta di queste contraddizioni fu la così detta rivoluzione parlamentare del 1876). Ma la sua soluzione, appunto per questo, era uno dei punti cruciali dello sviluppo nazionale. Le forze urbane sono socialmente omogenee, quindi devono trovarsi in una posizione di perfetta uguaglianza. Ciò era vero teoricamente, ma storicamente la quistione si poneva diversamente: le forze urbane del Nord erano nettamente alla testa della loro sezione nazionale, mentre per le forze urbane del Sud ciò non si verificava, per lo meno in egual misura. Le forze urbane del Nord dovevano quindi ottenere da quelle del Sud che la loro funzione direttiva si limitasse ad assicurare la direzione del Nord verso il Sud nel rapporto generale di città-campagna, cioè la funzione direttiva delle forze urbane del Sud non poteva essere altro che un momento subordinato della più vasta funzione direttiva del Nord. La contraddizione più stridente nasceva da questo ordine di fatti: la forza urbana del Sud non poteva essere considerata come qualcosa a sé, indipendente da quella del Nord; porre la quistione così avrebbe significato affermare pregiudizialmente un insanabile dissidio «nazionale», dissidio tanto grave che neanche la soluzione federalistica avrebbe potuto comporre; si sarebbe affermata l’esistenza di nazioni diverse, tra le quali avrebbe potuto realizzarsi solo un’alleanza diplomatico‑militare contro il comune nemico, l’Austria (l’unico elemento di comunità e solidarietà, insomma, sarebbe consistito solo nell’avere un «comune» nemico). In realtà, però, esistevano solo alcuni «aspetti» della quistione nazionale, non «tutti» gli aspetti e neanche quelli più essenziali. L’aspetto più grave era la debole posizione delle forze urbane meridionali in rapporto alle forze rurali, rapporto sfavorevole che si manifestava talvolta in una vera e propria soggezione della città alla campagna. Il collegamento stretto tra forze urbane del Nord e del Sud, dando alle seconde la forza rappresentativa del prestigio delle prime, doveva aiutare quelle a rendersi autonome, ad acquistare coscienza della loro funzione storica dirigente in modo «concreto» e non puramente teorico e astratto, suggerendo le soluzioni da dare ai vasti problemi regionali. Era naturale che si trovassero forti opposizioni nel Sud all’unità: il compito più grave per risolvere la situazione spettava in ogni modo alle forze urbane del Nord che non solo dovevano convincere i loro «fratelli» del Sud, ma dovevano incominciare col convincereIntegrato sulla base del testo A. se stesse di questa complessità di sistema politico: praticamente quindi la quistione si poneva nell’esistenza di un forte centro di direzione politica, al quale necessariamente avrebbero dovuto collaborare forti e popolari individualità meridionali e delle isole. Il problema di creare una unità Nord‑Sud era strettamente legato e in gran parte assorbito nel problema di creare una coesione e una solidarietà tra tutte le forze urbane nazionali. (Il ragionamento svolto più sopra è infatti valido per tutte e tre le sezioni meridionali, Napoletano, Sicilia, Sardegna).
Le forze rurali settentrionali‑centrali ponevano alla loro volta una serie di problemi che la forza urbana del Nord doveva porsi per stabilire un rapporto normale città‑campagna, espellendo le interferenze e gli influssi di origine estranea allo sviluppo del nuovo Stato. In queste forze rurali occorreva distinguere due correnti: quella laica e quella clericale‑austriacante. La forza clericale aveva il suo peso massimo nel Lombardo‑Veneto, oltre che in Toscana e in una parte dello Stato pontificio; quella laica nel Piemonte, con interferenze più o meno vaste nel resto d’Italia, oltre che nelle legazioni, specialmente in Romagna, anche nelle altre sezioni, fino al Mezzogiorno e alle isole. Risolvendo bene questi rapporti immediati, le forze urbane settentrionali avrebbero dato un ritmo a tutte le quistioni simili su scala nazionale.
Su tutta questa serie di problemi complessi il Partito d’Azione fallì completamente: esso si limitò infatti a fare quistione di principio e di programma essenziale quella che era semplicemente quistione del terreno politico su cui tali problemi avrebbero potuto accentrarsi e trovare una soluzione legale: la quistione della Costituente. Non si può dire che abbia fallito il partito moderato, che si proponeva l’espansione organica del Piemonte, voleva soldati per l’esercito piemontese e non insurrezioni o armate garibaldine troppo vaste.
Perché il Partito d'Azione non pose in tutta la sua estensione la quistione agraria? Che non la ponessero i moderati era ovvio: l’impostazione data dai moderati al problema nazionale domandava un blocco di tutte le forze di destra, comprese le classi dei grandi proprietari terrieri, intorno al Piemonte come Stato e come esercito. La minaccia fatta dall’Austria di risolvere la quistione agraria a favore dei contadini, minaccia che ebbe effettuazione in Galizia contro i nobili polacchi a favore dei contadini ruteni, non solo gettò lo scompiglio tra gli interessati in Italia, determinando tutte le oscillazioni dell’aristocrazia (fatti di Milano del febbraio 53 e atto di omaggio delle più illustri famiglie milanesi a Francesco Giuseppe proprio alla vigilia delle forche di Belfiore), ma paralizzò lo stesso Partito d'Azione, che in questo terreno pensava come i moderati e riteneva «nazionali» l’aristocrazia e i proprietari e non i milioni di contadini. Solo dopo il febbraio 53 Mazzini ebbe qualche accenno sostanzialmente democratico (vedi Epistolario di quel periodo), ma non fu capace di una radicalizzazione decisiva del suo programma astratto. È da studiare la condotta politica dei garibaldini in Sicilia nel 1860, condotta politica che era dettata da Crispi: i movimenti di insurrezione dei contadini contro i baroni furono spietatamente schiacciati e fu creata la Guardia nazionale anticontadina; è tipica la spedizione repressiva di Nino Bixio nella regione catanese, dove le insurrezioni furono più violente. Eppure anche nelle relle di G. C. Abba ci sono elementi per dimostrare che la quistione agraria era la molla per far entrare in moto le grandi masse: basta ricordare i discorsi dell’Abba col frate che va incontro ai garibaldini subito dopo lo sbarco di Marsala. In alcune novelle di G. Verga ci sono elementi pittoreschi di queste sommosse contadine che la guardia nazionale soffocò col terrore e con la fucilazione in massa. (Questo aspetto della spedizione dei Mille non è stato mai studiato e analizzato).
La non impostazione della quistione agraria portava alla quasi impossibilità di risolvere la quistione del clericalismo e dell’atteggiamento antiunitario del Papa. Sotto questo riguardo i moderati furono molto più arditi del Partito d'Azione: è vero che essi non distribuirono i beni ecclesiastici fra i contadini, ma se ne servirono per creare un nuovo ceto di grandi e medi proprietari legati alla nuova situazione politica, e non esitarono a manomettere la proprietà terriera, sia pure solo quella delle Congregazioni. Il Partito d'Azione, inoltre, era paralizzato, nella sua azione verso i contadini, dalle velleità mazziniane di una riforma religiosa, che non solo non interessava le grandi masse rurali, ma al contrario le rendeva passibili di una sobillazione contro i nuovi eretici. L’esempio della Rivoluzione francese era lì a dimostrare che i giacobini, che erano riusciti a schiacciare tutti i partiti di destra fino ai girondini sul terreno della quistione agraria e non solo a impedire la coalizione rurale contro Parigi ma a moltiplicare i loro aderenti nelle provincie, furono danneggiati dai tentativi di Robespierre di instaurare una riforma religiosa, che pure aveva, nel processo storico reale, un significato e una concretezza immediati. (Bisognerebbe studiare attentamente la politica agraria reale della Repubblica Romana e il vero carattere della missione repressiva data da Mazzini a Felice Orsini nelle Romagne e nelle Marche: in questo periodo e fino al 70 – anche dopo – col nome di brigantaggio si intendeva quasi sempre il movimento caotico, tumultuario e punteggiato di ferocia, dei contadini per impadronirsi della terra).
Q19 §27 I moderati e gli intellettuali. Perché i moderati dovevano avere il sopravvento nella massa degli intellettuali. Gioberti e Mazzini. Gioberti offriva agli intellettuali una filosofia che appariva come originale e nel tempo stesso nazionale, tale da porre l’Italia almeno allo stesso livello delle nazioni più progredite e dare una nuova dignità al pensiero italiano. Mazzini invece offriva solo delle affermazioni nebulose e degli accenni filosofici che a molti intellettuali, specialmente napoletani, dovevano apparire come vuote chiacchiere (l’abate Galiani aveva insegnato a sfottere quel modo di pensare e di ragionare).
Quistione della scuola: attività dei moderati per introdurre il principio pedagogico dell’insegnamento reciproco (Confalonieri, Capponi ecc.); movimento di Ferrante Aporti e degli asili, legato al problema del pauperismo. Nei moderati si affermava il solo movimento pedagogico concreto opposto alla scuola «gesuitica»; ciò non poteva non avere efficacia sia tra i laici, ai quali dava nella scuola una propria personalità, sia nel clero liberaleggiante e antigesuitico (ostilità accanita contro Ferrante Aporti, ecc.; il ricovero e l’educazione dell’infanzia abbandonata era un monopolio clericale e queste iniziative spezzavano il monopolio). Le attività scolastiche di carattere liberale o liberaleggiante hanno un gran significato per afferrare il meccanismo dell’egemonia dei moderati sugli intellettuali. L’attività scolastica, in tutti i suoi gradi, ha un’importanza enorme anche economica, per gli intellettuali di tutti i gradi: l’aveva allora anche maggiore di oggi, data la ristrettezza dei quadri sociali e le scarse strade aperte all’iniziativa dei piccoli borghesi (oggi: giornalismo, movimento dei partiti, industria, apparato statale estesissimo ecc. hanno allargato in modo inaudito le possibilità di impiego).
L’egemonia di un centro direttivo sugli intellettuali si afferma attraverso due linee principali: 1) una concezione generale della vita, una filosofia (Gioberti), che offra agli aderenti una «dignità» intellettuale che dia un principio di distinzione e un elemento di lotta contro le vecchie ideologie dominanti coercitivamente; 2) Un programma scolastico, un principio educativo e pedagogico originale che interessi e dia un’attività propria, nel loro campo tecnico, a quella frazione degli intellettuali che è la più omogenea e la più numerosa (gli insegnanti, dal maestro elementare ai professori di Università).
I Congressi degli scienziati che furono organizzati ripetutamente nel periodo del primo Risorgimento ebbero una doppia efficacia: 1) riunire gli intellettuali del grado più elevato, concentrandoli e moltiplicando il loro influsso; 2) ottenere una più rapida concentrazione e un più deciso orientamento negli intellettuali dei gradi inferiori, che sono portati normalmente a seguire gli Universitari e i grandi scienziati per spirito di casta.
Lo studio delle Riviste enciclopediche e specializzate dà un altro aspetto dell’egemonia dei moderati. Un partito come quello dei moderati offriva alla massa degli intellettuali tutte le soddisfazioni per le esigenze generali che possono essere offerte da un governo (da un partito al governo), attraverso i servizi statali. (Per questa funzione di partito italiano di governo servì ottimamente dopo il 48‑49 lo Stato piemontese che accolse gli intellettuali esuli e mostrò in modello ciò che avrebbe fatto un futuro Stato unificato).
Q19 §28 Direzione politico‑militare del moto nazionale italiano. Nell’esame della direzione politica e militare impressa al moto nazionale prima e dopo il 48 occorre fare alcune preventive osservazioni di metodo e di nomenclatura. Per direzione militare non deve intendersi solo la direzione militare in senso stretto, tecnico, cioè con riferimento alla strategia e alla tattica dell’esercito piemontese, o delle truppe garibaldine o delle varie milizie improvvisate nelle insurrezioni locali (cinque giornate di Milano, difesa di Venezia, difesa della Repubblica Romana, insurrezione di Palermo nel 48 ecc.); deve intendersi invece in senso molto più largo e più aderente alla direzione politica vera e propria. Il problema essenziale che si imponeva dal punto di vista militare era quello di espellere dalla penisola una potenza straniera, l’Austria, che disponeva di uno dei più grandi eserciti dell’Europa d’allora e che aveva inoltre non pochi e deboli aderenti nella penisola stessa, persino nel Piemonte. Pertanto il problema militare era questo: come riuscire a mobilitare una forza insurrezionale che fosse in grado di espellere dalla penisola l’esercito austriaco non solo, ma anche di impedire che esso potesse ritornare con una controffensiva, dato che l’espulsione violenta avrebbe messo in pericolo la compagine dell’Impero e quindi ne avrebbe galvanizzato tutte le forze di coesione per una rivincita. Le soluzioni che del problema furono presentate astrattamente erano parecchie, tutte contraddittorie e inefficienti. «L’Italia farà da sé» fu la parola d’ordine piemontese del 48, ma volle dire la sconfitta disastrosa. La politica incerta, ambigua, timida e nello stesso tempo avventata dei partiti di destra piemontesi fu la cagione principale della sconfitta: essi furono di una astuzia meschina, essi furono la causa del ritirarsi degli eserciti degli altri Stati italiani, napoletani e romani, per aver troppo presto mostrato di volere l’espansione piemontese e non una confederazione italiana; essi non favorirono, ma osteggiarono, il movimento dei volontari; essi, insomma, volevano che solo armati vittoriosi fossero i generali piemontesi, inetti al comando di una guerra tanto difficile. L’assenza di una politica popolare fu disastrosa: i contadini lombardi e veneti arruolati dall’Austria furono uno degli strumenti più efficaci per soffocare la rivoluzione di Vienna e quindi anche italiana; per i contadini il moto del Lombardo-Veneto era una cosa di signori e di studenti come il moto viennese. Mentre i partiti nazionali italiani avrebbero dovuto, con la loro politica, determinare o aiutare il disgregamento dell’Impero austriaco, con la loro inerzia ottennero che i reggimenti italiani fossero uno dei migliori puntelli della reazione austriaca. Nella lotta tra il Piemonte e l’Austria il fine strategico non poteva essere quello di distruggere l’esercito austriaco e occupare il territorio del nemico, che sarebbe stato fine irraggiungibile e utopistico, ma poteva essere quello di disgregare la compagine interna austriaca e aiutare i liberali ad andare al potere stabilmente per mutare la struttura politica dell’impero in federalistica o almeno per crearvi uno stato prolungato di lotte interne che desse respiro alle forze nazionali italiane e permettesse loro di concentrarsi politicamente e militarmente (lo stesso errore fu commesso da Sonnino nella guerra mondiale e ciò contro le insistenze del Cadorna: Sonnino non voleva la distruzione dell’impero absburgico e si rifiutò a ogni politica di nazionalità; anche dopo Caporetto, una politica nazionalitaria fu fatta obtorto collo e malthusianamente e perciò non dette i più rapidi risultati che avrebbe potuto dare). Dopo aver iniziato la guerra col motto «l’Italia farà da sé», dopo la sconfitta, quando tutta l’impresa era compromessa, si cercò di avere l’aiuto francese, proprio quando, anche per effetto del rinvigorimento austriaco, al governo in Francia erano andati i reazionari, nemici di uno Stato italiano unitario e forte e anche di una espansione piemontese: la Francia non volle dare al Piemonte neanche un generale provetto e si ricorse al polacco Chrzanowsky.
La direzione militare era una quistione più vasta della direzione dell’esercito e della determinazione del piano strategico che l’esercito doveva eseguire; essa comprendeva in più la mobilitazione politico‑insurrezionale di forze popolari che fossero insorte alle spalle del nemico e ne avessero intralciato i movimenti e i servizi logistici, la creazione di masse ausiliarie e di riserva da cui trarre nuovi reggimenti e che dessero all’esercito «tecnico» l’atmosfera di entusiasmo e di ardore. La politica popolare non fu fatta neanche dopo il 49; anzi sugli avvenimenti del 49 si cavillò stoltamente per intimidire le tendenze democratiche: la politica nazionale di destra si impegnò nel secondo periodo del Risorgimento nella ricerca dell’aiuto della Francia bonapartista e con l’alleanza francese si equilibrò la forza austriaca. La politica della destra nel 48 ritardò l’unificazione della penisola di alcuni decenni.
Le incertezze nella direzione politico‑militare, le continue oscillazioni tra dispotismo e costituzionalismo ebbero i loro contraccolpi disastrosi anche nell’esercito piemontese. Si può affermare che quanto più un esercito è numeroso, in senso assoluto, come massa reclutata, o in senso relativo, come proporzioni di uomini reclutati sulla popolazione totale, tanto più aumenta l’importanza della direzione politica su quella meramente tecnico‑militare. La combattività dell’esercito piemontese era altissima all’inizio della campagna del 48: i destri credettero che tale combattività fosse espressione di un puro spirito militare e dinastico astratto, e cominciarono a intrigare per restringere le libertà popolari e smorzare le aspettative in un avvenire democratico. Il «morale» dell’esercito decadde. La polemica sulla fatal Novara è tutta qui. A Novara l’esercito non volle combattere, perciò fu sconfitto. I destri accusarono i democratici di aver portato la politica nell’esercito e d’averlo disgregato: accusa inetta, perché il costituzionalismo appunto «nazionalizzava» l’esercito, ne faceva un elemento della politica generale e con ciò lo rafforzava militarmente. Tanto più inetta l’accusa, in quanto l’esercito si accorge di un mutamento di direzione politica, senza bisogno di «disgregatori», da una molteplicità di piccoli cambiamenti, ognuno dei quali può parere insignificante e trascurabile, ma che nell’insieme formano una nuova atmosfera asfissiante. Responsabili della disgregazione sono pertanto quelli che hanno mutato la direzione politica, senza prevederne le conseguenze militari, hanno cioè sostituito una cattiva politica a quella precedente che era buona, perché conforme al fine. L’esercito è anche uno «strumento» per un fine determinato, ma esso è costituito di uomini pensanti e non di automi che si possono impiegare nei limiti della loro coesione meccanica e fisica. Se si può e si deve, anche in questo caso, parlare di opportuno e di conforme al fine, occorre però includere anche la distinzione: secondo la natura dello strumento dato. Se si batte un chiodo con una mazza di legno con lo stesso vigore con cui si batterebbe con un martello d’acciaio, il chiodo penetra nella mazza invece che nella parete. La direzione politica giusta è necessaria anche con un esercito di mercenari professionisti (anche nelle compagnie di ventura c’era un minimo di direzione politica, oltre a quella tecnico‑militare); tanto più è necessaria con un esercito nazionale di leva. La quistione diventa ancora più complessa e difficile nelle guerre di posizione, fatte da masse enormi che solo con grandi riserve di forze morali possono resistere al grande logorio muscolare, nervoso, psichico: solo un’abilissima direzione politica, che sappia tener conto delle aspirazioni e dei sentimenti più profondi delle masse umane, ne impedisce la disgregazione e lo sfacelo.
La direzione militare deve essere sempre subordinata alla direzione politica, ossia il piano strategico deve essere l’espressione militare di una determinata politica generale. Naturalmente può darsi che in una condizione data, gli uomini politici siano inetti, mentre nell’esercito ci siano dei capi che alla capacità militare congiungano la capacità politica: è il caso di Cesare e di Napoleone. Ma in Napoleone si è visto come il mutamento di politica, coordinato alla presunzione di avere uno strumento militare astrattamente militare, abbia portato alla sua rovina: anche nei casi in cui la direzione politica e quella militare si trovano unite nella stessa persona, è il momento politico che deve prevalere su quello militare. I commentari di Cesare sono un classico esempio di esposizione di una sapiente combinazione di arte politica e arte militare: i soldati vedevano in Cesare non solo un grande capo militare, ma specialmente il loro capo politico, il capo della democrazia. È da ricordare come Bismarck, sulle traccie del Clausewitz, sosteneva la supremazia del momento politico su quello militare, mentre Guglielmo II, come riferisce Ludwig, annotò rabbiosamente un giornale in cui l’opinione del Bismarck era riportata: così i tedeschi vinsero brillantemente quasi tutte le battaglie, ma perdettero la guerra.
Esiste una certa tendenza a sopravalutare l’apporto delle classi popolari al Risorgimento, insistendo specialmente sul fenomeno del volontariato. Le cose più serie e ponderate in proposito sono state scritte da Ettore Rota nella «Nuova Rivista Storica» del 1928‑29. A parte l’osservazione fatta in altra nota sul significato da dare ai volontari, è da rilevare che gli scritti stessi del Rota mostrano come i volontari fossero mal visti e sabotati dalle autorità piemontesi, ciò che appunto conferma la cattiva direzione politico‑militare. Il governo piemontese poteva arruolare obbligatoriamente soldati nel suo territorio statale, in rapporto alla popolazione, come l’Austria poteva fare nel suo e in rapporto a una popolazione enormemente più grande: una guerra a fondo, in questi termini, sarebbe sempre stata disastrosa per il Piemonte dopo un certo tempo. Posto il principio che «l’Italia fa da sé» bisognava o accettare subito la Confederazione con gli altri Stati italiani o proporsi l’unità politica territoriale su una tale base radicalmente popolare che le masse fossero state indotte a insorgere contro gli altri governi, e avessero costituito eserciti volontari che fossero accorsi accanto ai piemontesi. Ma appunto qui stava la quistione: le tendenze di destra piemontesi o non volevano ausiliari, pensando di poter vincere gli austriaci con le sole forze regolari piemontesi (e non si capisce come potessero avere una tale presunzione) o avrebbero voluto essere aiutati a titolo gratuito (e anche qui non si capisce come politici serii potessero pretendere un tale assurdo): nella realtà non si può pretendere entusiasmo, spirito di sacrifizio, ecc. senza una contropartita neppure dai propri sudditi di uno Stato; tanto meno si può pretenderla da cittadini estranei allo Stato su un programma generico e astratto e per una fiducia cieca in un governo lontano. Questo è stato il dramma del 48‑49, ma non è certo giusto deprezzare per ciò il popolo italiano; la responsabilità del disastro è da attribuire sia ai moderati, sia al Partito d'Azione, cioè, in ultima analisi, alla immaturità e alla scarsissima efficienza delle classi dirigenti.
Le osservazioni fatte sulla deficienza di direzione politico‑militare nel Risorgimento potrebbero essere ribattute con un argomento molto triviale e frusto: «quegli uomini non furono demagoghi, non fecero della demagogia». Un’altra trivialità molto diffusa per parare il giudizio negativo sulla capacità direttiva dei capi del moto nazionale è quella di ripetere in vari modi e forme che il moto nazionale si poté operare per merito delle sole classi colte. Dove sia il merito è difficile capire. Merito di una classe colta, perché sua funzione storica, è quello di dirigere le masse popolari e svilupparne gli elementi progressivi; se la classe colta non è stata capace di adempiere alla sua funzione, non deve parlarsi di merito, ma di demerito, cioè di immaturità e debolezza intima. Così occorre intendersi sulla parola e sul concetto di demagogia. Quegli uomini effettivamente non seppero guidare il popolo, non seppero destarne l’entusiasmo e la passione, se si intende demagogia nel suo significato primordiale. Raggiunsero essi almeno il fine che si proponevano? Essi dicevano di proporsi la creazione dello Stato moderno in Italia e produssero un qualcosa di bastardo, si proponevano di suscitare una classe dirigente diffusa ed energica e non ci riuscirono, di inserire il popolo nel quadro statale e non ci riuscirono. La meschina vita politica dal 70 al 900, il ribellismo elementare ed endemico delle classi popolari, l’esistenza gretta e stentata di un ceto dirigente scettico e poltrone sono la conseguenza di quella deficienza: e ne sono conseguenza la posizione internazionale del nuovo Stato, privo di effettiva autonomia perché minato all’interno dal Papato e dalla passività malevola delle grandi masse.
In realtà poi i destri del Risorgimento furono dei grandi demagoghi: essi fecero del popolo‑nazione uno strumento, un oggetto, degradandolo e in ciò consiste la massima e più spregevole demagogia, proprio nel senso che il termine ha assunto in bocca ai partiti di destra in polemica con quei di sinistra, sebbene siano i partiti di destra ad avere sempre esercitato la peggiore demagogia e ad aver fatto spesso appello alla feccia popolare (come Napoleone III in Francia),
Q19 §29 Il nesso 1848‑49. Novara. Nel febbraio 1849 Silvio Spaventa visitò a Pisa il D’Azeglio e del colloquio fa ricordo in uno scritto politico composto nel 1856, mentre era all’ergastolo: «Un uomo di Stato piemontese dei più illustri diceva a me un mese innanzi: noi non possiamo vincere, ma combatteremo di nuovo: la nostra sconfitta sarà la sconfitta di quel partito che oggi ci risospinge alla guerra; e tra una sconfitta e una guerra civile noi scegliamo la prima: essa ci darà la pace interna e la libertà e l’indipendenza del Piemonte, che non può darci l’altra. Le previsioni di quel saggio (!) uomo si avverarono. La battaglia di Novara fu perduta per la causa dell’indipendenza e guadagnata per la libertà del Piemonte. E Carlo Alberto fece, secondo me, il sacrifizio della sua corona più a questa che a quella» (cfr Silvio Spaventa, Dal 1848 al 1861. Lettere, scritti, documenti, pubblicati da B. Croce, 2a ed., Laterza, p. 58 nota). È da domandare se si avverarono le «previsioni», o se fu preparata la sconfitta da uomini tanto saggi quanto il D’Azeglio.
In un articolo pubblicato nel «Corriere della Sera» del 14 maggio 1934 (Onoranze americane a Filippo Caronti), Antonio Monti riporta dalle Memorie del Caronti (inedite e possedute dal Museo del Risorgimento di Milano) questi due episodi: il Caronti, dopo aver vinto gli austriaci a Como nel 1848, formò una compagnia di volontari e andò a Torino per avere le armi. Il ministro Balbo gli dette questa risposta che il Monti dice «stupefacente»: «È inutile ormai l’armarsi, giacché un esercito regolare e forte debellerà il nemico. Volete forse servirvi delle armi fra voi onde le discordie fra Comaschi e Milanesi risorgano a danno del buon esito della causa italiana?» (Non è inutile ricordare che poco prima della guerra del 48 il Piemonte si era sguarnito di armi per inviarle in Isvizzera ai cattolici reazionari insorti dei Sonderbund). Sulla «preparazione» della sconfitta di Novara il Caronti narra che mentre si preparava febbrilmente una ripresa della lotta armata a Corno e si organizzavano volontari, giunse la notizia dell’armistizio concluso dopo Novara dal generale Chrzanowsky (il Monti scrive Czarnowsky). Il Caronti affrontò il generale che disse: «Nous avons conclu un armistice honorable. – Comment, honorable? – Oui, très honorable avec une armée qui ne se bat pas». Il colloquio è confermato da Gabriele Camozzi.
Ma non importano le parole del generale polacco, che era una festuca presa nella tormenta, ma l’indirizzo dato alla politica militare dal governo piemontese, che preferiva la sconfitta a una insurrezione generale italiana.
Q19 §30 A proposito della minaccia continua che il governo austriaco faceva ai nobili del Lombardo‑Veneto di promulgare una legislazione agraria favorevole ai contadini (minaccia non vana perché già attuata in Galizia contro l’aristocrazia polacca), sono interessanti alcuni spunti di storia della Polonia contenuti in un articolo della «Pologne littéraire» riassunto dal «Marzocco» del 1° dicembre 1929. Il giornale polacco, ricercando le cause storiche dello spirito militare dei polacchi, per cui si trovano volontari polacchi in tutte le guerre e le guerriglie, in tutte le insurrezioni e in tutte le rivoluzioni del secolo scorso, risale a questo fatto: il 13 luglio 1792 «una nazione che contava 9 milioni di abitanti, che aveva 70 000 soldati sotto le armi, fu conquistata senza essere stata vinta». Il 3 maggio 1791 era stata proclamata una costituzione il cui spirito largamente democratico poteva divenire un pericolo per i vicini, il re di Prussia, l’imperatore d’Austria, e lo zar di Russia e che aveva parecchi punti di contatto con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino votata dalla Costituente francese nell’agosto 1789. La Polonia fu conquistata colla piena connivenza dei nobili polacchi, i quali, più previdenti dei loro confratelli di Francia, non avevano atteso l’applicazione della carta costituzionale per provocare l’intervento straniero. Costoro preferirono vendere la nazione al nemico piuttosto che cedere la benché minima parte delle terre ai contadini. Preferirono cadere in servitù essi medesimi, anziché concedere la libertà al popolo. Secondo l’autore dell’articolo, Z. St. Klingsland, i 70 000 soldati presero la via dell’esilio e si diressero verso la Francia, ciò che è per lo meno esagerato. Il nocciolo degli avvenimenti polacchi è tuttavia altamente istruttivo e spiega molta parte degli avvenimenti fino al 1859 anche in Italia.
È da rilevare il fatto che una pubblicazione polacca scritta in francese per la propaganda all’estero (così almeno pare) spieghi la spartizione della Polonia del 1792 specialmente col tradimento dei nobili piuttosto che con la debolezza militare polacca, nonostante che la nobiltà abbia ancora in Polonia una funzione molto rilevante e Pilsudsky si sia ben guardato anche lui dal procedere a una radicale riforma agraria. Strano «punto d’onore» nazionale. Darwin nel Viaggio intorno al mondo di un naturalista racconta un episodio simile per la Spagna: i suoi interlocutori sostenevano che una sconfitta della flotta alleata franco‑spagnola era stata dovuta alla slealtà degli spagnoli, i quali se avessero combattuto davvero, non avrebbero potuto essere stati vinti. Meglio sleali e traditori che «senza spirito militare invincibile».
Q19 §31 Italia reale e Italia legale. La formula escogitata dai clericali dopo il 70 per indicare il disagio politico nazionale risultante dalla contraddizione tra la minoranza dei patriotti decisi e attivi e la maggioranza avversa (clericali e legittimisti‑passivi e indifferenti). A Torino si pubblicò fino a qualche anno prima della guerra un quotidiano (poi settimanale) diretto da un avv. Scala e intitolato «L’Italia reale» organo del più nero clericalismo. Come sorse la formula, da chi fu escogitata e quale giustificazione teorico‑politico‑morale ne fu data? Occorre fare una ricerca nella «Civiltà Cattolica» e nei primi numeri della stessa «Italia reale» di Torino, che negli ultimi tempi si ridusse ad essere un insulso libello di sagrestia. La formula è felice dal punto di vista «demagogico» perché esisteva di fatto ed era fortemente sentito un netto distacco tra lo Stato (legalità formale) e la società civile (realtà di fatto), ma la società civile era tutta e solamente nel «clericalismo»? Intanto la società civile era qualcosa di informe e di caotico e tale rimase per molti decenni; fu possibile pertanto allo Stato di dominarla, superando volta a volta i conflitti che si manifestavano in forma sporadica, localistica, senza nesso e simultaneità nazionale. Il clericalismo non era quindi neanche esso l’espressione della società civile, perché non riuscì a darle un’organizzazione nazionale ed efficiente, nonostante esso fosse un’organizzazione forte e formalmente compatta: non era politicamente omogenea ed aveva paura delle stesse masse che in un certo senso controllava. La formula politica del «non expedit» fu appunto l’espressione di tale paura ed incertezza: il boicottaggio parlamentare, che pareva un atteggiamento aspramente intransigente, in realtà era l’espressione dell’opportunismo più piatto. L’esperienza politica francese aveva dimostrato che il suffragio universale e il plebiscito a base larghissima, in date circostanze, poteva essere un meccanismo favorevolissimo alle tendenze reazionarie e clericali (cfr a questo proposito le ingenue osservazioni di Jacques Bainville nella sua Storia di Francia, quando rimprovera al legittimismo di non aver avuto fiducia nel suffragio universale come invece aveva fatto Napoleone III); ma il clericalismo italiano sapeva di non essere l’espressione reale della società civile e che un possibile successo sarebbe stato effimero e avrebbe determinato l’attacco frontale da parte delle energie nazionali nuove, evitato felicemente nel 1870. Esperienza del suffragio allargato nel 1882 e reazione crispino‑massonica. Tuttavia l’atteggiamento clericale di mantenere «statico» il dissidio tra Stato e società civile era obbiettivamente sovversivo e ogni nuova organizzazione espressa dalle forze che intanto maturavano nella società, poteva servirsene come terreno di manovra per abbattere il regime costituzionale monarchico: perciò la reazione del 98 abbatté insieme e socialismo e clericalismo, giudicandoli giustamente ugualmente «sovversivi» e obbiettivamente alleati. Da questo momento comincia pertanto una nuova politica vaticanesca, con l’abbandono di fatto del «non expedit» anche nel campo parlamentare (il Comune era tradizionalmente considerato società civile e non Stato) e ciò permette l’introduzione del suffragio universale, il patto Gentiloni e finalmente la fondazione nel 1919 del Partito Popolare. La quistione dell’esistenza di un’Italia reale e un’Italia legale si ripresenta in altra forma, negli avvenimenti del 24‑26, fino alla soppressione di tutti i partiti politici, con l’affermazione dell’essersi ormai raggiunta l’identità tra il reale e il legale perché la società civile in tutte le sue forme era inquadrata da una sola organizzazione politica di partito e statale.
Q19 §32 Piero Pieri, Il Regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806, Napoli, Ricciardi, 1928, pp. 330, L. 25,00 (utile per comprendere meglio la Repubblica Partenopea attraverso la politica dei Borboni nel breve periodo della restaurazione).
Q19 §33 Giovanni Maioli, Il fondatore della Società Nazionale, Soc. Naz. per la Storia del Risorgimento, Roma, 1928 (contiene 22 lettere di Giorgio Pallavicino e di Felice Foresti sul periodo 1856‑58, quando il Pallavicino, presidente della Società Nazionale di cui era segretario G. La Farina lavorava a creare il blocco liberale di destra e del centro su due caposaldi: «opinione italiana», «esercito sardo». Un detto del Pallavicino: «il rivoluzionario italiano, uomo fortissimo sul campo dell’azione, è troppo spesso un fanciullo in quello del pensiero»).
È da rilevare che nell’attuale storiografia del Risorgimento, che è tendenziosissima a modo suo, si dà come «acuto realismo politico» tutto ciò che coincide col programma piemontese dei moderati: è un giudizio del senno di poi abbastanza ingenuo e poco acuto: corrisponde alla concezione dei «Gesta dei per Allobrogos» riverniciata e spolverata di qualche concetto moderno.
Q19 §34 Giuseppe Solitro, Due famigerati gazzettieri dell’Austria (Luigi Mazzoldi, Pietro Perego), Padova, Draghi, 1927, L. 15. (Nella recensione pubblicata dalla «Fiera Letteraria» del 16 dicembre 1928, Guido Zadei scrive di possedere materiale inedito e non sfruttato sul Mazzoldi e su una curiosa polemica in cui Filippo Ugoni accusa il Mazzoldi di propaganda comunista, che vorrà poi dire di propaganda per la riforma agraria in senso austriacante).
Q19 §35 Gioberti e il cattolicismo liberale. Nella prefazione alle Letture del Risorgimento il Carducci scrive: «Staccatosi dalla Giovane Italia nel 1834 tornò a quello che il Santarosa voleva e chiamava cospirazione letteraria ed egli la fece con certa sua filosofia battagliera, che molto alta portava la tradizione italiana, finché uscì nell’agone col Primato e predicando la lega dei principi riformatori, capo il pontefice, attrasse le anime timorose e gli ingegni timorosi, attrasse e rapì il giovane clero, che alla sua volta traevasi dietro il popolo credente anche della campagna». In altro punto il Carducci scrive: «… l’abate italiano riformista e mezzo giacobino col Parini, soprannuotato col Cesarotti e col Barbieri alla rivoluzione, che s’era fatto col Di Breme banditore di romanticismo e soffiatore nel carbonarismo del 21, che aveva intinto col Gioberti nelle cospirazioni e bandito il Primato d’Italia e il Rinnovamento, che aveva col Rosmini additato le piaghe della Chiesa, che aveva coll’Andreoli e col Tazzoli salito il patibolo…».
Q19 §36 Augusto Sandonà. Dopo l’armistizio il Sandonà ha fatto ricerca negli Archivi viennesi per raccogliere la documentazione ufficiale austriaca su una serie di avvenimenti del Risorgimento italiano. Prima della guerra il Sandonà aveva pubblicato, tra l’altro: Contributo alla storia dei processi del 21 e dello Spielberg, Torino, Bocca, 1911; L’idea unitaria ed i partiti politici alla vigilia del 1848, in «Rivista d’Italia» del giugno 1914; Il Regno lombardo‑veneto. La costituzione e l’amministrazione, Milano, Cogliati, 1912.
Q19 §37 Confidenti e agenti provocatori dell’Austria. I confidenti che operavano all’estero e che dipendevano dalla Cancelleria di Stato di Vienna, non dovevano fare gli agenti provocatori: ciò risulta dalle precise istruzioni del principe di Metternich che in un dispaccio segreto dell’8 febbraio 1844 indirizzato al conte Appony, ambasciatore d’Austria a Parigi, così si esprimeva in merito al servizio che prestava nella capitale francese il famigerato Attilio Partesotti: «Il grande fine che il Governo imperiale si propone non è di trovare dei colpevoli né di provocare delle imprese criminali… Partesotti deve di conseguenza considerarsi come un osservatore attento e fedele ed evitare con cura di essere agente provocatore». (Documenti della Staatskanzlei di Vienna).
Il brano è riportato da Augusto Sandonà nello studio: Il preludio delle cinque giornate di Milano ‑ Nuovi documenti, pubblicato nella «Rivista d’Italia» del 15 gennaio 1927 e sgg., con riferimento all’accusa lanciata dal dott. Carlo Casati (Nuove Rivelazioni sui fatti di Milano del 1847‑48, Milano, Hoepli, 1885) e dall’«Archivio triennale delle cose d’Italia» (vol. I, Capolago, Tip. Elvetica, 1850) contro il barone Carlo Torresani, direttore generale della polizia di Milano dal 1822 al 1848 di aver organizzato un servizio di agenti provocatori che inscenassero i tumulti.
È da osservare però, che nonostante le disposizioni del Metternich, gli agenti provocatori potevano operare lo stesso o per necessità delle polizie locali o anche per necessità personale dei medesimi «osservatori».
Q19 §38 Il nesso 1848‑49. La lega doganale, promossa da Cesare Balbo e stretta a Torino il 3 novembre 1847 dai tre rappresentanti del Piemonte, della Toscana e dello Stato pontificio, doveva preludere alla costituzione della Confederazione politica che poi fu disdetta dallo stesso Balbo: facendo abortire anche la lega doganale. La Confederazione era desiderata dagli Stati minori italiani; i reazionari piemontesi (fra cui il Balbo) credendo ormai assicurata l’espansione territoriale del Piemonte, non volevano pregiudicarla con legami che l’avrebbero ostacolata (il Balbo nelle Speranze d’Italia aveva sostenuto che la Confederazione era impossibile finché una parte d’Italia fosse stata in mano agli stranieri!?) e disdissero la Confederazione dicendo che le leghe si stringono prima o dopo le guerre (!?): la Confederazione fu respinta nel 48, nei primi mesi (confrontare).
Gioberti, con altri, vedevano nella Confederazione politica e doganale, stretta anche durante la guerra, la necessaria premessa per rendere possibile l’attuazione del motto «l’Italia farà da sé». Questa politica infida nei rapporti della Confederazione, con le altre direttive altrettanto fallaci a proposito dei volontari e della Costituente, mostra che il moto del 48 fallì per gli intrighi furbescamente meschini dei destri, che furono i moderati del periodo successivo. Essi non seppero dare un indirizzo, né politico né militare, al moto nazionale.
Q19 §39 La costituzione spagnola del 1812. Perché fu tanto popolare? Bisognerebbe confrontarla con le costituzioni elargite nel 1848. La ragione della popolarità della costituzione spagnola non pare debba ricercarsi nella sua forma ultraliberale, o nella pigrizia intellettuale dei rivoluzionari liberali italiani o in altre quistioni secondarie, ma nel fatto essenziale che la situazione spagnola era «esemplare» per l’Europa assolutista e i liberali spagnoli seppero trovare la soluzione giuridico‑costituzionale più appropriata e più generalizzata di problemi che non erano solo spagnoli, ma italiani, specialmente del Mezzogiorno.
Q19 §40 La Sicilia. Luigi Natoli: Rivendicazioni (attraverso le rivoluzioni siciliane del 1848‑1860), Treviso, Cattedra italiana di pubblicità, 1927, L. 14. «Il Natoli vuole reagire contro quella tendenza di studi e di studiosi che ancor oggi o per scarsa padronanza delle testimonianze o per residui di antiche prevenzioni politiche, mira a svalutare il contributo della Sicilia alla storia unitaria del Risorgimento. L’autore polemizza specialmente con B. Croce, il quale considera la rivoluzione siciliana del 1848 come un “moto separatista” dannoso alla causa italiana, ecc.». Ciò che è interessante, in questa letteratura siciliana, giornalistica o libresca, è il tono fortemente polemico e irritato (unitarismo ossessionato). La quistione invece dovrebbe essere molto semplice, dal punto di vista storico: il separatismo o c’è stato o non c’è stato o è stato solo tendenziale in una misura da determinarsi secondo un metodo storicamente obbiettivo, astraendo da ogni valutazione attuale di polemica di partito, di corrente o di ideologia; la ricostruzione delle difficoltà incontrate in Sicilia dal moto unitario potrebbero non essere maggiori o diverse da quelle incontrate in altre regioni, a cominciare dal Piemonte. Se in Sicilia il separatismo ci fosse stato, ciò non dovrebbe essere storicamente considerato né riprovevole, né immorale, né antipatriottico, ma solo considerato come un nesso storico da giustificare storicamente e che in ogni modo dovrebbe servire ad esaltare di più l’energia politica degli unitari che ne trionfarono.
Il fatto che la polemica continui accanita ed aspra significa dunque che sono in gioco «interessi attuali» e non interessi storici, significa in fondo che queste pubblicazioni tipo Natoli dimostrano esse stesse proprio ciò che vorrebbero negare, cioè il fatto che lo strato sociale unitario in Sicilia è molto sottile e che esso padroneggia a stento forze latenti «demoniache» che potrebbero anche essere separatiste se questa soluzione, in determinate occasioni, si presentasse come utile per certi interessi. Il Natoli non parla del moto del 67 e tanto meno di certe manifestazioni del dopoguerra, che hanno pure un valore di sintomo per rivelare l’esistenza di correnti sotterranee, che mostrano un certo distacco tra le masse popolari e lo Stato unitario, su cui speculavano certi gruppi dirigenti.
Pare che il Natoli sostenga che l’accusa di separatismo giochi sull’equivoco, sfruttando il programma federalista che in un primo tempo parve a taluni uomini insigni dell’isola e alle sue rappresentanze la soluzione più rispondente alle tradizioni politiche locali, ecc. In ogni modo il fatto che il programma federalista abbia avuto più forti sostenitori in Sicilia che altrove e sia durato più a lungo ha il suo significato.
Q19 §41 Interpretazioni del Risorgimento. Cfr Massimo Lelj: Il Risorgimento dello spirito italiano (1725-1861), «L’Esame», Edizioni di Storia moderna, Milano, 1928, L. 15.
Q19 §42 Federico Confalonieri. Per capire l’impressione «penosa» che produceva tra gli esuli italiani l’atteggiamento di inerzia del Confalonieri durante la sua dimora all’estero, dopo la liberazione dallo Spielberg, occorre tener presente un brano della lettera scritta dal Mazzini a Filippo Ugoni il 15 novembre 1838, pubblicata da Ugo Da Corno nella Nuova Antologia del 16 giugno 1928 (Lettera inedita di Giuseppe Mazzini): «Mi sorprende che Confalonieri rientri. Quando tu mi parli della guerra che susciterebbe nel mio cuore il pensiero di mia madre, di mio padre, della sorella che mi rimane, dici il vero; ma Confalonieri da che affetto prepotente è egli richiamato in Italia? dopo la morte di Teresa sua moglie? Non capisco la vita se non consacrata al dovere, o all’amore che è anch’esso un dovere. Intendo, senza approvare o disapprovare, l’individuo che rinunzia alla lotta pel vero e pel bene a fronte della felicità o infelicità di persone care e sacre; non intendo chi vi rinunzia per vivere, come si dice, quieto; otto o dieci anni di vita d’individualismo, di sensazioni che passano e non producono cosa alcuna per altri, conchiusi dalla morte, mi paiono cosa spregevole per chi non ha credenza di vita futura, più che spregevole rea forse per chi ne ha. Confalonieri, solo, in età già inoltrata, senza forti doveri che lo leghino a una famiglia di esseri amati, dovrebbe, secondo me, aver tutto a noia fuorché la idea di contribuire all’emancipazione del suo paese e alla crociata contro l’Austria».
Il Da Corno nella sua introduzione alla lettera scrive: «E per questo è pure nella nostra lettera un accorato pensiero per Federico Confalonieri. Egli era passato da Londra, un anno prima, diretto in Francia: Mazzini aveva saputo che era mesto e silenzioso, ma i patimenti, secondo lui, non dovevano mutare il fondo dell’anima. Lo seguiva con trepidazione, perché voleva che fosse sempre un’alta diritta figura, un esempio. Pensava che se egli stesso fosse uscito dallo Spielberg, trovandosi un deserto d’intorno, non avrebbe ad altro inteso che al modo di ritentare qualche cosa a pro’ dell’antica idea e finirvi. Non voleva che supplicasse, che volesse e ottenesse il ritorno chi aveva sofferto quindici anni senza avvilirsi, senza indizi di cangiamento. Voleva che fosse sempre un nuovo Farinata degli Uberti, come lo raffigurò Gabriele Rosa, affettuoso e costante esaltatore, sino all’ultimo, del suo compagno di prigionia».
Il Da Corno è completamente fuori strada e le parole del Mazzini, altro che accorate, sono aspre e dure. L’agiografia impedisce al Da Corno di rilevare il tono giusto delle parole del Mazzini. Altri accenni al Confalonieri nell’epistolario mazziniano e nelle lettere degli altri esuli: il giudizio reale bisogna cercarlo appunto in queste lettere private, perché si comprende che gli esuli non abbiano voluto pubblicamente gettare ombre sulla figura del Confalonieri. Una ricerca indispensabile è da farsi nelle relazioni degli informatori austriaci al governo di Vienna dai paesi dove il Confalonieri dimorò dopo la liberazione e nelle istruzioni che questi informatori ricevevano da Metternich.
Q19 §43 La morte di Vittorio Emanuele II. In una lettera di Guido Baccelli a Paulo Fambri, del 12 agosto (forse 1880, poiché manca l’anno e il 1880 è un’ipotesi del Guidi) pubblicata da Angelo Flavio Guidi (L’archivio inedito di Paulo Fambri nella Nuova Antologia del 16 giugno 1928) è scritto: «Il cuore di tutta Italia sanguina ancora al ricordo della morte del glorioso Vittorio Emanuele: quella immensa sciagura però poteva essere cento volte più grande se non si fossero guadagnate coll’aspirazione dell’ossigeno parecchie ore di vita». (Seguono puntini, dell’editore Guidi a quanto pare, perché completano tutta la linea, non sono cioè i soliti puntini di sospensione). Cosa significa?
Q19 §44 Federico Confalonieri. Il Confalonieri prima di essere tradotto allo Spielberg e dopo la liberazione, prima di essere tradotto nel carcere di Gradisca, per essere poi deportato, andò a Vienna. Vedere se anche in questo secondo soggiorno a Vienna, che si disse fatto per ragioni di salute, ebbe colloqui con uomini politici austriaci. I dati esterni sulla vita del Confalonieri si possono trovare nelle pubblicazioni del D’Ancona.
Come curiosità sarà da vedere il dramma di Rino Alessi, Il conte Aquila. Ma perché l’Alessi ha creduto di chiamare il Confalonieri il conte «Aquila»?
Q19 §45 La Repubblica Partenopea e le classi rivoluzionarie nel Risorgimento. Nell’edizione Laterza delle «Memorie storiche del regno di Napoli dal 1790 al 1815» di Francesco Pignatelli Principe di Strongoli (Nino Cortese, Memorie di un generale della Repubblica e dell’Impero, 2 voll. In 8°, di pp. 136-CCCCXXV, 312, L. 509, il Cortese pubblica un saggio «Stato e ideali politici nell’Italia meridionale nel Settecento e l’esperienza di una rivoluzione», in cui si pone il problema: come mai, nel Mezzogiorno d’Italia, la nobiltà apparisca dalla parte dei rivoluzionari e sia poi ferocemente perseguitata dalla reazione, mentre in Francia nobiltà e monarchia sono unite davanti al pericolo rivoluzionario. Il Cortese risale ai tempi di Carlo di Borbone per trovare il punto di contatto tra la concezione degli innovatori aristocratici e quella dei borghesi: per i primi la libertà e le necessarie riforme devono essere garantite soprattutto da un parlamento aristocratico, mentre sono disposti ad accettare la collaborazione dei migliori della borghesia; per questa il controllo deve essere esercitato e la garanzia della libertà affidata all’aristocrazia dell’intelligenza, del sapere, della capacità, ecc., da qualsiasi parte venga. Per ambedue lo Stato deve essere governato dal re, circondato, illuminato e controllato da un’aristocrazia. Nel 1799, dopo la fuga del re, si ha prima il tentativo di una repubblica aristocratica da parte dei nobili e poi quello degli innovatori borghesi nella successiva repubblica napoletana.
Pare che gli eventi napoletani non possano essere contrapposti a quelli francesi; anche in Francia ci fu un tentativo di alleanza tra monarchia, nobili e alta borghesia dopo un inizio di rottura tra nobili e monarchia. In Francia però la rivoluzione ebbe la forza motrice anche nelle classi popolari che le impedirono di fermarsi ai primi stadi, ciò che mancò invece nell’Italia meridionale e successivamente in tutto il Risorgimento. Occorre inoltre tener presente che il movimento napoletano avvenne dopo quello francese, quando la monarchia era sotto l’incubo del terrore francese e vedeva un nemico in chiunque parteggiasse per le idee innovatrici, fosse nobile o borghese. Il libro del Cortese è da vedere.
Q19 §46 Il popolo nel Risorgimento. 1) Vedere il volume di Niccolò Rodolico: Il popolo agli inizi del Risorgimento, Firenze, Le Monnier, in 8°, pp. 312. 2) Nello statuto della Società segreta Esperia fondata dai fratelli Bandiera si legge: «Non si facciano, se non con sommo riguardo, affiliazioni tra la plebe, perché dessa quasi sempre per natura è imprudente e per bisogno corrotta. È da rivolgersi a preferenza ai ricchi, ai forti e ai dotti, negligendo i poveri, i deboli, gli ignoranti» (da verificare).
Occorre raccogliere tutte le osservazioni che nel primo periodo del Risorgimento (prima del 48) si riferiscono a questo argomento e vedere l’origine di questa differenza. Una causa è da ricercare nei processi che seguirono il tentativo di rivolta militare del 21 in Piemonte e altrove: differenza di atteggiamento tra soldati e ufficiali; i soldati o tradirono spesso o si mostrarono molto deboli dinanzi ai giudizi nell’istruzione dei processi.
Atteggiamento di Mazzini prima e dopo l’insurrezione del febbraio 1853 a Milano; dopo il 1853 sono da vedere le sue istruzioni a Crispi per la fondazione di sezioni del Partito d’Azione in Portogallo, nelle quali si raccomanda di mettere un operaio in ogni Comitato di tre.
Q19 §47 L’Italia e il carciofo. L’immagine dell’Italia come di un carciofo, le cui foglie si mangiano ad una ad una, viene attribuita a parecchi principi italiani, non solo della casa Savoia. L’ultima attribuzione è quella a Vittorio Emanuele II (e ciò non sarebbe contrario al suo carattere, come mostra l’aneddoto di Quintino Sella, riportato da Ferdinando Martini; cfr altra nota). Secondo Amerigo Scarlatti (nell’«Italia che scrive» del febbraio 1928), l’immagine sarebbe dovuta a Vittorio Amedeo II, come risulta dal Voyage d’Italie del Misson, stampato all’Aja nel 1703.
Q19 §48 Piero Pieri, Il regno di Napoli dal luglio T799 al marzo 1806, Napoli, Ricciardi, 1928, pp. 314, L. 25. Studia la politica borbonica dopo la prima restaurazione e le cause del suo crollo nel 1806, avvenuto pur non essendoci all’interno nessuna forza contraria attiva e quando l’esercito francese era ancora lontano. Studia il difficile regime delle classi nel Mezzogiorno e il nascere del pensiero liberale che sostituisce il vecchio giacobinismo del 1799. (Ma si può chiamare «giacobinismo» l’indirizzo politico dei rivoluzionari napoletani del 1799?) Pare si tratti di un libro molto interessante.
Per comprendere l’orientamento delle classi e il loro sviluppo nel Mezzogiorno deve essere molto interessante anche il libro di A. Zago: L’istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767‑186o), Città di Castello, «Il Solco», 1927, pp. 228, L. 15. (Lo squilibrio tra l’attività scolastica statale e quella privata si è avuto dopo il 1821: le scuole private fioriscono, mentre l’attività statale decade: si costituisce così uno strato di intellettuali nettamente separato dalle masse popolari e in opposizione allo Stato, relativamente forte nella disgregazione politica generale, a stento unificata esteriormente dalla repressione di polizia. Questo argomento merita di essere approfondito).
Q19 §49 Il nodo storico 1848‑49. Ricostruire ed analizzare minutamente il succedersi dei governi e delle combinazioni di partiti (costituzionali e assolutisti) nel Piemonte dall’inizio del nuovo regime fino al proclama di Moncalieri, da Solaro della Margarita a Massimo d’Azeglio. Funzione del Gioberti e del Rattazzi e loro effettivo potere sulla macchina statale che era rimasta immutata o quasi dal tempo dell’assolutismo.
Significato del così detto connubio Cavour‑Rattazzi: fu il primo passo della disgregazione democratica? ma fino a qual punto il Rattazzi poteva dirsi un liberale‑democratico?
Q19 §50 Criteri introduttivi. La storia come «biografia» nazionale. Questo modo di scrivere la storia comincia col nascere del sentimento nazionale ed è uno strumento politico per coordinare e rinsaldare nelle grandi masse gli elementi che appunto costituiscono il sentimento nazionale. 1) Si presuppone che ciò che si desidera, sia sempre esistito e non possa affermarsi e manifestarsi apertamente per l’intervento di forze esterne o perché le virtù intime erano «addormentate; 2) ha dato luogo alla storia popolare oleografica: l’Italia è veramente pensata come qualcosa di astratto e concreto (troppo concreto) nello stesso tempo, come la bella matrona delle oleografie popolari, che influiscono più che non si creda nella psicologia di certi strati del popolo, positivamente e negativamente (ma sempre in modo irrazionale), come la madre di cui gli italiani sono i «figli». Con un passaggio che sembra brusco e irrazionale, ma ha indubbiamente efficacia, la biografia della «madre» si trasforma nella biografia collettiva dei «figli buoni», contrapposti ai figli degeneri, deviati ecc. Si capisce che un tal modo di scrivere e declamare la storia è nato per ragioni pratiche, di propaganda: ma perché si continua ancora in tale tradizione? Oggi questa presentazione della storia d’Italia è doppiamente antistorica: 1) perché è in contraddizione con la realtà; 2) perché impedisce di valutare adeguatamente lo sforzo compiuto dagli uomini del Risorgimento, sminuendone la figura e l’originalità, sforzo che non fu solo verso i nemici esterni, ma specialmente contro le forze interne conservatrici che si opponevano all’unificazione.
Per comprendere le ragioni «pedagogiche» di questa forma di storia, anche in questo caso può servire il paragone con la situazione francese nello stesso tempo in cui si attuò il Risorgimento, Napoleone si chiamò imperatore dei Francesi e non della Francia, e così Luigi Filippo, re dei Francesi. La denominazione ha un carattere nazionale‑popolare profondo, e significa un taglio netto con l’epoca dello Stato patrimoniale, una maggiore importanza data agli uomini invece che al territorio. «Marianna» perciò in Francia può essere canzonata anche dai più accesi patriotti, mentre in Italia mettere in caricatura la figura stilizzata dell’Italia significherebbe senz’altro essere antipatriotti come lo furono i sanfedisti e i gesuiti prima e dopo il 1870.
Q19 §51 Il nodo storico 1848‑49. Cfr Carlo Pagani, Dopo Custoza e Volta nel 1848 (nella Nuova Antologia del 1° marzo 1929). Riporta alcuni documenti inediti tratti dall’archivio Casati di Milano, non essenziali, ma significativi per vedere la crisi politica di quel momento, crisi politica che fu uno degli elementi principali della disfatta militare: mancanza di un indirizzo unitario politico ben stabilito e risoluto, esitazioni, azione irresponsabile delle cricche reazionarie, nessuna cura per i bisogni dell’esercito come massa umana ecc.
L’Inghilterra era contraria all’intervento militare della Francia a favore del Piemonte: Palmerston dichiarò che l’intervento francese avrebbe scatenato una guerra europea perché l’Inghilterra non l’avrebbe tollerato, mentre solo mollemente appoggiava il Piemonte in via diplomatica per evitare una disfatta rovinosa e mutamenti territoriali troppo favorevoli all’Austria. L’articolo del Pagani è da rivedere in caso di ricostruzione degli avvenimenti del 48‑49 per trovare elementi di concordanza e di sussidio di altri documenti.
Per le vicende del Ministero Casati‑Gioberti (luglio‑agosto 1848) cfr la lettera del Gioberti a Giuseppe Massari pubblicata con proemio dal senatore Matteo Mazziotti nella Nuova Antologia del 16 giugno 1918. Per la missione di Carlo d’Adda in Francia e Inghilterra svolta per incarico del governo provvisorio di Milano cfr Carlo Pagani nel Resoconto del Congresso Storico di Trento nel 1926 (discorso: Il Governo provvisorio di Milano nel 1848 e il Trentino); Carlo Pagani, Uomini e cose in Milano dal marzo all’agosto del 1848, Ed. Cogliati, Milano (con documenti tratti dal Museo storico del Risorgimento di Milano e specialmente dagli archivi Casati, d’Adda, Arese, Giulini‑Crivelli, Restelli).
Q19 §52 I volontari. Sui volontari alcune osservazioni acute si trovano nelle Memorie di Leonetto Cipriani, specialmente per i volontari toscani e per il modo con cui furono trattati dall’esercito piemontese nel 1848. Le Memorie di Cipriani sono da leggere anche per alcune impressioni vive sugli avvenimenti del Risorgimento.
Q19 §53 Luzio e la storiografia tendenziosa e faziosa dei moderati. 1) È da porre in rilievo come il modo di scrivere la storia del Risorgimento di A. Luzio è stato spesso lodato dai gesuiti della «Civiltà Cattolica». Non sempre, ma più spesso di quanto si crede, l’accordo tra il Luzio e i gesuiti è possibile. Cfr nella «Civiltà Cattolica» del 4 agosto 1928 le pp. 216‑17 dell’articolo Processo politico e condanna dell’abate Gioberti nell’anno 1833. Il Luzio deve difendere la politica di Carlo Alberto (nel libro Mazzini carbonaro, p. 498) e non esita a giudicare aspramente l’atteggiamento del Gioberti nel processo per i fatti del 31, d’accordo coi gesuiti. È da rilevare come dagli articoli pubblicati dalla «Civiltà Cattolica» nel 1928 sul processo di Gioberti risulta dai documenti vaticani che il Papa aveva già dato preventivamente, in forma loiolesca, il suo placet alla condanna capitale e all’esecuzione del Gioberti, mentre nel 1821, per esempio, la condanna a morte di un ecclesiastico in Piemonte era stata trasformata nell’ergastolo per l’intervento vaticano.
2) Sulla letteratura «storica» del Luzio riguardante i processi del Risorgimento sono da fare parecchi rilievi di ordine politico‑fazioso, di metodo e di mentalità. Troppo spesso il Luzio (per ciò che riguarda gli arrestati dei partiti democratici) pare che rimproveri gli imputati di non essersi fatti condannare e impiccare. Anche da un punto di vista giuridico o giudiziario, il Luzio imposta le quistioni in modo falso e tendenzioso, ponendosi dal punto di vista del «giudice» e non da quello degli imputati: quindi i suoi tentativi (inetti e stolti) di «riabilitare» i giudici reazionari, come il Salvotti. Anche ammesso che il Salvotti sia da giudicare irreprensibile sia personalmente, sia come funzionario austriaco, ciò non muta che i processi da lui imbastiti fossero contrari alla nuova coscienza giuridica rappresentata dai patrioti rivoluzionari e apparissero loro mostruosi. La condizione dell’imputato era difficilissima e delicatissima: anche una piccola ammissione poteva avere conseguenze catastrofiche non solo per l’imputato singolo, ma per tutta una serie di persone, come si vide nel caso del Pallavicino. Alla «giustizia» stataria, che è una forma di guerra, non importa nulla della verità e della giustizia obbiettiva: importa solo distruggere il nemico, ma in modo che appaia che il nemico merita di essere distrutto e ammetta egli stesso di meritarselo. Un esame degli scritti «storico‑giudiziari» del Luzio potrebbe dar luogo a tutta una serie di osservazioni di metodo storico interessanti psicologicamente e fondamentali scientificamente (è da confrontare l’articolo di Mariano d’Amelio Il successo e il diritto nel «Corriere della Sera» del 3 settembre 1934).
3) Questo modo di fare la storia del Risorgimento alla Luzio ha mostrato il suo carattere fazioso specialmente nella seconda metà del secolo scorso (e più determinatamente dopo il 1876, cioè dopo l’avvento della sinistra al potere): esso è stato addirittura un tratto caratteristico della lotta politica tra cattolici‑moderati (o moderati che desideravano riconciliarsi coi cattolici e trovare il terreno per la formazione di un gran partito di destra che attraverso il clericalismo avesse una base larga nelle masse rurali) e i democratici, che per ragioni analoghe, volevano distruggere il clericalismo. Un episodio tipico è stato l’attacco sferrato contro Luigi Castellazzo per il suo presunto atteggiamento nel processo di Mantova che portò alle impiccagioni di Belfiore di don Tazzoli, di Carlo Poma, di Tito Speri, di Montanari e del Frattini. La campagna era puramente faziosa, perché le accuse fatte al Castellazzo non furono fatte ad altri che nei processi notoriamente si comportavano certo peggio di quanto si affermava per il Castellazzo e non persuasivamente, perché uomini come il Carducci si mantennero solidali con l’attaccato; ma il Castellazzo era repubblicano, massone (capo della Massoneria?) e aveva persino manifestato simpatia per la Comune. Il Castellazzo si comportò peggio di Giorgio Pallavicino al processo Confalonieri? (cfr attacchi del Luzio contro l’Andryane per la sua ostilità al Pallavicino). È vero che il processo di Mantova si concluse con esecuzioni capitali, mentre ciò non avvenne per il Confalonieri e compagni, ma a parte che ciò non deve modificare il giudizio sulle azioni dei singoli individui, si può dire che le esecuzioni di Belfiore siano dovute al presunto comportamento del Castellazzo e non furono invece la fulminea risposta all’insurrezione milanese del 3 febbraio 1853? E non contribuì a rafforzare la volontà spietata di Francesco Giuseppe l’atteggiamento vile dei nobili milanesi che strisciarono ai piedi dell’imperatore proprio alla vigilia dell’esecuzione? (cfr le date). È da vedere come il Luzio si comporta verso questa serie complessa di avvenimenti. I moderati cercarono di attenuare la responsabilità dei nobili milanesi in forma veramente sconcia (cfr i Cinquanta anni di patriottismo di R. Bonfadini). Vedere come il Luzio si atteggia nella quistione dei Costituti Confalonieri e in quella del comportamento del Confalonieri dopo la sua liberazione. Sulla quistione del Castellazzo cfr Luzio: I Martiri di Belfiore nelle diverse edizioni (la 4a è del 1924); I processi politici di Milano e di Mantova restituiti dall’Austria, Milano, Cogliati, 1919 (questo libretto dovrebbe parlare dei Costituti Confalonieri che il senatore Salata scriveva di aver «scoperto» negli archivi viennesi); La Massoneria e il Risorgimento Italiano, 2 voll., Bocca (pare che questo lavoro sia giunto alla 4a edizione in pochissimo tempo, ciò che sarebbe meraviglioso); cfr ancora P. L. Rambaldi, Luci ed ombre nei processi di Mantova, nell’«Archivio Storico Italiano», V‑XLIII pp. 257‑331 e Giuseppe Fatini, Le elezioni di Grosseto e la Massoneria, in Nuova Antologia del 16 dicembre 1928 (parla dell’elezione a deputato del Castellazzo nel settembre 1883 e della campagna che si scatenò: il Carducci sostenne il Castellazzo e scrisse contro l’«accanimento fariseo moderato»).
4) Cosa si proponevano e in parte si propongono ancora (ma in questo campo da alcuni anni molte cose sono cambiate) gli storici e i pubblicisti moderati con questo loro indefesso, accortissimo e molto bene organizzato (pare talvolta che ci sia stato un centro direttivo per questa attività, una specie di massoneria moderata, tanto è grande lo spirito di sistema) lavoro di propaganda? «Dimostrare» che l’unificazione della penisola è stata opera precipua dei moderati alleati alla dinastia e legittimare storicamente il monopolio del potere. Occorre ricordare che ai moderati appartenevano le maggiori personalità della cultura, mentre la sinistra non brillava (salvo poche eccezioni) per troppa serietà intellettuale, specialmente nel campo degli studi storici e della pubblicistica di medio grado. L’attività polemica dei moderati, attraverso la sua «dimostrazione» addomesticata riusciva a disgregare ideologicamente la democrazia, assorbendone molti elementi individuali e specialmente influendo sull’educazione delle generazioni giovani, formandole con le loro concezioni, con le loro parole d’ordine, coi loro programmi. Inoltre: 1) i moderati, nella loro propaganda, erano senza scrupoli, mentre gli uomini del Partito d'Azione erano pieni di «generosità» patriottica, nazionale ecc. e rispettavano tutti quelli che per il Risorgimento avevano realmente sofferto, anche se in qualche momento erano stati deboli; 2) il regime degli archivi pubblici era favorevole ai moderati, ai quali era permesso individualmente fare ricerche di documenti contro i loro avversari politici e mutilare o tacere dei documenti che sarebbero stati sfavorevoli ai loro; solo da pochi anni è stato possibile pubblicare epistolari completi, per esempio di moderati toscani, che ancora nel 59 si aggrappavano alle falde del granduca per non farlo scappare ecc. I moderati non riconoscono sistematicamente una forza collettiva agente e operante nel Risorgimento all’infuori della dinastia e dei moderati: del Partito d'Azione riconoscono la benemerenza di personalità singole che vengono esaltate tendenziosamente per catturarle; altre sono diffamate, ottenendo in ogni caso di spezzare il vincolo collettivo. In realtà il Partito d’Azione non seppe contrapporre nulla di efficace a questa propaganda, che attraverso la scuola, divenne insegnamento ufficiale: lamentazioni o sfoghi così puerilmente settari e partigiani che non potevano convincere i giovani colti e lasciavano indifferenti i popolani, cioè erano senza efficacia sulle nuove generazioni: così il Partito d'Azione fu disgregato e la democrazia borghese non seppe mai crearsi una base popolare. La sua propaganda non doveva basarsi sul passato, sulle polemiche del passato, che interessano sempre poco le grandi masse e sono utili solo, entro certi limiti, a costituire e rafforzare i quadri dirigenti, ma sul presente e sull’avvenire, cioè su programmi costruttivi in opposizione (o integrativi) dei programmi ufficiali. La polemica del passato era specialmente difficile e pericolosa per il Partito d’Azione, perché esso era stato vinto, e il vincitore, per il solo fatto di essere tale, ha dei grandi vantaggi nella lotta ideologica. Non è senza significato che nessuno abbia mai pensato a scrivere una storia del Partito d'Azione, nonostante l’indubbia importanza che esso ebbe nello svolgersi degli eventi: basta pensare ai tentativi democratici del 48‑49 in Toscana, nel Veneto, a Roma, e all’impresa dei Mille.
In un certo periodo tutte le forze della democrazia si allearono e la Massoneria divenne il perno di tale alleanza: è questo un periodo ben determinato nella storia della Massoneria, divenuta una delle forze più efficienti dello Stato nella società civile, per arginare le pretese e i pericoli del clericalismo, e questo periodo finì con lo svilupparsi delle forze operaie. La Massoneria divenne il bersaglio dei moderati che evidentemente speravano di conquistare così almeno una parte delle forze cattoliche specialmente giovanili; m, in realtà i moderati valorizzarono le forze cattoliche controllate dal Vaticano e così la formazione dello Stato moderno e di una coscienza laica nazionale (in definitiva il sentimento patriottico) ne subì un fiero contraccolpo come si vide in seguito. (Osservazioni da approfondire).
Q19 §54 Confalonieri. In un articolo di Panfilo (Giulio Caprin) nel «Corriere della Sera» del 26 settembre 1934, si dice: «Teresa, consunta dagli strazi, doveva morire prima che il nuovo Imperatore Ferdinando facesse la grazia che Francesco aveva sempre negata all’aristocratico cospiratore non pentito». Quel «non pentito» non è più possibile dopo ciò che Silvio D’Amico ha pubblicato sulla domanda di grazia fatta dal Confalonieri e conservata nel museo italiano dello Spielberg. L’articolo del Caprin recensisce il libro di Luigi Ceria, Vita di una moglie (Milano, Baldini e Castoldi, L. 12) su Teresa e sulla vita «amorosa» di Federico non molto regolare. Col titolo Confalonieri (romanzo), l’editore Treves ha pubblicato un volume di Riccarda Huch (1934, L. 8).
Q19 §55 Gli avvenimenti del febbraio 1853 a Milano e i moderati. Nell’articolo su Francesco Brioschi («Marzocco» del 6 aprile 1930, capitolo del libro Rievocazioni dell’Ottocento) Luca Beltrami ricorda come il Brioschi fu accusato di aver firmato l’indirizzo di devozione a Francesco Giuseppe nel febbraio 1853 (dopo l’attentato di un calzolaio viennese). Il Beltrami afferma che il Brioschi non firmò (se c’è un Brioschi fra i firmatari, non si tratta dell’illustre matematico, professore dell’Università di Pavia e futuro organizzatore del Politecnico di Milano). Il Beltrami annota: «e non sarebbe nemmeno da definire atto di cortigianeria quello dei funzionari del governo, “invitati” a firmare la protesta contro l’atto insano e incosciente di un calzolaio viennese», dimenticando: 1) che l’indirizzo fu firmato dopo la repressione di Milano e alla vigilia di Belfiore; 2) che i nobili milanesi firmatari non erano «funzionari»; 3) che se il Brioschi, funzionario, non firmò, senza essere perseguitato, significa che non solo i nobili, ma anche i funzionari potevano non firmare. Pertanto nella sua annotazione è implicita la condanna morale di tutti i firmatari.
Q19 §56 L’Italia nel Settecento. L’influenza francese nella politica, nella letteratura, nella filosofia, nell’arte, nei costumi. I Borboni regnano a Napoli e nel ducato di Parma. Sugli influssi francesi a Parma sono da vedere le pubblicazioni minuziose di Henri Bedarida: Parme dans la politique française au XVIII e siècle, Paris, Alcan e altre due precedenti. È da vedere anche: Giuseppe Ortolani, Italie et France au XVIII e siècle, nei Mélanges de littérature et d’histoire publiés par l’Union intellectuelle franco‑italienne, Parigi, Ed. Leroux.
Nella politica francese l’Italia, per la sua posizione geografica, è destinata ad assumere la funzione di elemento di equilibrio dinanzi alla crescente potenza dell’Austria: quindi la Francia da Luigi XIV a Luigi XVI tende ad esercitare in Italia un’azione di predominio, anticipando la politica dei Napoleoni, anticipazione che si palesa nei ripetuti progetti o tentativi di federare gli Stati italiani a servizio della Francia. (Questi elementi della politica francese sono da analizzare attentamente, per fissare il rapporto tra i fattori internazionali e quelli nazionali nello sviluppo del Risorgimento. È da notare come questa impostazione della politica francese sia agli antipodi di quella sostenuta da Jacques Bainville nella critica della politica napoleonica contrapposta a quella della monarchia).
Q19 §57 La Repubblica partenopea. Cfr: Antonio Manes, Un cardinale condottiere. Fabrizio Ruffo e la Repubblica partenopea, Aquila, Vecchioni, 1930. Il Manes cerca di «riabilitare» il cardinale Ruffo (il fatto è da citare nella rubrica «Passato e Presente» in cui si citano altre «riabilitazioni»: quella di Solaro della Margarita, di Fra Diavolo ecc. si accenna al fatto che alcuni insegnanti «polemizzano» con le Memorie del Settembrini e vi trovano troppa «demagogia» contro i Borboni) addossando la responsabilità delle repressioni e degli spergiuri sul Borbone e sul Nelson. Pare che il Manes non sappia orientarsi bene per fissare le divisioni politiche e sociali nel Napoletano; ora parla di taglio netto tra nobiltà e clero da una parte e popolo dall’altra; ora il taglio sparisce e si vedono nobili e clero nelle due parti. A un certo punto dice che il Ruffo «assume un carattere tutt’affatto nazionale, se può essere usata questa parola di colore troppo moderno e contemporaneo» e allora dovrebbe concludere che non erano nazionali i patriotti sterminati dalle bande sanfedistiche. (Sui rapporti tra nobiltà, clero e popolo cfr il libro di N. Rodolico sull’Italia Meridionale e il suo articolo nel «Marzocco», n. 11 del 1926).
Q19 §58 Un’opinione di Stendhal. Cfr P. P. Trompeo, Stendhal fra un Cardinale ed un Nunzio, Nuova Antologia del 1° febbraio 1935. Il Trompeo, dopo aver enumerato alcuni giudizi dello Stendhal molto favorevoli alla causa della libertà italiana e al valore dei patriotti italiani, come Santarosa ecc. (p. 445), estratti da Rome, Naples et Florence e da Promenades dans Rome, conclude: «Ma giudicava che contro un’Austria sicura di sé ogni tentativo d’insurrezione sarebbe fallito, anche per il poco séguito che aveva nel popolo “l’innocence vertueuse et girondine” dei cospiratori, e che d’altra parte un intervento a favore di una Italia ancora immatura per una valida riscossa sarebbe stato per la Francia un rischio troppo forte».
QUADERNO 20
AZIONE CATTOLICA – CATTOLICI INTEGRALI, GESUITI, MODERNISTI
Q20 §1 L’Azione Cattolica. L’Azione Cattolica, nata specificatamente dopo il 1848, era molto diversa da quella attuale, riorganizzata da Pio XI. La posizione originaria dell’Azione Cattolica dopo il 1848 (e in parte anche nel periodo di incubazione che va dal 1789 al 1848, quando sorge e si sviluppa il fatto e il concetto di nazione e di patria che diventa l’elemento ordinatore – intellettualmente e moralmente – delle grandi masse popolari in concorrenza vittoriosa con la Chiesa e la religione cattolica) può essere caratterizzata estendendo alla religione cattolica l’osservazione che uno storico francese (verificare) ha fatto a proposito della monarchia «legittimista» e di Luigi XVIII: pare che Luigi XVIII non riuscisse a persuadersi che nella Francia dopo il 1815 la monarchia dovesse avere un partito politico specifico per sostenersi.
Tutti i ragionamenti fatti dagli storici cattolici (e le affermazioni apodittiche dei pontefici nelle Encicliche) per spiegare la nascita dell’Azione Cattolica e per riallacciare questa nuova formazione a movimenti e attività «sempre esistiti» da Cristo in poi, sono di una estrema fallacia. Dopo il 1848 in tutta l’Europa (in Italia la crisi assume la forma specifica e diretta dell’anticlericalismo e della lotta anche militare contro la Chiesa) la crisi storico‑politico‑intellettuale è superata con la netta vittoria del liberalismo (inteso come concezione del mondo oltre che come particolare corrente politica) sulla concezione cosmopolitica e «papalina» del cattolicismo. Prima del 1848 si formavano partiti più o meno effimeri e insorgevano singole personalità contro il cattolicismo;dopo il 1848 il cattolicismo e la Chiesa «devono» avere un proprio partito per difendersi, e arretrare il meno possibile, non possono più parlare (altro che ufficialmente, perché la Chiesa non confesserà mai l’irrevocabilità di tale stato di cose) come se sapessero di essere la premessa necessaria e universale di ogni modo di pensare e di operare. Molti oggi non riescono più neanche a persuadersi che così potesse essere una volta. Per dare un’idea di questo fatto, si può offrire questo modello: oggi nessuno può pensare sul serio a fondare un’associazione contro il suicidio (è possibile che in qualche parte esista una qualche società del genere, ma si tratta di altra cosa), perché non esiste nessuna corrente d’opinione che cerchi persuadere gli uomini (e riesca sia pure parzialmente) che occorre suicidarsi in massa (sebbene siano esistiti singoli individui e anche piccoli gruppi che hanno sostenuto tali forme di nichilismo radicale, pare in Ispagna): la «vita» è la premessa necessaria di ogni manifestazione di vita, evidentemente. Il cattolicismo ha avuto una tale funzione e di ciò rimangono tracce abbondanti nel linguaggio e nei modi di pensare specialmente dei contadini: cristiano e uomo sono sinonimi, anzi sono sinonimi cristiano e «uomo incivilito». («Non sono cristiano!» – «E allora cosa sei, una bestia?») I coatti dicono ancora: «cristiani e coatti» (ad Ustica prime meraviglie quando all’arrivo del vaporetto si sentiva dire dai coatti: «sono tutti cristiani, non ci sono che cristiani, non c’è neanche un cristiano»). I carcerati invece dicono più comunemente: «borghesi e detenuti», o scherzosamente: «soldati e borghesi», sebbene i meridionali dicano anche «cristiani e detenuti». Sarebbe così interessante studiare tutta la serie di passaggi storico‑semantici per cui nel francese da «cristiano» si è ottenuto «crétin» (donde l’italiano «cretino») e addirittura «grédin»; il fenomeno deve essere simile a quello per cui «villano» da «uomo di campagna» ha finito per significare «screanzato» e addirittura «gaglioffo e mascalzone», cioè il nome «cristiano» impiegato dai contadini (pare dal contadini di alcune regioni alpine) per indicare se stessi come «uomini», si è, in alcuni casi di pronunzia locale, staccato dal significato religioso ed ha avuto la stessa sorte di «manant». Forse anche il russo «krestianin» = contadino ha la stessa origine, mentre «cristiano» in senso religioso, forma più colta, ha mantenuto l’aspirazione X greco (in senso spregiativo si diceva «muĝik»). A questa concezione è forse da legare anche il fatto che in alcuni paesi, dove gli ebrei non sono conosciuti, si crede o si credeva che essi avessero la coda e le orecchie di porco o altro attributo animalesco.
L’esame storico critico del movimento d’Azione Cattolica può dar luogo, analiticamente, a diverse serie di ricerche e di studi.
I Congressi nazionali. Come sono preparati dalla stampa centrale e locale. Il materiale ufficiale preparatorio: relazioni ufficiali e d’opposizione.
L’Azione Cattolica è stata sempre un organismo complesso, anche prima della costituzione della Confederazione bianca del Lavoro e del Partito Popolare. La Confederazione del Lavoro era considerata organicamente una parte costitutiva dell’Azione Cattolica, il Partito Popolare invece no, ma lo era di fatto. Oltre che alle altre ragioni, la costituzione del Partito Popolare fu consigliata da ciò che si riteneva inevitabile nel dopo guerra una avanzata democratica, alla quale occorreva dare un organo e un freno, senza mettere in rischio la struttura autoritaria dell’Azione Cattolica che ufficialmente è diretta personalmente dal Papa e dai Vescovi: senza il Partito Popolare e le innovazioni in senso democratico portate nella Confederazione sindacale, la spinta popolaresca avrebbe sovvertito tutta la struttura dell’Azione Cattolica, mettendo in quistione l’autorità assoluta delle gerarchie ecclesiastiche. La stessa complessità si verificava e si verifica ancora nel campo internazionale; sebbene il Papa rappresenti un centro internazionale per eccellenza, di fatto esistono alcuni uffici che funzionano per coordinare e dirigere il movimento politico e sindacale cattolico in tutti i paesi, come l’Ufficio di Malines che ha compilato il Codice Sociale e l’Ufficio di Friburgo per l’azione sindacale (è da verificare la funzionalità di questi uffici dopo i mutamenti avvenuti nei paesi tedeschi oltre che in Italia nel campo dell’organizzazione politica e sindacale cattolica).
Svolgimento dei Congressi. Argomenti messi all’ordine del giorno e argomenti omessi per evitare conflitti radicali.
L’ordine del giorno dovrebbe risultare dai problemi concreti che si sono imposti all’attenzione nello spazio tra un congresso e l’altro e dalle prospettive avvenire, oltre che dai punti dottrinari intorno ai quali si formano le correnti generali d’opinione e si raggruppano le frazioni.
Su quale base e con quali criteri vengono scelte o rinnovate le direzioni? Sulla base di una tendenza dottrinaria generica, dando alla nuova Direzione una fiducia generica, oppure dopo che il Congresso ha fissato un indirizzo concreto e preciso di attività? La democrazia interna di un movimento (cioè il grado più o meno grande di democrazia interna, cioè di partecipazione degli elementi di base alla decisione e alla fissazione della linea di attività) si può misurare e giudicare anche e forse specialmente a questa stregua.
Altro elemento importante è la composizione sociale dei Congressi, del gruppo degli oratori e della direzione eletta, in rapporto alla composizione sociale del movimento nel suo complesso.
Rapporto tra le generazioni adulte e quelle giovanili. I Congressi si occupano essi direttamente del movimento giovanile, che dovrebbe essere la fonte maggiore per il reclutamento e la migliore scuola per il movimento, o lascia ai giovani di pensare a se stessi?
Che influsso hanno (avevano) nei Congressi le organizzazioni subordinate e sussidiarie (o che tali dovrebbero essere), il gruppo parlamentare, gli organizzatori sindacali, ecc.? Ai deputati e ai capi sindacali viene fatta nei Congressi una posizione speciale, ufficialmente e organicamente o sia pure solo di fatto?
Oltre che nelle discussioni dei Congressi è necessario fissare lo svolgimento che hanno avuto nel tempo e nello spazio i problemi concreti più importanti: la quistione sindacale, il rapporto tra il centro politico e i sindacati, la quistione agraria,
le quistioni di organizzazione interna, in tutte le diverse interferenze. Ogni quistione presenta due aspetti: come è stata trattata teoricamente e tecnicamente e come è stata affrontata praticamente.
Altra quistione è quella della stampa, nei suoi diversi aspetti: quotidiana, periodica, opuscoli, libri, centralizzazione o autonomia della stampa ecc.
La frazione parlamentare: trattando di ogni determinata attività parlamentare, occorre tener presenti alcuni criteri di ricerca e di giudizio. Quando il deputato di un movimento popolaresco parla in Parlamento (e un senatore al Senato) ci possono essere tre o più versioni del suo discorso: 1) la versione ufficiale degli Atti parlamentari, che di solito è riveduta e corretta e spesso edulcorata post festum; 2) la versione dei giornali ufficiali del movimento al quale il deputato appartiene ufficialmente: essa è combinata dal deputato d’accordo col corrispondente parlamentare, in modo da non urtare certe suscettibilità o della maggioranza ufficiale del partito o dei lettori locali e non creare ostacoli prematuri a determinate combinazioni in corso o desiderate; 3) la versione dei giornali di altri partiti o dei così detti organi della pubblica opinione (giornali a grande diffusione) che è fatta dal deputato d’accordo coi rispettivi corrispondenti parlamentari in modo da favorire determinate combinazioni in corso: tali giornali possono mutare da un periodo all’altro a seconda dei mutamenti avvenuti nelle rispettive direzioni politiche o nel governi. Lo stesso criterio può essere esteso al campo sindacale, a proposito dell’interpretazione da dare a determinati eventi o anche all’indirizzo generale della data organizzazione sindacale. Per esempio: la «Stampa», il «Resto del Carlino», il «Tempo» (di Naldi) hanno servito, in certi anni, da casse di risonanza e da strumenti di combinazioni politiche tanto ai cattolici come ai socialisti. Un discorso parlamentare (o uno sciopero, o una dichiarazione di un capo sindacale) socialista o popolare, era presentato sotto una certa luce da questi giornali per il loro pubblico, mentre era presentato sotto altra luce dagli organi cattolici o socialisti. I giornali popolari e socialisti tacevano addirittura al loro pubblico certe affermazioni di rispettivi deputati che tendevano a rendere possibile una combinazione parlamentare‑governativa delle due tendenze, ecc. ecc. È indispensabile anche tener conto delle interviste date dai deputati ad altri giornali e degli articoli pubblicati in altri giornali. L’omogeneità dottrinale e politica di un partito può anche essere saggiata con questo criterio: quali indirizzi sono favoriti dai soci di questo partito nella loro collaborazione ai giornali di altra tendenza o così detti di opinione pubblica: talvolta i dissensi interni si manifestano solo così, i dissidenti scrivono, in altri giornali, articoli firmati o non firmati, danno interviste, suggeriscono motivi polemici, si fanno provocare per essere «costretti» a rispondere, non smentiscono certe opinioni loro attribuite ecc.
Q20 §2 L’Azione Cattolica e i terziari francescani. Può farsi un paragone qualsiasi tra l’Azione Cattolica e le istituzioni come i terziari francescani? Certo no, quantunque sia bene accennare introduttivamente non solo ai terziari, ma anche al fenomeno più generale dell’apparire nello sviluppo storico della Chiesa degli ordini religiosi, per meglio definire i caratteri e i limiti della stessa Azione Cattolica. La creazione dei terziari è un fatto molto interessante di origine e tendenza democratico‑popolare, che illumina meglio il carattere del francescanesimo come ritorno tendenziale ai modi di vita e di credenza del cristianesimo primitivo, comunità di fedeli e non del solo clero come esso era venuto sempre più diventando. Sarebbe perciò utile studiare bene la fortuna di questa iniziativa, che non è stata molto grande, perché il francescanesimo non divenne tutta la religione, come era nell’intenzione di Francesco, ma si ridusse a uno dei tanti ordini religiosi esistenti. L’Azione Cattolica segna l’inizio di una epoca nuova nella storia della religione cattolica: quando essa da concezione totalitaria (nel duplice senso: che era una totale concezione del mondo di una società nel suo totale), diventa parziale (anche nel duplice senso) e deve avere un proprio partito. I diversi ordini religiosi rappresentano la reazione della Chiesa (comunità dei fedeli o comunità del clero), dall’alto o dal basso, contro le disgregazioni parziali della concezione del mondo (eresie, scismi ecc. e anche degenerazione delle gerarchie); l’Azione Cattolica rappresenta la reazione contro l’apostasia di intere masse, imponente, cioè contro il superamento di massa della concezione religiosa del mondo. Non è più la Chiesa che fissa il terreno e i mezzi della lotta; essa invece deve accettare il terreno impostole dagli avversari o dall’indifferenza e servirsi di armi prese a prestito dall’arsenale dei suoi avversari (l’organizzazione politica di massa). La Chiesa, cioè, è sulla difensiva, ha perduto l’autonomia dei movimenti e delle iniziative, non è più una forza ideologica mondiale, ma una forza subalterna.
Q20 §3 Sulla povertà, il cattolicismo e la gerarchia ecclesiastica. In un libretto su Ouvriers et Patrons (memoria premiata nel 1906 dall’Accademia di Scienze morali e politiche di Parigi) è riferita la risposta data da un operaio cattolico francese all’autore dell’obbiezione mossagli che, secondo le parole di Gesù riportate da un Evangelo, ci devono essere sempre ricchi e poveri: «ebbene, lasceremo almeno due poveri perché Gesù non abbia ad aver torto». La risposta è epigrammatica, ma degna dell’obbiezione. Da quando la quistione ha assunto un’importanza storica per la Chiesa, cioè da quando la Chiesa ha dovuto porsi il problema di arginare la così detta «apostasia» delle masse, creando un sindacalismo cattolico (operaio, perché agli imprenditori non è stato mai imposto di dare un carattere confessionale alle loro organizzazioni sindacali), le opinioni più diffuse sulla quistione della «povertà» che risultano dalle encicliche e da altri documenti autorizzati, possono riassumersi in questi punti: 1) La proprietà privata, specialmente quella fondiaria, è un «diritto naturale» che non si può violare neanche con forti imposte (da questo principio sono derivati i programmi politici delle tendenze democratico-cristiane per la distribuzione delle terre con indennità, ai contadini poveri, e le loro dottrine finanziarie); 2) I poveri devono contentarsi della loro sorte, poiché le distinzioni di classe e la distribuzione della ricchezza sono disposizioni di dio e sarebbe empio cercare di eliminarle; 3) L’elemosina è un dovere cristiano e implica l’esistenza della povertà; 4) La quistione sociale è anzitutto morale e religiosa, non economica e dev’essere risolta con la carità cristiana e con i dettami della moralità e il giudizio della religione. (È da cfr il Codice Sociale di Malines, nelle successive elaborazioni).
Q20 §4 Cattolici integrali, gesuiti, modernisti. I «cattolici integrali» ebbero molta fortuna sotto il papato di Pio X; rappresentarono una tendenza europea del cattolicismo, politicamente di estrema destra, ma naturalmente erano più forti in certi paesi, come l’Italia, la Francia, il Belgio, dove, in forme diverse, le tendenze di sinistra in politica e nel campo intellettuale, si facevano sentire più fortemente nell’organizzazione cattolica. Nel Belgio, durante la guerra, i tedeschi sequestrarono una grande quantità di documenti riservati e segreti degli integrali, in seguito pubblicati e così si ebbe la prova abbondante che gli integrali avevano costituito una vera e propria associazione segreta per controllare, dirigere, «purgare» il movimento cattolico in tutti i suoi gradi gerarchici, con cifrari, fiduciari, corrispondenze clandestine, agenti per lo spionaggio ecc. Il capo degli integrali era monsignor Umberto Benigni, e una parte dell’organizzazione era costituita dal «Sodalitium Pianum» (da Papa Pio V), Monsignor Benigni, morto nel 1934, era un uomo di grande capacità teorica e pratica e di una attività incredibile: ha scritto, tra l’altro, un’opera di grande mole, La Storia sociale della Chiesa, di cui sono usciti 4 volumi d’oltre 600 pagine l’uno, in gran formato, editi dalla casa Hoepli. Come appare dalla «Civiltà Cattolica», il Benigni non ha mai interrotto la sua azione cospirativa nell’interno della Chiesa, nonostante le difficoltà in cui gli integrali sono venuti a trovarsi per il corso della politica di Pio XI, esitante, titubante, timida, ma tuttavia con indirizzo popolare democratico per la necessità di creare forti masse di Azione Cattolica. Gli integrali appoggiavano in Francia il movimento dell’Action Française, furono contro il Sillon: da per tutto sono contro ogni modernismo politico e religioso.
Di fronte ai gesuiti assumevano un atteggiamento quasi giansenistico, cioè di grande rigore morale e religioso, contro ogni forma di lassismo, di opportunismo, di centrismo. I gesuiti naturalmente accusano gli integrali di giansenismo (di ipocrisia giansenistica) e ancor di più, di fare il gioco dei modernisti (teologanti): 1) per la loro lotta contro i gesuiti; 2) perché allargavano talmente la nozione di modernismo e quindi ampliavano talmente il bersaglio, da offrire ai modernisti un campo di manovra comodissimo. Di fatto è avvenuto che nella loro comune lotta contro i gesuiti, integrale e modernisti si siano trovati obbiettivamente nello stesso terreno e abbiano collaborato tra loro (il Buonaiuti avrebbe scritto nella rivista del Benigni).
Cosa rimane oggi dei modernisti e degli integrali? È difficile identificare e calcolare la loro forza oggettiva nell’organizzazione ecclesiastica, specialmente dei modernisti (gli integrali hanno mantenuto le loro forze quasi intatte, anche dopo la campagna contro l’Action Française): in ogni modo essi sono sempre dei «fermenti» che continuano ad operare, in quanto rappresentano la lotta contro i gesuiti e il loro strapotere, lotta condotta anche oggi da elementi di destra e di sinistra, nell’apparente indifferenza della massa del clero e con risultati non trascurabili nella massa dei fedeli, che ignora queste lotte e il loro significato, ma appunto perciò non può raggiungere una mentalità unitaria e omogenea di base.
A queste forze interne, antagonistiche e clandestine o quasi, della Chiesa (per il modernismo la clandestinità è indispensabile) conviene avere dei «centri» esterni pubblici, o con efficacia diretta sul pubblico, con periodici o edizioni di opuscoli e di libri. Tra i centri clandestini e quelli pubblici esistono collegamenti clandestini che diventano il canale delle ire, delle vendette, delle denunzie, delle insinuazioni perfide, dei pettegolezzi per tenere sempre viva la lotta contro i gesuiti (che hanno anche loro una organizzazione non ufficiale o addirittura clandestina, alla quale devono contribuire i così detti «gesuiti laici», curiosa istituzione forse copiata dai terziari francescani e che numericamente pare rappresentino circa 1/4 di tutte le forze gesuitiche: questa istituzione dei «gesuiti laici» merita di essere studiata con attenzione). Tutto ciò dimostra che la forza coesiva della Chiesa è molto minore di ciò che si pensa, non solo per il fatto che la crescente indifferenza della massa dei fedeli per le quistioni puramente religiose ed ecclesiastiche dà un valore molto relativo alla superficiale ed apparente omogeneità ideologica, ma per il fatto ben più grave che il centro ecclesiastico è impotente ad annientare le forze organizzate che lottano coscientemente nel seno della Chiesa. Specialmente la lotta contro il modernismo ha demoralizzato il giovane clero, che non esita a pronunziare il giuramento antimodernista pur continuando a conservare le sue opinioni. (Ricordare gli ambienti torinesi dei giovani ecclesiastici, anche domenicani, prima della guerra, e le loro deviazioni che andavano fino ad accogliere benevolmente le tendenze modernizzanti dell’islamismo e del buddismo e a concepire la religione come un sincretismo mondiale di tutte le religioni superiori: dio è come il sole, di cui le religioni sono i raggi e ogni raggio guida all’unico sole ecc.),
Da un articolo di padre Rosa (Risposta ad «Una polemica senza onestà e senza legge», nella «Civiltà Cattolica» del 21 luglio 1928) sono tolte queste indicazioni: Monsignor Benigni continua (nel 1928) ad avere una notevole organizzazione: una collezione intitolata Vérités è pubblicata a Parigi e vi appaiono le firme Récalde, Luc Verus, Simon: Luc Verus è lo pseudonimo collettivo degli «integrali». Il Rosa cita l’opuscolo Les découvertes du jésuite Rosa, successeur de Von Gerlach, Parigi, Linotypie G. Dosne, Rue Turgot 20, 1928, che attribuisce al Benigni almeno per il materiale. I gesuiti sono accusati di essere «amici dei massoni e dei giudei» (fa ricordare la «dottrina» di Ludendorff sull’«internazionale massonico‑giudeo‑gesuitica»), sono chiamati «demagoghi e rivoluzionari» ecc. A Roma il Benigni si serve dell’agenzia Urbs o Romana e firma le sue pubblicazioni col nome di suo nipote Mataloni. Il bollettino romano del Benigni si intitolava «Veritas» (esce ancora o fino a quando è uscito?) Il Benigni (nel 1928 o prima?) ha pubblicato un opuscolo Di fronte alla calunnia, di poche pagine, con documenti che concernono il Sodalizio Piano, opuscolo che è stato riprodotto in parte e difeso da due periodici cattolici: «Fede e Ragione» (di Firenze) e la «Liguria del Popolo» di Genova). Il Benigni diresse il periodico «Miscellanea di storia ecclesiastica».
L’opuscolo Una polemica senza onestà e senza legge contro il p. Rosa è del prof. E. Buonaiuti. Il Rosa parla del libro di Buonaiuti: Le Modernisme catholique (pubblicato collezione diretta da P. L. Couchaud, edito dal Rieder) e osserva che l’autore finalmente ammette una serie di fatti che avrebbe sempre negato durante la polemica modernista (per es. che il Buonaiuti fu l’autore della campagna modernistica del «Giornale d’Italia», ciò che veramente il Buonaiuti nel suo libro non dice esplicitamente, ma che si può dedurre come verosimile, data la tortuosità di questi scrittori). Il Benigni organizzò il servizio stampa contro i modernisti al tempo dell’Enciclica Pascendi. Nelle sue «Ricerche religiose» (luglio 1928, p. 335) il Buonaiuti racconta un episodio caratteristico (riportato dal p. Rosa con espressioni di biasimo ecc.). Nel 1909 il modernista prof. Antonino De Stefano (attualmente prete spretato e insegnante di storia all’Università) doveva pubblicare a Ginevra una «Revue moderniste internationale»: il Buonaiuti scrisse una lettera. A poche settimane di distanza è chiamato al Sant’Uffizio. L’assessore del tempo, il domenicano Pasqualigo, gli contestò parola per parola la lettera al Da Stefano. La lettera era stata trafugata a Ginevra; un emissario romano si era «traforato» in casa De Stefano ecc. (Naturalmente per il Buonaiuti, Benigni è stato uno strumento e un complice dei gesuiti, ma pare che nel 1904 il Buonaiuti abbia collaborato nella «Miscellanea» del Benigni).
Su questo argomento, Cattolici integrali - gesuiti ‑ modernisti che rappresentano le tre tendenze «organiche» del cattolicismo, cioè sono le forze che si contendono l’egemonia nella Chiesa romana, occorre raccogliere tutto il materiale e costruire una bibliografia. (La collezione della «Civiltà Cattolica», delle «Ricerche religiose» del Buonaiuti, «Miscellanea» del Benigni, le collezioni di opuscoli polemici delle tre correnti ecc.).
Da quanto si rileva dalla «Civiltà Cattolica» pare che «Fede e Ragione» sia oggi la rivista più importante dei cattolici integrali. Vedere quali ne sono i principali collaboratori e in quali punti si pone in contrasto coi gesuiti: se in punti riguardanti la fede, la morale, la politica ecc. Gli «integrali» sono forti nel complesso di qualche ordine religioso rivale dei gesuiti (domenicani, francescani): è da ricordare che neanche i gesuiti sono perfettamente omogenei: il cardinale Billot, integrale intransigente fino ad abbandonare la porpora, era gesuita, e gesuiti furono alcuni modernisti di grido come il Tyrrell.
L’articolo: L’equilibrio della verità tra gli estremi dell’errore, nella «Civiltà Cattolica» del 3 novembre 1928, prende lo spunto dalla pubblicazione di Nicolas Fontaine: Saint‑Siège, «Action Française», et «Catholiques intégraux», Parigi, Gamber, 1928, di cui, in nota, si dà questo giudizio: «L’autore è dominato da pregiudizi politici e liberali, massime quando vede la politica nella condanna dell’Action Française; ma i fatti e i documenti, da lui allegati, sul famoso “Sodalizio” non furono smentiti». Ora il Fontaine non ha pubblicato nulla di completamente inedito (i documenti del Fontaine sugli «integrali» erano stati pubblicati nell’aprile 1924 dal «Mouvement»); perché dunque i gesuiti non se ne sono serviti prima? La quistione è importante e pare possa essere risolta in questi termini: l’azione pontificia contro l’Action Française è l’aspetto più appariscente e risolutivo di un’azione più vasta per liquidare una serie di conseguenze della politica di Pio X (in Francia, ma indirettamente anche negli altri paesi), cioè Pio XI vuole limitare l’importanza dei cattolici integrali, apertamente reazionari e che rendono quasi impossibile in Francia l’organizzazione di una forte Azione Cattolica e di un partito democratico‑popolare che possa far la concorrenza ai radicali, senza però attaccarli di fronte. La lotta contro il modernismo aveva squilibrato troppo a destra il cattolicismo; occorre pertanto nuovamente «incentrarlo» nei gesuiti, cioè ridargli una forma politica duttile, senza irrigidimenti dottrinari, con una grande libertà di manovra ecc.; Pio XI è veramente il papa dei gesuiti.
Ma lottare contro i cattolici integrali su un fronte organico è molto più difficile che lottare contro i modernisti. La lotta contro l’Action Française offre un terreno ottimo; gli integrali sono combattuti non come tali, ma in quanto sostenitori di Maurras, cioè la lotta è in ordine sparso, contro singole persone che non obbediscono al papa, che ne intralciano la difesa della fede e della morale contro un ateo e un pagano confesso, mentre l’insieme della tendenza è ufficialmente ignorato. Ecco l’importanza capitale del libro del Fontaine, che mostra il nesso organico tra Maurras e l’«integrismo» e aiuta energicamente l’azione del papa e dei gesuiti (è da notare che il Fontaine a più riprese insiste presso i «laicisti» francesi sul fatto che gli integrali e non i gesuiti sono «antidemocratici», che i gesuiti, in realtà, aiutano la democrazia ecc.; chi è il Fontaine? è uno specialista di studi sulla politica religiosa? non potrebbe essere ispirato dagli stessi gesuiti?)
Questo articolo della «Civiltà Cattolica», scritto certo dal p. Rosa, è molto cauto nell’uso dei documenti ristampati dal Fontaine, evita di analizzare quelli che non solo screditano gli integrali, ma gettano un’ombra di comicità e di discredito su tutta la Chiesa (gli integrali avevano organizzato una vera società segreta con cifrari, in cui il papa è chiamato «la baronessa Michelina» e altre personalità con nomi altrettanto romanzeschi, ciò che mostra la mentalità del Benigni verso i suoi «gerarchi»).
Sulla quistione «di merito» della politica di Pio XI le conclusioni non sono facili, come mostra lo stesso corso di questa politica, corso incerto, timido, titubante per le immense difficoltà contro cui deve cozzare continuamente. Si è detto più volte che la Chiesa cattolica ha virtù di adattamento e di sviluppo inesauribili. Ciò non è molto esatto. Nella vita della Chiesa possono essere fissati alcuni punti decisivi: il primo è quello che si identifica con lo scisma tra Oriente e Occidente, di carattere territoriale, tra due civiltà storiche in contrasto, con scarsi elementi ideologici e culturali, che ha inizio con l’avvento dell’Impero di Carlo Magno, cioè con un rinnovato tentativo di egemonia politica culturale dell’Occidente sull’Oriente; lo scisma avviene in un periodo in cui le forze ecclesiastiche sono scarsamente organizzate e si approfondisce sempre più, automaticamente, per la forza stessa delle cose, impossibili a controllare come avviene di due persone che per decenni non hanno contatti e si allontanano una dall’altra fino a parlare due lingue diverse. Il secondo è quello della Riforma, che avviene in ben diverse condizioni e che se ha come risultato una separazione territoriale, ha specialmente un carattere culturale e determina la Controriforma, e le decisioni del Concilio di Trento che limitano enormemente le possibilità di adattamento della Chiesa Cattolica. Il terzo è quello della Rivoluzione francese (Riforma liberale‑democratica) che costringe ancor più la Chiesa a irrigidirsi e mummificarsi in un organismo assolutistico e formalistico di cui il papa è il capo nominale, con poteri teoricamente «autocratici», in verità molto scarsi perché tutto il sistema si regge solo per il suo irrigidimento da paralitico. Tutta la società in cui la Chiesa si muove e può evolvere, ha la tendenza a irrigidirsi, lasciando alla Chiesa scarse possibilità di adattamento, già scarse per la natura attuale della Chiesa stessa. L’irrompere di forme nuove di nazionalismo, che poi sono il termine finale del processo storico iniziatosi con Carlo Magno, cioè col primo rinascimento, rende non solo impossibile l’adattamento, ma difficile l’esistenza, come si vede nella Germania hitleriana. D’altronde il papa non può «scomunicare» la Germania hitleriana, deve talvolta persino appoggiarsi ad essa, e ciò rende impossibile ogni politica religiosa rettilinea, positiva, di un qualche vigore. Di fronte a fenomeni come l’hitlerismo, anche larghe concessioni al modernismo non avrebbero nessun significato ormai, ma solo aumenterebbero la confusione e l’imbroglio. Né è detto che in Francia le cose siano più allegre, perché proprio in Francia è stata creata la teoria di contrapporre la «religione della patria» a quella «romana» e si può supporre un incremento di nazionalismo patriottico, non di cosmopolitismo romano, Dall’articolo della «Civiltà Cattolica» del 3 novembre 1928 sono tratti questi spunti. Si accenna che anche in Italia Maurras ha trovato difensori tra i cattolici: si parla di «imitatori o fautori, palesi od occulti, ma del pari aberranti dalla pienezza della fede e della morale cattolica, o nella teoria o nella pratica, pure gridando e anche illudendosi di volerle difendere integralmente e meglio di qualsiasi altro». L’Action Française «avventò contro chi scrive queste righe (il p. Rosa) un cumulo di vilipendii e di calunnie incredibili (sic), fino a quelle insinuate ripetutamente di assassinii ed esecuzioni spietate di confratelli!» (è da vedere quando e come queste accuse furono fatte al p. Rosa; tra i gesuiti c’era un’ala integralista e favorevole al Maurras, con uomini di primo piano come il cardinale Billot, che fu uno dei principali compilatori dell’enciclica Pascendi e che rinunziò alla carica di cardinale, cosa rarissima nella storia della Chiesa, che dimostra l’ostinata pervicacia del Billot e la volontà risoluta del papa di superare ogni ostacolo nella lotta contro Maurras).
La «Revue internationale des sociétés secrètes», diretta dall’abbate Boulin, è «integrale» e accanita antigesuita; il Boulin è collegato a Benigni‑Mataloni e si serve di pseudonimi (Roger Duguet). L’Action Française e gli integrali si attaccano disperatamente a Pio X e pretendono di restare fedeli ai suoi insegnamenti (ciò che nello sviluppo della Chiesa sarebbe un bel precedente, perché ogni papa, morto, potrebbe offrire il terreno per organizzare una setta che si attacca a un suo particolare atteggiamento; gli «integrali» vogliono rimettere in onore il Sillabo di Pio IX: nella proposta dell’Action Française di avere un ecclesiastico per la cattedra del Sillabo nelle sue scuole, era contenuta un’abile provocazione, ma Pio XI non solo non vuole ridare attualità al Sillabo, ma cerca perfino di attenuare ed edulcorare l’enciclica Pascendi).
L’articolo della «Civiltà Cattolica» è veramente importante e occorrerà rivederlo per il caso di un approfondimento della quistione. Bisognerà vedere tutte le sfumature dei «distinguo» a proposito della massoneria, dell’antisemitismo, del nazionalismo, della democrazia ecc. Anche per i modernisti si distingue tra illusi, ecc., e si prende posizione contro l’antimodernismo del Benigni ecc.: «Tanto più che era da temere e non mancammo di farlo notare fino da quegli anni a chi di dovere, che siffatti metodi avrebbero fatto il gioco dei modernisti veri, preparando in futuro gravi danni alla Chiesa. Il che si vide poi, ed anche al presente si vede, nello spirito cattivo di reazione, non del vecchio modernismo solamente e del liberalismo, ma del nuovo altresì e dell’integralismo stesso. Questo mostrava allora di volersi opporre ad ogni forma o parvenza di modernismo, anzi presumeva essere, come suol dirsi, più papale del papa, ed invece ora con grave scandalo o gli resiste ipocritamente o apertamente lo combatte, come avviene tra i fautori rumorosi dell’Action Française in Francia e i silenziosi loro complici in Italia».
Gli integrali chiamano i gesuiti «modernizzanti» e «modernizzantismo» la loro tendenza: hanno diviso i cattolici in integrali e non integrali cioè «papali» ed «episcopali» (pare che l’enciclica di Benedetto XV Ad beatissimi abbia notato, biasimandola, questa tendenza a introdurre tali distinzioni tra i cattolici, che lederebbero la carità e l’unità dei fedeli).
La «Sapinière» (da S. P. iniziali del «Sodalizio Piano») era la società segreta che si nascondeva dietro il velo del «Sodalizio Piano», ed organizzò la lotta contro i gesuiti modernizzanti, «in tutto contrariamente alla prima idea ed al programma officiale proposto al Santo Pontefice Pio X, indi approvato dal Segretario della Concistoriale, non certamente perché servisse allo sfogo di passioni private, alla denuncia e diffamazione di integerrimi ed anche eminenti personaggi, di Vescovi e d’interi Ordini religiosi, nominatamente del nostro, che mai finora erasi veduto in balia a siffatte calunnie, neppure ai tempi della sua soppressione. Da ultimo poi, finita la guerra e molto più dopo lo scioglimento del “Sodalizio Piano” – decretato dalla Sacra Congregazione del Concilio, non certo a titolo di lode, ma di proibizione e di biasimo – fu promossa tutta a spese di un noto e ricchissimo finanziere Simon di Parigi e della sua larga consorteria, la pubblicazione e la prodiga diffusione gratuita di libelli i più ignominiosi e criticamente insipienti contro la Compagnia di Gesù, i suoi Santi, i suoi dottori e le sue opere e le sue costituzioni, pure solennemente approvate dalla Chiesa. È la nota collezione dei così detti “Récalde”, cresciuta già ad oltre una dozzina di libelli, alcuni di più volumi, in cui è troppo riconosciuta e non meno retribuita la parte dei complici romani. Essa viene ora rinforzata dalla pubblicazione sorella di foglietti diffamatori, i più farneticanti, sotto il titolo complessivo ed antifrastico di “Vérités”, emuli dei fogli gemelli dell’Agenzia Urbs ovvero Romana, i cui articoli ritornano poi talora, quasi a verbo, in altri fogli “periodici”».
Gli integrali sparsero «le peggiori calunnie» contro Benedetto XV, come si può vedere dall’articolo comparso alla morte di questo papa nella «Vieille France» (di Urbain Gohier) e nella «Ronda» (febbraio 1922), «anche questo (periodico) tutt’altro che cattolico e morale, ma onorato tuttavia dalla collaborazione di Umberto Benigni, il cui nome si trova registrato nella bella compagnia di quei giovani più o meno scapestrati». «Lo stesso spirito di diffamazione, continuato sotto il presente Pontificato, in mezzo alle file medesime dei cattolici, dei religiosi e del clero, non si può dire quanto abbia fatto di male nelle coscienze, quanto scandalo portatovi e quanta alienazione di animi, in Francia sopra tutto. Quivi infatti la passione politica induceva a credere più facilmente le calunnie, mandate spesso da Roma, dopo che i ricchi Simon e altri compari, di spirito gallicano e giornalistico (sic), ne spesarono gli autori e procurarono la diffusione gratuita dei loro libelli, massime degli antigesuitici sopra menzionati, nei seminari, nelle canoniche, nelle curie ecclesiastiche, ovunque fosse qualche probabilità o verosimiglianza che la calunnia potesse attecchire; ed anche fra laici, massime giovani, e degli stessi licei governativi, con una prodigalità senza esempio». Gli autori già sospetti si servono dell’anonimo o di pseudonimi. «È notorio, tra i giornalisti specialmente, quanto poco meriti qualsiasi titolo di onore un siffatto gruppo col suo principale ispiratore, il più astuto a nascondersi, ma il più colpevole e il più interessato nell’intrigo» (si riferisce al Benigni o a qualche altro pezzo grosso del Vaticano?)
Secondo il p. Rosa, tra l’Action Française e gli «integrali» non c’era inizialmente «accordo» ma esso si è venuto formando dopo il 1926; ma questa affermazione è certo fatta ad arte per escludere ogni movente politico (lotta contro gli ultrareazionari) dalla lotta contro l’Action Française e per diminuire le responsabilità di Pio X. Nell’ultima nota dell’articolo si dice: «Non si deve tuttavia confondere l’uno con l’altro partito, come taluno ha fatto, per es. Nicolas Fontaine nell’opera citata Saint‑Siège, “Action Française” et “Catholiques intégraux”. Questo autore, come notammo, è più che liberale, ma purtroppo (sic) informatissimo dei casi niente edificanti della menzionata società clandestina, detta della “Sapinière” e dei suoi fautori francesi ed italiani, ed in ciò è ridicolo rinfacciare il suo liberalismo: occorre smentire i fatti su cui riparleremo a suo tempo». In realtà il Fontaine mostra esaurientemente il nesso tra integrali e Action Française, anche se è possibile dire che si tratta di due partiti distinti, di cui uno tende a servirsi dell’altro, e mostra come tale nesso risalga a Pio X. È curioso quel «purtroppo informatissimo», perché il Fontaine si è servito di materiale di dominio pubblico, come è «curioso» che il p. Rosa, nella «Civiltà Cattolica» non abbia più «riparlato» della «Sapinière» (fino alla morte di Monsignor Benigni, che non è stato ricordato; ed è difficile pensare che ne parli ancora, a meno che al Benigni non succeda qualche altra forte personalità nella direzione degli integrali): questo silenzio ha il suo significato. L’articolo conclude: «Ma la verità non ha da temere: e per parte nostra, noi siamo ben risoluti a difenderla senza paura né trepidazione od esitanza, anche contro i nemici interni, siano pure ecclesiastici facoltosi e potenti, che hanno fuorviato i laici per trarli ai loro disegni e interessi».
Ricorda un viaggio del Benigni in America (di cui parla la «Civiltà Cattolica», 1927, iv, p. 399) per la distribuzione di libelli antigesuiti: a Roma ci sarebbe un deposito di più decine di migliaia di copie di questi libelli.
L’Action Française aveva a Roma un suo redattore, Havard de la Montagne, che dirigeva un settimanale in lingua francese «Rome» destinato specialmente ai cattolici francesi, religiosi o laici, residenti o di passaggio a Roma: era il portavoce degli integrali e dei maurrassiani, il centro del loro raccoglimento e del servizio di informazione dell’Action Française presso il Vaticano, non solo per le quistioni religiose, ma specialmente per quelle politiche francesi e internazionali di carattere riservato. Non bisogna dimenticare che il Vaticano ha un servizio d’informazioni talvolta e per certi argomenti più preciso, più largo e più abbondante di qualsiasi altro governo. Poter servirsi di questa fonte era per l’Action Française una ragione non delle minori di certi successi giornalistici e di molte campagne personali e scandalistiche. Pare che dopo la rottura del 1926, «Rome» sia deperito e poi morto.
Il caso dell’abate Turmel di Rennes. Nella raccolta di scritti su L’Enciclica Pascendi e il modernismo il p. Rosa (il libro è del 1908‑1909) dedica alcune pagine «gustosissime» (non per il garbo e le virtù stilistiche dell’autore, che è un pedestre scribacchiatore, molto più pedestre, incondito e rozzo del suo antagonista Buonaiuti che pure non scherza) al caso «straordinario» dell’abate Turmel, modernista, che scriveva libri modernisti e persino di carattere tutt’affatto ateistico sotto varii pseudonimi e poi li confutava col suo vero nome. Dal 1908 al 1929 il Turmel ha continuato nel suo gioco di pseudonimi finché, per un caso, l’autorità ecclesiastica ebbe le prove palmari di questa duplicità; ma queste prove non furono subito esibite per liquidare l’abate: fu prima dato incarico al prof. L. Saltet, dell’Istituto cattolico di Tolosa, di fare un’ampia dimostrazione filologico‑critico-teologica (nel «Bulletin de Littérature Ecclésiastique» di Tolosa) della paternità turmeliana di tutta una serie di scritti pubblicati con ben 14 pseudonimi, e poi il Turmel fu espulso dalla Chiesa. (Su questo argomento vedi altra nota, più oltre). (La quistione dell’anonimato e degli pseudonimi cui ricorrevano i modernisti per sfuggire alle misure immediate di repressione è trattata dal Buonaiuti nel suo libro del 1927 sul modernismo Cattolico con qualche sofisma e con una certa imbarazzata reticenza. È certo che questa tattica da «politicante» nocque molto specialmente al Buonaiuti, che dagli «idealisti» della «Voce» fu presentato come una personalità quasi spregevole. La figura del Buonaiuti non perde, nonostante tutto, una certa sua aura di grandezza morale e di severità di carattere, se si pensa che egli è il solo che da più di 30 anni si è mantenuto nella sua posizione contro la Curia e i gesuiti, abbandonato da sostenitori e da amici, che o sono rientrati nell’ovile o sono passati decisamente nel campo laico. Né la sua attività è senza conseguenze per la Chiesa cattolica, se si tiene conto della diffusione dei suoi libri e del fatto che la Chiesa ripetute volte gli ha offerto dei compromessi).
Cfr l’articolo «La lunga crisi dell’Action Française» nella «Civiltà Cattolica» del 7 settembre 1929. Si loda il libro La trop longue crise de l’Action Française di Mons. Sagot du Vauroux, évêque d’Agen, Parigi, ed. Bloud, 1929, opera che «riuscirà utilissima anche agli stranieri, i quali non riescono a comprendere le origini e meno ancora la persistenza, congiunta a tanta ostinazione, degli aderenti cattolici che li acceca fino a farli vivere e morire senza sacramenti, piuttosto che rinunciare alle odiose esorbitanze di un loro partito e dei suoi dirigenti increduli». La «Civiltà Cattolica» cerca giustificarsi del fatto che non si occupa più spesso della polemica dell’Action Française e tra l’altro dice: «Oltre a ciò la prolungata crisi non tocca l’Italia se non per riverbero, ossia per una lontana (!?) concomitanza ed analogia, che essa potrebbe (!) avere con le tendenze generali paganeggianti dell’età moderna». (Questo maltusianismo polemico costituisce appunto la debolezza principale della posizione gesuitica contro l’Action Française ed è la causa maggiore del furore fanatico di Maurras e dei suoi seguaci: questi sono persuasi, non a torto, che il Vaticano fa su di loro una esperienza «in corpore vili», che essi hanno la funzione del ragazzo che, una volta, accompagnava il principe ereditario inglese e si pigliava le nerbate per conto del regale padrone; da ciò a far persuasi i seguaci di Maurras che l’assalto subìto è meramente politico, perché non universale che a parole, ci vuol poco. In verità il papa si è ben guardato, e così la «Civiltà Cattolica», di identificare e «punire» con le stesse sanzioni, negli altri paesi, gli elementi individuali o di gruppo che hanno le stesse tendenze di Maurras e non le nascondono).
Altre indicazioni di «cattolici integrali»: il Bloc antirévolutionnaire di Felix Lacointe, «degno amico del citato Boulin e dei suoi soci» (il Boulin dirige la «Revue Internationale des Sociétés secrètes»). Il Lacointe avrebbe pubblicato che il cardinale Rampolla era iscritto alla Massoneria o qualcosa di simile (al Rampolla si rimprovera la politica del ralliement fatta da Leone XIII; ricordare a proposito del Rampolla che il veto al Conclave contro la sua elezione al ponteficato fu fatto dall’Austria, ma per domanda di Zanardelli; sul Rampolla e la sua posizione verso lo Stato italiano offre elementi nuovi il Salata nel I° volume, e solo pubblicato, dei suoi Documenti diplomatici sulla questione romana).
Un elemento ideologico molto significativo del lavoro che i gesuiti esplicano in Francia per costituire una larga base popolare al movimento cattolico‑democratico è questo giudizio storico‑politico: Chi è responsabile dell’«apostasia» del popolo francese? Solo gli intellettuali democratico-rivoluzionari che si richiamavano al Rousseau? No. I più responsabili sono gli aristocratici e la grande borghesia che hanno civettato con Voltaire: «… le rivendicazioni tradizionali (dei monarchici) del ritorno all’antico sono pure rispettabili, quantunque inattuabili, nelle condizioni presenti. E sono inattuabili anzitutto per colpa di tanta parte dell’aristocrazia e borghesia di Francia, poiché dalla corruzione e dall’apostasia di questa classe dirigente fino al secolo XVIII originò la corruzione e l’apostasia della massa popolare in Francia, avverandosi anche allora che regis ad exemplum totus componitur orbis. Il Voltaire era l’idolo di quella parte dell’aristocrazia corrotta e corrompitrice del suo popolo, alla cui fede e costumatezza procurando scandalose seduzioni, essa scavava a se medesima la fossa. E sebbene poi al sorgere del Rousseau con la sua democrazia sovversiva in opposizione all’aristocrazia volterriana, si fecero opposizione teorica le due correnti dell’apostasia – come tra i due tristi corifei – che parevano muovere da contrari errori, confluirono in una stessa pratica ed esiziale conclusione: nell’ingrossare cioè il torrente rivoluzionario ecc. ecc.».
Così oggi: Maurras e C. sono avversari della democrazia alla Rousseau e delle «esagerazioni democratiche» («esagerazioni», si badi bene, solo «esagerazioni») del Sillon, ma sono discepoli e ammiratori di Voltaire (Jacques Bainville ha curato un’edizione di lusso degli scritti di Voltaire e i gesuiti non lo dimenticano). Su questo nesso storico-critico riguardante le origini dell’«apostasia» popolare in Francia la «Civiltà Cattolica» cita un articolo della «Croix» del 15‑16 agosto 1929: L’apostasie navrante de la masse populaire en France che si riferisce al libro: Pour faire l’avenir del P. Croizier dell’«Action populaire» edito nel 1929 dalle edizioni Spes di Parigi.
Tra i seguaci di Maurras e C. oltre ai conservatori e monarchici la «Civiltà Cattolica» (sulle tracce del vescovo di Agen) rileva altri quattro gruppi: 1) gli snobisti (attratti dalle doti letterarie, specialmente del Maurras); 2) gli adoratori della violenza e della maniera forte, «con le esagerazioni dell’autorità, spinta verso il dispotismo, sotto colore di resistenza allo spirito di insubordinazione o sovvertimento sociale, dell’età contemporanea»; 3) i «falsi mistici», «creduli a vaticinii di straordinarie ristaurazioni, di conversioni meravigliose o di provvidenziali missioni» assegnate proprio a Maurras e C. Questi, fin dal tempo di Pio X, «imperterriti», scusano l’incredulità di Maurras, imputandola «al difetto della grazia», «quasi che non fosse data a tutti la grazia sufficiente per la conversione, né fosse imputabile a chi vi resiste il cadere o il persistere nella colpa» (sarebbero questi, pertanto, semieretici, perché, a giustificare Maurras, ripetono le posizioni giansenistiche o calviniste. A questo proposito occorre spiegare la pervicacia di Maurras nel non volersi «convertire» cosa che non può essere solo dovuta alla «integrità e lealtà etica e intellettuale» e appunto perciò fa trepidare i gesuiti: essi comprendono che se il gruppo Maurras prendesse il potere statale, la situazione di fatto del cattolicismo in Francia diverrebbe più difficile dell’attuale. Fa meraviglia perciò l’atteggiamento del Vaticano verso lo hitlerismo, nonostante che Rosenberg avesse scritto il suo Mito prima della presa del potere: è vero che Rosenberg intellettualmente non è della statura di Maurras ma tutto il movimento hitleriano è intellettualmente basso e volgare ed era prevedibile ciò che poi è successo verso il cattolicismo e il cristianesimo).
Il quarto gruppo (il più pericoloso per la «Civiltà Cattolica») sarebbe composto dagli «integrali» (la «Civiltà Cattolica» osserva che il vescovo di Agen li chiama anche «integristi», «ma è notorio che essi non sono da confondere col partito politico, chiamato degli “integristi”, nella Spagna»). Questi «integrali», scrive la «Civiltà», «anche in Italia non mancarono di favorire i positivisti e increduli dell’Action Française solo perché violenti contro il liberalismo e altre forme di errori moderni senza avvertire che essi trascorrevano ad estremi opposti, del pari erronei e perniciosi ecc.». «Così abbiamo veduto, anche in Italia, qualche loro foglio accennare appena, come di volo, alla condanna dell’Action Française, in cambio di pubblicarne i documenti e illustrarne il senso e la ragione, indugiandosi invece sulla ristampa ed il commento della condanna del Sillon; quasi che i due moti fra loro opposti, ma del pari opposti alla dottrina cattolica, non potessero essere e non fossero egualmente riprovevoli. Cosa questa degna di nota, perché mentre quasi in ogni numero di siffatte pubblicazioni non manca qualche accusa o escandescenza contro autori cattolici, sembra che venga meno o lo spazio o la lena per una franca ed energica trattazione di condanna contro quelli dell’Action Française; anzi si ripetono spesso le calunnie, come quella di una pretesa piega a sinistra, ossia verso il liberalismo, popolarismo, falsa democrazia, contro chi non seguiva il loro modi procedere».
Nella corrente dei «cattolici integrali» bisogna mettere anche Henri Massis e il gruppo dei «difensisti dell’Occidente»; ricordare le frecciate del padre Rosa contro il Massis nella risposta alla lettera aperta di Ugo Ojetti).
QUADERNO 21
PROBLEMI DELLA CULTURA NAZIONALE ITALIANA.
I. LETTERATURA POPOLARE
Q21 §1 Nesso di problemi. Polemiche sorte nel periodo di
formazione della nazione italiana e della lotta per l’unità
politica e territoriale e che hanno continuato e continuano ad
ossessionare almeno una parte degli intellettuali italiani.
Alcuni di tali problemi (come quello della lingua) molto
antichi. Risalgono ai primi tempi della formazione di una unità
culturale italiana. Nati per il confronto tra le condizioni
generali dell’Italia e quelle di altri paesi, specialmente della
Francia o per il riflesso di condizioni peculiari italiane come
il fatto che la penisola fu la sede dell’Impero Romano e divenne
la sede del maggiore centro della religione cristiana. L’insieme
di questi problemi è il riflesso della faticosa elaborazione di
una nazione italiana di tipo moderno, contrastata da condizioni
di equilibrio di forze interne e internazionali.
Non è mai esistita una coscienza, tra le classi intellettuali e dirigenti, che esista un nesso tra questi problemi, nesso di coordinazione e di subordinazione. Nessuno ha mai presentato questi problemi come un insieme collegato e coerente, ma ognuno di essi si è ripresentato periodicamente a seconda di interessi polemici immediati, non sempre chiaramente espressi, senza volontà di approfondimento; la trattazione ne è stata perciò fatta in forma astrattamente culturale, intellettualistica, senza prospettiva storica esatta e pertanto senza che se ne prospettasse una soluzione politico‑sociale concreta e coerente. Quando si dice che non è mai esistita una coscienza dell’unità organica di tali problemi occorre intendersi: forse è vero che non si è avuto il coraggio di impostare esaurientemente la quistione, perché da una tale impostazione rigorosamente critica e consequenziaria si temeva derivassero immediatamente pericoli vitali per la vita nazionale unitaria; questa timidezza di molti intellettuali italiani deve essere a sua volta spiegata, ed è caratteristica della nostra vita nazionale. D’altronde pare inconfutabile che nessuno di tali problemi può essere risolto isolatamente (in quanto essi sono ancora attuali e vitali). Pertanto una trattazione critica e spassionata di tutte queste quistioni che ancora ossessionano gli intellettuali e anzi vengono oggi presentate come in via di organica soluzione (unità della lingua, rapporto tra arte e vita, quistione del romanzo e del romanzo popolare, quistione di una riforma intellettuale e morale cioè di una rivoluzione popolare che abbia la stessa funzione della Riforma protestante nei paesi germanici e della Rivoluzione francese, quistione della «popolarità» del Risorgimento che sarebbe stata raggiunta con la guerra del 1915‑18 e coi rivolgimenti successivi, onde l’impiego inflazionistico dei termini di rivoluzione e rivoluzionario) può dare la traccia più utile per ricostruire i caratteri fondamentali della vita culturale italiana, e delle esigenze che da essi sono indicate e proposte per la soluzione.
Ecco il «catalogo» delle più significative quistioni da esaminate ed analizzare: 1) «Perché la letteratura italiana non è popolare in Italia?» (per usare l’espressione di Ruggero Bonghi); 2) esiste un teatro italiano? polemica impostata da Ferdinando Martini e che va collegata con l’altra sulla maggiore o minore vitalità del teatro dialettale e di quello in lingua; 3) quistione della lingua nazionale, così come fu impostata da Alessandro Manzoni; 4) se sia esistito un romanticismo italiano; 5) è necessario provocare in Italia una riforma religiosa come quella protestante? cioè l’assenza di lotte religiose vaste e profonde determinata dall’essere stata in Italia la sede del papato quando fermentarono le innovazioni politiche che sono alla base degli Stati moderni fu origine di progresso o di regresso?; 6) l’Umanesimo e il Rinascimento sono stati progressivi o regressivi?; 7) impopolarità del Risorgimento ossia indifferenza popolare nel periodo delle lotte per l’indipendenza e l’unità nazionale; 8) apoliticismo del popolo italiano che viene espresso con le frasi di «ribellismo», di «sovversivismo», di «antistatalismo» primitivo ed elementare; 9) non esistenza di una letteratura popolare in senso stretto (romanzi d’appendice, d’avventure, scientifici, polizieschi ecc.) e «popolarità» persistente di questo tipo di romanzo tradotto da lingue straniere, specialmente dal francese; non esistenza di una letteratura per l’infanzia. In Italia il romanzo popolare di produzione nazionale è quello anticlericale oppure le biografie di briganti. Si ha però un primato italiano nel melodramma, che in un certo senso è il romanzo popolare musicato.
Una delle ragioni per cui tali problemi non sono stati trattati esplicitamente e criticamente è da trovarsi nel pregiudizio rettorico (d’origine letteraria) che la nazione italiana sia sempre esistita da Roma antica ad oggi e su alcuni altri idoli e borie intellettuali che se furono «utili» politicamente nel periodo della lotta nazionale, come motivo per entusiasmare e concentrare le forze, sono inette criticamente e, in ultima istanza, diventano un elemento di debolezza, perché non permettono di apprezzare giustamente lo sforzo compiuto dalle generazioni che realmente lottarono per costituire l’Italia moderna e perché inducono a una sorta di fatalismo e di aspettazione passiva di un avvenire che sarebbe predeterminato completamente dal passato. Altre volte questi problemi sono mal posti per l’influsso di concetti estetici di origine crociana, specialmente quelli concernenti il così detto «moralismo» nell’arte, il «contenuto» estrinseco all’arte, la storia della cultura da non confondersi con la storia dell’arte ecc. Non si riesce a intendere concretamente che l’arte è sempre legata a una determinata cultura o civiltà, e che lottando per riformare la cultura si giunge a modificare il «contenuto» dell’arte, si lavora a creare una nuova arte, non dall’esterno (pretendendo un’arte didascalica, a tesi, moralistica), ma dall’intimo, perché si modifica tutto l’uomo in quanto si modificano i suoi sentimenti, le sue concezioni e i rapporti di cui l’uomo è l’espressione necessaria.
Connessione del «futurismo» col fatto che alcune di tali quistioni sono state mal poste e non risolute, specialmente il futurismo nella forma più intelligente datagli dai gruppi fiorentini di «Lacerba» e della «Voce», col loro «romanticismo» o Sturm und Drang popolaresco. Ultima manifestazione «Strapaese». Ma sia il futurismo di Marinetti, sia quello di Papini, sia Strapaese hanno urtato, oltre il resto, in questo ostacolo: l’assenza di carattere e di fermezza dei loro inscenatori e la tendenza carnevalesca e pagliaccesca dei piccoli borghesi intellettuali, aridi e scettici.
Anche la letteratura regionale è stata essenzialmente folcloristica e pittoresca: il popolo «regionale» era visto «paternalisticamente», dall’esterno, con spirito disincantato, cosmopolitico, da turisti in cerca di sensazioni forti e originali per la loro crudezza. Agli scrittori italiani ha proprio nuociuto l’«apoliticismo» intimo, verniciato di rettorica nazionale verbosa. Da questo punto di vista sono stati più simpatici Enrico Corradini e il Pascoli, col loro nazionalismo confessato e militante, in quanto cercarono risolvere il dualismo letterario tradizionale tra popolo e nazione, sebbene siano caduti in altre forme di rettorica e di oratoria (Nel ms le rimanenti righe di questa pagina e le pagine 7, 8, 9 e 10 sono rimaste bianche.).
Q21 §2 Nel «Marzocco» del 13 settembre 1931, Aldo Sorani (che si è occupato spesso, in diverse riviste e giornali, della letteratura popolare) ha pubblicato un articolo: Romanzieri popolari contemporanei in cui commenta la serie di bozzetti sugli «Illustri Ignoti» pubblicati dallo Charensol nelle «Nouvelles Littéraires» (di cui è nota più avanti). «Si tratta di scrittori popolarissimi di romanzi d’avventure e d’appendice, sconosciuti o quasi al pubblico letterario, ma idoleggiati e seguiti ciecamente da quel più grosso pubblico di lettori che decreta le tirature mastodontiche e di letteratura non s’intende affatto, ma vuol essere interessato e appassionato da intrecci sensazionali di vicende criminali od amorose. Per il popolo sono essi i veri scrittori e il popolo sente per loro un’ammirazione ed una gratitudine che questi romanzieri tengon deste somministrando ad editori e lettori una mole di lavoro così continua ed imponente da parere incredibile e insostenibile da forze, non dico intellettuali, ma fisiche». Il Sorani osserva che questi scrittori «si sono asserviti ad un compito stremante e adempiono ad un servizio pubblico reale se infinite schiere di lettori e di lettrici non possono farne a meno e gli editori conseguono dalla loro inesauribile attività lauti guadagni». Il Sorani impiega l’espressione di «servizio pubblico reale» ma ne dà una definizione meschina, e che non corrisponde a quella di cui si parla in queste . Il Sorani nota che questi scrittori, come appare dagli articoli dello Charensol, «hanno reso più severi i loro costumi e più morigerata in genere la loro vita, dal tempo ormai remoto in cui Ponson du Terrail o Xavier de Montépin esigevano una notorietà mondana e facevano di tutto per accaparrarsela …, pretendendo che, alla fine, essi non si distinguevano dai loro più accademici confratelli che per una diversità di stile. Essi scrivevano come si parla, mentre gli altri scrivevano come non si parla!» (Tuttavia anche gli «illustri ignoti» fanno parte, in Francia, delle associazioni di letterati, tal quale il Montépin. Ricordare anche l’astio di Balzac contro Sue per i successi mondani e finanziari di questo).
Scrive ancora il Sorani: «Un lato non trascurabile della persistenza di questa letteratura popolare … è offerto dalla passione del pubblico. Specialmente il grosso pubblico francese, quel pubblico che taluno crede il più smaliziato, critico e blasé del mondo, è rimasto fedele al romanzo d’avventure e d’appendice. Il giornalismo francese d’informazione e di grande tiratura è quello che non ha ancora saputo o potuto rinunziare al romanzo d’appendice. Proletariato e borghesia sono ancora in grandi masse così ingenui (!) da aver bisogno degli interminabili racconti emozionanti e sentimentali, raccapriccianti o larmoyants per nutrimento quotidiano della loro curiosità e della loro sentimentalità, hanno ancora bisogno di parteggiare tra gli eroi della delinquenza e quelli della giustizia e della vendetta».
«A differenza del pubblico francese, quello inglese o americano s’è riversato sul romanzo di avventure storiche (e i francesi no?!) o su quello di avventure poliziesche ecc. (luoghi comuni sui caratteri nazionali)».
«Quanto all’Italia credo che ci si potrebbe domandare perché la letteratura popolare non sia popolare in Italia. (Non è detto con esattezza; non ci sono in Italia scrittori, ma i lettori sono una caterva). Dopo il Mastriani e l’Invernizio mi pare che siano venuti a mancare tra noi i romanzieri capaci di conquistare la folla facendo inorridire e lacrimare un pubblico di lettori ingenui, fedeli e insaziabili. Perché questo genere di romanzieri non ha continuato ad allignare tra noi? La nostra letteratura è stata anche nei suoi bassifondi troppo accademica o letterata? I nostri editori non hanno saputo coltivare una pianta ritenuta troppo spregevole? I nostri scrittori non hanno fantasia capace di animare le appendici e le dispense? O noi, anche in questo campo, ci siamo contentati e ci contentiamo di importare quanto producono gli altri mercati? Certo non abbondiamo come la Francia di “illustri sconosciuti” e una qualche ragione per questa deficienza ci deve essere e varrebbe forse la pena di ricercarla».
Q21 §3 Gli «umili». Questa espressione – «gli umili» – è caratteristica per comprendere l’atteggiamento tradizionale degli intellettuali italiani verso il popolo e quindi il significato della «letteratura per gli umili». Non si tratta del rapporto contenuto nell’espressione dostoievschiana di «umiliati e offesi». In Dostojevschij c’è potente il sentimento nazionale‑popolare, cioè la coscienza di una missione degli intellettuali verso il popolo, che magari è «oggettivamente» costituito di «umili» ma deve essere liberato da questa «umiltà», trasformato, rigenerato. Nell’intellettuale italiano l’espressione di «umili» indica un rapporto di protezione paterna e padreternale, il sentimento «sufficiente» di una propria indiscussa superiorità, il rapporto come tra due razze, una ritenuta superiore e l’altra inferiore, il rapporto come tra adulto e bambino nella vecchia pedagogia o peggio ancora un rapporto da «società protettrice degli animali», o da esercito della salute anglosassone verso i cannibali della Papuasia.
Q21 §4 Il pubblico e la letteratura italiana. In un articolo pubblicato dal «Lavoro» e riportato in estratti dalla «Fiera Letteraria» del 28 ottobre 1928, Leo Ferrero scrive: «Per una ragione o per l’altra si può dire che gli scrittori italiani non abbiano più pubblico. … Un pubblico infatti vuol dire un insieme di persone, non soltanto che compra dei libri, ma soprattutto che ammira degli uomini. Una letteratura non può fiorire che in un clima di ammirazione e l’ammirazione non è, come si potrebbe credere, il compenso, ma lo stimolo del lavoro. … Il pubblico che ammira, che ammira davvero, di cuore, con gioia, il pubblico che ha la felicità di ammirare (niente è più deleterio dell’ammirazione convenzionale) è il più grande animatore di una letteratura. Da molti segni si capisce ahimè che il pubblico sta abbandonando gli scrittori italiani».
L’«ammirazione» del Ferrero non è altro che una metafora e un «nome collettivo» per indicare il complesso sistema di rapporti, la forma di contatto tra una nazione e i suoi scrittori. Oggi questo contatto manca, cioè la letteratura non è nazionale perché non è popolare. Paradosso del tempo attuale. Inoltre non c’è una gerarchia nel mondo letterario, cioè manca una personalità eminente che eserciti una egemonia culturale. Quistione del perché e del come una letteratura sia popolare. La «bellezza» non basta: ci vuole un determinato contenuto intellettuale e morale che sia l’espressione elaborata e compiuta delle aspirazioni più profonde di un determinato pubblico, cioè della nazione‑popolo in una certa fase del suo sviluppo storico. La letteratura deve essere nello stesso tempo elemento attuale di civiltà e opera d’arte, altrimenti alla letteratura d’arte viene preferita la letteratura d’appendice che, a modo suo, è un elemento attuale di cultura, di una cultura degradata quanto si vuole ma sentita vivamente.
Q21 §5 Concetto di «nazionale‑popolare». In una nota della «Critica Fascista» del 1° agosto 1930 si lamenta che due grandi quotidiani, uno di Roma e l’altro di Napoli, abbiano iniziato la pubblicazione in appendice di questi romanzi: Il conte di Montecristo e Giuseppe Balsamo di A. Dumas, e il Calvario di una madre di Paolo Fontenay. Scrive la «Critica»: «L’ottocento francese è stato senza dubbio un periodo aureo per il romanzo d’appendice, ma debbono avere un ben scarso concetto dei propri lettori quei giornali che ristampano romanzi di un secolo fa, come se il gusto, l’interesse, l’esperienza letteraria non fossero per niente mutate da allora ad ora. Non solo, ma … perché non tener conto che esiste, malgrado le opinioni contrarie, un romanzo moderno italiano? E pensare che questa gente è pronta a spargere lacrime d’inchiostro sulla infelice sorte delle patrie lettere». La «Critica» confonde diversi ordini di problemi: quello della non diffusione tra il popolo della così detta letteratura artistica e quello della non esistenza in Italia di una letteratura «popolare», per cui i giornali sono «costretti» a rifornirsi all’estero (certo nulla impedisce teoricamente che possa esistere una letteratura popolare artistica – l’esempio più evidente è la fortuna «popolare» dei grandi romanzieri russi – anche oggi; ma non esiste, di fatto, né una popolarità della letteratura artistica, né una produzione paesana di letteratura «popolare» perché manca una identità di concezione del mondo tra «scrittori» e «popolo», cioè i sentimenti popolari non sono vissuti come propri dagli scrittori, né gli scrittori hanno una funzione «educatrice nazionale», cioè non si sono posti e non si pongono il problema di elaborare i sentimenti popolari dopo averli rivissuti e fatti propri); la «Critica» non si pone neanche questi problemi e non sa trarre le conclusioni «realistiche» dal fatto che se i romanzi di cento anni fa piacciono, significa che il gusto e l’ideologia del popolo sono proprio quelli di cento anni fa. I giornali sono organismi politico‑finanziari e non si propongono di diffondere le belle lettere «nelle proprie colonne», se queste belle lettere fanno aumentare la resa. Il romanzo d’appendice è un mezzo per diffondersi tra le classi popolari (ricordare l’esempio del «Lavoro» di Genova sotto la direzione di Giovanni Ansaldo, che ristampò tutta la letteratura francese d’appendice, nello stesso tempo in cui cercava di dare ad altre parti del quotidiano il tono della più raffinata cultura), ciò che significa successo politico e successo finanziario. Perciò il giornale cerca quel romanzo, quel tipo di romanzo che piace «certamente» al popolo, che assicurerà una clientela «continuativa» e permanente. L’uomo del popolo compra un solo giornale, quando lo compra: la scelta del giornale non è neanche personale, ma spesso di gruppo famigliare: le donne pesano molto nella scelta e insistono per il «bel romanzo interessante» (ciò non significa che anche gli uomini non leggano il romanzo, ma certo le donne si interessano specialmente al romanzo e alla cronaca dei fatti diversi). Da ciò derivò sempre il fatto che i giornali puramente politici o d’opinione non hanno mai potuto avere una grande diffusione (eccetto periodi di intensa lotta politica): essi erano comprati dai giovani, uomini e donne, senza preoccupazioni famigliari troppo grandi e che si interessavano fortemente alla fortuna delle loro opinioni politiche e da un numero mediocre di famiglie fortemente compatte come idee. In generale i lettori di giornali non sono dell’opinione del giornale che acquistano, o ne sono scarsamente influenzati: perciò è da studiare, dal punto di vista della tecnica giornalistica, il caso del «Secolo» e del «Lavoro» che pubblicavano fino a tre romanzi d’appendice per conquistare una tiratura alta e permanente (non si pensa che per molti lettori il «romanzo d’appendice» è come la «letteratura» di classe per le persone colte: conoscere il «romanzo» che pubblicava la «Stampa» era una specie di «dovere mondano» di portineria, di cortile e di ballatoio in comune; ogni puntata dava luogo a «conversazioni» in cui brillava l’intuizione psicologica, la capacità logica d’intuizione dei «più distinti» ecc.; si può affermare che i lettori di romanzo d’appendice s’interessano e si appassionano ai loro autori con molta maggiore sincerità e più vivo interesse umano di quanto nei salotti così detti colti non s’interessassero ai romanzi di D’Annunzio o non s’interessino alle opere di Pirandello).
Ma il problema più interessante è questo: perché i giornali italiani del 1930, se vogliono diffondersi (o mantenersi) devono pubblicare i romanzi d’appendice di un secolo fa (o quelli moderni dello stesso tipo)? E perché non esiste in Italia una letteratura «nazionale» del genere, nonostante che essa debba essere redditizia? È da osservare il fatto che in molte lingue, «nazionale» e «popolare» sono sinonimi o quasi (così in russo, così in tedesco in cui «volkisch» ha un significato ancora più intimo, di razza, così nelle lingue slave in genere; in francese «nazionale» ha un significato in cui il termine «popolare» è già più elaborato politicamente, perché legato al concetto di «sovranità», sovranità nazionale e sovranità popolare hanno uguale valore o l’hanno avuto). In Italia il termine «nazionale» ha un significato molto ristretto ideologicamente e in ogni caso non coincide con «popolare», perché in Italia gli intellettuali sono lontani dal popolo, cioè dalla «nazione» e sono invece legati a una tradizione di casta, che non è mai stata rotta da un forte movimento politico popolare o nazionale dal basso: la tradizione è «libresca» e astratta e l’intellettuale tipico moderno si sente più legato ad Annibal Caro o Ippolito Pindemonte che a un contadino pugliese o siciliano. Il termine corrente «nazionale» è in Italia legato a questa tradizione intellettuale e libresca, quindi la facilità sciocca e in fondo pericolosa di chiamare «antinazionale» chiunque non abbia questa concezione archeologica e tarmata degli interessi del paese.
Sono da vedere gli articoli di Umberto Fracchia nell’«Italia Letteraria» del luglio 1930 e la Lettera a Umberto Fracchia sulla critica di Ugo Ojetti nel «Pègaso» dell’agosto 1930. I lamenti del Fracchia sono molto simili a quelli della «Critica Fascista». La letteratura «nazionale» così detta «artistica», non è popolare in Italia. Di chi la colpa? Del pubblico che non legge? Della critica che non sa presentare ed esaltare al pubblico i «valori» letterari? Dei giornali che invece di pubblicare in appendice «il romanzo moderno italiano» pubblicano il vecchio Conte di Montecristo? Ma perché il pubblico non legge in Italia mentre legge negli altri paesi? Ed è poi vero che in Italia non si legga? Non sarebbe più esatto porsi il problema: perché il pubblico italiano legge la letteratura straniera, popolare e non popolare, e non legge invece quella italiana? Lo stesso Fracchia non ha pubblicato degli ultimatum agli editori che pubblicano (e quindi devono vendere, relativamente) opere straniere, minacciando provvedimenti governativi? E un tentativo di intervento governativo non c’è stato, almeno in parte, per opera dell’on. Michele Bianchi, sottosegretario agli interni?
Cosa significa il fatto che il popolo italiano legge di preferenza gli scrittori stranieri? Significa che esso subisce l’egemonia intellettuale e morale degli intellettuali stranieri, che esso si sente legato più agli intellettuali stranieri che a quelli «paesani», cioè che non esiste nel paese un blocco nazionale intellettuale e morale, né gerarchico e tanto meno egualitario. Gli intellettuali non escono dal popolo, anche se accidentalmente qualcuno di essi è d’origine popolana, non si sentono legati ad esso (a parte la retorica), non ne conoscono e non ne sentono i bisogni, le aspirazioni, i sentimenti diffusi, ma, nei confronti del popolo, sono qualcosa di staccato, di campato in aria, una casta, cioè, e non un’articolazione, con funzioni organiche, del popolo stesso. La quistione deve essere estesa a tutta la cultura nazionale‑popolare e non ristretta alla sola letteratura narrativa: le stesse cose si devono dire del teatro, della letteratura scientifica in generale (scienze della natura, storia ecc.). Perché non sorgono in Italia degli scrittori come il Flammarion? perché non è nata una letteratura di divulgazione scientifica come in Francia e negli altri paesi? Questi libri stranieri, tradotti, sono letti e ricercati e conoscono spesso grandi successi. Tutto ciò significa che tutta la «classe colta», con la sua attività intellettuale, è staccata dal popolo‑nazione, non perché il popolo‑nazione non abbia dimostrato e non dimostri di interessarsi a questa attività in tutti i suoi gradi, dai più infimi (romanzacci d’appendice) ai più elevati, tanto vero che ricerca i libri stranieri in proposito, ma perché l’elemento intellettuale indigeno è più straniero degli stranieri di fronte al popolo‑nazione. La quistione non è nata oggi: essa si è posta fin dalla fondazione dello Stato italiano, e la sua esistenza anteriore è un documento per spiegare il ritardo della formazione politico‑nazionale unitaria della penisola. Il libro di Ruggero Bonghi sulla impopolarità della let
teratura italiana. Anche la quistione della lingua posta dal Manzoni riflette questo problema, il problema della unità intellettuale e morale della nazione e dello Stato, ricercato nell’unità della lingua. Ma l’unità della lingua è uno dei modi esterni e non esclusivamente necessario dell’unità nazionale: in ogni caso è un effetto e non una causa. Scritti di F. Martini sul teatro: sul teatro esiste e continua a svilupparsi tutta una letteratura.
In Italia è sempre mancata e continua a mancare una letteratura nazionale‑popolare, narrativa e d’altro genere. (Nella poesia sono mancati i tipi come Béranger e in genere il tipo dello chansonnier francese). Tuttavia sono esistiti scrittori, popolari individualmente e che hanno avuto grande fortuna: il Guerrazzi ha avuto fortuna e i suoi libri continuano ad essere pubblicati e diffusi: Carolina Invernizio è stata letta e forse continua ad esserlo, nonostante sia di un livello più basso dei Ponson e dei Montépin. F. Mastriani è stato letto ecc. (G. Papini ha scritto un articolo sulla Invernizio nel «Resto del Carlino», durante la guerra, verso il 1916: vedere se l’articolo è stato raccolto
in volume. Il Papini scrisse qualcosa d’interessante su questa onesta gallina della letteratura popolare, appunto notando come essa si facesse leggere dal popolino. Forse, nella bibliografia del Papini pubblicata nel saggio del Palmieri – o in altra – si potrà trovare la data di questo articolo e altre indicazioni).
In assenza di una sua letteratura «moderna», alcuni strati del popolo minuto soddisfano in vari modi le esigenze intellettuali e artistiche che pur esistono, sia pure in forma elementare ed incondita: diffusione del romanzo cavalleresco medioevale – Reali di Francia, Guerino detto il Meschino ecc. – specialmente nell’Italia meridionale e nelle montagne; I Maggi in Toscana (gli argomenti rappresentati dai Maggi sono tratti dai libri, novelle e specialmente da leggende divenute popolari, come la Pia dei Tolomei; esistono varie pubblicazioni sui Maggi e sul loro repertorio).
I laici hanno fallito al loro compito storico di educatori ed elaboratori della intellettualità e della coscienza morale del popolo‑nazione, non hanno saputo dare una soddisfazione alle esigenze intellettuali del popolo: proprio per non aver rappresentato una cultura laica, per non aver saputo elaborare un moderno «umanesimo» capace di diffondersi fino agli strati più rozzi e incolti, come era necessario dal punto di vista nazionale, per essersi tenuti legati a un mondo antiquato, meschino, astratto, troppo individualistico o di casta. La letteratura popolare francese, che è la più diffusa in Italia, rappresenta invece, in maggiore o minor grado, in un modo che può essere più o meno simpatico, questo moderno umanesimo, questo laicismo a suo modo moderno: lo rappresentarono il Guerrazzi, il Mastriani e gli altri pochi scrittori paesani popolari. Ma se i laici hanno fallito, i cattolici non hanno avuto miglior successo. Non bisogna lasciarsi illudere dalla discreta diffusione che hanno certi libri cattolici: essa è dovuta alla vasta e potente organizzazione della chiesa, non ad una intima forza di espansività: i libri vengono regalati nelle cerimonie numerosissime e vengono letti per castigo, per imposizione o per disperazione. Colpisce il fatto che nel campo della letteratura avventurosa i cattolici non abbiano saputo esprimere che meschinerie: eppure essi hanno una sorgente di prim’ordine nei viaggi e nella vita movimentata e spesso arrischiata dei missionari. Tuttavia anche nel periodo di maggior diffusione del romanzo geografico d’avventure, la letteratura cattolica in proposito è stata meschina e per nulla comparabile a quella laica francese, inglese e tedesca: le vicende del cardinal Massaja in Abissinia sono il libro più notevole, per il resto c’è stata l’invasione dei libri di Ugo Mioni (già padre gesuita), inferiori a ogni esigenza. Anche nella letteratura popolare scientifica i cattolici hanno ben poco, nonostante i loro grandi astronomi come il padre Secchi (gesuita) e che l’astronomia sia la scienza che più interessa il popolo. Questa letteratura cattolica trasuda di apologetica gesuitica come il becco di muschio e stucca per la sua meschinità gretta. L’insufficienza degli intellettuali cattolici e la poca fortuna della loro letteratura sono uno degli indizii più espressivi della intima rottura che esiste tra la religione e il popolo: questo si trova in uno stato miserrimo di indifferentismo e di assenza di una vivace vita spirituale: la religione è rimasta allo stato di superstizione, ma non è stata sostituita da una nuova moralità laica e umanistica per l’impotenza degli intellettuali laici (la religione non è stata né sostituita né intimamente trasformata e nazionalizzata come in altri paesi, come in America lo stessogesuitismo: l’Italia popolare è ancora nelle condizioni create immediatamente dalla Controriforma: la religione, tutt’al più, si è combinata col folclore pagano ed è rimasta in questo stadio).
Q21 §6 Diversi tipi di romanzo popolare. Esiste una certa varietà di tipi di romanzo popolare ed è da notare che, seppure tutti i tipi simultaneamente godano di una qualche diffusione e fortuna, tuttavia prevale uno di essi e di gran lunga. Da questo prevalere si può identificare un cambiamento dei gusti fondamentali, così come dalla simultaneità della fortuna dei diversi tipi si può ricavare la prova che esistono nel popolo diversi strati culturali, diverse «masse di sentimenti» prevalenti nell’uno o nell’altro strato, diversi «modelli di eroi» popolari. Fissare un catalogo di questi tipi e stabilire storicamente la loro relativa maggiore o minore fortuna ha pertanto una importanza ai fini del presente saggio: 1) Tipo Victor Hugo ‑ Eugenio Sue (I Miserabili, I Misteri di Parigi): a carattere spiccatamente ideologico‑politico, di tendenza democratica legata alle ideologie quarantottesche; 2) Tipo sentimentale, non politico in senso stretto, ma in cui si esprime ciò che si potrebbe definire una «democrazia sentimentale» (Richebourg - Decourcelle ecc.); 3) Tipo che si presenta come di puro intrigo, ma ha un contenuto ideologico conservatore‑reazionario (Montépin); 4) Il romanzo storico di A. Dumas e di Ponson du Terrail, che oltre al carattere storico, ha un carattere ideologico‑politico, ma meno spiccato: Ponson du Terrail tuttavia è conservatore‑reazionario e l’esaltazione degli aristocratici e dei loro servi fedeli ha un carattere ben diverso dalle rappresentazioni storiche di A. Dumas, che tuttavia non ha una tendenza democratico‑politica spiccata, ma è piuttosto pervaso da sentimenti democratici generici e «passivi» e spesso si avvicina al tipo «sentimentale»; 5) Il
romanzo poliziesco nel suo doppio aspetto (Lecocq, Rocambole, Sherlock Holmes, Arsenio Lupin); 6) Il romanzo tenebroso (fantasmi, castelli misteriosi ecc: Anna Radcliffe ecc.); 7) Il romanzo scientifico d’avventure, geografico, che può essere tendenzioso o semplicemente d’intrigo (J. Verne ‑ Boussenard).
Ognuno di questi tipi ha poi diversi aspetti nazionali (in America il romanzo d’avventure è l’epopea dei pionieri ecc.). Si può osservare come nella produzione d’insieme di ogni paese sia implicito un sentimento nazionalistico, non espresso retoricamente, ma abilmente insinuato nel racconto. Nel Verne e nei francesi il sentimento antinglese, legato alla perdita delle colonie e al bruciore delle sconfitte marittime è vivissimo: nel romanzo geografico d’avventure i francesi non si scontrano coi tedeschi, ma con gli inglesi. Ma il sentimento antinglese è vivo anche nel romanzo storico e persino in quello sentimentale (per es. George Sand). (Reazione per la guerra dei cento anni e l’assassinio di Giovanna D’Arco e per la fine di Napoleone).
In Italia nessuno di questi tipi ha avuto scrittori (numerosi) di qualche rilievo (non rilievo letterario, ma valore «commerciale», di invenzione, di costruzione ingegnosa di intrighi, macchinosi sì ma elaborati con una certa razionalità). Neanche il romanzo poliziesco, che ha avuto tanta fortuna internazionale (e finanziaria per gli autori e gli editori) ha avuto scrittori in Italia; eppure molti romanzi, specialmente storici, hanno preso per argomento l’Italia e le vicende storiche delle sue città, regioni, istituzioni, uomini. Così la storia veneziana, con le sue organizzazioni politiche, giudiziarie, poliziesche, ha dato e continua a dare argomento ai romanzieri popolari di tutti i paesi, eccetto l’Italia. Una certa fortuna ha avuto in Italia la letteratura popolare sulla vita dei briganti, ma la produzione è di valore bassissimo.
L’ultimo e più recente tipo di libro popolare è la vita romanzata, che in ogni modo rappresenta un tentativo inconsapevole di soddisfare le esigenze culturali di alcuni strati popolari più smaliziati culturalmente, che non si accontentano della storia tipo Dumas. Anche questa letteratura non ha in Italia molti rappresentanti (Mazzucchelli, Cesare Giardini ecc.): non solo gli scrittori italiani non sono paragonabili per numero, fecondità, e doti di piacevolezza letteraria ai francesi, ai tedeschi, agli inglesi, ma ciò che è più significativo essi scelgono i loro argomenti fuori d’Italia (Mazzucchelli e Giardini in Francia, Eucardio Momigliano in Inghilterra), per adattarsi al gusto popolare italiano che si è formato sui romanzi storici specialmente francesi. Il letterato italiano non scriverebbe una biografia romanzata di Masaniello, di Michele di Lando, di Cola di Rienzo senza credersi in dovere di inzepparla di stucchevoli «pezze d’appoggio» retoriche, perché non si creda… non si pensi… ecc. ecc. È vero che la fortuna delle vite romanzate ha indotto molti editori a iniziare la pubblicazione di collane biografiche, ma si tratta di libri che stanno alla vita romanzata come la Monaca di Monza sta al Conte di Montecristo; si tratta del solito schema biografico, spesso filologicamente corretto, che può trovare al massimo qualche migliaio di lettori, ma non diventare popolare.
È da notare che alcuni dei tipi di romanzo popolare su elencati hanno una corrispondenza nel teatro e oggi nel cinematografo. Nel teatro la fortuna considerevole di D. Niccodemi è certo dovuta a ciò: che egli ha saputo drammatizzare spunti e motivi eminentemente legati all’ideologia popolare; così in Scampolo, nell’Aigrette, nella Volata ecc. Anche in G. Forzano esiste qualcosa del genere, ma sul modello di Ponson du Terrail, con tendenze conservatrici. Il lavoro teatrale che in Italia ha avuto il maggior successo popolare è La Morte Civile del Giacometti, di carattere italiano: non ha avuto imitatori di pregio (sempre in senso non letterario). In questo reparto teatrale si può notare come tutta una serie di drammaturghi, di grande valore letterario, possono piacere moltissimo anche al pubblico popolare: Casa di Bambola di Ibsen è molto gradita al popolo delle città, in quanto i sentimenti rappresentati e la tendenza morale dell’autore trovano una profonda risonanza nella psicologia popolare. E cosa dovrebbe essere poi il così detto teatro d’idee se non questo, la rappresentazione di passioni legate ai costumi con soluzioni drammatiche che rappresentino una catarsi «progressiva», che rappresentino il dramma della parte più progredita intellettualmente e moralmente di una società e che esprime lo sviluppo storico immanente negli stessi costumi esistenti? Queste passioni e questo dramma però devono essere rappresentati e non svolti come una tesi, un discorso di propaganda, cioè l’autore deve vivere nel mondo reale, con tutte le sue esigenze contraddittorie e non esprimere sentimenti assorbiti solo dai libri.
Q21 §7 Romanzo e teatro popolare. Il dramma popolare viene chiamato, con un significato dispregiativo, dramma o drammone da arena, forse perché esistono in alcune città dei teatri all’aperto chiamati Arene (l’Arena del Sole a Bologna). È da ricordare ciò che scrisse Edoardo Boutet sugli spettacoli classici (Eschilo, Sofocle) che la Compagnia Stabile di Roma diretta appunto dal Boutet dava all’Arena del Sole di Bologna il lunedì – giorno delle lavandaie – e sul grande successo che tali rappresentazioni avevano. (Questi ricordi di vita teatrale del Boutet furono stampati per la prima volta nella rivista «Il Viandante» pubblicata a Milano da T. Monicelli negli anni 1908‑9). È anche da rilevare il successo che nelle masse popolari hanno sempre avuto alcuni drammi dello Shakespeare, ciò che appunto dimostra come si possa essere grandi artisti e nello stesso tempo «popolari».
Nel «Marzocco» del 17 novembre 1929 è pubblicata una nota di Gaio (Adolfo Orvieto), molto significativa: «Danton», il melodramma e il «romanzo nella vita». La nota dice: «Una compagnia drammatica di recente “formazione”, che ha messo insieme un repertorio di grandi spettacoli popolari – dal Conte di Montecristo alle Due orfanelle – con la speranza legittima di richiamare un po’ di gente a teatro, ha visto i suoi voti esauditi – a Firenze – con un novissimo dramma d’autore ungherese e di soggetto franco-rivoluzionario: Danton». Il dramma è di De Pekar ed è «pura favola patetica con particolari fantastici di estrema libertà» (per es. Robespierre e Saint‑Just assistono al processo di Danton e altercano con lui, ecc.). «Ma è favola, tagliata alla brava, che si vale dei vecchi metodi infallibili del teatro popolare, senza pericolose deviazioni modernistiche. Tutto è elementare, limitato, di taglio netto. Le tinte fortissime e i clamori si alternano alle opportune smorzature e il pubblico respira e consente. Mostra di appassionarsi e si diverte. Che sia questa la strada migliore per riportarlo al teatro di prosa?» La conclusione dell’Orvieto è significativa. Così nel 1929 per aver pubblico a teatro bisogna rappresentare il Conte di Montecristo e le Due Orfanelle e nel 1930 per far leggere i giornali bisogna pubblicare in appendice il Conte di Montecristo e Giuseppe Balsamo.
Q21 §8 Rilievi statistici. Quanti romanzi di autore italiano hanno pubblicato i periodici popolari più diffusi, come il «Romanzo Mensile», la «Domenica del Corriere», la «Tribuna Illustrata», il «Mattino Illustrato»? La «Domenica del Corriere» forse nessuno in tutta la sua vita (circa 36 anni) su circa un centinaio di romanzi pubblicati. La «Tribuna Illustrata» qualcuno (negli ultimi tempi una serie di romanzi polizieschi del principe Valerio Pignatelli); ma occorre notare che la «Tribuna» è enormemente meno diffusa della «Domenica», non è bene organizzata redazionalmente ed ha un tipo di romanzo meno scelto.
Sarebbe interessante vedere la nazionalità degli autori e il tipo dei romanzi d’avventura pubblicati. Il «Romanzo Mensile» e la «Domenica» pubblicano molti romanzi inglesi (quelli francesi tuttavia devono prevalere) e di tipo poliziesco (hanno pubblicato Sherlock Holmes e Arsenio Lupin) ma anche tedeschi, ungheresi (la baronessa Orczy è molto diffusa e i suoi romanzi sulla Rivoluzione francese hanno avuto molte ristampe anche nel «Romanzo Mensile» che pure deve avere una grande diffusione) e persino australiani (di Guido Boothby che ha avuto diverse edizioni): prevale certamente il romanzo poliziesco o affine, imbevuto di una concezione conservatrice e retriva o basato sul puro intrigo. Sarebbe interessante sapere chi, nella redazione del «Corriere della Sera», era incaricato di scegliere questi romanzi e quali direttive gli erano state impartite, dato che nel «Corriere» tutto era organizzato sapientemente. Il «Mattino Illustrato», sebbene esca a Napoli, pubblica romanzi del tipo «Domenica», ma si lascia guidare da quistioni finanziarie e spesso da velleità letterarie (così credo abbia pubblicato Conrad, Stevenson, London): lo stesso è da dire a proposito dell’«Illustrazione del Popolo» torinese. Relativamente, e forse anche in modo assoluto, l’amministrazione del «Corriere» è il centro di maggior diffusione dei romanzi popolari: ne pubblica almeno 15 all’anno con tirature altissime. Deve venir poi la Casa Sonzogno, che deve avere anche una pubblicazione periodica. Un confronto nel tempo dell’attività editoriale della Casa Sonzogno darebbe un quadro abbastanza approssimativo delle variazioni avvenute nel gusto del pubblico popolare; la ricerca è difficile, perché la Sonzogno non stampa l’anno di pubblicazione e non numera spesso le ristampe, ma un esame critico dei cataloghi darebbe qualche risultato. Già un confronto tra i cataloghi di 50 anni fa (quando il «Secolo» era in auge) e quelli odierni sarebbe interessante: tutto il romanzo lacrimoso‑sentimentale deve essere caduto nel dimenticatoio, eccetto qualche «capolavoro» del genere che deve ancora resistere (come la Capinera del Mulino, del Richebourg): d’altronde ciò non vuol dire che tali libri non siano letti da certi strati della popolazione di provincia, dove «si gusta» ancora dagli «spregiudicati» Paul De Kock e si discute animatamente sulla filosofia dei Miserabili. Così sarebbe interessante seguire la pubblicazione dei romanzi a dispense, fino a quelli di speculazione, che costano decine e decine di lire e sono legati a premi.
Un certo numero di romanzi popolari hanno pubblicato Edoardo Perino e più recentemente il Nerbini, tutti a sfondo anticlericale e legati alla tradizione guerrazziana. (È inutile ricordare il Salani, editore popolare per eccellenza). Occorrerebbe compilare una lista degli editori popolari.
Q21 §9 Ugo Mioni. La collezione «Tolle et lege» della Casa editrice «Pia Società S. Paolo», Alba‑Roma, su 111 numeri contenuti in una lista del 1928, aveva 65 romanzi di Ugo Mioni e non sono certo tutti quelli pubblicati dal prolifico monsignore, che d’altronde non ha scritto solo romanzi d’avventura, ma anche di apologetica, di sociologia e anche un grosso trattato di «Missionologia». Case editrici cattoliche per pubblicazioni popolari: esiste anche una pubblicazione periodica di romanzi. Male stampati e in traduzioni scorrette.
Q21 §10 Verne e il romanzo geografico‑scientifico. Nei libri del Verne non c’è mai nulla di completamente impossibile: le «possibilità» di cui dispongono gli eroi del Verne sono superiori a quelle realmente esistenti nel tempo, ma non troppo superiori e specialmente non «fuori» della linea di sviluppo delle conquiste scientifiche realizzate; l’immaginazione non è del tutto «arbitraria» e perciò possiede la facoltà di eccitare la fantasia del lettore già conquistato dall’ideologia dello sviluppo fatale del progresso scientifico nel dominio del controllo delle forze naturali. Diverso è il caso di Wells e di Poe, in cui appunto domina in gran parte l’«arbitrario», anche se il punto di partenza può essere logico e innestato in una realtà scientifica concreta: nel Verne c’è l’alleanza dell’intelletto umano e delle forze materiali, in Wells e in Poe l’intelletto umano predomina e perciò Verne è stato più popolare, perché più comprensibile. Nello stesso tempo però questo equilibrio nelle costruzioni romanzesche del Verne è diventato un limite, nel tempo, alla sua popolarità (a parte il valore artistico scarso): la scienza ha superato Verne e i suoi libri non sono più «eccitanti psichici».
Qualche cosa di simile si può dire delle avventure poliziesche, per es. di Conan Doyle; per il tempo erano eccitanti, oggi quasi nulla e per varie ragioni: perché il mondo delle lotte poliziesche è oggi più noto, mentre Conan Doyle in gran parte lo rivelava, almeno a un gran numero di pacifici lettori. Ma specialmente perché in Sherlock Holmes c’è un equilibrio razionale (troppo) tra l’intelligenza e la scienza. Oggi interessa di più l’apporto individuale dell’eroe, la tecnica «psichica» in sé, e quindi Poe e Chesterton sono più interessanti ecc.
Nel «Marzocco» del 19 febbraio 1928, Adolfo Faggi (Impressioni da Giulio Verne) scrive che il carattere antinglese di molti romanzi del Verne è da riportare a quel periodo di rivalità fra la Francia e l’Inghilterra che culminò nell’episodio di Fashoda. L’affermazione è errata e anacronistica: l’antibritannicismo era (e forse è ancora) un elemento fondamentale della psicologia popolare francese; l’antitedeschismo è relativamente recente ed era meno radicato dell’antibritannicismo, non esisteva prima della Rivoluzione francese e si è incancrenito dopo il 70, dopo la sconfitta e la dolorosa impressione che la Francia non era la più forte nazione militare e politica dell’Europa occidentale, perché la Germania, da sola, non in coalizione, aveva vinto la Francia. L’antinglesismo risale alla formazione della Francia moderna, come Stato unitario e moderno, cioè alla guerra dei cento anni e ai riflessi dell’immaginazione popolare della epopea di Giovanna D’Arco; è stato rinforzato modernamente dalle guerre per l’egemonia sul continente (e nel mondo) culminate nella Rivoluzione francese e in Napoleone: l’episodio di Fashoda, con tutta la sua gravità, non può essere paragonato a questa imponente tradizione che è testimoniata da tutta la letteratura francese popolare.
Q21 §11 Emilio De Marchi. Perché il De Marchi, nonostante che in parecchi suoi libri ci siano molti elementi di popolarità, non è stato e non è molto letto? Rileggerlo e analizzare questi elementi, specialmente in Giacomo l’idealista. (Sul De Marchi e il romanzo d’appendice ha scritto un saggio Arturo Pompeati nella «Cultura», non soddisfacente).
Q21 §12 Sul romanzo poliziesco. Il romanzo poliziesco è nato ai margini della letteratura sulle «Cause Celebri». A questa, d’altronde, è collegato anche il romanzo del tipo Conte di Montecristo; non si tratta anche qui di «cause celebri» romanzate, colorite con l’ideologia popolare intorno all’amministrazione della giustizia, specialmente se ad essa si intreccia la passione politica? Rodin dell’Ebreo Errante non è un tipo di organizzatore di «intrighi scellerati» che non si ferma dinanzi a qualsiasi delitto ed assassinio e invece il principe Rodolfo non è, al contrario, l’«amico del popolo» che sventa altri intrighi e delitti? Il passaggio da tale tipo di romanzo a quelli di pura avventura è segnato da un processo di schematizzazione del puro intrigo, depurato da ogni elemento di ideologia democratica e piccolo borghese: non più la lotta tra il popolo buono, semplice e generoso e le forze oscure della tirannide (gesuiti, polizia segreta legata alla ragion di Stato o all’ambizione di singoli principi ecc.) ma solo la lotta tra la delinquenza professionale o specializzata e le forze dell’ordine legale, private o pubbliche, sulla base della legge scritta. La collezione delle «Cause Celebri», nella celebre collezione francese, ha avuto il corrispettivo negli altri paesi; fu tradotta in italiano, la collezione francese, almeno in parte, per i processi di fama europea, come quello Fualdès, per l’assassinio del corriere di Lione ecc.
L’attività «giudiziaria» ha sempre interessato e continua a interessare: l’atteggiamento del sentimento pubblico verso l’apparato della giustizia (sempre screditato e quindi fortuna del poliziotto privato o dilettante) e verso il delinquente è mutato spesso o almeno si è colorito in vario modo. Il grande delinquente è stato spesso rappresentato superiore all’apparato giudiziario, addirittura come il rappresentante della «vera» giustizia: influsso del romanticismo,
I Masnadieri di Schiller, racconti di Hoffmann, Anna Radcliffe, il Vautrin di Balzac.
Il tipo di Javert dei Miserabili è interessante dal punto di vista della psicologia popolare: Javert ha torto dal punto di vista della «vera giustizia», ma Hugo lo rappresenta in modo simpatico, come «uomo di carattere», ligio al dovere «astratto» ecc.; da Javert nasce forse una tradizione secondo cui anche il poliziotto può essere «rispettabile». Rocambole di Ponson du Terrail. Gaboriau continua la riabilitazione del poliziotto col «signor Lecoq» che apre la strada a Sherlock Holmes.
Non è vero che gli Inglesi nel romanzo «giudiziario» rappresentano la «difesa della legge», mentre i Francesi rappresentano l’esaltazione del delinquente. Si tratta di un passaggio «culturale» dovuto al fatto che questa letteratura si diffonde anche in certi strati colti. Ricordare che il Sue, molto letto dai democratici delle classi medie, ha escogitato tutto un sistema di repressione della delinquenza professionale.
In questa letteratura poliziesca si sono sempre avute due correnti: una meccanica – d’intrigo – l’altra artistica: Chesterton oggi è il maggiore rappresentante dell’aspetto «artistico» come lo fu un tempo Poe: Balzac con Vautrin, si occupa del delinquente, ma non è «tecnicamente» scrittore di romanzi polizieschi.
Q21 §13 Romanzi polizieschi. 1) È da vedere il libro di Henry Jagot: Vidocq, ed. Berger‑Levrault, Parigi, 1930. Vidocq ha dato lo spunto al Vautrin di Balzac e ad Alessandro Dumas (lo si ritrova anche un po’ nel Jean Valjean dell’Hugo e specialmente in Rocambole). Vidocq fu condannato a otto anni come falso monetario, per una sua imprudenza, 20 evasioni ecc. Nel 1812 entrò a far parte della polizia di Napoleone e per 15 anni comandò una squadra di agenti creata apposta per lui: divenne famoso per gli arresti sensazionali. Congedato da Luigi Filippo, fondò un’agenzia privata di detectives, ma con scarso successo: poteva operare solo nelle file della polizia statale. Morto nel 1857. Ha lasciato le sue Memorie che non sono state scritte da lui solo e in cui sono contenute molte esagerazioni e vanterie.
2) È da vedere l’articolo di Aldo Sorani Conan Doyle e la fortuna del romanzo poliziesco, nel «Pègaso» dell’agosto 1930, notevole per l’analisi di questo genere di letteratura e per le diverse specificazioni che ha avuto finora. Nel parlare del Chesterton e della serie di novelle del padre Brown il Sorani non tiene conto di due elementi culturali che paiono invece essenziali: a) non accenna all’atmosfera caricaturale che si manifesta specialmente nel volume L’innocenza di padre Brown e che anzi è l’elemento artistico che innalza la novella poliziesca del Chesterton, quando, non sempre, l’espressione è riuscita perfetta; b) non accenna al fatto che le novelle del padre Brown sono «apologetiche» del cattolicismo e del clero romano, educato a conoscere tutte le pieghe dell’animo umano dall’esercizio della confessione e della funzione di guida spirituale e di intermediario tra l’uomo e la divinità, contro lo «scientismo» e la psicologia positivistica del protestante Conan Doyle. Il Sorani, nel suo articolo, riferisce sui diversi tentativi, specialmente anglosassoni, e di maggior significato letterario, per perfezionare tecnicamente il romanzo poliziesco. L’archetipo è Sherlock Holmes, nelle sue due fondamentali caratteristiche: di scienziato e di psicologo: si cerca di perfezionare l’una o l’altra caratteristica o ambedue insieme. Il Chesterton ha appunto insistito sull’elemento psicologico, nel gioco delle induzioni e deduzioni col padre Brown, ma pare abbia ancora esagerato nella sua tendenza col tipo del poeta‑poliziotto Gabriel Gale.
Il Sorani schizza un quadro della inaudita fortuna del romanzo poliziesco in tutti gli ordini della società e cerca di identificarne l’origine psicologica: sarebbe una manifestazione di rivolta contro la meccanicità e la standardizzazione della vita moderna, un modo di evadere dal tritume quotidiano. Ma questa spiegazione si può applicare a tutte le forme della letteratura, popolare o d’arte: dal poema cavalleresco (Don Chisciotte non cerca di evadere anch’egli, anche praticamente, dal tritume e dalla standardizzazione della vita quotidiana di un villaggio spagnolo?) al romanzo d’appendice di vario genere. Tutta la letteratura e la poesia sarebbe dunque uno stupefacente contro la banalità quotidiana? In ogni modo l’articolo del Sorani è indispensabile per una futura ricerca più organica su questo genere di letteratura popolare.
Il problema: perché è diffusa la letteratura poliziesca? è un aspetto particolare del problema più generale: perché è diffusa la letteratura non‑artistica? Per ragioni pratiche e culturali (politiche e morali), indubbiamente: e questa risposta generica è la più precisa, nei suoi limiti approssimativi. Ma anche la letteratura artistica non si diffonde anch’essa per ragioni pratiche e politico‑morali e solo mediatamente per ragioni di gusto artistico, di ricerca e godimento della bellezza? In realtà si legge un libro per impulsi pratici (e occorre ricercare perché certi impulsi si generalizzino più di altri) e si rilegge per ragioni artistiche. L’emozione estetica non è quasi maidi prima lettura. Ciò si verifica ancor di più nel teatro, in cui l’emozione estetica è una «percentuale» minima dell’interesse dello spettatore, perché nella scena giocano altri elementi, molti dei quali non sono neppure d’ordine intellettuale, ma di ordine meramente fisiologico, come il «sex‑appeal», ecc. In altri casi l’emozione estetica nel teatro non è originata dall’opera letteraria, ma dall’interpretazione degli attori e del regista: in questi casi occorre però che il testo letterario del dramma che dà il pretesto all’interpretazione non sia «difficile» e ricercato psicologicamente, ma invece «elementare e popolare» nel senso che le passioni rappresentate siano le più profondamente «umane» e di immediata esperienza (vendetta, onore, amore materno, ecc.) e quindi l’analisi si complica anche in questi casi. I grandi attori tradizionali venivano acclamati nella Morte civile, nelle Due orfanelle, nella Gerla di papà Martin, ecc., più che nelle complicate macchine psicologiche: nel primo caso l’applauso era senza riserve, nel secondo era più freddo, destinato a scindere l’attore amato dal pubblico, dal lavoro rappresentato, ecc.
Una giustificazione simile a quella del Sorani della fortuna dei romanzi popolari si trova in un articolo di Filippo Burzio sui Tre Moschettieri di Alessandro Dumas (pubblicato nella «Stampa» del 22 ottobre 1930 e riportato in estratti dall’«Italia Letteraria» del 9 novembre). Il Burzio considera i Tre Moschettieri una felicissima personificazione, come il Don Chisciotte e l’Orlando Furioso, del mito dell’avventura, «cioè di qualcosa di essenziale alla natura umana, che sembra gravemente e progressivamente straniarsi dalla vita moderna. Quanto più l’esistenza si fa razionale (o razionalizzata, piuttosto, per coercizione, che se è razionale per i gruppi dominanti, non è razionale per quelli dominati, e che è connessa con l’attività economico‑pratica, per cui la coercizione si esercita, sia pure indirettamente, anche sui ceti “intellettuali”?) e organizzata, la disciplina sociale ferrea, il compito assegnato all’individuo preciso e prevedibile (ma non prevedibile per i dirigenti come appare dalle crisi e dalle catastrofi storiche), tanto più il margine dell’avventura si riduce, come la libera selva di tutti fra i muretti soffocanti della proprietà privata… Il taylorismo è una bella cosa e l’uomo è un animale adattabile, però forse ci sono dei limiti alla sua meccanizzazione. Se a me chiedessero le ragioni profonde dell’inquietudine occidentale, risponderci senza esitare: la decadenza della fede (!) e la mortificazione dell’avventura». «Vincerà il taylorismo o vinceranno i Moschettieri? Questo è un altro discorso e la risposta, che trent’anni fa sembrava certa, sarà meglio tenerla in sospeso. Se l’attuale civiltà non precipita, assisteremo forse a interessanti miscugli dei due».
La quistione è questa: che il Burzio non tiene conto del fatto che c’è sempre stata una gran parte di umanità la cui attività è sempre stata taylorizzata e ferreamente disciplinata e che essa ha cercato di evadere dai limiti angusti dell’organizzazione esistente che la schiacciava, con la fantasia e col sogno. La più grande avventura, la più grande «utopia» che l’umanità ha creato collettivamente, la religione, non è un modo di evadere dal «mondo terreno»? E non è in questo senso che Balzac parla del lotto come di oppio della miseria, frase ripresa poi da altri? (Cfr nel quaderno 1° degli Argomenti di cultura). Ma il più notevole è che accanto a Don Chisciotte esiste Sancho Panza, che non vuole «avventure», ma certezza di vita e che il gran numero degli uomini è tormentato proprio dall’ossessione della non «prevedibilità del domani», dalla precarietà della propria vita quotidiana, cioè da un eccesso di «avventure» probabili. Nel mondo moderno la quistione si colorisce diversamente che nel passato per ciò che la razionalizzazione coercitiva dell’esistenza colpisce sempre più le classi medie e intellettuali,
in una misura inaudita; ma anche per esse si tratta non di decadenza dell’avventura, ma di troppa avventurosità della vita quotidiana, cioè di troppa precarietà nell’esistenza, unita alla persuasione che contro tale precarietà non c’è modo individuale di arginamento: quindi si aspira all’avventura «bella» e interessante, perché dovuta alla propria iniziativa libera, contro l’avventura «brutta» e rivoltante, perché dovuta alle condizioni imposte da altri e non proposte.
La giustificazione del Sorani e del Burzio vale anche a spiegare il tifo sportivo, cioè spiega troppo e quindi nulla. Il fenomeno è vecchio almeno come la religione, ed è poliedrico, non unilaterale: ha anche un aspetto positivo, cioè il desiderio di «educarsi» conoscendo un modo di vita che si ritiene superiore al proprio, il desiderio di innalzare la propria personalità proponendosi modelli ideali (cfr lo spunto sull’origine popolaresca del superuomo negli Argomenti di cultura), il desiderio di conoscere più mondo e più uomini di quanto sia possibile in certe condizioni di vita, lo snobismo ecc. ecc. Lo spunto della «letteratura popolare come oppio del popolo» è annotato in una nota sull’altro romanzo di Dumas: Il Conte di Montecristo.
Q21 §14 Derivazioni culturali del romanzo d’appendice. È da vedere il fascicolo della «Cultura» dedicato a Dostojevskij nel 1931. Vladimiro Pozner in un articolo sostiene giustamente che i romanzi di Dostojevskij sono derivati culturalmente dai romanzi d’appendice tipo E. Sue ecc.
Questa derivazione è utile tener presente per lo svolgimento di questa rubrica sulla letteratura popolare, in quanto mostra come certe correnti culturali (motivi e interessi morali, sensibilità, ideologie ecc.) possono avere una doppia espressione: quella meramente meccanica di intrigo sensazionale (Sue ecc.) e quella «lirica» (Balzac, Dostojevskij e in parte V. Hugo). I contemporanei non sempre si accorgono della deteriorità di una parte di queste manifestazioni letterarie, come è avvenuto in parte per il Sue, che fu letto da tutti i gruppi sociali e «commuoveva» anche le persone di «cultura», mentre poi decadde a «scrittore letto solo dal popolo» (la «prima lettura» dà puramente, o quasi, sensazioni «culturali» o di contenuto e il «popolo» è lettore di prima lettura, acritico, che si commuove per la simpatia verso l’ideologia generale di cui il libro è espressione spesso artificiosa e voluta).
Per questo stesso argomento è da vedere: 1) Mario Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, in 16°, pp. x‑505, Milano‑Roma, ed. La Cultura, L. 40 (vedere la recensione di L. F. Benedetto nel «Leonardo» del marzo 1931: da essa appare che il Praz non ha fatto con esattezza la distinzione tra i vari gradi di cultura, onde alcune obbiezioni del Benedetto, che d’altronde non pare colga egli stesso il nesso storico della quistione storico‑letteraria); 2) Servais Étienne: Le genre romanesque en France depuis l’apparition de la «Nouvelle Héloïse» jusqu’aux approches de la Révolution, ed. Armand Colin; 3) Reginald W. Hartland: Le Roman terrifiant ou «Roman noir» de Walpole à Anne Radcliffe, et son influence sur la littérature française jusqu’en 1860, ed. Champion e dello stesso autore (presso lo stesso editore) Walter Scott et le «Roman frénétique» (l’affermazione del Pozner che il romanzo di Dostojevskij sia «romanzo d’avventura» è probabilmente derivata da un saggio di Jacques Rivière sul «romanzo d’avventure», forse pubblicato nella «N. R. F.», che significherebbe «una vasta rappresentazione di azioni che sono insieme drammatiche e psicologiche» così come l’hanno concepito Balzac, Dostojevskij, Dickens e George Elliot);
4) un saggio di André Moufflet su Le style du roman feuilleton nel «Mercure de France» del 1° febbraio 1931 (Nel ms le pagine del Quaderno successive a p. 37 sono rimaste bianche, salvo una breve annotazione a p. 155.).
Q21 §15 Bibliografia. N. Atkinson, Eugène Sue et le
roman‑feuilleton, in 8°, pp. 226, Parigi, Nizet et Bastard, Frs.
40.
QUADERNO 22
AMERICANISMO E FORDISMO
Q22 §1 Serie di problemi che devono essere esaminati sotto
questa rubrica generale e un po’ convenzionale di «Americanismo
e Fordismo», dopo aver tenuto conto del fatto fondamentale che
le risoluzioni di essi sono necessariamente impostate e tentate
nelle condizioni contraddittorie della società moderna, ciò che
determina complicazioni, posizioni assurde, crisi economiche e
morali a tendenza spesso catastrofica, ecc. Si può dire
genericamente che l’americanismo e il fordismo risultano dalla
necessità immanente di giungere all’organizzazione di
un’economia programmatica e che i vari problemi esaminati
dovrebbero essere gli anelli della catena che segnano il
passaggio appunto dal vecchio individualismo economico
all’economia programmatica: questi problemi nascono dalle varie
forme di resistenza che il processo di sviluppo trova al suo
svolgimento, resistenze che vengono dalle difficoltà insite
nella «societas rerum» e nella «societas hominum». Che un
tentativo progressivo sia iniziato da una o altra forza sociale
non è senza conseguenze fondamentali: le forze subalterne, che
dovrebbero essere «manipolate» e razionalizzate secondo i nuovi
fini, resistono necessariamente. Ma resistono anche alcuni
settori delle forze dominanti, o almeno alleate delle forze
dominanti. Il proibizionismo, che negli Stati Uniti era una
condizione necessaria per sviluppare il nuovo tipo di lavoratore
conforme a un’industria fordizzata, è caduto per l’opposizione
di forze marginali, ancora arretrate, non certo per
l’opposizione degli industriali o degli operai. Ecc.
Registro di alcuni dei problemi più importanti o interessanti essenzialmente anche se a prima vista paiono non di primo piano: 1) sostituzione all’attuale ceto plutocratico, di un nuovo meccanismo di accumulazione e distribuzione del capitale finanziario fondato immediatamente sulla produzione industriale; 2) quistione sessuale; 3) quistione se l’americanismo possa costituire un’«epoca» storica, se cioè possa determinare uno svolgimento graduale del tipo, altrove esaminato, delle «rivoluzioni passive» proprie del secolo scorso o se invece rappresenti solo l’accumularsi molecolare di elementi destinati a produrre un’«esplosione», cioè un rivolgimento di tipo francese; 4) quistione della «razionalizzazione» della composizione demografica europea; 5) quistione se lo svolgimento debba avere il punto di partenza nell’intimo del mondo industriale e produttivo o possa avvenire dall’esterno, per la costruzione cautelosa e massiccia di una armatura giuridica formale che guidi dall’esterno gli svolgimenti necessari dell’apparato produttivo; 6) quistione dei così detti «alti salari» pagati dall’industria fordizzata e razionalizzata; 7) il fordismo come punto estremo del processo di tentativi successivi da parte dell’industria di superare la legge tendenziale della caduta del saggio del profitto; 8) la psicanalisi (sua enorme diffusione nel dopoguerra) come espressione dell’aumentata coercizione morale esercitata dall’apparato statale e sociale sui singoli individui e delle crisi morbose che tale coercizione determina; 9) il Rotary Club e la Massoneria; 10) … (Nel ms l’enumerazione è interrotta a questo punto e non è stata più completata. Il resto della pagina e le pagine seguenti, fino a p. 10 compresa, sono rimaste bianche.).
Q22 §2 Razionalizzazione della composizione demografica europea. In Europa i diversi tentativi di introdurre alcuni aspetti dell’americanismo e del fordismo sono dovuti al vecchio ceto plutocratico, che vorrebbe conciliare ciò che, fino a prova contraria, pare inconciliabile, la vecchia e anacronistica struttura sociale‑demografica europea con una forma modernissima di produzione e di modo di lavorare quale è offerta dal tipo americano più perfezionato, l’industria di Enrico Ford. Perciò l’introduzione del fordismo trova tante resistenze «intellettuali» e «morali» e avviene in forme particolarmente brutali e insidiose, attraverso la coercizione più estrema. Per dirla in parole povere, l’Europa vorrebbe avere la botte piena e la moglie ubriaca, tutti i benefizi che il fordismo produce nel potere di concorrenza, pur mantenendo il suo esercito di parassiti che divorando masse ingenti di plusvalore, aggravano i costi iniziali e deprimono il potere di concorrenza sul mercato internazionale. La reazione europea all’americanismo è pertanto da esaminare con attenzione: dalla sua analisi risulterà più di un elemento necessario per comprendere l’attuale situazione di una serie di Stati del vecchio continente e gli avvenimenti politici del dopoguerra.
L’americanismo, nella sua forma più compiuta, domanda una condizione preliminare, di cui gli americani che hanno trattato questi problemi non si sono occupati, perché essa in America esiste «naturalmente»: questa condizione si può chiamare «una composizione demografica razionale» e consiste in ciò che non esistano classi numerose senza una funzione essenziale nel mondo produttivo, cioè classi assolutamente parassitarie. La «tradizione», la «civiltà» europea è invece proprio caratterizzata dall’esistenza di classi simili, create dalla «ricchezza» e «complessità» della storia passata che ha lasciato un mucchio di sedimentazioni passive attraverso i fenomeni di saturazione e fossilizzazione del personale statale e degli intellettuali, del clero e della proprietà terriera, del commercio di rapina e dell’esercito prima professionale poi di leva, ma professionale per l’ufficialità. Si può anzi dire che quanto più vetusta è la storia di un paese, e tanto più numerose e gravose sono queste sedimentazioni di masse fannullone e inutili, che vivono del «patrimonio» degli «avi», di questi pensionati della storia economica. Una statistica di questi elementi economicamente passivi (in senso sociale) è difficilissima, perché è impossibile trovare la «Voce» che li possa definire ai fini di una ricerca diretta; indicazioni illuminanti si possono ricavare indirettamente, per esempio dall’esistenza di determinate forme di vita nazionale.
Il numero rilevante di grandi e medi (e anche piccoli) agglomerati di tipo urbano senza industria (senza fabbriche) è uno di questi indizi e dei più rilevanti.
Il così detto «mistero di Napoli». Sono da ricordare le osservazioni fatte dal Goethe su Napoli e le «consolanti» conclusioni «morali» che ne ha tratto Giustino Fortunato (l’opuscolo del Fortunato su Goethe e il suo giudizio sui Napoletani è stato ristampato dalla Bibliotheca editrice di Rieti nella collana dei «Quaderni critici» diretta da Domenico Petrini; sull’opuscolo del Fortunato è da leggere la recensione di Luigi Einaudi nella Riforma Sociale forse del 1912). Il Goethe aveva ragione nel demolire la leggenda del «lazzaronismo» organico dei napoletani e nel rilevare invece che essi sono molto attivi e industriosi. Ma la quistione consiste nel vedere quale sia il risultato effettivo di questa industriosità: essa non è produttiva e non è rivolta a soddisfare i bisogni e le esigenze di classi produttive. Napoli è la città dove la maggior parte dei proprietari terrieri del Mezzogiorno (nobili e no) spendono la rendita agraria. Intorno a qualche decina di migliaia di queste famiglie di proprietari, di maggiore o minore importanza economica, con le loro corti di servi e di lacché immediati, si organizza la vita pratica di una parte imponente della città, con le sue industrie artigianesche, coi suoi mestieri ambulanti, con lo sminuzzamento inaudito dell’offerta immediata di merci e servizi agli sfaccendati che circolano nelle strade. Un’altra parte importante della città si organizza intorno al transito e al commercio all’ingrosso. L’industria «produttiva» nel senso che crea e accumula nuovi beni è relativamente piccola, nonostante che nelle statistiche ufficiali Napoli sia annoverata come la quarta città industriale dell’Italia, dopo Milano, Torino e Genova.
Questa struttura economico‑sociale di Napoli (e su di essa è oggi possibile, attraverso le attività dei Consigli provinciali dell’economia corporativa avere informazioni sufficientemente esatte) spiega molta parte della storia di Napoli città, così piena di apparenti contraddizioni e di spinosi problemi politici.
Il fatto di Napoli si ripete in grande per Palermo e Roma e per tutta una serie numerosa (le famose «cento città») di città non solo dell’Italia meridionale e delle Isole, ma dell’Italia centrale e anche di quella settentrionale (Bologna, in buona parte, Parma, Ferrara ecc.). Si può ripetere per molta popolazione di tal genere di città il proverbio popolare: quando un cavallo caca, cento passeri fanno il loro desinare.
Il fatto che non è stato ancora convenientemente studiato è questo: che la media e la piccola proprietà terriera non è in mano a contadini coltivatori, ma a borghesi della cittaduzza o del borgo, e che questa terra viene data a mezzadria primitiva (cioè in affitto con corrisponsione in natura e servizi) o in enfiteusi; esiste così un volume enorme (in rapporto al reddito lordo) di piccola e media borghesia di «pensionati» e «redditieri», che ha creato in certa letteratura economica degna di Candide la figura mostruosa del così detto «produttore di risparmio», cioè di uno strato di popolazione passiva economicamente che dal lavoro primitivo di un numero determinato di contadini trae non solo il proprio sostentamento, ma ancora riesce a risparmiare: modo di accumulazione di capitale dei più mostruosi e malsani, perché fondato sull’iniquo sfruttamento usurario dei contadini tenuti al margine della denutrizione e perché costa enormemente; poiché al poco capitale risparmiato corrisponde una spesa inaudita quale è quella necessaria per sostenere spesso un livello di vita elevato di tanta massa di parassiti assoluti. (Il fenomeno storico per cui si è formato nella penisola italiana, a ondate, dopo la caduta dei Comuni medioevali e la decadenza dello spirito d’iniziativa capitalistica della borghesia urbana, una tale situazione anormale, determinatrice di stagnazione storica, è chiamato dallo storico Niccolò Rodolico «ritorno alla terra» ed è stato assunto addirittura come indice di benefico progresso nazionale, tanto le frasi fatte possono ottundere il senso critico).
Un’altra sorgente di parassitismo assoluto è sempre stata l’amministrazione dello Stato. Renato Spaventa ha calcolato che in Italia un decimo della popolazione (4 milioni di abitanti) vive sul bilancio statale. Avviene anche oggi che uomini relativamente giovani (di poco più che 40 anni), con buonissima salute, nel pieno vigore delle forze fisiche e intellettuali, dopo 25 anni di servizio statale, non si dedicano più a nessuna attività produttiva, ma vivacchiano con le pensioni più o meno grandi, mentre un operaio può godere una assicurazione solo dopo i 65 anni e per il contadino non esiste limite di età al lavoro (perciò un italiano medio si maraviglia se sente dire che un americano multimilionario continua ad essere attivo fino all’ultimo giorno della sua vita cosciente). Se in una famiglia un prete diventa canonico, subito il «lavoro manuale» diventa «una vergogna» per l’intero parentado; ci si può dedicare al commercio, tutt’al più.
La composizione della popolazione italiana era già stata resa «malsana» dall’emigrazione a lungo termine e dalla scarsa occupazione delle donne nei lavori produttivi di nuovi beni; il rapporto tra popolazione «potenzialmente» attiva e quella passiva era uno dei più sfavorevoli dell’Europa (cfr le ricerche in proposito del prof. Mortara, per esempio nelle Prospettive economiche del 1922). Esso è ancora più sfavorevole se si tiene conto: 1) delle malattie endemiche (malaria ecc.) che diminuiscono la media individuale del potenziale di forza di lavoro; 2) dello stato cronico di denutrizione di molti strati inferiori contadineschi (come risulta dalle ricerche del prof. Mario Camis pubblicate nella Riforma Sociale del 1926, le cui medie nazionali dovrebbero essere scomposte per medie di classe: se la media nazionale raggiunge appena lo standard fissato dalla scienza come indispensabile, è ovvio concludere alla denutrizione cronica di uno strato non indifferente della popolazione. Nella discussione al Senato del bilancio preventivo per l’anno 1929‑30, l’on. Mussolini affermò che in alcune regioni, per intere stagioni, si vive di sole erbe: cfr gli Atti parlamentari della sessione, e il discorso del senatore Ugo Ancona, le cui velleità reazionarie furono prontamente rimbeccate dal Capo del Governo); 3) della disoccupazione endemica esistente in alcune regioni agricole, e che non può risultare dalle inchieste ufficiali; 4) della massa di popolazione assolutamente parassitaria che è volissima e che per i suoi servizi domanda il lavoro di altra ingente massa parassitaria indirettamente, e di quella «semiparassitaria» che è tale perché moltiplica in modo anormale e malsano attività economiche subordinate come il commercio e l’intermediariato in generale.
Questa situazione non esiste solo in Italia; in misura maggiore o minore esiste in tutti i paesi della vecchia Europa e in forma peggiore ancora esiste in India e in Cina, ciò che spiega il ristagno della storia in questi paesi e la loro impotenza politico‑militare. (Nell’esame di questo problema non è in quistione immediatamente la forma di organizzazione economico‑sociale, ma la razionalità delle proporzioni tra i diversi settori della popolazione nel sistema sociale esistente: ogni sistema ha una sua legge delle proporzioni definite nella composizione demografica, un suo equilibrio «ottimo» e squilibri che, non raddrizzati con opportuna legislazione, possono essere di per sé catastrofici, perché essiccano le sorgenti della vita economica nazionale, a parte ogni altro elemento di dissoluzione).
L’America non ha grandi «tradizioni storiche e culturali» ma non è neanche gravata da questa cappa di piombo: è questa una delle principali ragioni – più importante certo della così detta ricchezza naturale – della sua formidabile accumulazione di capitali, nonostante il tenore di vita superiore, nelle classi popolari, a quello europeo. La non esistenza di queste sedimentazioni vischiosamente parassitarie lasciate dalle fasi storiche passate, ha permesso una base sana all’industria e specialmente al commercio e permette sempre più la riduzione della funzione economica rappresentata dai trasporti e dal commercio a una reale attività subalterna della produzione, anzi il tentativo di assorbire queste attività nell’attività produttiva stessa (cfr gli esperimenti fatti da Ford e i risparmi fatti dalla sua azienda con la gestione diretta del trasporto e del commercio della merce prodotta, risparmi che hanno influito sui costi di produzione, cioè hanno permesso migliori salari e minori prezzi di vendita). Poiché esistevano queste condizioni preliminari, già razionalizzate dallo svolgimento storico, è stato relativamente facile razionalizzare la produzione e il lavoro, combinando abilmente la forza (distruzione del sindacalismo operaio a base territoriale) con la persuasione (alti salari, benefizi sociali diversi, propaganda ideologica e politica abilissima) e ottenendo di imperniare tutta la vita del paese sulla produzione. L’egemonia nasce dalla fabbrica e non ha bisogno per esercitarsi che di una quantità minima di intermediari professionali della politica e dell’ideologia.
Il fenomeno delle «masse» che ha tanto colpito il Romier non è che la forma di questo tipo di società razionalizzata, in cui la «struttura» domina più immediatamente le soprastrutture e queste sono «razionalizzate» (semplificate e diminuite di numero).
Rotary Club e Massoneria (il Rotary è una massoneria senza i piccoli borghesi e senza la mentalità piccolo borghese). L’America ha il Rotary e l’Y.M.C.A., l’Europa ha la Massoneria e i gesuiti. Tentativi di introdurre l’YMCA in Italia; aiuti dati dall’industria italiana a questi tentativi (finanziamento di Agnelli e reazione violenta dei cattolici). Tentativi di Agnelli di assorbire il gruppo dell’«Ordine Nuovo» che sosteneva una sua forma di «americanismo» accetta alle masse operaie.
In America la razionalizzazione ha determinato la necessità di elaborare un nuovo tipo umano, conforme al nuovo tipo di lavoro e di processo produttivo: questa elaborazione finora è solo nella fase iniziale e perciò (apparentemente) idillica. È ancora la fase dell’adattamento psico‑fisico alla nuova struttura industriale, ricercata attraverso gli alti salari; non si è verificata ancora (prima della crisi del 1929), se non sporadicamente, forse, alcuna fioritura «superstrutturale», cioè non è ancora stata posta la quistione fondamentale dell’egemonia. La lotta avviene con armi prese dal vecchio arsenale europeo e ancora imbastardite, quindi sono ancora «anacronistiche» in confronto dello sviluppo delle «cose». La lotta che si svolge in America (descritta dal Philip) è ancora per la proprietà del mestiere, contro la «libertà industriale», cioè simile a quella svoltasi in Europa nel secolo XVIII, sebbene in altre condizioni: il sindacato operato americano è più l’espressione corporativa della proprietà dei mestieri qualificati che altro e perciò lo stroncamento che ne domandano gli industriali ha un aspetto «progressivo». L’assenza della fase storica europea che anche nel campo economico è segnata dalla Rivoluzione francese ha lasciato le masse popolari americane allo stato grezzo: a ciò si aggiunga l’assenza di omogeneità nazionale, il miscuglio delle culture‑razze, la quistione dei negri.
In Italia si è avuto un inizio di fanfara fordistica (esaltazione della grande città, piani regolatori per la grande Milano ecc., l’affermazione che il capitalismo è ancora ai suoi inizi e che occorre preparargli dei quadri di sviluppo grandiosi ecc.: su ciò è da vedere nella Riforma Sociale qualche articolo di Schiavi), poi si è avuta la conversione al ruralismo e all’illuministica depressione della città, l’esaltazione dell’artigianato e del patriarcalismo idillico, accenni alla «proprietà del mestiere» e a una lotta contro la libertà industriale. Tuttavia, anche se lo sviluppo è lento e pieno di comprensibili cautele, non si può dire che la parte conservatrice, la parte che rappresenta la vecchia cultura europea con tutti i suoi strascichi parassitarii, sia senza antagonisti (da questo punto di vista è interessante la tendenza rappresentata dai «Nuovi Studi», dalla «Critica Fascista» e dal centro intellettuale di studi corporativi organizzato presso l’Università di Pisa).
Il libro del De Man è anch’esso, a suo modo, un’espressione di questi problemi che sconvolgono la vecchia ossatura europea, una espressione senza grandezza e senza adesione a nessuna delle forze storiche maggiori che si contendono il mondo.
Q22 §3 Alcuni aspetti della quistione sessuale. Ossessione della quistione sessuale e pericoli di una tale ossessione. Tutti i «progettisti» pongono in prima linea la quistione sessuale e la risolvono «candidamente». È da rilevare come nelle «utopie» la quistione sessuale abbia larghissima parte, spesso prevalente (l’osservazione del Croce che le soluzioni del Campanella nella Città del Sole non possono spiegarsi coi bisogni sessuali dei contadini calabresi è inetta). Gli istinti sessuali sono quelli che hanno subito la maggiore repressione da parte della società in isviluppo; il loro «regolamento», per le contraddizioni cui dà luogo e per le perversioni che gli si attribuiscono, sembra il più «innaturale», quindi più frequenti in questo campo i richiami alla «natura». Anche la letteratura «psicanalitica» è un modo di criticare la regolamentazione degli istinti sessuali in forma talvolta «illuministica», con la creazione di un nuovo mito del «selvaggio» sulla base sessuale (inclusi i rapporti tra genitori e figli).
Distacco, in questo campo, tra città e campagna, ma non in senso idillico per la campagna, dove avvengono i reati sessuali più mostruosi e numerosi, dove è molto diffuso il bestialismo e la pederastia. Nell’inchiesta parlamentare sul Mezzogiorno del 1911 si dice che in Abruzzo e Basilicata (dove maggiore è il fanatismo religioso, il patriarcalismo e minore l’influsso delle idee cittadine, tanto che negli anni 1919‑20, secondo il Serpieri, non vi fu neppure un’agitazione di contadini) si ha l’incesto nel 30% delle famiglie e non pare che la situazione sia cambiata fino agli ultimi anni.
La sessualità come funzione riproduttiva e come «sport»: l’ideale «estetico» della donna oscilla tra la concezione di «fattrice» e di «ninnolo». Ma non è solo in città che la sessualità è diventata uno «sport»; i proverbi popolari: «l’uomo è cacciatore, la donna è tentatrice», «chi non ha di meglio, va a letto con la moglie» ecc., mostrano la diffusione della concezione sportiva anche in campagna e nei rapporti sessuali tra elementi della stessa classe.
La funzione economica della riproduzione: essa non è solo un fatto generale, che interessa tutta la società nel suo complesso, per la quale è necessaria una certa proporzione tra le diverse età ai fini della produzione e del mantenimento della parte passiva della popolazione (passiva in via normale, per l’età, per l’invalidità ecc.), ma è anche un fatto «molecolare», interno ai più piccoli aggregati economici quale la famiglia. L’espressione sul «bastone della vecchiaia» mostra la coscienza istintiva del bisogno economico che ci sia un certo rapporto tra giovani e vecchi in tutta l’area sociale. Lo spettacolo del come sono bistrattati, nei villaggi, i vecchi e le vecchie senza figliolanza spinge le coppie a desiderare la prole (il proverbio che «una madre alleva cento figli e cento figli non sostengono una madre» mostra un altro aspetto della quistione): i vecchi senza figli, delle classi popolari, sono trattati come i «bastardi».
I progressi dell’igiene, che hanno elevato le medie della vita umana, pongono sempre più la quistione sessuale come un aspetto fondamentale e a sé stante della quistione economica, aspetto tale da porre a sua volta problemi complessi del tipo di «superstruttura». L’aumento della media della vita in Francia, con la scarsa natalità e coi bisogni di far funzionare un molto ricco e complesso apparato di produzione, pone già oggi alcuni problemi coordinati al problema nazionale: le generazioni vecchie vanno mettendosi in un rapporto sempre più anormale con le generazioni giovani della stessa cultura nazionale, e le masse lavoratrici si impinguano di elementi stranieri immigrati che modificano la base: si verifica già, come in America, una certa divisione del lavoro (mestieri qualificati per gli indigeni, oltre alle funzioni di direzione e organizzazione; mestieri non qualificati per gli immigrati).
Un rapporto simile, ma con conseguenze antieconomiche rilevanti, si pone in tutta una serie di Stati tra le città industriali a bassa natalità e la campagna prolifica: la vita nell’industria domanda un tirocinio generale, un processo di adattamento psico‑fisico a determinate condizioni di lavoro, di nutrizione, di abitazione, di costumi ecc. che non è qualcosa di innato, di «naturale», ma domanda di essere acquisito, mentre i caratteri urbani acquisiti si tramandano per ereditarietà o vengono assorbiti nello sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza. Così la bassa natalità urbana domanda una continua e rilevante spesa per il tirocinio dei continuamente nuovi inurbati e porta con sé un continuo mutarsi della composizione sociale‑politica della città, ponendo continuamente su nuove basi il problema dell’egemonia.
La quistione etico‑civile più importante legata alla quistione sessuale è quella della formazione di una nuova personalità femminile: finché la donna non avrà raggiunto non solo una reale indipendenza di fronte all’uomo, ma anche un nuovo modo di concepire se stessa e la sua parte nei rapporti sessuali, la quistione sessuale rimarrà ricca di caratteri morbosi e occorrerà esser cauti in ogni innovazione legislativa. Ogni crisi di coercizione unilaterale nel campo sessuale porta con sé a uno sfrenamento «romantico» che può essere aggravato dall’abolizione della prostituzione legale e organizzata. Tutti questi elementi complicano e rendono difficilissima ogni regolamentazione del fatto sessuale e ogni tentativo di creare una nuova etica sessuale che sia conforme ai nuovi metodi di produzione e di lavoro. D’altronde è necessario procedere a tale regolamentazione e alla creazione di una nuova etica. È da rilevare come gli industriali (specialmente Ford) si siano interessati dei rapporti sessuali dei loro dipendenti e in generale della sistemazione generale delle loro famiglie; la apparenza di «puritanesimo» che ha assunto questo interesse (come nel caso del proibizionismo) non deve trarre in errore; la verità è che non può svilupparsi il nuovo tipo di uomo domandato dalla razionalizzazione della produzione e del lavoro, finché l’istinto sessuale non sia stato conformemente regolato, non sia stato anch’esso razionalizzato.
Q22 §4 Alcune affermazioni sulla quistione di «Stracittà e Strapaese». Brani riferiti dalla «Fiera Letteraria» del 15 gennaio 1928. Di Giovanni Papini: «La città non crea, ma consuma. Com’è l’emporio dove affluiscono i beni strappati ai campi e alle miniere, così vi accorrono le anime più fresche delle province e le idee dei grandi solitari. La città è come un rogo che illumina perché brucia ciò che fu creato lontano da lei e talvolta contro di lei. Tutte le città sono sterili. Vi nascono in proporzione pochi figlioli e quasi mai di genio. Nelle città si gode, ma non si crea, si ama ma non si genera, si consuma ma non si produce». (A parte le numerose sciocchezze «assolute», è da rilevare come il Papini abbia dinanzi il modello «relativo» della città non città, della città Coblenza dei consumatori di rendita agraria e casa di tolleranza).
Nello stesso numero della «Fiera Letteraria» si legge questo brano: «Il nostro arrosto strapaesano si presenta con questi caratteri: avversione decisa a tutte quelle forme di civiltà che non si confacciano alla nostra o che guastino, non essendo digeribili, le doti classiche degli italiani; poi: tutela del senso universale del paese, che è, per dirla alla spiccia, il rapporto naturale e immanente fra l’individuo e la sua terra; infine, esaltazione delle caratteristiche nostrane, in ogni campo e attività della vita, e cioè: fondamento cattolico, senso religioso del mondo, semplicità e sobrietà fondamentali, aderenza alla realtà, dominio della fantasia, equilibrio fra spirito e materia». (Da notare: come sarebbe esistita l’Italia odierna, la nazione italiana, senza il formarsi e lo svilupparsi delle città e senza l’influsso cittadino unificatore? «Strapaesanismo» nel passato avrebbe significato municipalismo – come significò – disgregazione popolare e dominio straniero. E il cattolicismo stesso si sarebbe sviluppato se il Papa, invece di risiedere a Roma, avesse avuto la residenza a Scaricalasino?)
E questo giudizio di Francesco Meriano (pubblicato nell’«Assalto» di Bologna): «Nel campo filosofico, io credo di trovare invece una vera e propria antitesi: che è l’antitesi, vecchia di oltre cento anni e sempre vestita di nuovi aspetti, tra il volontarismo il pragmatismo l’attivismo identificabile nella stracittà e l’illuminismo il razionalismo lo storicismo identificabile nello strapaese». (Cioè gli immortali principii si sarebbero rifugiati in strapaese). In ogni caso è da notare come la polemica «letteraria» tra Strapaese e Stracittà non sia stata altro che la spuma saponacea della polemica tra conservatorismo parassitario e le tendenze innovatrici della società italiana.
Nella «Stampa» del 4 maggio 1929 Mino Maccari scrive: «Quando Strapaese si oppone alle importazioni modernistiche, la sua opposizione vuol salvare il diritto di selezionarle al fine di impedire che i contatti nocivi, confondendosi con quelli che possono essere benefici, corrompano l’integrità della natura e del carattere proprii alla civiltà italiana, quintessenziata nei secoli, ed oggi anelante (!) a una sintesi unificatrice». (Già «quintessenziata», ma non «sintetizzata» e «unificata»!!)
Q22 §5 Eugenio Giovannetti ha scritto, nel «Pègaso» del maggio 1929, un articolo su FedericoTaylor e l’americanismo, in cui scrive: «L’energia letteraria, astratta, nutrita di retorica generalizzante, non è insomma oggi più in grado di capire l’energia tecnica, sempre più individuale ed acuta, tessuto originalissimo di volontà singolare e di educazione specializzata. La letteratura energetica è ancora al suo Prometeo scatenato, immagine troppo comoda. L’eroe della civiltà tecnica non è uno scatenato: è un silenzioso che sa portare pei cieli la sua ferrea catena. Non è un ignorante che si goda l’aria: è uno studioso nel più bel senso classico, perché studium significava “punta viva”. Mentre la civiltà tecnica o meccanistica come volete chiamarla, elabora in silenzio questo suo tipo di eroe incisivo, il culto letterario dell’energia non crea che un gaglioffo aereo, un acchiappanuvole scalmanato».
È da rilevare come non si sia cercato di applicare all’americanismo la formuletta del Gentile sulla «filosofia che non si enunzia in formule ma si afferma nell’azione»; ciò è significativo e istruttivo, perché se la formula ha un valore, è proprio l’americanismo che può rivendicarlo. Invece, quando si parla dell’americanismo, si trova che esso è «meccanicistico», rozzo, brutale, cioè «pura azione», e gli si contrappone la tradizione, ecc. Ma questa tradizione, ecc., perché non viene assunta anche come base filosofica, come la filosofia enunziata in formule di quei movimenti per i quali invece la «filosofia è affermata nell’azione»? Questa contraddizione può spiegare molte cose: la differenza, per esempio, tra l’azione reale, che modifica essenzialmente sia l’uomo che la realtà esterna (cioè la reale cultura) ed è l’americanismo, e il gladiatorismo gaglioffo che si autoproclama azione e modifica solo il vocabolario, non le cose, il gesto esterno, non l’uomo interiore. La prima sta creando un avvenire che è intrinseco alla sua attività obbiettiva e del quale si preferisce tacere. Il secondo crea solo dei fantocci perfezionati, stagliati su un figurino retoricamente prefissato, e che cadranno nel nulla non appena saranno recisi i fili esterni che danno loro l’apparenza del moto e della vita.
Q22 §6 Autarchia finanziaria dell’industria. Un articolo notevole di Carlo Pagni A proposito di un tentativo di teoria pura del corporativismo (nella Riforma Sociale del settembre‑ottobre 1929) esamina il volume di N. Massimo Fovel, Economia e corporativismo (Ferrara, S.A.T.E., 1929) e accenna a un altro scritto dello stesso Fovel, Rendita e salario nello Stato Sindacale (Roma, 1928), ma non si accorge o non mette espressamente in rilievo che il Fovel nei suoi scritti concepisce il «corporativismo» come la premessa per l’introduzione in Italia dei sistemi americani più avanzati nel modo di produrre e di lavorare.
Sarebbe interessante sapere se il Fovel scrive «estraendo dal suo cervello» oppure se egli ha dietro di sé (praticamente e non solo «in generale») determinate forze economiche che lo sorreggono e lo spingono. Il Fovel non è mai stato uno «scienziato» puro, che esprima certe tendenze così come gli intellettuali, anche «puri», esprimono sempre. Egli per molti aspetti, rientra nella galleria del tipo Ciccotti, Naldi, Bazzi, Preziosi, ecc. ma è più complesso, per l’innegabile suo valore intellettuale. Il Fovel ha sempre aspirato a diventare un grande leader politico, e non è riuscito perché gli mancano alcune doti fondamentali: la forza di volontà diretta a un solo fine e la non volubilità intellettuale tipo Missiroli; inoltre troppo spesso egli si è troppo chiaramente legato a piccoli interessi loschi. Ha cominciato come «giovane radicale», prima della guerra: avrebbe voluto ringiovanire, dandogli un contenuto più concreto e moderno, il movimento democratico tradizionale, civettando un po’ coi repubblicani, specialmente federalisti e regionalisti («Critica Politica» di Oliviero Zuccarini). Durante la guerra fu neutralista giolittiano. Nel 1919 entra nel P. S. a Bologna, ma non scrive mai nell’«Avanti!». Prima dell’armistizio fa delle scappate a Torino. Gli industriali torinesi avevano acquistato la vecchia e malfamata «Gazzetta di Torino» per trasformarla e farne un loro organo diretto. Il Fovel aspirava a diventare il direttore della nuova combinazione ed era certamente in contatto con gli ambienti industriali. Invece fu scelto come direttore Tomaso Borelli, «giovane liberale» al quale successe ben presto Italo Minunni dell’«Idea Nazionale» (ma la «Gazzetta di Torino», anche sotto il nome di «Paese» e nonostante le somme prodigate per svilupparla, non attecchì e fu soppressa dai suoi sostenitori). Lettera «curiosa» del Fovel nel 1919: egli scrive che «sente il dovere» di collaborare all’«Ordine Nuovo» settimanale, risposta in cui vengono fissati i limiti di una sua possibile collaborazione, dopo cui la «voce del dovere» si tace repentinamente. Il Fovel si aggregò alla banda Passigli, Martelli, Gardenghi che aveva fatto del «Lavoratore» di Trieste un centro d’affari assai lucrosi e che doveva avere dei contatti con l’ambiente industriale torinese: tentativo di Passigli di trasportare l’«Ordine Nuovo» a Trieste con gestione «commercialmente» redditizia (vedere per la data, la sottoscrizione di 100 lire fatta dal Passigli che era venuto a Torino per parlare direttamente); quistione se un «galantuomo» poteva collaborare al «Lavoratore». Nel 1921 negli uffici del «Lavoratore» furono trovate carte appartenenti al Fovel e al Gardenghi, da cui risultava che i due compari giocavano in borsa sui valori tessili durante lo sciopero guidato dai sindacalisti di Nicola Vecchi e dirigevano il giornale secondo gli interessi del loro gioco. Dopo Livorno, Fovel non fece parlare di sé per qualche tempo. Ricomparve nel 1925, collaboratore dell’«Avanti!» di Nenni e Gardenghi e impostò una campagna favorevole all’infeudamento dell’industria italiana alla finanza americana, campagna subito sfruttata (ma doveva esserci già accordo preventivo) dalla «Gazzetta del Popolo» legata all’ing. Ponti della s.i.p. Nel 25‑26 il Fovel collaborò spesso alla «Voce Repubblicana». Oggi (1929) sostiene il corporativismo come premessa a una forma italiana d’americanizzazione, collabora al «Corriere Padano» di Ferrara, ai «Nuovi Studi», ai «Nuovi Problemi», ai «Problemi del Lavoro» e insegna (pare) all’Università di Ferrara.
Ciò che nella tesi del Fovel, riassunta dal Pagni, pare significativo, è la sua concezione della corporazione come di un blocco industriale‑produttivo autonomo, destinato a risolvere in senso moderno e accentuatamente capitalistico il problema di un ulteriore sviluppo dell’apparato economico italiano, contro gli elementi semifeudali e parassitari della società che prelevano una troppo grossa taglia sul plusvalore, contro i così detti «produttori di risparmio». La produzione del risparmio dovrebbe diventare una funzione interna (a miglior mercato) dello stesso blocco produttivo, attraverso uno sviluppo della produzione a costi decrescenti che permetta, oltre a una maggior massa di plusvalore, più alti salari, con la conseguenza di un mercato interno più capace, di un certo risparmio operaio e di più alti profitti. Si dovrebbe avere così un ritmo più accelerato di accumulazione di capitali nel seno stesso dell’azienda e non attraverso l’intermediario dei «produttori di risparmio» che in realtà sono divoratori di plusvalore. Nel blocco industriale‑produttivo l’elemento tecnico – direzione e operai – dovrebbe avere il sopravvento sull’elemento «capitalistico» nel senso più «meschino» della parola, cioè all’alleanza tra capitani d’industria e piccoli borghesi risparmiatori dovrebbe sostituirsi un blocco di tutti gli elementi direttamente efficienti nella produzione, che sono i soli capaci di riunirsi in Sindacato e quindi di costituire la Corporazione produttiva (donde la conseguenza estrema, tratta dallo Spirito, della Corporazione proprietaria). Il Pagni obbietta al Fovel che la sua trattazione non è una nuova economia politica, ma solo una nuova politica economica, obbiezione formale, che può avere un rilievo in certa sede, ma non tocca l’argomento principale; le altre obbiezioni, concretamente, non sono altro che la constatazione di alcuni aspetti arretrati dell’ambiente italiano per rispetto a un simile rivolgimento «organizzativo» dell’apparecchio economico. Le deficienze maggiori del Fovel consistono nel trascurare la funzione economica che lo Stato ha sempre avuto in Italia per la diffidenza dei risparmiatori verso gli industriali, e nel trascurare il fatto che l’indirizzo corporativo non ha avuto origine dalle esigenze di un rivolgimento delle condizioni tecniche dell’industria e neanche da quelle di una nuova politica economica, ma piuttosto dalle esigenze di una polizia economica, esigenze aggravate dalla crisi del 1929 e ancora in corso. In realtà le maestranze italiane, né come individui singoli né come sindacati, né attivamente né passivamente, non si sono mai opposte alle innovazioni tendenti a una diminuzione dei costi, alla razionalizzazione del lavoro, all’introduzione di automatismi più perfetti e di più perfette organizzazioni tecniche del complesso aziendale. Tutt’altro. Ciò è avvenuto in America e ha determinato la semiliquidazione dei sindacati liberi e la loro sostituzione con un sistema di isolate (fra loro) organizzazioni operaie di azienda. In Italia invece, ogni anche minimo e timido tentativo di fare della fabbrica un centro di organizzazione sindacale (ricordare la quistione dei fiduciari di azienda) è stato combattuto aspramente e stroncato risolutamente. Un’analisi accurata della storia italiana prima del ’22 e anche prima del ’26, che non si lasci allucinare dal carnevale esterno, ma sappia cogliere i motivi profondi del movimento operaio, deve giungere alla conclusione obbiettiva che proprio gli operai sono stati i portatori delle nuove e più moderne esigenze industriali e a modo loro le affermarono strenuamente; si può dire anche che qualche industriale capì questo movimento e cercò di accaparrarselo (così è da spiegare il tentativo fatto da Agnelli di assorbire l’«Ordine Nuovo» e la sua scuola nel complesso Fiat, e di istituire così una scuola di operai e di tecnici specializzati per un rivolgimento industriale e del lavoro con sistemi «razionalizzati»: l’Y.M.C.A. cercò di aprire dei corsi di «americanismo» astratto, ma nonostante le forti somme spese, i corsi fallirono).
A parte queste considerazioni, un’altra serie di quistioni si presenta: il movimento corporativo esiste e per alcuni aspetti le realizzazioni giuridiche già avvenute hanno creato le condizioni formali in cui il rivolgimento tecnico‑economico può verificarsi su larga scala, perché gli operai né possono opporsi ad esso né possono lottare per diventarne essi stessi i portabandiera L’organizzazione corporativa può diventare la forma di tale rivolgimento, ma si domanda: si vedrà una di quelle vichiane «astuzie della provvidenza» per cui gli uomini senza proporselo e senza volerlo ubbidiscano agli imperativi della storia? Per ora, si è portati a dubitarne. L’elemento negativo della «polizia economica» ha avuto finora il sopravvento sull’elemento positivo dell’esigenza di una nuova politica economica che rinnovi, ammodernandola, la struttura economico‑sociale della nazione pur nei quadri del vecchio industrialismo. La forma giuridica possibile è una delle condizioni, non la sola condizione e neanche la più importante: è solo la più importante delle condizioni immediate. L’americanizzazione richiede un ambiente dato, una data struttura sociale (o la volontà decisa di crearla) e un certo tipo di Stato. Lo Stato è lo Stato liberale, non nel senso del liberismo doganale o della libertà effettiva politica, ma nel senso più fondamentale della libera iniziativa e dell’individualismo economico che giunge con mezzi propri, come «società civile», per lo stesso sviluppo storico, al regime della concentrazione industriale e del monopolio. La sparizione del tipo semifeudale del redditiero è in Italia una delle condizioni maggiori del rivolgimento industriale (è, in parte, il rivolgimento stesso), non una conseguenza. La politica economico‑finanziaria dello Stato è lo strumento di tale sparizione: ammortamento del debito pubblico, nominatività dei titoli, maggior peso della tassazione diretta su quella indiretta nella formazione delle entrate di bilancio. Non pare che questo sia o sia per diventare l’indirizzo della politica finanziaria. Anzi. Lo Stato crea nuovi redditieri, cioè promuove le vecchie forme di accumulazione parassitaria del risparmio e tende a creare dei quadri chiusi sociali. In realtà finora l’indirizzo corporativo ha funzionato per sostenere posizioni pericolanti di classi medie, non per eliminare queste e sta sempre più diventando, per gli interessi costituiti che sorgono sulla vecchia base, una macchina di conservazione dell’esistente così come è e non una molla dipropulsione. Perché? Perché l’indirizzo corporativo è anche in dipendenza della disoccupazione: difende agli occupati un certo minimo di vita che, se fosse libera la concorrenza, crollerebbe anch’esso, provocando gravi rivolgimenti sociali; e crea occupazioni di nuovo tipo, organizzativo e non produttivo, ai disoccupati delle classi medie. Rimane sempre una via d’uscita: l’indirizzo corporativo, nato in dipendenza di una situazione così delicata, di cui bisogna mantenere l’equilibrio essenziale a tutti i costi, per evitare una immane catastrofe, potrebbe procedere a tappe lentissime, quasi insensibili, che modifichino la struttura sociale senza scosse repentine: anche il bambino meglio e più solidamente fasciato si sviluppa tuttavia e cresce. Ed ecco perché sarebbe interessante sapere se il Fovel è la voce di se stesso o è l’esponente di forze economiche che cercano, ad ogni costo, la loro via. In ogni caso, il processo sarebbe così lungo e troverebbe tante difficoltà, che nel frattempo nuovi interessi possono costituirsi e fare nuova tenace opposizione al suo sviluppo fino a stroncarlo.
Q22 §7 Mino Maccari e l’americanismo. Dal Trastullo di Strapaese di Mino Maccari (Firenze, Vallecchi, 1928):
Per un ciondolo luccicante / Il tuo paese non regalare: / Il forestiero è trafficante / Dargli retta non è affare / Se tu fossi esperto e scaltro / Ogni mistura terresti discosta: / Chi ci guadagna è sempre quell’altro / Che la tua roba un mondo costa / Val più un rutto del tuo pievano / Che l’America e la sua boria: / Dietro l’ultimo italiano / C’è cento secoli di storia / … Tabarino e ciarlestone / Ti fanno dare in ciampanelle / O Italiano ridatti al trescone / Torna a mangiare il centopelle / Italiano torna alle zolle / Non ti fidar delle mode di Francia / Bada a mangiar pane e cipolle / E terrai a dovere la pancia.
Il Maccari, però, è andato a fare il redattore capo della «Stampa» di Torino e a mangiar pane ecipolle nel centro più stracittadino e industriale d’Italia.
Q22 §8 Quantità e qualità. Nel mondo della produzione significa niente altro che «buon mercato» e «alto prezzo», cioè soddisfazione o no dei bisogni elementari delle classi popolari e tendenza ad elevare o a deprimere il loro tenore di vita: tutto il resto non è altro che romanzo ideologico d’appendice, di cui Guglielmo Ferrero ha scritto la prima puntata. In un’azienda‑nazione, che ha disponibile molta mano d’opera e poche materie prime (ciò che è discutibile, perché ogni nazione‑azienda «si crea» la propria materia prima) il motto: «Qualità!» significa solo la volontà di impiegare molto lavoro su poca materia, perfezionando il prodotto all’estremo, cioè la volontà di specializzarsi per un mercato di lusso. Ma è ciò possibile per un’intiera nazione molto popolosa?
Dove esiste molta materia prima sono possibili i due indirizzi, qualitativo e quantitativo, mentre non esiste reciproca per i così detti paesi poveri. La produzione quantitativa può essere anche qualitativa, cioè fare la concorrenza all’industria puramente qualitativa, tra quella parte della classe consumatrice di oggetti «distinti» che non è tradizionalista perché di nuova formazione. Tali appunti sono validi se si accetta il criterio della «qualità» così come è posto comunemente e che non è un criterio razionale: in realtà si può parlare di «qualità» solo per le opere d’arte individue e non riproducibili, tutto ciò che è riproducibile rientra nel regno della «quantità» e può essere fabbricato in serie.
Si può osservare inoltre: se una nazione si specializza nella produzione «qualitativa», quale industria procurerà gli oggetti di consumo delle classi povere? Si promuoverà una situazione di divisione internazionale del lavoro? Si tratta di niente altro che di una formula da letterati perdigiorno e di politici la cui demagogia consiste nel costruire castelli in aria. La qualità dovrebbe essere attribuita agli uomini e non alle cose: e la qualità umana si eleva e si raffina nella misura in cui l’uomo soddisfa un maggior numero di bisogni e se ne rende quindi indipendente. Il caro prezzo del pane dovuto al fatto di voler mantenere legata a una determinata attività una maggiore quantità di persone, porta alla denutrizione. La politica della qualità determina quasi sempre il suo opposto: una quantità squalificata.
Q22 §9 Dalla recensione che A. De Pietri Tonelli ha pubblicato nella «Rivista di politica economica» (febbraio 1930) del libro di Anthony M. Ludovici, Woman. A vindication (2a ediz., 1929, Londra): «Quando le cose vanno male nella struttura sociale di una nazione, a cagione della decadenza nelle capacità fondamentali dei suoi uomini – afferma il Ludovici – due distinte tendenze sembrano sempre rendersi rilevabili: la prima è quella di interpretare cambiamenti, che sono puramente e semplicemente segni della decadenza e della rovina di vecchie e sane (!) istituzioni, come sintomi di progresso; la seconda, dovuta alla giustificata perdita di confidenza nella classe governante, è di dare a ciascuno, abbia o no le qualità volute, la sicurezza di essere indicato per fare uno sforzo al fine di aggiustare le cose». (La traduzione è manifestamente incerta e inesatta). L’autore fa del femminismo un’espressione di questa seconda tendenza e domanda una rinascita del «maschilismo».
A parte ogni altra considerazione di merito, difficile da fare perché il testo dato del De Pietri Tonelli è incerto, è da rilevare la tendenza antifemminista e «maschilista». È da studiare l’origine della legislazione anglosassone così favorevole alle donne in tutta una serie di conflitti «sentimentali» o pseudo sentimentali. Si tratta di un tentativo di regolare la quistione sessuale, di farne una cosa seria, ma non pare abbia raggiunto il suo scopo: ha dato luogo a deviazioni morbose, «femministiche» in senso deteriore e ha creato alla donna (delle classi alte) una posizione sociale paradossale.
Q22 §10 «Animalità» e industrialismo. La storia dell’industrialismo è sempre stata (e lo diventa oggi in una forma più accentuata e rigorosa) una continua lotta contro l’elemento «animalità» dell’uomo, un processo ininterrotto, spesso doloroso e sanguinoso, di soggiogamento degli istinti (naturali, cioè animaleschi e primitivi) a sempre nuove, più complesse e rigide norme e abitudini di ordine, di esattezza, di precisione che rendano possibili le forme sempre più complesse di vita collettiva che sono la conseguenza necessaria dello sviluppo dell’industrialismo. Questa lotta è imposta dall’esterno e finora i risultati ottenuti, sebbene di grande valore pratico immediato, sono puramente meccanici in gran parte, non sono diventati una «seconda natura». Ma ogni nuovo modo di vivere, nel periodo in cui si impone la lotta contro il vecchio, non è sempre stato per un certo tempo il risultato di una compressione meccanica? Anche gli istinti che oggi sono da superare come ancora troppo «animaleschi» in realtà sono stati un progresso notevole su quelli anteriori, ancor più primitivi: chi potrebbe descrivere il «costo», in vite umane e in dolorosi soggiogamenti degli istinti, del passaggio dal nomadismo alla vita stanziale e agricola? Ci rientrano le prime forme di schiavitù della gleba e del mestiere ecc. Finora tutti i mutamenti del modo di essere e di vivere sono avvenuti per coercizione brutale, cioè attraverso il dominio di un gruppo sociale su tutte le forze produttive della società: la selezione o «educazione» dell’uomo adatto ai nuovi tipi di civiltà, cioè alle nuove forme di produzione e di lavoro, è avvenuta con l’impiego di brutalità inaudite, gettando nell’inferno delle sottoclassi i deboli e i refrattari o eliminandoli del tutto. A ogni avvento di nuovi tipi di civiltà, o nel corso del processo di sviluppo, ci sono state delle crisi. Ma chi fu coinvolto in queste crisi? Non le masse lavoratrici, ma le classi medie e una parte della stessa classe dominante, che avevano sentito anche esse la pressione coercitiva, che necessariamente era esercitata su tutta l’area sociale. Le crisi di libertinismo sono state numerose: ogni epoca storica ne ha avuta una.
Quando la pressione coercitiva viene esercitata su tutto il complesso sociale (e ciò avviene specialmente dopo la caduta della schiavitù e l’avvento del cristianesimo) si sviluppano ideologie puritane che danno la forma esteriore della persuasione e del consenso all’intrinseco uso della forza: ma una volta che il risultato è stato raggiunto, almeno in una certa misura, la pressione si spezza (storicamente questa frattura si verifica in modi diversissimi, come è naturale, perché la pressione ha sempre assunto forme originali, spesso personali; si è identificata con un movimento religioso, ha creato un proprio apparato che si è impersonato in determinati strati o caste, ha preso il nome di Cromwell o di Luigi XV ecc.) e avviene che la crisi di libertinismo (la crisi francese dopo la morte di Luigi XV, per esempio, non può essere paragonata con la crisi americana dopo l’avvento di Roosevelt, né il proibizionismo ha riscontro nelle epoche precedenti, col suo seguito di banditismi ecc.) che però non tocca altro che superficialmente le masse lavoratrici o le tocca indirettamente perché deprava le loro donne: queste masse infatti o hanno già acquisito le abitudini e i costumi necessari ai nuovi sistemi di vita e di lavoro oppure continuano a sentire la pressione coercitiva per le necessità elementari della loro esistenza (anche l’antiproibizionismo non fu voluto dagli operai, e la corruzione che il contrabbando e il banditismo portò con sé era diffusa nelle classi superiori).
Nel dopoguerra si è verificata una crisi dei costumi di estensione e profondità inaudite, ma si è verificata contro una forma di coercizione che non era stata imposta per creare le abitudini conformi a una nuova forma di lavoro, ma per le necessità, già concepite come transitorie, della vita di guerra e di trincea. Questa pressione ha represso specialmente gli istinti sessuali, anche normali, in grandi masse di giovani e la crisi che si è scatenata al momento del ritorno della vita normale è stata resa ancor più violenta dalla sparizione di tanti maschi e da uno squilibrio permanente nel rapporto numerico tra gli individui dei due sessi. Le istituzioni legate alla vita sessuale hanno ricevuto una forte scossa e nella quistione sessuale si sono sviluppate nuove forme di utopia illuministica. La crisi è stata (ed è ancora) resa più violenta dal fatto che ha toccato tutti gli strati della popolazione ed è entrata in conflitto con le necessità dei nuovi metodi di lavoro che intanto si sono venuti imponendo (taylorismo e razionalizzazione in generale). Questi nuovi metodi domandano una rigida disciplina degli istinti sessuali (del sistema nervoso), cioè un rafforzamento della «famiglia» in senso largo (non di questa o quella forma del sistema famigliare), della regolamentazione e stabilità dei rapporti sessuali.
Occorre insistere sul fatto che nel campo sessuale il fattore ideologico più depravante e «regressivo» è la concezione illuministica e libertaria propria delle classi non legate strettamente al lavoro produttivo, e che da questa classi viene contagiata alle classi lavoratrici. Questo elemento diventa tanto più grave se in uno Stato le masse lavoratrici non subiscono più la pressione coercitiva di una classe superiore, se le nuove abitudini e attitudini psicofisiche connesse ai nuovi metodi di produzione e di lavoro devono essere acquistate per via di persuasione reciproca o di convinzione individualmente proposta ed accettata. Può venirsi creando una situazione a doppio fondo, un conflitto intimo tra l’ideologia «verbale» che riconosce le nuove necessità e la pratica reale «animalesca» che impedisce ai corpi fisici l’effettiva acquisizione delle nuove attitudini. Si forma in questo caso quella che si può chiamare una situazione di ipocrisia sociale totalitaria. Perché totalitaria? Nella altre situazioni gli strati popolari sono costretti a osservare la «virtù»; chi la predica, non la osserva, pur rendendole omaggio verbale e quindi l’ipocrisia è di strati, non totale; ciò non può durare, certo, e porterà a una crisi di libertinismo; ma quando già le masse avranno assimilato la «virtù» viene affermata genericamente, ma non osservata né per convinzione né per coercizione e pertanto non ci sarà l’acquisizione delle attitudini psicofisiche necessarie per i nuovi metodi di lavoro. La crisi può diventare «permanente», cioè a prospettiva catastrofica, poiché solo la coercizione potrà definirla, una coercizione di nuovo tipo, in quanto esercitata dalla élite di una classe sulla propria classe, non può essere che un’autocoercizione, cioè un’autodisciplina. (Alfieri che si fa legare alla sedia). In ogni caso, ciò che si può opporre a questa funzione delle élites è la mentalità illuministica e libertaria nella sfera dei rapporti sessuali; lottare contro questa concezione significa poi appunto creare le élites necessarie al compito storico, o almeno svilupparle perché la loro funzione si estenda a tutte le sfere dell’attività umana.
Q22 §11 Razionalizzazione della produzione e del lavoro. La tendenza di Leone Davidovi era strettamente connessa a questa serie di problemi, ciò che non mi pare sia stato messo bene in luce. Il suo contenuto essenziale, da questo punto di vista, consisteva nella «troppo» risoluta (quindi non razionalizzata) volontà di dare la supremazia, nella vita nazionale, all’industria e ai metodi industriali, di accelerare, con mezzi coercitivi esteriori, la disciplina e l’ordine nella produzione, di adeguare i costumi alle necessità del lavoro. Data l’impostazione generale di tutti i problemi connessi alla tendenza, questa doveva sboccare necessariamente in una forma di bonapartismo, quindi la necessità inesorabile di stroncarla. Le sue preoccupazioni erano giuste, ma le soluzioni pratiche erano profondamente errate: in questo squilibrio tra teoria e pratica era insito il pericolo, che del resto si era già manifestato precedentemente, nel 1921. Il principio della coercizione, diretta e indiretta, nell’ordinamento della produzione e del lavoro è giusto (Cfr il discorso pronunziato contro Martov e riportato nel volume sul Terrorismo) ma la forma che esso aveva assunto era errata: il modello militare era diventato un pregiudizio funesto e gli eserciti del lavoro fallirono. Interesse di Leone Davidovi per l’americanismo; suoi articoli, sue inchieste sul «byt» e sulla letteratura, queste attività erano meno sconnesse tra loro di quanto poteva sembrare, poiché i nuovi metodi di lavoro sono indissolubili da un determinato modo di vivere, di pensare e di sentire la vita: non si possono ottenere successi in un campo senza ottenere risultati tangibili nell’altro.
In America la razionalizzazione del lavoro e il proibizionismo sono indubbiamente connessi: le inchieste degli industriali sulla vita intima degli operai, i servizi di ispezione creati da alcune aziende per controllare la «moralità» degli operai sono necessità del nuovo metodo di lavoro. Chi irridesse a queste iniziative (anche se andate fallite) e vedesse in esse solo una manifestazione ipocrita di «puritanismo», si negherebbe ogni possibilità di capire l’importanza, il significato e la portata obbiettiva del fenomeno americano, che è anche il maggior sforzo collettivo verificatosi finora per creare con rapidità inaudita e con una coscienza del fine mai vista nella storia, un tipo nuovo di lavoratore e di uomo. La espressione «coscienza del fine» può sembrare per lo meno spiritosa a chi ricorda la frase del Taylor sul «gorilla ammaestrato». Il Taylor infatti esprime con cinismo brutale il fine della società americana: sviluppare nel lavoratore al massimo grado gli atteggiamenti macchinali ed automatici, spezzare il vecchio nesso psico‑fisico del lavoro professionale qualificato che domandava una certa partecipazione attiva dell’intelligenza, della fantasia, dell’iniziativa del lavoratore e ridurre le operazioni produttive al solo aspetto fisico macchinale. Ma in realtà non si tratta di novità originali: si tratta solo della fase più recente di un lungo processo che si è iniziato col nascere dello stesso industrialismo, fase che è solo più intensa delle precedenti e si manifesta in forme più brutali, ma che essa pure verrà superata con la creazione di un nuovo nesso psico‑fisico di un tipo differente da quelli precedenti e indubbiamente di un tipo superiore. Avverrà ineluttabilmente una selezione forzata, una parte della vecchia classe lavoratrice verrà spietatamente eliminata dal mondo del lavoro e forse dal mondo tout court.
Da questo punto di vista occorre studiare le iniziative «puritane» degli industriali americani tipo Ford. È certo che essi non si preoccupano dell’«umanità», della «spiritualità» del lavoratore che immediatamente viene schiantata. Questa «umanità e spiritualità» non può non realizzarsi che nel mondo della produzione e del lavoro, nella «creazione» produttiva; essa era massima nell’artigiano, nel «demiurgo», quando la personalità del lavoratore si rifletteva tutta nell’oggetto creato, quando era ancora molto forte il legarne tra arte e lavoro. Ma appunto contro questo «umanesimo» lotta il nuovo industrialismo. Le iniziative «puritane» hanno solo il fine di conservare, fuori del lavoro, un certo equilibrio psico‑fisico che impedisca il collasso fisiologico del lavoratore, spremuto dal nuovo metodo di produzione. Questo equilibrio non può essere che puramente esteriore e meccanico, ma potrà diventare interiore se esso sarà proposto dal lavoratore stesso e non imposto dal di fuori, da una nuova forma di società, con mezzi appropriati e originali.
L’industriale americano si preoccupa di mantenere la continuità dell’efficienza fisica del lavoratore, della sua efficienza muscolare‑nervosa: è suo interesse avere una maestranza stabile, un complesso affiatato permanentemente, perché anche il complesso umano (il lavoratore collettivo) di un’azienda è una macchina che non deve essere troppo spesso smontata e rinnovata nei suoi pezzi singoli senza perdite ingenti. Il così detto alto salario è un elemento dipendente da questa necessità: esso è lo strumento per selezionare una maestranza adatta al sistema di produzione e di lavoro e per mantenerla stabilmente. Ma l’alto salario è a due tagli: occorre che il lavoratore spenda «razionalmente» i quattrini più abbondanti, per mantenere, rinnovare e possibilmente per accrescere la sua efficienza muscolare-nervosa, non per distruggerla o intaccarla. Ed ecco la lotta contro l’alcool, l’agente più pericoloso di distruzione delle forze di lavoro, che diventa funzione di Stato. È possibile che anche altre lotte «puritane» divengano funzione di Stato, se l’iniziativa privata degli industriali si dimostra insufficiente o si scatena una crisi di moralità troppo profonda ed estesa nelle masse lavoratrici, ciò che potrebbe avvenire in conseguenza di una crisi lunga ed estesa di disoccupazione.
Quistione legata a quella dell’alcool è l’altra sessuale: l’abuso e l’irregolarità delle funzioni sessuali è, dopo l’alcoolismo, il nemico più pericoloso delle energie nervose ed è osservazione comune che il lavoro «ossessionante» provoca depravazione alcoolica e sessuale. I tentativi fatti dal Ford di intervenire, con un corpo di ispettori, nella vita privata dei suoi dipendenti e controllare come spendevano il loro salario e come vivevano, è un indizio di queste tendenze ancora «private» o latenti, che possono diventare, a un certo punto, ideologia statale, innestandosi nel puritanesimo tradizionale, presentandosi cioè come un rinascimento della morale dei pionieri, del «vero» americanismo, ecc. Il fatto più notevole del fenomeno americano in rapporto a queste manifestazioni è il distacco che si è formato e si andrà sempre più accentuando, tra la moralità‑costume dei lavoratori e quella di altri strati della popolazione. Il proibizionismo ha già dato un esempio di tale distacco. Chi consumava l’alcool introdotto di contrabbando negli S. U.? L’alcool era diventato una merce di gran lusso e neanche i più alti salari potevano permetterne il consumo ai larghi strati delle masse lavoratrici: chi lavora a salario, con un orario fisso, non ha tempo da dedicare alla ricerca dell’alcool, non ha tempo da dedicare allo sport di eludere le leggi.
La stessa osservazione si può fare per la sessualità. La «caccia alla donna» domanda troppi «loisirs»; nell’operaio di tipo nuovo si ripeterà, in altra forma, ciò che avviene nei villaggi contadini. La relativa fissità delle unioni sessuali contadine è strettamente legata al sistema di lavoro della campagna. Il contadino, che torna a casa la sera dopo una lunga giornata di fatica, vuole la «Venerem facilem parabilemque» di Orazio: egli non ha l’attitudine a fare le fusa intorno a donne di fortuna; ama la sua donna, sicura, immancabile, che non farà smancerie e non pretenderà la commedia della seduzione e dello stupro per essere posseduta. Pare che così la funzione sessuale sia meccanizzata, ma in realtà si tratta del sorgere di una nuova forma di unione sessuale, senza i colori «abbaglianti» dell’orpello romantico proprio del piccolo borghese e del bohémien sfaccendato.
Appare chiaro che il nuovo industrialismo vuole la monogamia, vuole che l’uomo‑lavoratore non sperperi le sue energie nervose nella ricerca disordinata ed eccitante del soddisfacimento sessuale occasionale: l’operaio che va al lavoro dopo una notte di «stravizio» non è un buon lavoratore, l’esaltazione passionale non può andar d’accordo coi movimenti cronometrati dei gesti produttivi legati ai più perfetti automatismi. Questo complesso di compressioni e coercizioni dirette e indirette esercitate sulla massa otterrà indubbiamente dei risultati e sorgerà una nuova forma di unione sessuale di cui la monogamia e la stabilità relativa paiono dover essere il tratto caratteristico e fondamentale. Sarebbe interessante conoscere le risultanze statistiche dei fenomeni di deviazione dai costumi sessuali ufficialmente propagandati negli Stati Uniti, analizzati per gruppi sociali: in generale si verificherà che i divorzi sono specialmente numerosi nelle classi superiori.
Questo distacco di moralità tra le masse lavoratrici ed elementi sempre più numerosi delle classi dirigenti, negli Stati Uniti, pare sia uno dei fenomeni più interessanti e ricco di conseguenze. Fino a poco tempo fa quello americano era un popolo di lavoratori: la «vocazione laboriosa» non era un tratto inerente solo alle classi operaie, ma era una qualità specifica anche delle classi dirigenti. Il fatto che un miliardario continuasse ad essere praticamente operoso fino a quando la malattia o la vecchiaia non lo costringessero al riposo e che la sua attività occupasse un numero di ore molto notevole della sua giornata: ecco uno dei fenomeni tipicamente americani, ecco l’americanata più strabiliante per l’europeo medio. È stato notato precedentemente che questa differenza tra americani ed europei è data dalla mancanza di «tradizione» negli Stati Uniti, in quanto tradizione significa anche residuo passivo di tutte le forme sociali tramontate nella storia: negli Stati Uniti invece è recente ancora la «tradizione» dei pionieri, cioè di forti individualità in cui la «vocazione laboriosa» aveva raggiunto la maggior intensità e vigore, di uomini che direttamente, e non per il tramite di un esercito di schiavi o di servi, entravano in contatto energico con le forze naturali per dominarle e sfruttarle vittoriosamente. Sono questi residui passivi che in Europa resistono all’americanismo, «rappresentano la qualità ecc.», perché essi sentono istintivamente che le nuove forme di produzione e di lavoro li spazzerebbero via implacabilmente.
Ma se è vero che in Europa, in tal modo, il vecchiume non ancora seppellito verrebbe definitivamente distrutto, cosa incomincia ad avvenire nella stessa America? Il distacco di moralità su accennato mostra che si stanno creando margini di passività sociale sempre più ampi. Pare che le donne abbiano una funzione prevalente in questo fenomeno. L’uomo‑industriale continua a lavorare anche se miliardario, ma sua moglie e le sue figlie diventano sempre più «mammiferi di lusso». I concorsi di bellezza, i concorsi per il personale cinematografico (ricordare le 30 000 ragazze italiane che nel 1926 inviarono la loro fotografia in costume da bagno alla Fox), il teatro ecc., selezionando la bellezza femminile mondiale e ponendola all’asta, suscitano una mentalità di prostituzione, e la «tratta delle bianche» viene fatta legalmente per le classi alte. Le donne, oziose, viaggiano, attraversano continuamente l’oceano per venire in Europa, sfuggono al proibizionismo patrio e contraggono «matrimoni» stagionali (è da ricordare che fu tolto ai capitani marittimi degli S. U. la facoltà di sanzionare matrimoni a bordo, perché molte coppie si sposavano alla partenza dall’Europa e divorziavano prima dello sbarco in America): la prostituzione reale dilaga, appena larvata da fragili formalità giuridiche.
Questi fenomeni propri delle classi alte renderanno più difficile la coercizione sulle masse lavoratrici per conformarle ai bisogni della nuova industria; in ogni modo determinano una frattura psicologica e accelerano la cristallizzazione e la saturazione dei gruppi sociali, rendendo evidente il loro trasformarsi in caste come è avvenuto in Europa.
Q22 §12 Taylorismo e meccanizzazione del lavoratore. A proposito del distacco che il taylorismo determinerebbe tra il lavoro manuale e il «contenuto umano» del lavoro, si possono fare utili osservazioni sul passato, e proprio a riguardo di quelle professioni che sono ritenute tra le più «intellettuali», le professioni cioè legate alla riproduzione degli scritti per la pubblicazione o per altra forma di diffusione e trasmissione: gli amanuensi di prima dell’invenzione della stampa, i compositori a mano, i linotypisti, gli stenografi, i dattilografi. Se si riflette, si vede che in questi mestieri il processo di adattamento alla meccanizzazione è più difficile che negli altri. Perché? Perché è difficile raggiungere la massima qualifica professionale, che domanda da parte dell’operaio di «dimenticare» o non riflettere al contenuto intellettuale dello scritto che riproduce, per fissare la sua attenzione solo o alla forma calligrafica delle singole lettere, se amanuense, o per scomporre le frasi in parole «astratte» e queste in lettere‑caratteri e rapidamente scegliere i pezzi di piombo nelle caselle, per scomporre non più solo le singole parole, ma gruppi di parole, nel contesto di un discorso, meccanicamente aggruppandoli in sigle stenografiche, per ottenere la rapidità, nel dattilografo ecc. L’interesse del lavoratore per il contenuto intellettuale del testo si misura dai suoi errori, cioè è una deficienza professionale: la sua qualifica è proprio commisurata dal suo disinteressamento intellettuale, cioè dal suo «meccanizzarsi». Il copista medioevale che si interessava al testo, mutava l’ortografia, la morfologia, la sintassi del testo ricopiato, tralasciava periodi interi che non comprendeva, per la sua scarsa cultura, il corso dei pensieri suscitati in lui dall’interesse per il testo lo portava a interpolare glosse e avvertenze; se il suo dialetto o la sua lingua erano diversi da quelli del testo, egli introduceva sfumature alloglottiche; era un cattivo amanuense perché in realtà
«rifaceva» il testo. La lentezza dell’arte scrittoria medioevale spiega molte di queste deficienze: c’era troppo tempo per riflettere e quindi la «meccanizzazione» era più difficile. Il tipografo deve essere molto rapido, deve tenere in continuo movimento le mani e gli occhi e ciò rende più facile la sua meccanizzazione. Ma a pensarci bene, lo sforzo che questi lavoratori devono fare per isolare dal contenuto intellettuale del testo, talvolta molto appassionante (e allora infatti si lavora meno e peggio), la sua simbolizzazione grafica e applicarsi solo a questa, è lo sforzo forse più grande che sia richiesto da un mestiere. Tuttavia esso viene fatto e non ammazza spiritualmente l’uomo. Quando il processo di adattamento è avvenuto, si verifica in realtà che il cervello dell’operaio, invece di mummificarsi, ha raggiunto uno stato di completa libertà. Si è completamente meccanizzato solo il gesto fisico; la memoria del mestiere, ridotto a gesti semplici ripetuti con ritmo intenso, si è «annidata» nei fasci muscolari e nervosi che ha lasciato il cervello libero e sgombro per altre occupazioni. Come si cammina senza bisogno di riflettere a tutti i movimenti necessari per muovere sincronicamente tutte le parti del corpo, in quel determinato modo che è necessario per camminare, così è avvenuto e continuerà ad avvenire nell’industria per i gesti fondamentali del mestiere; si cammina automaticamente e nello stesso tempo si pensa a tutto ciò che si vuole. Gli industriali americani hanno capito benissimo questa dialettica insita nei nuovi metodi industriali. Essi hanno capito che «gorilla ammaestrato» è una frase, che l’operaio rimane «purtroppo» uomo e persino che egli, durante il lavoro, pensa di più o per lo meno ha molto maggiori possibilità di pensare, almeno quando ha superato la crisi di adattamento e non è stato eliminato: e non solo pensa, ma il fatto che non ha soddisfazioni immediate dal lavoro, e che comprende che lo si vuol ridurre a un gorilla ammaestrato, lo può portare a un corso di pensieri poco conformisti. Che una tale preoccupazione esista negli industriali appare da tutta una serie di cautele e di iniziative «educative» che si possono rilevare dai libri del Ford e dall’opera del Philip.
Q22 §13 Gli alti salari. È ovvio pensare che i così detti alti salari sono una forma transitoria di retribuzione. L’adattamento ai nuovi metodi di produzione e di lavoro non può avvenire solo attraverso la coazione sociale: è questo un «pregiudizio» molto diffuso in Europa e specialmente nel Giappone, dove non può tardare ad aver conseguenze gravi per la salute fisica e psichica dei lavoratori, «pregiudizio» che d’altronde ha una base solo nella endemica disoccupazione che si è verificata nel dopo guerra. Se la situazione fosse «normale», l’apparato di coercizione necessario per ottenere il risultato voluto costerebbe più degli alti salari. La coercizione perciò deve essere sapientemente combinata con la persuasione e il consenso e questo può essere ottenuto nelle forme proprie della società data da una maggiore retribuzione che permetta un determinato tenore di vita capace di mantenere e reintegrare le forze logorate dal nuovo tipo di fatica. Ma non appena i nuovi metodi di lavoro e di produzione si saranno generalizzati e diffusi, appena il tipo nuovo di operaio sarà creato universalmente e l’apparecchio di produzione materiale sarà ancora perfezionato, il turnover eccessivo verrà automaticamente ad essere limitato da una estesa disoccupazione e gli alti salari spariranno. In realtà l’industria americana ad alti salari sfrutta ancora un monopolio dato dall’avere l’iniziativa dei nuovi metodi; ai profitti di monopolio corrispondono salari di monopolio. Ma il monopolio sarà necessariamente prima limitato e poi distrutto dalla diffusione dei nuovi metodi sia nell’interno degli S. U. sia all’estero (cfr il fenomeno giapponese dei bassi prezzi delle merci) e coi vasti profitti spariranno gli alti salari. D’altronde è noto che gli alti salari sono necessariamente legati a una aristocrazia operaia e non sono dati a tutti i lavoratori americani.
Tutta l’ideologia fordiana degli alti salari è un fenomeno derivato da una necessità obbiettiva dell’industria moderna giunta a un determinato grado di sviluppo e non un fenomeno primario (ciò che però non esonera dallo studio dell’importanza e delle ripercussioni che l’ideologia può avere per conto suo). Intanto cosa significa «alto salario»? Il salario pagato da Ford è alto solo in confronto alla media dei salari americani, o è alto come prezzo della forza di lavoro che i dipendenti di Ford consumano nella produzione e coi metodi di lavoro del Ford? Non pare che una tale ricerca sia stata fatta sistematicamente, ma pure essa sola potrebbe dare una risposta conclusiva. La ricerca è difficile, ma le cause stesse di tale difficoltà sono una risposta indiretta. La risposta è difficile perché le maestranze Ford sono molto instabili e non è perciò possibile stabilire una media della mortalità «razionale» tra gli operai di Ford da porre a confronto con la media delle altre industrie. Ma perché questa instabilità? Come mai un operaio può preferire un salario «più basso» a quello pagato dal Ford? Non significa questo che i così detti «alti salari» sono meno convenienti a ricostituire la forza di lavoro consumata, di quanto non siano i salari più bassi delle altre aziende? La instabilità delle maestranze dimostra che le condizioni normali di concorrenza tra gli operai (differenza di salario) non operano per ciò che riguarda l’industria Ford che entro certi limiti: non opera il livello diverso tra le medie del salario e non opera la pressione dell’armata di riserva dei disoccupati. Ciò significa che nell’industria Ford è da ricercare un qualche elemento nuovo, che sarà la origine reale sia degli «alti salari» che degli altri fenomeni accennati (instabilità ecc.). Questo elemento non può essere ricercato che in ciò: l’industria Ford richiede una discriminazione, una qualifica, nei suoi operai che le altre industrie ancora non richiedono, un tipo di qualifica di nuovo genere, una forma di consumo di forza di lavoro e una quantità di forza consumata nello stesso tempo medio che sono più gravose e più estenuanti che altrove e che il salario non riesce a compensare in tutti, a ricostituire nelle condizioni date dalla società così com’è. Poste queste ragioni, si presenta il problema: se il tipo di industria e di organizzazione del lavoro e della produzione proprio del Ford sia «razionale», possa e debba cioè generalizzarsi o se invece si tratti di un fenomeno morboso da combattere con la forza sindacale e con la legislazione. Se cioè sia possibile, con la pressione materiale e morale della società e dello Stato, condurre gli operai come massa a subire tutto il processo di trasformazione psicofisica per ottenere che il tipo medio dell’operaio Ford diventi il tipo medio dell’operaio moderno o se ciò sia impossibile perché porterebbe alla degenerazione fisica e al deterioramento della razza, distruggendo ogni forza di lavoro. Pare di poter rispondere che il metodo Ford è «razionale», cioè deve generalizzarsi, ma che perciò sia necessario un processo lungo, in cui avvenga un mutamento delle condizioni sociali e un mutamento dei costumi e delle abitudini individuali, ciò che non può avvenire con la sola «coercizione», ma solo con un contemperamento della coazione (autodisciplina) e della persuasione, sotto forma anche di alti salari, cioè di possibilità di miglior tenore di vita, o forse, più esattamente, di possibilità di realizzare il tenore di vita adeguato ai nuovi modi di produzione e di lavoro, che domandano un particolare dispendio di energie muscolari e nervose.
In misura limitata, ma tuttavia rilevante, fenomeni simili a quelli determinati in larga scala dal Fordismo, si verificavano e si verificano in certi rami di industria o in certi stabilimenti non «fordizzati». Costituire una organica e bene articolata maestranza di fabbrica o una squadra di lavorazione specializzata non è mai stato cosa semplice: ora, una volta la maestranza o la squadra costituite, i suoi componenti, o una parte di essi, finiscono talvolta col beneficiare di un salario di monopolio, non solo, ma non vengono licenziati in caso di arresto temporaneo della produzione; sarebbe antieconomico lasciare disperdere gli elementi di un tutto organico costituito faticosamente perché sarebbe quasi impossibile riaccozzarli insieme, mentre la sua ricostruzione con elementi nuovi, di fortuna, costerebbe tentativi e spese non indifferenti. È questo un limite alla legge della concorrenza determinata dall’armata di riserva e dalla disoccupazione e questo limite è sempre stato all’origine delle formazioni di aristocrazie privilegiate. Poiché non ha mai funzionato e non funziona una legge di equiparazione perfetta dei sistemi e dei metodi di produzione e di lavoro per tutte le aziende di un determinato ramo d’industria, consegue che ogni azienda, in una certa misura più o meno ampia, è «unica», e si forma una maestranza con una qualifica propria alla particolare azienda: piccoli «segreti» di fabbricazione e di lavoro, «trucchi» che sembrano trascurabili in sé, ma che, ripetuti infinità di volte, possono avere una portata economica ingente. Un caso particolare si può studiare nell’organizzazione del lavoro dei porti, specialmente in quelli ove esiste squilibrio tra imbarco e sbarco di merci e dove si verificano ingorghi stagionali di lavoro e morte stagioni. È necessario avere una maestranza che sia sempre disponibile (che non si allontani dal posto di lavoro) per il minimo di lavoro stagionale o d’altro genere, e quindi la formazione dei ruoli chiusi, con gli alti salari e altri privilegi, in contrapposizione alla massa degli «avventizi» ecc. Ciò si verifica anche nell’agricoltura, nel rapporto tra coloni fissi e braccianti e in molte industrie dove esistono le «morte stagioni», per ragioni inerenti all’industria stessa, come l’abbigliamento, o per la difettosa organizzazione del commercio all’ingrosso che fa i suoi acquisti secondo cicli propri, non ingranati col ciclo di produzione, ecc.
Q22 §14 Azioni, obbligazioni, titoli di Stato. Quale radicale mutamento porterà nell’orientamento del piccolo e medio risparmio l’attuale depressione economica se essa, come pare probabile, si prolunga ancora per qualche tempo? Si può osservare che la caduta del mercato azionario ha determinato uno smisurato spostamento di ricchezza e un fenomeno di espropriazione «simultanea» del risparmio di vastissime masse della popolazione, un po’ da per tutto, ma specialmente in America: così i processi morbosi che si erano verificati a causa dell’inflazione, nel primo dopo guerra, si sono rinnovati in tutta una serie di paesi, e hanno operato nei paesi che nel periodo precedente non avevano conosciuto l’inflazione.
Il sistema che il governo italiano ha intensificato in questi anni (continuando una tradizione già esistente, sia pure su scala più piccola) pare il più razionale ed organico, almeno per un gruppo di paesi, ma quali conseguenze potrà avere? Differenza tra azioni comuni e azioni privilegiate, tra queste e le obbligazioni, e tra azioni e obbligazioni del mercato libero e obbligazioni o titoli di Stato. La massa dei risparmiatori cerca di disfarsi completamente delle azioni di ogni genere, svalutate in modo inaudito, preferisce le obbligazioni alle azioni, ma preferisce i titoli di Stato a ogni altra forma di investimento. Si può dire che la massa dei risparmiatori vuole rompere ogni legame diretto con l’insieme del sistema capitalistico privato, ma non rifiuta la sua fiducia allo Stato: vuole partecipare all’attività economica, ma attraverso lo Stato, che garantisca un interesse modico ma sicuro. Lo Stato viene così ad essere investito di una funzione di primordine nel sistema capitalistico, come azienda (holding statale) che concentra il risparmio da porre a disposizione dell’industria e dell’attività privata, come investitore a medio e lungo termine (creazione italiana dei vari Istituti, di Credito mobiliare di ricostruzione industriale ecc.; trasformazione della Banca Commerciale, consolidamento delle Casse di risparmio, creazione di nuove forme nel risparmio postale ecc.). Ma, una volta assunta questa funzione, per necessità economiche imprescindibili, può lo Stato disinteressarsi dell’organizzazione della produzione e dello scambio? lasciarla, come prima, all’iniziativa della concorrenza e all’iniziativa privata? Se ciò avvenisse, la sfiducia che oggi colpisce l’industria e il commercio privato, travolgerebbe anche lo Stato; il formarsi di una situazione che costringesse lo Stato a svalutare i suoi titoli (con l’inflazione o in altra forma) come si sono svalutate le azioni private, diventerebbe catastrofica per l’insieme dell’organizzazione economico‑sociale. Lo Stato è così condotto necessariamente a intervenire per controllare se gli investimenti avvenuti per il suo tramite sono bene amministrati e così si comprende un aspetto almeno delle discussioni teoriche sul regime corporativo. Ma il puro controllo non è sufficiente. Non si tratta infatti solo di conservare l’apparato produttivo così come è in un momento dato; si tratta di riorganizzarlo per svilupparlo parallelamente all’aumento della popolazione e dei bisogni collettivi. Appunto in questi sviluppi necessari è il maggiore rischio dell’iniziativa privata e dovrebbe essere maggiore l’intervento statale, che non è anch’esso scevro di pericoli, tutt’altro. (Si accenna a questi elementi, come a quelli più organici ed essenziali, ma anche altri elementi conducono all’intervento statale, o lo giustificano teoricamente: l’aggravarsi dei regimi doganali e delle tendenze autarchiche, i premi, il dumping, i salvataggi delle grandi imprese in via di fallimento o pericolanti; cioè, come è stato detto, la «nazionalizzazione delle perdite e dei deficit industriali» ecc.).
Se lo Stato si proponesse di imporre una direzione economica per cui la produzione del risparmio da «funzione» di una classe parassitaria fosse per divenire funzione dello stesso organismo produttivo, questi sviluppi ipotetici sarebbero progressivi, potrebbero rientrare in un vasto disegno di razionalizzazione integrale: bisognerebbe perciò promuovere una riforma agraria (con l’abolizione della rendita terriera come rendita di una classe non lavoratrice e incorporazione di essa nell’organismo produttivo, come risparmio collettivo da dedicare alla ricostruzione e a ulteriori progressi) e una riforma industriale, per ricondurre tutti i redditi a necessità funzionali tecnico‑industriali e non più a conseguenze giuridiche del puro diritto di proprietà.
Da questo complesso di esigenze, non sempre confessate, nasce la giustificazione storica delle così dette tendenze corporative, che si manifestano prevalentemente come esaltazione dello Stato in generale, concepito come qualcosa di assoluto e come diffidenza e avversione alle forme tradizionali del capitalismo. Ne consegue che teoricamente lo Stato pare avere la sua base politico‑sociale nella «piccola gente» e negli intellettuali, ma in realtà la sua struttura rimane plutocratica e riesce impossibile rompere i legami col grande capitale finanziario: del resto è lo Stato stesso che diventa il più grande organismo plutocratico, l’holding delle grandi masse di risparmio dei piccoli capitalisti. (Lo Stato gesuitico del Paraguay potrebbe essere utilmente richiamato come modello di molte tendenze contemporanee).
Che possa esistere uno Stato che si basi politicamente sulla plutocrazia e sulla piccola gente nello stesso tempo non è poi del tutto contradditorio, come dimostra un paese esemplare, la Francia, dove appunto non si comprenderebbe il dominio del capitale finanziario senza la base politica di una democrazia di redditieri piccolo‑borghesi e contadini. Tuttavia la Francia, per ragioni complesse, ha ancora una composizione sociale abbastanza sana, perché vi esiste una larga base di piccola e media proprietà coltivatrice. In altri paesi, invece, i risparmiatori sono staccati dal mondo della produzione e del lavoro; il risparmio vi è «socialmente» troppo caro, perché ottenuto con un livello di vita troppo basso dei lavoratori industriali e specialmente agricoli. Se la nuova struttura del credito consolidasse questa situazione, in realtà si avrebbe un peggioramento: se il risparmio parassitario, grazie alla garanzia statale, non dovesse più neanche correre le alee generali del mercato normale, la proprietà terriera parassitaria si rafforzerebbe da una parte e dall’altra le obbligazioni industriali, a dividendo legale, certo graverebbero sul lavoro in modo ancora più schiacciante.
Q22 §15 Civiltà americana ed europea. In una intervista con Corrado Alvaro («L’Italia Letteraria», 14 aprile 1929) Luigi Pirandello afferma: «L’americanismo ci sommerge. Credo che un nuovo faro di civiltà si sia acceso laggiù». «Il denaro che corre il mondo è americano (?!), e dietro al denaro (!) corre il modo di vita e la cultura (ciò è vero solo per la schiuma della società, e di tale schiuma cosmopolita pare che il Pirandello, e con lui molti altri, creda sia costituito tutto il “mondo”). Ha una cultura l’America? (occorrerebbe dire: ha una cultura unitaria e centralizzata, cioè l’America è una nazione del tipo francese, tedesco e inglese?) Ha libri e costumi. I costumi sono la sua nuova letteratura, quella che penetra attraverso le porte più munite e difese. A Berlino lei non sente il distacco tra vecchia e nuova Europa perché la struttura stessa della città non offre resistenze (Pirandello oggi non potrebbe dire lo stesso, e quindi è da comprendere che egli si riferiva alla Berlino dei caffè notturni). A Parigi, dove esiste una struttura storica e artistica, dove le testimonianze di una civiltà autoctona sono presenti, l’americanismo stride come il belletto sulla vecchia faccia di una mondana».
Ma il problema non è se in America esista una nuova civiltà, una nuova cultura, sia pure ancora allo stato di «faro» e se esse stiano invadendo o abbiano già invaso l’Europa: se il problema dovesse porsi così, la risposta sarebbe facile: no, non esiste ecc., e anzi in America non si fa che rimasticare la vecchia cultura europea. Il problema è questo: se l’America, col peso implacabile della sua produzione economica (e cioè indirettamente) costringerà o sta costringendo l’Europa a un rivolgimento della sua assise economico‑sociale troppo antiquata, che sarebbe avvenuto lo stesso, ma con ritmo lento e che immediatamente si presenta invece come un contraccolpo della «prepotenza» americana, se cioè si sta verificando una trasformazione delle basi materiali della civiltà europea, ciò che a lungo andare (e non molto lungo, perché nel periodo attuale tutto è più rapido che nei periodi passati) porterà a un travolgimento della forma di civiltà esistente e alla forzata nascita di una nuova civiltà.
Gli elementi di «nuova cultura» e di «nuovo modo di vita» che oggi si diffondono sotto l’etichetta americana, sono appena i primi tentativi a tastoni, dovuti non già a un «ordine» che nasce da una nuova assise, che ancora non si è formata, ma all’iniziativa superficiale e scimmiesca degli elementi che incominciano a sentirsi socialmente spostati dall’operare (ancora distruttivo e dissolutivo) della nuova assise in formazione. Ciò che oggi viene chiamato «americanismo» è in gran parte la critica preventiva dei vecchi strati che dal possibile nuovo ordine saranno appunto schiacciati e che sono già preda di un’ondata di panico sociale, di dissoluzione, di disperazione, è un tentativo di reazione incosciente di chi è impotente a ricostruire e fa leva sugli aspetti negativi del rivolgimento. Non è dai gruppi sociali «condannati» dal nuovo ordine che si può attendere la ricostruzione, ma da quelli che stanno creando, per imposizione e con la propria sofferenza, le basi materiali di questo nuovo ordine: essi «devono» trovare il sistema di vita «originale» e non di marca americana, per far diventare «libertà» ciò che oggi è «necessità».
Questo criterio che tanto le reazioni intellettuali e morali allo stabilirsi di un nuovo metodo produttivo quanto le esaltazioni superficiali dell’americanismo sono dovute ai detriti dei vecchi strati in isfacelo e non ai gruppi il cui destino è legato a un ulteriore sviluppo del nuovo metodo, è estremamente importante e spiega come alcuni elementi responsabili della politica moderna, che basano la loro fortuna nell’organizzazione dell’insieme dello strato medio, non vogliano prendere posizione ma si mantengano neutrali «teoricamente», risolvendo i problemi pratici col tradizionale metodo dell’empirismo e dell’opportunismo (cfr le diverse interpretazioni date del ruralismo, da U. Spirito, che vuole «urbanizzare» la campagna, agli altri che suonano il flauto di Pan).
Che non si tratti, nel caso dell’americanismo, inteso non solo come vita da caffè ma anche come ideologia del Rotary Club, di un nuovo tipo di civiltà si vede da ciò che nulla è mutato nel carattere e nei rapporti dei gruppi fondamentali: si tratta di un prolungamento organico e di una intensificazione della civiltà europea, che ha solo assunto una epidermide nuova nel clima americano. L’osservazione del Pirandello sull’opposizione che l’americanismo trova a Parigi (ma nel Creusot?) e sull’accoglienza immediata che avrebbe trovato a Berlino, prova, in ogni caso, la non differenza di natura ma solo di grado con l’«europeismo». A Berlino le classi medie erano già state rovinate dalla guerra e dall’inflazione e l’industria berlinese nel suo complesso ha caratteri ben diversi da quella parigina: le classi medie francesi non subirono le crisi occasionali come l’inflazione tedesca né la crisi organica del ’29 sgg. (Nel ms, seguono alcune parole cancellate: «che fu in Germania più rapida del normale ritmo».), con lo stesso ritmo accelerato con cui la subì la Germania. Perciò è vero che a Parigi l’americanismo appaia come un belletto, una superficiale moda straniera.
Q22 §16 Varie. Sono da ricordare alcuni libri di Guglielmo Ferrero sull’America: quanti dei luoghi comuni coniati dal Ferrero sono entrati in circolazione e continuano a essere spesi senza ricordare il conio e la zecca? (Quantità contro qualità, per esempio, è di origine ferreriana, che pertanto è il padre spirituale di tutta l’ideologia scema sul ritorno all’artigianato ecc. Il libro del Ferrero Fra i due mondi è da rivedere come la bibbia di una serie di banalità delle più trite e volgari).
Sull’americanismo è da vedere l’articolo L’America nella letteratura francese del 1927, di Étienne Fournol nella «Nuova Antologia» del 1° aprile 1928, comodo come repertorio delle banalità più marchiane sull’argomento. Parla del libro del Siegfried e di quello del Romier (Qui sera le maître?), accenna a un libro di Andrea Tardieu (Devant l’obstacle: l’Amérique et nous, Parigi, Librairie Emil Paul) e a due libri di Luc Durtain, un romanzo, Hollywood depassé, e una raccolta di novelle, Quarantième étage, editi ambedue dalla N. R. F. e che paiono interessanti.
A proposito del prof. Siegfried è da notare questa sua contraddizione: a p. 350 del suo volume Les États‑Unis d’aujourd’hui egli riconosce nella vita americana «l’aspetto di una società realmente (!) collettivistica, voluto dalle classi elette e accettato allegramente (sic) dalla moltitudine», ma il Siegfried scrive poi la prefazione al volume del Philip sul movimento operaio americano e lo loda, nonostante che non vi si dimostri precisamente questa «allegria» e che in America non esista lotta di classe, ma anzi vi si dimostri l’esistenza della più sfrenata e feroce lotta di una parte contro l’altra. Lo stesso confronto si potrebbe fare tra il libro del Romier e quello del Philip. È da rilevare come in Europa sia stato accettato molto facilmente (e diffuso molto abilmente) il quadro oleografico di un’America senza lotte interne (attualmente i nodi son venuti al pettine) ecc. ecc. Così che nello stesso tempo si è combattuto l’americanismo come sovversivo della stagnante società europea, ma si è presentata l’America come esempio di omogeneità sociale per uso di propaganda e come premessa ideologica di leggi eccezionali.
QUADERNO 23
CRITICA LETTERARIA
Q23 §1 Ritorno al De Sanctis. Cosa significa e cosa può e
dovrebbe significare la parola d’ordine di Giovanni Gentile:
«Torniamo al De Sanctis!»? (cfr tra l’altro il 1° numero del
settimanale «Il Quadrivio»). Significa «tornare» meccanicamente
ai concetti che il De Sanctis svolse intorno all’arte e alla
letteratura, o significa assumere verso l’arte e la vita un
atteggiamento simile a quello assunto dal De Sanctis ai suoi
tempi? Posto questo atteggiamento come «esemplare», è da vedere:
1) in che sia consistita tale esemplarità; 2) quale
atteggiamento sia oggi corrispondente, cioè quali interessi
intellettuali e morali corrispondano oggi a quelli che
dominarono l’attività del De Sanctis e le impressero una
determinata direzione.
Né si può dire che la biografia del De Sanctis, pur essendo essenzialmente coerente, sia stata «rettilinea», come volgarmente s’intende. Il De Sanctis, nell’ultima fase della sua vita e della sua attività, rivolse la sua attenzione al romanzo «naturalista» o «verista» e questa forma di romanzo, nell’Europa occidentale, fu l’espressione «intellettualistica» del movimento più generale di «andare al popolo», di un populismo di alcuni gruppi intellettuali sullo scorcio del secolo scorso, dopo il tramonto della democrazia quarantottesca e l’avvento di grandi masse operaie per lo sviluppo della grande industria urbana. Del De Sanctis è da ricordare il saggio Scienza e Vita, il suo passaggio alla sinistra parlamentare, il suo timore di tentativi forcaioli velati da forme pompose ecc. Un giudizio del De Sanctis: «Manca la fibra perché manca la fede. E manca la fede perché manca la cultura». Ma cosa significa «cultura» in questo caso? Significa indubbiamente una coerente, unitaria e di diffusione nazionale «concezione della vita e dell’uomo», una «religione laica», una filosofia che sia diventata appunto «cultura», cioè abbia generato un’etica, un modo di vivere, una condotta civile e individuale. Ciò domandava innanzi tutto l’unificazione della «classe colta», e in tal senso lavorò il De Sanctis con la fondazione del «Circolo filologico» che avrebbe dovuto determinare «l’unione di tutti gli uomini colti e intelligenti» di Napoli, ma domandava specialmente un nuovo atteggiamento verso le classi popolari, un nuovo concetto di ciò che è «nazionale», diverso da quello della destra storica, più ampio, meno esclusivista, meno «poliziesco» per così dire. È questo lato dell’attività del De Sanctis che occorrerebbe lumeggiare, questo elemento della sua attività che d’altronde non era nuovo ma rappresentava lo sviluppo di germi già esistenti in tutta la sua carriera di letterato e di uomo politico.
Q23 §2 Una nota giovanile di Luigi Pirandello. Pubblicata dalla Nuova Antologia del 1° gennaio 1934 e scritta dal Pirandello negli anni 1889‑90, quando era studente a Bonn: «Noi lamentiamo che alla nostra letteratura manchi il dramma – e sul riguardo si dicono tante cose e tante altre se ne propongono – conforti, esortazioni, additamenti, progetti – opera vana: il vero marcio non si vede e non si vuol vedere. Manca la concezione della vita e dell’uomo. E pure noi abbiamo campo da dare all’epica e al dramma. Arido stupido alessandrinismo, il nostro». Forse però questa nota del Pirandello non fa che riecheggiare discussioni di studenti tedeschi sulla necessità generica di una Weltanschauung ed è più superficiale di quanto non paia. In ogni modo il Pirandello si è fatta una concezione della vita e dell’uomo, ma essa è «individuale», incapace di diffusione nazionale‑popolare, che però ha avuto una grande importanza «critica», di corrosione di un vecchio costume teatrale.
Q23 §3 Arte e lotta per una nuova civiltà. Il rapporto artistico mostra, specialmente nella filosofia della prassi, la fatua ingenuità dei pappagalli che credono di possedere in poche formulette stereotipate, la chiave per aprire tutte le porte (queste chiavi si chiamano propriamente «grimaldelli»). Due scrittori possono rappresentare (esprimere) lo stesso momento storico‑sociale, ma uno può essere artista e l’altro un semplice untorello. Esaurire la quistione limitandosi a descrivere ciò che i due rappresentano o esprimono socialmente, cioè riassumendo, più o meno bene, le caratteristiche di un determinato momento storico‑sociale, significa non sfiorare neppure il problema artistico. Tutto ciò può essere utile e necessario, anzi lo è certamente, ma in un altro campo: in quello della critica politica, della critica del costume, nella lotta per distruggere e superare certe correnti di sentimenti e credenze, certi atteggiamenti verso la vita e il mondo; non è critica e storia dell’arte, e non può essere presentato come tale, pena il confusionismo e l’arretramento o la stagnazione dei concetti scientifici, cioè appunto il non conseguimento dei fini inerenti alla lotta culturale.
Un determinato momento storico‑sociale non è mai omogeneo, anzi è ricco di contraddizioni. Esso acquista «personalità», è un «momento» dello svolgimento, per il fatto che una certa attività fondamentale della vita vi predomina sulle altre, rappresenta una «punta» storica: ma ciò presuppone una gerarchia, un contrasto, una lotta. Dovrebbe rappresentare il momento dato, chi rappresenta questa attività predominante, questa «punta» storica; ma come giudicare chi rappresenta le altre attività, gli altri elementi? Non sono «rappresentativi» anche questi? E non è «rappresentativo» del «momento» anche chi ne esprime gli elementi «reazionari» e anacronistici? Oppure sarà da ritenersi rappresentativo chi esprimerà tutte le forze e gli elementi in contrasto e in lotta, cioè chi rappresenta le contraddizioni dell’insieme storico‑sociale?
Si può anche pensare che una critica della civiltà letteraria, una lotta per creare una nuova cultura, sia artistica nel senso che dalla nuova cultura nascerà una nuova arte, ma ciò appare un sofisma. In ogni modo è forse partendo da tali presupposti che si può intendere meglio il rapporto De Sanctis ‑ Croce e le polemiche sul contenuto e la forma. La critica del De Sanctis è militante, non «frigidamente» estetica, è la critica di un periodo di lotte culturali, di contrasti tra concezioni della vita antagonistiche. Le analisi del contenuto, la critica della «struttura» delle opere; cioè della coerenza logica e storico‑attuale delle masse di sentimenti rappresentati artisticamente sono legate a questa lotta culturale: proprio in ciò pare consista la profonda umanità e l’umanesimo del De Sanctis che rendono tanto simpatico anche oggi il critico. Piace sentire in lui il fervore appassionato dell’uomo di parte che ha saldi convincimenti morali e politici e non li nasconde e non tenta neanche di nasconderli. Il Croce riesce a distinguere questi aspetti diversi del critico che nel De Sanctis erano organicamente uniti e fusi. Nel Croce vivono gli stessi motivi culturali che nel De Sanctis, ma nel periodo della loro espansione e del loro trionfo; continua la lotta, ma per un raffinamento della cultura (di una certa cultura) non per il suo diritto di vivere: la passione e il fervore romantico si sono composti nella serenità superiore e nell’indulgenza piena di bonomia. Ma anche nel Croce questa posizione non è permanente: subentra una fase in cui la serenità e l’indulgenza s’incrinano e affiora l’acrimonia e la collera a stento repressa: fase difensiva non aggressiva e fervida e pertanto non confrontabile con quella del De Sanctis.
Insomma, il tipo di critica letteraria propria della filosofia della prassi è offerto dal De Sanctis, non dal Croce o da chiunque altro (meno che mai dal Carducci): in essa devono fondersi la lotta per una nuova cultura, cioè per un nuovo umanesimo, la critica del costume, dei sentimenti e delle concezioni del mondo con la critica estetica o puramente artistica nel fervore appassionato, sia pure nella forma del sarcasmo.
In un tempo recente alla fase De Sanctis ha corrisposto, su un piano subalterno, la fase della «Voce». Il De Sanctis lottò per la creazione ex novo in Italia di un’alta cultura nazionale, in opposizione ai vecchiumi tradizionali, la retorica e il gesuitismo (Guerrazzi e ilpadre Bresciani): la «Voce» lottò solo per la divulgazione, in uno strato intermedio, di quella stessa cultura, contro il provincialismo ecc. ecc.: la «Voce» fu un aspetto del crocismo militante, perché volle democratizzare ciò che necessariamente era stato «aristocratico» nel De Sanctis e si era mantenuto «aristocratico» nel Croce. Il De Sanctis doveva formare uno Stato Maggiore culturale, la «Voce» volle estendere agli ufficiali subalterni lo stesso tono di civiltà e perciò ebbe una funzione, lavorò nella sostanza e suscitò correnti artistiche, nel senso che aiutò molti a ritrovare se stessi, suscitò un maggior bisogno di interiorità e di espressione sincera di essa, anche se dal movimento non fu espresso nessun grande artista.
(Scritto da Raffaello Ramat nell’«Italia Letteraria» del 4 febbraio 1934: «È stato detto che per la storia della cultura a volte può maggiormente servire lo studio di uno scrittore minore che quello d’un sommo; e in parte è pur vero: perché se in questo – nel sommo – stravince l’individuo, che finisce col non esser più di alcun tempo, e potrebbe darsi il caso – come s’è dato – di attribuire al secolo qualità proprie dell’uomo; in quello, nel minore, pur che sia uno spirito attento e autocritico, è dato scorgere i momenti della dialettica di quella particolare cultura con chiarezza maggiore, in quanto non riescono, come nel sommo, a unificarsi»).
Il problema qui accennato trova un riscontro per assurdo nell’articolo di Alfredo Gargiulo Dalla cultura alla letteratura, nell’«Italia Letteraria» del 6 aprile 1930 (sesto capitolo di uno studio panoramico intitolato 1900‑1930 che sarà probabilmente raccolto in volume e che occorrerà tener presente per «I nipotini delpadre Bresciani»). In questa serie di articoli il Gargiulo mostra il più completo esaurimento intellettuale (uno dei tanti giovani senza «maturità»): egli si è completamente incanagliato nellabanda dell’«Italia Letteraria» e nel capitolo citato assume come proprio questo giudizio espresso da G. B. Angioletti nella prefazione all’antologia Scrittori Nuovi compilata da Enrico Falqui ed Elio Vittorini: «Gli scrittori di questa Antologia sono dunque nuovi non perché abbiano trovato nuove forme o cantato nuovi soggetti, tutt’altro; lo sono perché hanno dell’arte un’idea diversa da quella degli scrittori che li precedettero. O, per venir subito all’essenziale, perché credono all’arte, mentre quelli credevano a molte altre cose che con l’arte nulla avevano a che vedere. Tale novità, perciò, può consentire la forma tradizionale e il contenuto antico; ma non può consentire deviamenti dall’idea essenziale dell’arte. Quale possa essere questa idea, non è qui il luogo di ripetere. Ma mi sia consentito ricordare che gli scrittori nuovi, compiendo una rivoluzione (!) che per essere stata silenziosa (!) non sarà meno memorabile (!), intendono di essere soprattutto artisti, laddove i loro predecessori si compiacevano di essere moralisti, predicatori, estetizzanti, psicologisti, edonisti, ecc.». Il discorso non è molto chiaro e ordinato: se qualcosa di concreto se ne può estrarre è la tendenza a un secentismo programmatico, niente altro. Questa concezione dell’artista è un nuovo «guardarsi la lingua» nel parlare, è un nuovo modo di costruire «concettini». E puri costruttori di concettini, non di immagini, sono i più dei poeti esaltati dalla «banda», con a capo Giuseppe Ungaretti (che tra l’altro scrive una lingua sufficientemente infranciosata e impropria). Il movimento della «Voce» non poteva creare artisti, ut sic, è evidente; ma lottando per una nuova cultura, per un nuovo modo di vivere, indirettamente promuoveva anche la formazione di temperamenti artistici originali, poiché nella vita c’è anche l’arte. La «rivoluzione silenziosa» di cui parla l’Angioletti è stata solo una serie di confabulazioni da caffè e di mediocri articoli di giornale standardizzato e di rivistucole provinciali. La macchietta del «sacerdote dell’arte» non è una grande novità anche se muta il rituale.
Q23 §4 Una massima di Rivarol. «Per lodare un libro non è affatto necessario di aprirlo; ma, se si è deciso di cri ticarlo, è sempre prudente leggerlo. Almeno finché l’autore è vivo...».
Q23 §5 Alcuni criteri di giudizio «letterario». Un lavoro può essere pregevole: 1) Perché espone una nuova scoperta che fa progredire una determinata attività scientifica. Ma non solo l’«originalità» assoluta è un pregio. Può infatti avvenire: 2) che fatti ed argomenti già noti siano stati scelti e disposti secondo un ordine, una connessione, un criterio più adeguato e probante di quelli precedenti. La struttura (l’economia, l’ordine) di un lavoro scientifico può essere «originale» essa stessa. 3) I fatti e gli argomenti già noti possono aver dato luogo a considerazioni «nuove», subordinate, ma tuttavia importanti.
Il giudizio «letterario» deve, evidentemente, tener conto dei fini che un lavoro si è proposto: di creazione e riorganizzazione scientifica, di divulgazione dei fatti ed argomenti noti in un determinato gruppo culturale, di un determinato livello intellettuale e culturale ecc. Esiste perciò una tecnica della divulgazione che occorre adattare volta per volta e rielaborare: la divulgazione è un atto eminentemente pratico, in cui occorre esaminare la conformità dei mezzi al fine, cioè appunto la tecnica adoperata. Ma anche l’esame e il giudizio del fatto e dell’argomentazione «originale», ossia dell’«originalità» dei fatti (concetti ‑ nessi di pensiero) e degli argomenti sono molto difficili e complessi e richiedono le più ampie cognizioni storiche. È da vedere nel capitolo dal Croce dedicato al Loria questo criterio: «Altro è metter fuori una osservazione incidentale, che si lascia poi cadere senza svolgerla, ed altro stabilire un principio di cui si sono scorte le feconde conseguenze; altro enunciare un pensiero generico ed astratto ed altro pensarlo realmente e in concreto; altro, finalmente, inventare, ed altro ripetere di seconda o di terza mano». Si presentano i casi estremi: di chi trova che non c’è mai stato nulla di nuovo sotto il sole e che tutto il mondo è paese, anche nella sfera delle idee e di chi invece trova «originalità» a tutto spiano e pretende sia originale ogni rimasticatura per via della nuova saliva. Il fondamento di ogni attività critica pertanto deve basarsi sulla capacità di scoprire la distinzione e le differenze al di sotto di ogni superficiale e apparente uniformità e somiglianza, e l’unità essenziale al disotto di ogni apparente contrasto e differenziazione alla superficie. (Che occorra, nel giudicare un lavoro, tener conto del fine che l’autore si propone esplicitamente, non significa certo perciò che debba essere sottaciuto o misconosciuto o svalutato un qualsiasi apporto reale dell’autore, anche se in opposizione al fine proposto. Che Cristoforo Colombo si proponesse di andare «a la busca del Gran Khan», non sminuisce il valore del suo viaggio reale e delle sue reali scoperte per la civiltà europea).
Q23 §6 Arte e cultura. Che si debba parlare, per essere esatti, di lotta per una «nuova cultura» e non per una «nuova arte» (in senso immediato) pare evidente. Forse non si può neanche dire, per essere esatti, che si lotta per un nuovo contenuto dell’arte, perché questo non può essere pensato astrattamente, separato dalla forma. Lottare per una nuova arte significherebbe lottare per creare nuovi artisti individuali, ciò che è assurdo, poiché non si possono creare artificiosamente gli artisti. Si deve parlare di lotta per una nuova cultura, cioè per una nuova vita morale che non può non essere intimamente legata a una nuova intuizione della vita, fino a che essa diventi un nuovo modo di sentire e di vedere la realtà e quindi mondo intimamente connaturato con gli «artisti possibili» e con le «opere d’arte possibili». Che non si possa artificiosamente creare degli artisti individuali non significa quindi che il nuovo mondo culturale, per cui si lotta, suscitando passioni e calore di umanità, non susciti necessariamente «nuovi artisti»; non si può, cioè, dire che Tizio e Caio diventeranno artisti, ma si può affermare che dal movimento nasceranno nuovi artisti. Un nuovo gruppo sociale che entra nella vita storica con atteggiamento egemonico, con una sicurezza di sé che prima non aveva, non può non suscitare dal suo intimo personalità che prima non avrebbero trovato una forza sufficiente per esprimersi compiutamente in un certo senso.
Così non si può dire che si formerà una nuova «aura poetica», secondo una frase che è stata di moda qualche anno fa. L’«aura poetica» è solo una metafora per esprimere l’insieme degli artisti già formatisi e rivelatisi o almeno il processo iniziato e già consolidato di formazione e rivelazione.
Q23 §7 Neolalismo. Il neolalismo come manifestazione patologica del linguaggio (vocabolario) individuale. Ma non si può impiegare il termine in senso più generale, per indicare tutta una serie di manifestazioni culturali, artistiche, intellettuali? Cosa sono tutte le scuole e scolette artistiche e letterarie se non manifestazioni di neolalismo culturale? Nei periodi di crisi si hanno le manifestazioni più estese e molteplici di neolalismo. La lingua e i linguaggi. Ogni espressione culturale ha una sua lingua storicamente determinata, ogni attività morale e intellettuale: questa lingua è ciò che si chiama anche «tecnica» e anche «struttura». Se un letterato si mettesse a scrivere in un linguaggio personalmente arbitrario (cioè diventasse un «neolalico» nel senso patologico della parola) e fosse imitato da altri (ognuno con linguaggio arbitrario) si parlerebbe di Babele. La stessa impressione non si prova per il linguaggio (tecnica) musicale, pittorico, plastico ecc. (Questo punto è da meditare e approfondire).
Dal punto di vista della storia della cultura, e quindi anche della «creazione» culturale (da non confondersi con la creazione artistica, ma da avvicinare invece alle attività politiche, e infatti in questo senso si può parlare di una «politica culturale») tra l’arte letteraria e le altre forme di espressione artistica (figurative, musicali, orchestriche ecc.) esiste una differenza che bisognerebbe definire e precisare in modo teoricamente giustificato e comprensibile. L’espressione «verbale» ha un carattere strettamente nazionale‑popolare‑culturale: una poesia di Goethe, nell’originale, può essere capita e rivissuta compiutamente solo da un tedesco (o da chi si è «intedescato»). Dante può essere capito e rivissuto solo da un italiano colto ecc. Una statua di Michelangelo, un brano musicale di Verdi, un balletto russo, un quadro di Raffaello ecc., possono invece essere capiti quasi immediatamente da qualsiasi cittadino del mondo, anche di spiriti non cosmopolitici, anche se non ha superato l’angusta cerchia di una provincia del suo paese.
Tuttavia la cosa non è così semplice come potrebbe credersi tenendosi alla buccia. L’emozione artistica che un giapponese o un lappone prova dinanzi a una statua di Michelangelo o ascoltando una melodia di Verdi è certo un’emozione artistica (lo stesso giapponese o lappone resterebbe insensibile e sordo se ascoltasse la declamazione di una poesia di Dante, di Goethe, di Shelley o ammirerebbe l’arte del declamatore come tale); tuttavia l’emozione artistica del giapponese o del lappone non sarà della stessa intensità e colore dell’emozione di un italiano medio e tanto meno di un italiano colto. Ciò che significa che accanto o meglio al di sotto dell’espressione di carattere cosmopolitico del linguaggio musicale, pittorico ecc., c’è una più profonda sostanza culturale, più ristretta, più «nazionale‑popolare».
Non basta: i gradi di questo linguaggio sono diversi; c’è un grado nazionale‑popolare (e spesso prima di questo un grado provinciale‑dialettale‑folcloristico), poi il grado di una determinata «civiltà», che può determinarsi empiricamente dalla tradizione religiosa (per esempio cristiana, ma distinta in cattolica, protestante, ortodossa ecc.) e anche, nel mondo moderno, di una determinata «corrente culturale‑politica». Durante la guerra, per esempio, un oratore inglese, francese, russo, poteva parlare a un pubblico italiano, nella sua lingua incompresa, delle devastazioni compiute dai tedeschi nel Belgio; se il pubblico simpatizzava con l’oratore, il pubblico ascoltava attentamente e «seguiva» l’oratore, si può dire che lo «comprendeva». È vero che nell’oratoria non è solo elemento la «parola»: c’è il gesto, il tono della voce ecc., cioè un elemento musicale che comunica il leitmotiv del sentimento predominante, della passione principale e l’elemento orchestrico: il gesto in senso largo che scandisce e articola l’onda sentimentale e passionale.
Per stabilire una politica di cultura queste osservazioni sono indispensabili; per una politica di cultura delle masse popolari esse sono fondamentali. Ecco la ragione del «successo» internazionale del cinematografo modernamente e, prima, del melodramma e della musica in generale.
Q23 §8 Ricerca delle tendenze e degli interessi morali e intellettuali prevalenti tra i letterati. Per quali forme di attività hanno «simpatia» i letterati italiani? Perché l’attività economica, il lavoro come produzione individuale e di gruppo non li interessa? Se nelle opere d’arte si tratta di argomento economico, è il momento della «direzione», del «dominio», del «comando» di un «eroe» sui produttori che interessa. Oppure interessa la generica produzione, il generico lavoro in quanto generico elemento della vita e della potenza nazionale, e quindi motivo di volate oratorie. La vita dei contadini occupa un maggior spazio nella letteratura, ma anche qui non come lavoro e fatica, ma dei contadini come «folclore», come pittoreschi rappresentanti di costumi e sentimenti curiosi e bizzarri: perciò la «contadina» ha ancora più spazio, coi suoi problemi sessuali nel loro aspetto più esterno e romantico e perché la donna con la sua bellezza può facilmente salire ai ceti sociali superiori.
Il lavoro dell’impiegato è fonte inesausta di comicità: in ogni impiegato si vede l’Oronzo E. Marginati del vecchio «Travaso». Il lavoro dell’intellettuale occupa poco spazio, o è presentato nella sua espressione di «eroismo» e di «superumanismo», con l’effetto comico che gli scrittori mediocri rappresentano «genii» della loro propria taglia e, si sa, se un uomo intelligente può fingersi sciocco, uno sciocco non può fingersi intelligente.
Non si può certo imporre a una o a più generazioni di scrittori di aver «simpatia» per uno o altro aspetto della vita, ma che una o più generazioni di scrittori abbiano certi interessi intellettuali e morali e non altri ha pure un significato, indica che un certo indirizzo culturale predomina fra gli intellettuali. Anche il verismo italiano si distingue dalle correnti realistiche degli altri paesi, in quanto o si limita a descrivere la «bestialità» della così detta natura umana (un verismo in senso gretto) oppure rivolge la sua attenzione alla vita provinciale e regionale, a ciò che era l’Italia reale in contrasto con l’Italia «moderna» ufficiale: non offre apprezzabili rappresentazioni del lavoro e della fatica. Per gli intellettuali della tendenza verista la preoccupazione assillante non fu (come in Francia) di stabilire un contatto con le masse popolari già «nazionalizzate» in senso unitario, ma di dare gli elementi da cui appariva che l’Italia reale non era ancora unificata: del resto c’è differenza tra il verismo degli scrittori settentrionali e di quelli meridionali (per esempio Verga, nel quale il sentimento unitario era molto forte, come appare dall’atteggiamento assunto nel 1920 verso il movimento autonomista di «Sicilia Nuova»).
Ma non basta che gli scrittori non ritengano degna di epos l’attività produttiva che pure rappresenta tutta la vita degli elementi attivi della popolazione: quando se ne occupano, il loro atteggiamento è quello del Padre Bresciani.
(Sono da vedere gli scritti di Luigi Russo sul Verga e su G. C. Abba). G. C. Abba può essere citato come esempio italiano di scrittore «nazionale‑popolare», pur non essendo «popolaresco» e non facendo parte di nessuna corrente che critichi per ragioni di partito o settarie la posizione della classe dirigente. Sono da analizzare non solo gli scritti dell’Abba che hanno valore poetico, ma anche gli altri, come quello rivolto ai soldati, che fu premiato dalle autorità governative e militari e per qualche tempo fu diffuso nell’esercito. Nella stessa direzione è da ricordare il saggio del Papini pubblicato in «Lacerba»Nel ms: «nell’Acerba». dopo gli avvenimenti del giugno 1914. La posizione di Alfredo Oriani è anche da rilevare, ma essa è troppo astratta e oratoria, e deturpata dal suo titanismo di genio incompreso. Qualcosa è notevole nell’opera di Piero Jahier (ricordare le simpatie dello Jahier per il Proudhon), anche di carattere popolare‑militare, mal condita però dallo stile biblico e claudelliano dello scrittore, che spesso lo rende meno efficace e indisponente, perché maschera una forma snobistica di retorica. (Tutta la letteratura di Strapaese dovrebbe essere «nazionale‑popolare» come programma, ma lo è appunto per programma, ciò che la ha resa una manifestazione deteriore della cultura: il Longanesi deve anche aver scritto un libriccino per le reclute, ciò che dimostra come le scarse tendenze nazionali-popolari nascano forse più che altro da preoccupazioni militari). La preoccupazione nazionale‑popolare nell’impostazione del problema critico‑estetico e morale‑culturale appare rilevante in Luigi Russo (del quale è da vedere il volumetto su i Narratori) come risultato di un «ritorno» alle esperienze del De Sanctis dopo il punto d’arrivo del crocianesimo.
È da osservare che il Brescianesimo in fondo è individualismo antistatale e antinazionale anche quando e quantunque si veli di nazionalismo e statalismo frenetico. «Stato» significa specialmente direzione consapevole delle grandi moltitudini nazionali; è quindi necessario un «contatto» sentimentale e ideologico con tali moltitudini e, in una certa misura, simpatia e comprensione dei loro bisogni e delle loro esigenze. Ora, l’assenza di una letteratura nazionale‑popolare, dovuta all’assenza di preoccupazioni e di interesse per questi bisogni ed esigenze, ha lasciato il «mercato» letterario aperto all’influsso di gruppi intellettuali di altri paesi, che «popolari‑nazionali» in patria, lo diventano in Italia perché le esigenze e i bisogni che cercano soddisfare sono simili anche in Italia. Così il popolo italiano si è appassionato, attraverso il romanzo storico‑popolare francese (e continua ad appassionarsi, come dimostrano anche i più recenti bollettini librari), alle tradizioni francesi, monarchiche e rivoluzionarie e conosce la figura popolaresca di Enrico IV più che quella di Garibaldi, la Rivoluzione del 1789 più che il Risorgimento, le invettive di Victor Hugo contro Napoleone III più che le invettive dei patrioti italiani contro Metternich; si appassiona per un passato non suo, si serve nel suo linguaggio e nel suo pensiero di metafore e di riferimenti culturali francesi ecc., è culturalmentepiù francese che italiano.
Per l’indirizzo nazionale‑popolare dato dal De Sanctis alla sua attività critica, è da vedere l’opera di Luigi Russo: Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, 1860‑1885, Ed. La Nuova Italia, 1928 e il saggio del De Sanctis La Scienza e la Vita. Si può forse dire che il De Sanctis abbia fortemente sentito il contrasto «Riforma‑Rinascimento», cioè appunto il contrasto tra Vita e Scienza che era nella tradizione italiana come una debolezza della struttura nazionale‑statale e abbia cercato di reagire contro di esso. Ecco perché ad un certo punto si stacca dall’idealismo speculativo e si avvicina al positivismo e al verismo (simpatie per Zola, come il Russo per Verga e Di Giacomo). Come pare osservi il Russo nel suo libro (cfr la recensione di G. Marzot, nella «Nuova Italia» del maggio 1932) «il Segreto dell’efficacia di De Sanctis è tutto da cercare nella sua spiritualità democratica, la quale lo fa sospettoso e nemico di ogni movimento o pensiero che assuma carattere assolutistico e privilegiato …; e nella tendenza e nel bisogno di concepire lo studio come momento di un’attività più vasta, sia spirituale che pratica, racchiusa nella formula di un suo famoso discorso La Scienza e la Vita».
L’antidemocrazia negli scrittori brescianeschi non ha nessun significato politicamente rilevante e coerente; è la forma di opposizione a ogni forma di movimento nazionale-popolare, determinato dallo spirito economico‑corporativo di casta, di origine medioevale e feudale.
Q23 §9 I nipotini di padre Bresciani. Esame di una parte cospicua della letteratura narrativa italiana, specialmente degli ultimi decenni. La preistoria del Brescianesimo moderno (del dopoguerra) può essere identificata in una serie di scrittori come: Antonio Beltramelli, con libri del tipo Gli Uomini Rossi, Il Cavalier Mostardo ecc.; Polifilo (Luca Beltrami), con le diverse rappresentazioni dei «popolari di Casate Olona»; ecc. La letteratura abbastanza folta e diffusa in certi ambienti e che ha un carattere più tecnicamente «sagrestano»; essa è poco conosciuta nell’ambiente laico di cultura e per niente studiata. Il suo carattere tendenzioso e propagandistico è apertamente confessato: si tratta della «buona stampa». Tra la letteratura di sagrestia e il Brescianesimo laico sta una corrente letteraria che negli ultimi anni si è molto sviluppata (gruppo cattolico fiorentino guidato da Giovanni Papini, ecc.): un esempio tipico di essa sono i romanzi di Giuseppe Molteni. Uno di questi, L’Ateo, riflette il mostruoso scandalo Don Riva ‑ suor Fumagalli in un modo ancor più mostruosamente aberrante: il Molteni giunge ad affermare che appunto per la sua qualità di prete obbligato al celibato e alla castità bisogna compatire Don Riva (che violentò e contagiò una trentina di fanciullette di pochi anni, offertegli dalla Fumagalli per tenerselo «fedele») e crede che a tale massacro possa essere contrapposto, come moralmente equivalente, il volgare adulterio di un avvocato ateo. Il Molteni era molto noto nel mondo letterario cattolico: è stato critico letterario e articolista di tutta una serie di quotidiani e periodici clericali, fra i quali l’«Italia» e «Vita e Pensiero».
Il Brescianesimo assume una certa importanza nel «laicato» letterario del dopoguerra e va sempre più diventando la «scuola» narrativa preminente e ufficiosa.
Ugo Ojetti e il romanzo Mio figlio ferroviere. Caratteristiche generali della letteratura dell’Ojetti e diversi atteggiamenti «ideologici» dell’uomo. Scritti sull’Ojetti di Giovanni Ansaldo che d’altronde rassomiglia all’Ojetti molto più di quanto potesse parere una volta. La manifestazione più caratteristica di Ugo Ojetti è la sua lettera aperta al padre Enrico Rosa, pubblicata nel «Pègaso» e riprodotta nella «Civiltà Cattolica» con commento del Rosa. L’Ojetti dopo l’annunzio della avvenuta conciliazione tra Stato e Chiesa non solo era persuaso che ormai tutte le manifestazioni intellettuali italiane sarebbero state controllate secondo uno stretto conformismo cattolico e clericale, ma si era già adattato a questa idea e si rivolse al padre Rosa con uno stile untuosamente adulatorio delle benemerenze culturali della Compagnia di Gesù per impetrare una «giusta» libertà artistica. Non si può dire, alla luce degli avvenimenti posteriori (discorso alla Camera del Capo del Governo) se sia stata più abbietta la prostrazione dell’Ojetti o più comica la sicura baldanza del padre Rosa che, in ogni caso, diede una lezione di carattere all’Ojetti, s’intende al modo dei gesuiti. L’Ojetti è rappresentativo da più punti di vista: ma la codardia intellettuale dell’uomo supera ogni misura normale.
Alfredo Panzini: già nella preistoria con qualche brano, per esempio, della Lanterna di Diogene (l’episodio del «livido acciaro» vale un poema di comicità), poi Il padrone sono me, Il mondo è rotondo e quasi tutti i suoi libri dalla guerra in poi. Nella Vita di Cavour è contenuto un accenno proprio al padre Bresciani, veramente strabiliante se non fosse sintomatico. Tutta la letteratura pseudo‑storica del Panzini è da riesaminare dal punto di vista del Brescianesimo laico. L’episodio Croce‑Panzini, riferito nella «Critica» è un caso digesuitismo personale, oltre che letterario.
Di Salvatore Gotta si può dire ciò che il Carducci scrisse del Rapisardi: «Oremus sull’altare, e flatulenze in sacrestia»; tutta la sua produzione letteraria è brescianesca.
Margherita Sarfatti e il suo romanzo Il Palazzone. Nella recensione di Goffredo Bellonci pubblicata dall’«Italia Letteraria» del 23 giugno 1929, si legge: «verissima quella timidezza della vergine che si ferma pudica innanzi al letto matrimoniale mentre pur sente che “esso è benigno e accogliente per le future giostre”». Questa vergine pudica che sente con le espressioni tecniche dei novellieri licenziosi è impagabile: la vergine Fiorella avrà presentito anche le future «molte miglia» e il suo «pelliccione» ben scosso. Sul punto delle giostre ci sarebbe da fare qualche amena divagazione: si potrebbe ricordare l’episodio leggendario su Dante e la meretricula, riportato nella raccolta Papini (Carabba) per dire che di «giostre» può parlar l’uomo, non la donna; sarebbe anche da ricordare l’espressione del cattolico Chesterton nella Nuova Gerusalemme sulla chiave e la serratura a proposito della lotta dei sessi, per dire che il punto di vista della chiave non può essere quello della serratura. (È da rilevare come Goffredo Bellonci, che civetta volentieri con l’erudizione «preziosa» – a buon mercato – per fare spicco nel giornalistume romano, trovi «vero» che una vergine pensi alle giostre).
Mario Sobrero e il romanzo Pietro e Paolo può rientrare nel quadro generale del Brescianesimo per il chiaroscuro.
Francesco Perri e il romanzo Gli emigranti. Questo Perri non è poi Paolo Albatrelli dei Conquistatori? In ogni modo è da tener conto anche dei Conquistatori. Negli Emigranti il tratto più caratteristico è la rozzezza, ma non la rozzezza del principiante ingenuo che in tal caso potrebbe essere il grezzo non elaborato ma che lo può diventare: una rozzezza opaca, materiale, non da primitivo ma da rimbambito pretenzioso. Secondo il Perri il suo romanzo sarebbe «verista» ed egli sarebbe l’iniziatore di una specie di neorealismo; ma può oggi esistere un verismo non storicistico? Il verismo stesso del secolo XIX è stato in fondo una continuazione del vecchio romanzo storico nell’ambiente dello storicismo moderno. Negli Emigranti manca ogni accenno cronologico e si capisce. Vi sono due riferimenti generici: uno al fenomeno dell’emigrazione meridionale, che ha avuto un certo decorso storico e uno ai tentativi di invasione delle terre signorili «usurpate» al popolo che anche essi possono essere ricondotti a epoche ben determinate. Il fenomeno migratorio ha creato una ideologia (il mito dell’America) che ha contrastato la vecchia ideologia alla quale erano legati i tentativi sporadici ma endemici di invasione delle terre, prima della guerra. Tutt’altro è il movimento del 19‑20 che è simultaneo e generalizzato ed ha una organizzazione implicita nel combattentismo meridionale. Negli Emigranti tutte queste distinzioni storiche, che sono essenziali per comprendere e rappresentare la vita del contadino, sono annullate e l’insieme confuso si riflette in modo rozzo, brutale, senza elaborazione artistica. È evidente che il Perri conosce l’ambiente popolare calabrese non immediatamente, per esperienza propria sentimentale e psicologica, ma per il tramite di vecchi schemi regionalistici (se egli è l’Albatrelli occorre tener conto delle sue origini politiche, mascherate da pseudonimi per non perdere, nel 1924, l’impiego al Comune o alla Provincia di Milano). L’occupazione (il tentativo di) a Pandure nasce da «intellettuali», su una base giuridica (nientemeno che le leggi eversive di G. Murat) e termina nel nulla, come se il fatto (che pure è verbalmente presentato come un’emigrazione di popolo in massa) non avesse sfiorato neppure le abitudini di un villaggio patriarcale. Puro meccanismo di frasi. Così l’emigrazione. Questo villaggio di Pandure, con la famiglia di Rocco Blèfari, è (per dirla con la parola di un altro calabrese dal carattere temprato come l’acciaio, Leonida Répaci) un parafulmine di tutti i guai. Insistenza sugli errori di parola dei contadini, che è tipica del Brescianesimo, se non dell’imbecillità letteraria in generale. Le «macchiette» (Il Galeoto ecc.), compassionevoli, senza arguzia e umorismo. L’assenza di storicità è «voluta» per poter mettere in un sacco alla rinfusa tutti i motivi folcloristici generici, che in realtà sono molto ben distinti nel tempo e nello spazio.
Leonida Répaci: nell’Ultimo Cireneo è da smontare il congegno combinato in modo rivoltante; da vedere I fratelli Rupe che sarebbero i fratelli Répaci che pare siano stati da qualcuno paragonati ai Cairoli.
Umberto Fracchia: da vedere specialmente: Angela Maria. (Nel quadro generale occupano il primo posto Ojetti-Beltramelli‑Panzini; in essi il carattere gesuitesco‑retorico è più appariscente, e più importante è il posto loro assegnato nelle valutazioni letterarie più correnti).
Q23 §10 Due generazioni. La vecchia generazione degli intellettuali è fallita, ma ha avuto una giovinezza (Papini, Prezzolini, Soffici, ecc.). La generazione attuale non ha neanche questa età delle brillanti promesse (Titta Rosa, Angioletti, Malaparte ecc.). Asini brutti anche da piccoletti.
Q23 §11 G. Papini. È diventato il «pio autore» della «Civiltà Cattolica».
Q23 §12 A. Panzini. Nell’«Italia che scrive» del giugno 1929, Fernando Palazzi, recensendo I giorni del sole e del grano del Panzini, nota: «… soprattutto si occupa e si preoccupa della vita campestre come può occuparsene un padrone che vuol essere tranquillo sulle doti lavorative delle bestie da lavoro che possiede, sia di quelle quadrupedi, sia di quelle bipedi e che a veder un campo coltivato, pensa subito se il raccolto sarà quale spera». Panzini negriero, in una parola.
Q23 §13 Leonida Répaci. Nella sua novella «autobiografica», Crepuscolo («Fiera Letteraria», 3 marzo 1929) scrive: «A quell’epoca io già schieravo dentro di me, fortificandole ogni giorno sulle ime radici dell’istinto, quelle belle qualità che più tardi, negli anni a venire, avrebbero fatto di me una centrale di guai: l’amore dei vinti, degli offesi, degli umili, lo sprezzo del pericolo per la giusta causa, l’indipendenza del carattere che palesa la rettitudine, l’orgoglio matto che braveggia persino sulle rovine, ecc. ecc.». Quante belle qualità ha poi perduto Leonida Répaci! Pare invece che fino dalla più tenera infanzia, per ottenere una lode letteraria del «Corriere della Sera», il Répaci sarebbe passato sul corpo di sua madre.
Q23 §14 Curzio Malaparte. Il suo vero nome è Kurt Erich Suckert, italianizzato verso il 1924 in Malaparte per un bisticcio con i Buonaparte (cfr collezione della rivista «La Conquista dello Stato»). Nel primo dopoguerra sfoggiò il nome straniero. Appartenne all’organizzazione di Guglielmo Lucidi che arieggiava al gruppo francese di «Clarté» di H. Barbusse e al gruppo inglese del «Controllo democratico»; nella collezione della rivista del Lucidi intitolata «Rassegna (o Rivista) Internazionale» pubblicò un libro di guerra La rivolta dei santi maledetti, una esaltazione del presunto atteggiamento disfattista dei soldati italiani a Caporetto, brescianescamente corretta in senso contrario nella edizione successiva e quindi ritirata dal commercio. Il carattere prevalente del Suckert è uno sfrenato arrivismo, una smisurata vanità e uno snobismo camaleontesco: per aver successo il Suckert era capace di ogni scelleraggine. Suoi libri sull’Italia barbara e sua esaltazione della «Controriforma»; niente di serio e di meno che superficiale.
A proposito dell’esibizione del nome straniero (che a un certo punto cozzava con gli accenni a un razzismo e popolarismo di princisbecco e fu perciò sostituito dallo pseudonimo, in cui Kurt – Corrado – viene latinizzato in Curzio) è da notare una corrente abbastanza diffusa in certi intellettuali italiani del tipo «moralisti» o moralizzatori: essi erano portati a ritenere che all’estero si era più onesti, più capaci, più intelligenti che in Italia. Questa «esteromania» assumeva forme tediose e talvolta repugnanti in tipi invertebrati come il Graziadei, ma era più diffusa che non si creda e dava luogo a pose snobistiche rivoltanti; è da ricordare il breve colloquio con Giuseppe Prezzolini a Roma nel 1924 e la sua esclamazione sconsolata: «Avrei dovuto procurare a tempo ai miei figli la nazionalità inglese» o qualcosa di simile. Tale stato d’animo pare non sia stato caratteristico solo di alcuni gruppi intellettuali italiani, ma si sia verificato, in certe epoche di avvilimento morale, anche in altri paesi. In ogni modo è un segno rilevante di assenza di spirito nazionale‑popolare oltre che di stupidaggine. Si confonde tutto un popolo con alcuni strati corrotti di esso, specialmente della piccola borghesia (in realtà poi questi signori, essi stessi, appartengono essenzialmente a questi strati) che nei paesi essenzialmente agricoli, arretrati civilmente e poveri, è molto diffusa e può paragonarsi al Lumpen‑proletariat delle città industriali; la camorra e la maffia non è altro che una simile forma di malavita che vive parassitariamente sui grandi proprietari e sul contadiname. I moralizzatori cadono nel pessimismo più scempio perché le loro prediche lasciano il tempo che trovano; i tipi come Prezzolini, invece di concludere alla propria inettitudine organica, trovano più comodo giungere alla conclusione della inferiorità di un intero popolo, per cui non rimane altro che accomodarsi: «Viva Franza, viva Lamagna, purché se magna!» Questi uomini, anche se talvolta mostrano un nazionalismo dei più spinti, dovrebbero essere segnati dalla polizia tra gli elementi capaci di far la spia contro il proprio paese.
Q23 §15 Ugo Ojetti. Ricercare il giudizio brusco e tagliente datone dal Carducci.
Q23 §16 G. Papini. G. Papini, quando voleva far venire i vermi ai filistei italiani, nel 1912‑13, scrisse in «Lacerba», l’articolo Gesù Peccatore, sofistica raccolta di aneddoti e di sforzate congetture tratte dagli Evangeli apocrifi. Per questo articolo pareva dovesse subire un’azione giudiziaria, con grande suo spavento. Aveva sostenuto come plausibile e probabile l’ipotesi di rapporti omosessuali tra Gesù e Giovanni. Nel suo articolo su Cristo romano, nel volume Gli operai della vigna, con gli stessi procedimenti critici e lo stesso «vigore» intellettuale, sostiene che Cesare è un precursore di Cristo, fatto nascere a Roma dalla Provvidenza per preparare il terreno al cristianesimo. In un terzo periodo è probabile che il Papini, impiegando le geniali illuminazioni critiche che caratterizzano A. Loria, giunga a concludere della necessità di rapporti tra il cristianesimo e l’inversione.
Q23 §17 Filippo Crispolti. In un articolo pubblicato nel «Momento» del giugno 1928 (prima quindicina, pare, perché riportato in estratto dalla «Fiera Letteraria» dopo questo periodo) Filippo Crispolti ha raccontato come qualmente, quando nel 1906 si pensò in Isvezia di dare il premio Nobel a Giosuè Carducci, nacque il dubbio che un simile attestato di ammirazione al cantore di Satana potesse suscitare scandalo tra i cattolici: furono chieste pertanto informazioni al Crispolti che le dette per lettera e in un colloquio col ministro svedese a Roma, De Bildt. Le informazioni del Crispolti furono favorevoli. Così, il premio Nobel al Carducci sarebbe stato dato da nessun altro che da Filippo Crispolti.
Q23 §18 «Arte Cattolica». Edoardo Fenu, in un articolo Domande su un’arte cattolica pubblicato nell’«Avvenire d’Italia» e riassunto nella «Fiera Letteraria» del 15 gennaio 1928, rimprovera a «quasi tutti gli scrittori cattolici» il tono apologetico. «Ora la difesa (!) della fede deve scaturire dai fatti, dal processo critico (!) e naturale del racconto, deve cioè essere, manzonianamente, il “sugo” dell’arte stessa. È evidente (!) che uno scrittore cattolico per davvero (!), non andrà mai a battere la fronte contro le pareti opache (!) dell’eresia, morale o religiosa. Un cattolico, per il solo fatto (!) di essere tale, è già investito (! dal di fuori?) di quello spirito semplice e profondo che, trasfondendosi nelle pagine di un racconto o di una poesia, farà della sua un’arte schietta, serena, nient’affatto pedante. È dunque perfettamente inutile intrattenersi a ogni svolto di pagina a farci capire che lo scrittore ha una strada da farci percorrere, ha una luce per illuminarci. L’arte cattolica dovrà (!) mettersi in grado di essere essa medesima quella strada e quella luce, senza smarrirsi nella fungaia (solo le lumache si possono smarrire nelle fungaie) degli inutili predicozzi e degli oziosi avvertimenti». (In letteratura) «… se ne togli pochi nomi, Papini, Giuliotti, e in certo senso anche Manacorda, il bilancio è pressoché fallimentare. Scuole?… ne verbum quidem. Scrittori? Sì; a voler essere di manica larga si potrebbe tirar fuori qualche nome, ma quanto fiato per trarlo cogli argani! A meno che non si voglia patentare per cattolico il Gotta, o dar la qualifica di romanziere al Gennari, o battere un applauso a quella caterva innumere di profumati e agghindati scrittori e scrittrici per “signorine”».
Molte contraddizioni, improprietà e ingenuità melense nell’articolo del Fenu. Ma la conclusione implicita è giusta: il cattolicismo è sterile per l’arte, cioè non esistono e non possono esistere «anime semplici e sincere» che siano scrittori colti e artisti raffinati e disciplinati. Il cattolicismo è diventato, per gli intellettuali, una cosa molto difficile, che non può fare a meno, anche nel proprio intimo, di una apologetica minuziosa e pedantesca. Il fatto è già antico: risale al Concilio di Trento e alla Controriforma. «Scrivere», d’allora in poi, è diventato pericoloso, specialmente di cose e sentimenti religiosi. Da allora la chiesa ha adoperato un doppio metro, per misurare l’ortodossia: essere «cattolici» è diventato cosa facilissima e difficilissima nello stesso tempo. È cosa facilissima per il popolo, al quale non si domanda che di «credere» genericamente e di avere ossequio per le pratiche del culto: nessuna lotta effettiva ed efficace contro la superstizione, contro le deviazioni intellettuali e morali, purché non siano «teorizzate». In realtà un contadino cattolico intellettualmente può essere inconscio protestante, ortodosso, idolatra: basta che dica di essere «cattolico». Anche agli intellettuali non si domanda molto, se si limitano alle esteriori pratiche del culto; non si domanda neanche di credere, ma solo di non dare cattivo esempio, trascurando i «sacramenti» specialmente quelli più visibili e sui quali cade il controllo popolare: il battesimo, il matrimonio, i funerali (il viatico ecc.). È invece difficilissimo essere intellettuale attivo «cattolico» e artista «cattolico» (romanziere specialmente e anche poeta), perché si domanda un tale corredo di nozioni su encicliche, controencicliche, brevi, lettere apostoliche ecc., e le deviazioni dall’indirizzo ortodosso chiesastico sono state nella storia tante e così sottili che cadere nell’eresia o nella mezza eresia o in un quarto di eresia è cosa facilissima. Il sentimento religioso schietto è stato disseccato: occorre essere dottrinari per scrivere «ortodossamente». Perciò nell’arte la religione non è più un sentimento nativo, è un motivo, uno spunto. E la letteratura cattolica può avere dei padri Bresciani e degli Ugo Mioni, non può avere più un S. Francesco, un Passavanti, un Tommaso da Kempis; può essere «milizia», propaganda, agitazione, non più ingenua effusione di fede che non è incontrastata, ma polemizzata, anche nell’intimo di quelli che sono sinceramente cattolici. L’esempio del Manzoni può essere portato a prova: quanti articoli sul Manzoni ha pubblicato la «Civiltà Cattolica» nel suoi 84 anni di vita e quanti su Dante? In realtà i cattolici più ortodossi diffidano del Manzoni e ne parlano il meno che possono: certo non lo analizzano come fanno per Dante e qualche altro.
Q23 §19 Tommaso Gallarati Scotti. Nella sua raccolta di novelle Storie dell’Amor Sacro e dell’Amor Profano è da ricordare il racconto in cui si parla del corpo di una prostituta saracena portato nell’Italia Meridionale da un barone crociato e che la popolazione adora come la reliquia di una santa: sono sbalorditive le considerazioni del Gallarati Scotti, che pure è stato un «modernista» antigesuita. Tutto ciò dopo la novella boccaccesca di frate Cipolla e il romanzo del portoghese Eça de Queiroz La Reliquia, tradotto da L. Siciliani (ed. Rocco Carabba, Lanciano) e che è una derivazione del Cipolla boccaccesco. I Bollandisti sono rispettabili, perché almeno hanno contribuito a estirpare qualche radice di superstizione (sebbene le loro ricerche rimangano chiuse in una cerchia molto ristretta e servano più che altro per far credere agli intellettuali che la chiesa combatte le falsificazioni storiche), l’estetismo gesuitico‑folcloristico del Gallarati Scotti è rivoltante. È da ricordare il dialogo riferito nelle Memorie di W. Steed tra un giovane protestante e un Cardinale a proposito di S. Gennaro e la noticina di B. Croce a una lettera di G. Sorel a proposito di una sua conversazione con un prete napoletano sul sangue di S. Gennaro (a Napoli esistono, pare, altri tre o quattro sangui che bollono «miracolosamente» ma che non sono «sfruttati» per non screditare quello popolarissimo di S. Gennaro). La figura letteraria del Gallarati Scotti entra di scorcio fra i nipotini di padre Bresciani.
Q23 §20 Adelchi Baratono. Ha scritto nel II fascicolo della rivista «Glossa perenne» (che era diretta da Raffa Garzia e iniziò a pubblicarsi nel 1928 o 29) un articolo sul Novecentismo che deve essere ricchissimo di spunti «sfottendi». Tra l’altro: «L’arte e la letteratura di un tempo non può e non dev’essere (!) che quella corrispondente alla vita (!) e al gusto del tempo, e tutte le deplorazioni, come non servirebbero a mutarne l’ispirazione e la forma, così sarebbero anche contrarie a ogni criterio (!) storico (!) e quindi giusto (?) di giudicare» .
Ma la vita e il gusto di un tempo sono qualcosa di monolitico o non sono invece pieni di contraddizioni? E allora come si verifica la «corrispondenza»? Il periodo del Risorgimento era «corrisposto» dal Berchet o dal padre Bresciani? La deplorazione lamentosa e moralistica sarebbe certo scema, ma si può fare la critica e giudicare senza piangere. Il De Sanctis era un fautore deciso della rivoluzione nazionale, tuttavia seppe giudicare brillantemente il Guerrazzi e non solo il Bresciani.
L’agnosticismo del Baratono non è altro che vigliaccheria morale e civile. Se fosse vero che un giudizio di merito sui contemporanei è impossibile per difetto di obbiettività e universalità, la critica dovrebbe chiudere bottega; ma Baratono teorizza solo la propria impotenza estetica e filosofica e la propria coniglieria.
Q23 §21 Maddalena Santoro: L’amore ai forti, Romanzo, Bemporad, 1928 (ultrabrescianesco).
Q23 §22 Curzio Malaparte. Vedi nell’«Italia Letteraria» del 3 gennaio 1932 l’articolo di Malaparte: Analisi cinica dell’Europa. Negli ultimi giorni del 1931 nei locali dell’«École de la Paix» a Parigi, l’ex Presidente Herriot tenne un discorso sui mezzi migliori per organizzare la pace europea. Dopo Herriot parlò il Malaparte in contradditorio: «Siccome anche voi, sotto certi aspetti (sic), siete un rivoluzionario, dissi tra l’altro a Herriot (scrive Malaparte nel suo articolo), penso che siate in grado di capire che il problema della pace dovrebbe essere considerato non solo dal punto di vista del pacifismo accademico, ma anche da un punto di vista rivoluzionario. Soltanto lo spirito patriottico e lo spirito rivoluzionario (se è vero, come è vero, ad esempio, nel fascismo, che l’uno non esclude l’altro) possono suggerire i mezzi di assicurare la pace europea. – Io non sono un rivoluzionario, mi rispose Herriot; sono semplicemente un cartesiano. Ma voi, caro Malaparte, non siete che un patriota».
Così, per Malaparte, anche Herriot è un rivoluzionario, almeno per certi aspetti, e allora diventa ancor più difficile comprendere cosa significa «rivoluzionario» e per Malaparte e in generale. Se nel linguaggio comune di certi gruppi politici, rivoluzionario stava assumendo sempre più il significato di «attivista», di «interventista», di «volontarista», di «dinamico» è difficile dire come Herriot possa esserne qualificato e perciò Herriot con spirito ha risposto di essere un «cartesiano». Per Malaparte pare possa intendersi che «rivoluzionario» è diventato un complimento, come una volta «gentiluomo» o «grande galantuomo» o «vero galantuomo» ecc. Anche questo è Brescianesimo: dopo il 48 i gesuiti chiamavano se stessi «veri liberali» e i liberali, libertini e demagoghi.
Q23 §23 Giovanni Ansaldo. In un posticino a parte, nella rubrica dei «Nipotini delpadre Bresciani» deve essere inserito anche Giovanni Ansaldo. È da ricordare il suo dilettantismo politico‑letterario, che gli fece sostenere, in un certo periodo, la necessità di «essere in pochi», di costituire un’«aristocrazia»: il suo atteggiamento era banalmente snobistico più che espressione di un fermo convincimento etico‑politico, un modo di fare della letteratura «distinta», da salotto equivoco. Così l’Ansaldo è divenuto la «Stelletta nera» del «Lavoro», stelletta con cinque punte, da non confondersi con quella che nei «Problemi del Lavoro» serve a indicare Franz Weiss e che ha sei punte (che l’Ansaldo ci tenga alle sue cinque punte appare dall’Almanacco delle Muse del 1931, rubrica genovese; l’Almanacco delle Muse fu pubblicato dall’Alleanza del Libro). Per l’Ansaldo tutto diventa eleganza culturale e letteraria: l’erudizione, la precisione, l’olio di ricino, il bastone, il pugnale; la morale non è serietà morale ma eleganza, fiore all’occhiello. Anche questo atteggiamento è gesuitico, è una forma di culto del proprio particulare nell’ordine dell’intelligenza, una esteriorità da sepolcro imbiancato. Del resto, come dimenticare che appunto i gesuiti sono sempre stati maestri di «eleganza» (gesuitica) di stile e di lingua?
Q23 §24 Giuseppe Prezzolini. Articolo di Prezzolini: Monti, Pellico, Manzoni, Foscolo veduti da viaggiatori americani, pubblicato nel «Pègaso» (di Ojetti) del maggio 1932. Prezzolini riferisce un brano del critico d’arte americano H. Y. Tuckermann (The Italian Sketch‑Book, 1848, p. 123): «Alcuni dei giovani elementi liberali, in Italia, si dimostrano assai disillusi perché uno, il quale stava per diventare un martire della loro causa, si sia voltato invece alla devozione, e si mostrano spiacenti che egli abbia ad impiegar la sua penna per scrivere inni cattolici e odi religiose»; e commenta: «Il dispetto che i più accesiprovavano per non aver trovato in Pellico uno strumento di piccola polemica politica, è dipinto in queste “osservazioni”». Perché si dovesse trattare di meschino «dispetto» e perché, prima del 48, la polemica contro le persecuzioni austriache e clericali dovesse esser «piccola» è appunto un mistero «profano» della mentalità brescianesca.
Q23 §25 Letteratura di guerra. Quali riflessi ha avuto la tendenza «brescianistica» nella letteratura di guerra? La guerra ha costretto i diversi strati sociali ad avvicinarsi, a conoscersi, ad apprezzarsi reciprocamente nella comune sofferenza e nella comune resistenza in forme di vita eccezionali che determinavano una maggiore sincerità e un più approssimato avvicinarsi all’umanità «biologicamente» intesa. Cosa hanno imparato dalla guerra i letterati? E in generale cosa hanno imparato dalla guerra quei ceti da cui normalmente sorgono in maggior numero gli scrittori e gli intellettuali? Sono da seguire due linee di ricerca: 1) Quella riguardante lo strato sociale, ed essa è già stata esplorata per molti aspetti dal prof. Adolfo Omodeo nella serie di capitoli Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti, usciti nella «Critica» e poi raccolti in volume. La raccolta dell’Omodeo presenta un materiale già selezionato, secondo una tendenza che si può anche chiamare nazionale-popolare, perché l’Omodeo implicitamente si propone di dimostrare come già nel 1915 esistesse robusta una coscienza nazionale‑popolare, che ebbe modo di manifestarsi nel tormento della guerra, coscienza formata dalla tradizione liberale democratica; e quindi mostrare assurda ogni pretesa di palingenesi in questo senso nel dopo guerra. Che l’Omodeo riesca ad assolvere il suo compito di critico è altra quistione; intanto l’Omodeo ha una concezione di ciò che è nazionale‑popolare troppo angusta e meschina, le cui origini culturali sono facili da rintracciare; egli è un epigono della tradizione moderata, con in più un certo tono democratico o meglio popolaresco che non sa liberarsi da forti striature «borbonizzanti». In realtà la quistione di una coscienza nazionale‑popolare non si pone per l’Omodeo come quistione di un intimo legame di solidarietà democratica tra intellettuali‑dirigenti e masse popolari, ma come quistione di intimità delle singole coscienze individuali che hanno raggiunto un certo livello di nobile disinteresse nazionale e di spirito di sacrifizio. Siamo così ancora al punto dell’esaltazione del «volontarismo» morale, e della concezione di élites che si esauriscono in se stesse e non si pongono il problema di essere organicamente legate alle grandi masse nazionali.
2) La letteratura di guerra propriamente detta, cioè dovuta a scrittori «professionali» che scrivevano per essere pubblicati, ha avuto in Italia varia fortuna. Subito dopo l’armistizio è stata molto scarsa e di poco valore: ha cercato la sua fonte d’ispirazione nel Feu di Barbusse. È molto interessante da studiare Il diario di guerra di B. Mussolini per trovarvi le tracce dell’ordine di pensieri politici, veramente nazionali‑popolari, che avevano formato, anni prima, la sostanza ideale del movimento che ebbe come manifestazioni culminanti il processo per l’eccidio di Roccagorga e gli avvenimenti del giugno 1914. Si è poi avuta una seconda ondata di letteratura di guerra, che ha coinciso con un movimento europeo in questo senso, prodottosi dopo il successo internazionale del libro del Remarque e col proposito prevalente di arginare la mentalità pacifista alla Remarque. Questa letteratura è generalmente mediocre, sia come arte, sia come livello culturale, cioè come creazione pratica di «masse di sentimenti e di emozioni» da imporre al popolo. Molta di questa letteratura rientra perfettamente nel tipo «brescianesco». Esempio caratteristico il libro di C. Malaparte La rivolta dei santi maledetti a cui si è già accennato. È da vedere l’apporto a questa letteratura del gruppo di scrittori che sogliono essere chiamati «vociani» e che già prima del 1914 lavoravano con concordia discorde per elaborare una coscienza nazionale‑popolare moderna. Dai «minori» di questo gruppo sono stati scritti i libri migliori, per esempio quelli di Giani Stuparich. I libri di Ardengo Soffici sono intimamente repugnanti, per una nuova forma di rettoricume peggiore di quella tradizionale. Una rassegna della letteratura di guerra sotto la rubrica del Brescianesimo è necessaria.
Q23 §26 Leonida Répaci. È uscito il primo volume di un romanzo così detto «ciclico» di Leonida Répaci I fratelli Rupe (Milano, Ceschina, 1932, L. 15) che, nel suo complesso dovrebbe rappresentare lo sviluppo della vita italiana, nel primo trentennio del secolo, visto dalla Calabria (nella prefazione il Répaci presenta il piano dell’opera). A parte la gagliofferia morale del titolo, è da domandarsi se la Calabria abbia avuto in questo tempo una funzione nazionale rappresentativa e in generale se in Italia la provincia abbia avuto una funzione progressiva o qualunque altra funzione, nel dirigere un qualsiasi movimento nel paese, nel selezionare i dirigenti, nel rinfrescare l’ambiente chiuso, rarefatto o corrotto dei grandi centri urbani della vita nazionale. In realtà la provincia (e specialmente nel Mezzogiorno) era, come dirigenti, molto più corrotta del centro (nel Mezzogiorno le masse popolari domandavano dirigenti del Settentrione per i loro istituti economici) e i provinciali inurbati, troppo spesso, apportavano una nuova corruzione, sotto forma di pagliettismo meschino e di mania di bassi intrighi. Un esempio caratteristico di ciò sono stati proprio i fratelli Répaci, emigrati da Palmi a Torino e a Milano. I fratelli Rupe, si capisce, sono i fratelli Répaci; ma, se si eccettua Mariano, dov’è il carattere rupestre degli altri, di Ciccio e di Leonida? Il carattere «ricotta e fango» prevale, con la gagliofferia morale di pretendersi «rupe», niente di meno. È da osservare che il «Répaci Leonida» manca di ogni fantasia inventiva, per non parlare di quella creatrice; ha solo una certa mediocre disposizione ad ampliare meccanicamente (per aggregazione, per inflazione, per «sincretismo») la serie di fatterelli «drammatici» in tono minore, che caratterizzano la storia aneddotica della maggioranza delle famiglie piccolo‑borghesi italiane (specialmente meridionali) in questo inizio di secolo, e che hanno caratterizzato anche la famiglia Répaci, assunta da Leonida a sostanza mitologica della propria «scritturazione». Questo processo di gonfiamento meccanico può essere dimostrato analiticamente. Ed è poi una strana mitologia quella del Répaci, priva di umanità seria e pudica di se stessa, priva di dignità, di decoro, per non parlare della grandezza etica; l’impudicizia da puttanella di infimo ordine, è la caratteristica di Leonida nei riguardi dei suoi famigliari. L’Ultimo Cireneo, con le disgustose scene del dibattersi osceno di suo fratello Ciccio, divenuto impotente non per invalidità di guerra, ma per cause fisiologiche forse di origine luetica (Ciccio non arrivò al fronte e le sue prodezze militari sono quelle di Leonida che fu uomo coraggioso e ardito prima di impoltronirsi nella vanità letteraria) mostra di quale tempera sia l’umanità di Leonida (anche nei Fratelli Rupe c’è un impotente), il quale, si direbbe, è capace di attristarsi che nella sua famiglia non ci sia stato un incesto per poter scrivere un romanzo e dire che i «Rupe» hanno conosciuto tutte le tragedie, anche quella di Fedra e di Edipo.
Q23 §27 Arnaldo Frateili. È il critico letterario della «Tribuna» e appartiene alla schiera intellettuale dei Forges che isterilisce la terra ove pone piede. Ha scritto un romanzo Capogiro (Milano, Bompiani, 1932). Frateili: si presenta alla fantasia come appare in una caricatura‑ritratto pubblicata dall’«Italia Letteraria»: una faccia da fesso pretenzioso con la goccetta al naso. Prende tabacco il Frateili? Ha il cimurro il Frateili? Perché quella goccetta? Si tratta di un errore «zincografico»? di un colpo di matita fuori programma? E perché allora il disegnatore non ha cancellato la goccetta? Problemi angosciosi: i soli che si pongono a proposito del Frateili.
Q23 §28 Letteratura di guerra. Vedere il cap. IX: «Guerre et Littérature» del volume di B. Cremieux sulla Littérature Italienne (ed. Kra, 1928, pp. 243 sgg.). Per il Cremieux la letteratura italiana di guerra segna una scoperta del popolo da parte dei letterati. Ma il Cremieux esagera! Tuttavia il capitolo è interessante e da rileggere. D’altronde anche l’America è stata scoperta dall’italiano Colombo e colonizzata da Spagnoli e Anglosassoni.
Q23 §29 Novecentismo di Bontempelli. Il manifesto scritto da Bontempelli per la rivista «900» non è altro che l’articolo di G. Prezzolini Viva l’artificio! pubblicato nel 1915 e ristampato a pagina 51 e sgg. della raccolta Mi pare… (Fiume, Edizioni Delta, 1925). Il Bontempelli non ha fatto che svolgere e illanguidire, meccanizzandoli, una serie di spunti contenuti nell’articolo del Prezzolini. La commedia Nostra Dea del 1925 è una meccanica estensione delle parole del Prezzolini stampate a p. 56 di Mi pare… È da rilevare che l’articolo del Prezzolini è molto goffo e pedantesco: risente dello sforzo fatto dall’autore, dopo l’esperienza di «Lacerba» per diventare più «leggero e brioso»: ciò che potrebbe essere espresso in un epigramma viene masticato e insalivato con molte smorfie tediose. Bontempelli imita la goffaggine, moltiplicandola. Un epigramma diventa in Prezzolini un articolo e in Bontempelli un volume.
Q23 §30 Novecentisti e strapaesani. Il Barocco e l’Arcadia adattati ai tempi moderni. (Il solito Malaparte che fu redattore capo del «900» di Bontempelli, divenne poco dopo il «caposcuola» degli strapaesani e il calabrone punzecchiatore di Bontempelli).
Q23 §31 Prezzolini. Il Codice della Vita italiana (Editrice la S. A. «La Voce», Firenze, 1921) conchiude il periodo originario e originale dell’attività del Prezzolini, dello scrittore moralista sempre in campagna per rinnovare e ammodernare la cultura italiana. Subito dopo, Prezzolini «entra in crisi», con alti e bassi curiosissimi, fino a imbrancarsi nella corrente tradizionale e a lodare ciò che aveva vituperato.
Un momento della crisi è rappresentato dalla lettera scritta nel 1923 a P. Gobetti, Per una società degli Apoti, ristampata nel volumetto Mi pare…. Il Prezzolini sente che la sua posizione di «spettatore» è «un po’, un pochino (!), vigliacca». «Non sarebbe nostro dovere di prender parte? Non c’è qualche cosa di uggioso (!), di antipatico (!), di mesto (!), nello spettacolo di questi giovani … che stanno (quasi tutti) fuori della lotta, guardando i combattenti e domandandosi soltanto come si danno i colpi e perché e per come?» Trova una soluzione, molto comoda: «Il nostro compito, la nostra utilità, per il momento presente ed anche … per le contese stesse che ora dividono e operano, per il travaglio stesso nel quale si prepara il mondo di domani, non può essere che quello al quale ci siamo messi e cioè di chiarire delle idee, di far risaltare dei valori, di salvare, sopra le lotte, un patrimonio ideale, perché possa tornare a dare frutti nei tempi futuri». Il modo di vedere la situazione è strabiliante: «Il momento che si traversa è talmente credulo (!), fanatico, partigiano, che un fermento di critica, un elemento di pensiero (!), un nucleo di gente che guardi sopra agli interessi, non può che fare del bene. Non vediamo tanti dei migliori accecati? Oggi tutto è accettato dalle folle (! e al tempo della guerra libica non era lo stesso? eppure allora Prezzolini non si limitò a proporre una Società di Apoti!): il documento falso, la leggenda grossolana, la superstizione primitiva vengono ricevute senza esame, a occhi chiusi, e proposte come rimedio materiale e spirituale. E quanti dei capi hanno per aperto programma la schiavitù dello spirito come rimedio agli stanchi, come rifugio ai disperati, come sanatutto ai politici, come calmante agli esasperati. Noi potremmo chiamarci la Congregazione degli Apoti, di “coloro che non le bevono”, tanto non solo l’abitudine ma la generale volontà di berle è evidente e manifesta ovunque».
Un’affermazione di ungesuitismo sofistico singolare: «Ci vuole che una minoranza, adatta a ciò, si sacrifichi se occorre e rinunzi a molti successi esterni, sacrifichi anche il desiderio di sacrifizio e di eroismo (!), non dirò per andare proprio contro corrente, ma stabilendo un punto solido, dal quale il movimento in avanti riprenderà», ecc. ecc.
Differenza tra il Prezzolini e Gobetti; vedere se la lettera ha avuto risposta e quale.
Q23 §32 Alfredo Panzini. La Vita di Cavour del Panzini è stata pubblicata a puntate nell’«Italia Letteraria» nei numeri dal 9 giugno al 13 ottobre 1929 ed è stata ristampata (riveduta e corretta? sarebbe interessante un esame minuzioso, se ne valesse la pena) dall’editore Mondadori, in un volume delle «Scie» con notevole ritardo. Nell’«Italia Letteraria» del 30 giugno, col titolo Chiarimento è pubblicata una lettera inviata dal Panzini, con la data del 27 giugno 1929, al direttore del «Resto del Carlino»: il Panzini, con stile seccato e intimamente allarmato, si lamenta per un piccante commento, pubblicato dal giornale bolognese alle due prime puntate del suo scritto che era giudicato «piacevole giocherello» e «cosa leggera». Il Panzini risponde in stile da telegramma: «Nessuna intenzione scrivere una biografia alla maniera romanzesca francese. Mia intenzione scrivere in stile piacevole e drammatico, tutto però documentato (Carteggio Nigra‑Cavour)». (Come se la sola documentazione per la vita del Cavour fosse questo Carteggio!) Il Panzini cerca poi di difendersi, assai male, dall’aver accennato a una forma di dittatura propria del Cavour, «umana», che ellitticamente poteva sembrare un giudizio critico su altre forme di dittatura: figurarsi la tremarella del Panzini nel procedere per questi «ignes». L’episodio ha un certo significato, perché mostra come molti si siano cominciati ad accorgere che queste scritture pseudo‑nazionali e patriottiche del Panzini sono stucchevoli, insincere e mostrano la trama. L’imbecillità e l’inettitudine del Panzini di fronte alla storia sono incommensurabili: il suo scrivere è un puro e infantile gioco di parole, ammantato di una specie di melensa ironia che dovrebbe far credere all’esistenza di chissà mai quali profondità, come quelle che certi contadini esprimono nel loro ingenuo modo di parlare. Bertoldo storico! In realtà è una forma di stenterellismo che si dà l’aria del Machiavelli in maniche di camicia e non in abito curiale. Un’altra puntata contro il Panzini si può leggere nella «Nuova Italia» di quel torno di tempo: si dice che la Vita di Cavour è scritta come se il Cavour fosse Pinocchio!
Né si può dire che lo stile del Panzini, nelle sue scritture di storia, sia «piacevole e drammatico»: egli è piuttosto farsesco e la storia è rappresentata come una «piacevolezza» da commesso viaggiatore o da farmacista di provincia: il farmacista è Panzini e i clienti sono altrettanti Panzini che si beano della propria fatua stupidaggine.
Tuttavia la Vita di Cavour ha una sua utilità: è una raccolta stupefacente di luoghi comuni sul Risorgimento e un documento di primo ordine delgesuitismo letterario del Panzini. Esemplificazione: «Uno scrittore inglese ha chiamato la storia dell’unità d’Italia la più romanzesca storia dei tempi moderni». (Il Panzini, oltre a creare luoghi comuni per gli argomenti che tratta, si dà molto daffare per raccogliere tutti i luoghi comuni che sullo stesso argomento sono stati messi in circolazione da altri scrittori, specialmente stranieri, senza accorgersi che in molti casi, come in questo, è implicito un giudizio «diffamatorio» del popolo italiano: il Panzini deve essersi fatto uno schedario speciale di luoghi comuni, per condire opportunamente i propri scritti). «Re Vittorio era nato con la spada e senza paura: due terribili baffi, un gran pizzo. Gli piacevano le belle donne e la musica del cannone. Un gran Re».
Questo luogo comune, questa oleografia da bettola di Vittorio Emanuele è da unire all’altro sulla «tradizione» militare del Piemonte e della sua aristocrazia. In realtà in Piemonte è proprio mancata una «tradizione» militare nel senso non burocratico della parola, cioè è mancata una «continuità» di personale militare di prim’ordine, e ciò è proprio apparso nelle guerre del Risorgimento, in cui non si è rivelata nessuna personalità (eccetto che nel campo garibaldino), ma invece sono affiorate molte deficienze interne gravissime. In Piemonte esisteva una tradizione militare «popolare»; dalla sua popolazione era sempre possibile trarre un buon esercito; apparvero di tanto in tanto capacità militari di primo ordine, come Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele ecc., ma mancò appunto una tradizione, una continuità nell’aristocrazia, nell’ufficialità superiore. La situazione fu aggravata dalla restaurazione e la prova se ne ebbe nel 48 quando non si sapeva dove metter le mani per dare un capo all’esercito e dopo aver domandato invano un generale alla Francia, si fini con l’assumere un minchione qualsiasi di polacco. Le qualità guerriere di Vittorio Emanuele II consistevano solo in un certo coraggio personale, che si dovrebbe pensare essere stato molto raro in Italia se tanto si insiste per farlo rimarcare: lo stesso si dica per il «galantomismo»; si dovrebbe pensare che in Italia la stragrande maggioranza fosse di bricconi, se l’essere galantuomini viene elevato a titolo di distinzione. A proposito di Vittorio Emanuele II è da ricordare l’aneddoto riferito da F. Martini nel suo libro postumo di memorie (ed. Treves); racconta il Martini che dopo la presa di Roma Vittorio Emanuele abbia detto che gli dispiaceva non ci fosse più nulla da «piè» (pigliare) e ciò a chi raccontava l’aneddoto (credo Q. Sella) pareva dimostrare che non ci fosse stato nella storia un re più conquistatore di Vittorio Emanuele. Dell’aneddoto si potrebbe dare forse altra spiegazione più terra terra, legata alla concezione dello stato patrimoniale e alla varia misura della lista civile. È da ricordare poi l’epistolario di Massimo D’Azeglio pubblicato dal Bollea nel «Bollettino Storico Subalpino» e il conflitto tra Vittorio Emanuele e Quintino Sella su quistioni economiche.
Ciò che poi stupisce molto è che si insista tanto sugli episodi «galanti» della vita di Vittorio Emanuele come se essi fossero tali da rendere più popolare la figura del re: si narra di alti funzionari e di ufficiali che andavano nelle famiglie di contadini per convincerle a mandare delle ragazze a letto col re per quattrini. A pensarci bene è stupefacente che tali cose siano raccontate credendo di rafforzare l’ammirazione popolare.
«… il Piemonte… ha una tradizione guerriera, ha una nobiltà guerriera». Si potrebbe osservare che Napoleone III, data la «tradizione» guerriera della sua famiglia, si occupò di scienza militare e scrisse libri che pare non fossero troppo malvagi per i suoi tempi.
«Le donne? Già, le donne. Su tale argomento egli (Cavour) andava molto d’accordo col suo re, benché anche in questo ci fosse qualche differenza. Re Vittorio era di molta buona bocca come avrebbe potuto attestare la bella Rosina, che fu poi contessa di Mirafiori», e via di questo tono fino a ricordare che i propositi galanti (!) del re alla corte delle Tuglierì (sic) furono così audaci «che tutte le dame ne rimasero amabilmente (!) atterrite. Quel forte, magnifico Re montanaro!» (Il Panzini si riferisce agli aneddoti raccontati dal Paleologue, ma che differenza di tòcco. Il Paleologue, pur data la materia scabrosa, mantiene il tono del gentiluomo cortigiano: il Panzini non sa evitare il linguaggio del lenone da trivio, del commerciante in tratta delle bianche). «Cavour era assai più raffinato. Cavallereschi però tutti e due, e oserei (!) dire, romantici (!)». «Massimo D’Azeglio… da quel gentiluomo delicato che era…»
L’accenno del Panzini, di cui si parla a p. 37 e che gli attirò i fulmini… confinari del «Resto del Carlino» è contenuto nella seconda puntata della Vita di Cavour edizione «Italia Letteraria» (numero del 16 giugno) ed è bene riportarlo perché sarà stato cassato o modificato nell’ed. Mondadori: «Non ha bisogno di assumere atteggiamenti specifici. Ma in certi momenti doveva apparire meraviglioso e terribile. L’aspetto della grandezza umana è tale da indurre negli altri ubbidienza e terrore, e questa è dittatura più forte che non quella di assumere molti portafogli nei ministeri».
Pare incredibile che una tale frase sia potuta sfuggire al pavido Panzini ed è naturale che il «Resto del Carlino» l’abbia beccato. Dalla risposta del Panzini si può spiegare l’infortunio: «Quanto a certe puntate contro la dittatura, forse fu errore fidarmi nella conoscenza storica del lettore. Cavour, nel 1859, domandò (?!) i poteri dittatori assumendo diversi portafogli, fra i quali quello della guerra, con molto (!?) scandalo della allora quasi vergine costituzionalità. Non questa materiale forma di dittatura indusse ad obbedienza, ma la dittatura dell’umana grandezza di Cavour». Pare evidente che l’intento del Panzini fosse adulatorio, ma la sua innocenza politica e quindi storica gli diede lo sgambetto e trasformò l’adulazione servile in una smorfia equivoca. Non si può parlare di dittatura per il Cavour, tanto meno nel 1859 e anzi questa fu una debolezza nello svolgimento della guerra e nella posizione dei piemontesi in seno all’alleanza con Napoleone. Sono le opinioni del Cavour sulla dittatura e sulla funzione del Parlamento, opinioni di cui il Panzini pavidamente tace, sebbene il parlarne non sarebbe stato certo pericoloso. Ciò che è curioso è che più oltre il Panzini stesso mostra come il Cavour fosse stato tagliato fuori dallo svolgimento della guerra e sebbene ministro della guerra, non ricevesse neppure i bollettini dell’esercito. Per un dittatore non c’è male. Il Cavour non riuscì neppure a far valere le sue prerogative costituzionali di capo del Governo, che del resto non erano contemplate nello Statuto, e quindi il suo conflitto col re dopo l’armistizio di Villafranca. In. realtà non la politica di Cavour fu continuata dalla guerra del 59, ma un miscuglio delle velleità politiche di Napoleone e delle tendenze assolutiste piemontesi impersonate dal re e da un gruppo di generali. Si ripeté la situazione del 1848‑49, e se non ci fu disastro militare, ciò fu dovuto alla presenza dell’esercito francese: ma il risultato della situazione politica anormale fu grave lo stesso, perché nell’alleanza Napoleone ebbe l’egemonia illimitata, e il Piemonte un posto troppo subordinato.
«… la guerra d’Oriente, una cosa piuttosto complicata, che per chiarezza di discorso si omette». (Affermazione impagabile per uno storico: si afferma che Cavour è stato un genio politico ecc., ma l’affermazione non diventa mai dimostrazione e rappresentazione concreta. Il significato della partecipazione piemontese alla guerra di Crimea e della capacità politica di Cavour nell’averla voluta, è «omesso» per «chiarezza»). Il profilo di Napoleone III è sguaiatamente triviale: non si cerca di spiegare perché Napoleone abbia collaborato con Cavour (le citazioni d’appoggio dovrebbero essere troppe: occorrerà rivedere il libro o l’annata dell’«Italia Letteraria»).
«Al Museo napoleonico in Roma c’è un prezioso pugnale con una lama che può passare il cuore (non è un pugnale dei soliti, a quanto pare! «Può questo pugnale servire di documento? Di pugnali io non ho esperienza (!), ma sentii dire quello essere il pugnale carbonaro che si affidava a chi entrava nella setta tenebrosa ecc.». (Il Panzini deve sempre essere stato ossessionato dai pugnali: ricordare la «livida lama» della Lanterna di Diogene. Forse si è trovato per caso presente a qualche torbido in Romagna e deve aver visto qualche paio d’occhi guatarlo biecamente: onde le «livide lame» che passano il cuore ecc.).
«E chi volesse vedere come la setta carbonara assumesse l’aspetto di Belzebù, legga il romanzo L’Ebreo di Verona di Antonio Bresciani e si divertirà (sic) un mondo, anche perché, a dispetto di quel che ne dicono i moderni (ma il De Sanctis era contemporaneo del Bresciani), quel padre gesuita fu un potente narratore». (Questo brano si potrebbe porre come epigrafe al saggio sui «Nipotini delpadre Bresciani»: esso si trova nella puntata terza della Vita di Cavour, edizione dell’«Italia Letteraria», n. del 23 giugno 1929).
Tutta questa Vita di Cavour è una beffa della storia. Se le vite romanzate sono la forma attuale della letteratura storica amena tipo Alessandro Dumas, A. Panzini è il Ponson du Terrail del quadro. Il Panzini vuole così ostentatamente mostrare di «saperla lunga» sull’animo e sulla natura degli uomini, di essere un così furbissimo furbo, un realista così disincantato dalla tenebrosa nequizia dell’uman genere e specialmente dei politici, che, dopo averlo letto, viene voglia di rifugiarsi in Condorcet e in Bernardin de Saint‑Pierre, che almeno non furono così trivialmente filistei. Nessun nesso storico è ricostruito nel fuoco di una personalità: la storia ti diventa una sequela di storielle poco divertenti perché insalivate dal Panzini, senza nesso né di individualità eroiche, né di altre forze sociali; quella del Panzini è veramente una nuova forma di gesuitismo, molto più accentuata di quanto si pensava leggendo la Vita a puntate. Al luogo comune della «nobiltà guerriera e non da anticamera» si possono contrapporre i giudizi che il Panzini volta per volta dà dei singoli generali come il La Marmora e il Della Rocca, spesso con espressioni di scherno trivialmente spiritoso: «Della Rocca è un guerriero. A Custoza, 1866, non brillerà per troppo valore, ma è un ostinato guerriero e perciò tien duro coi bollettini». (È proprio una frase da «demagogo». Il Della Rocca non voleva più mandare i bollettini dello Stato Maggiore a Cavour, che ne aveva notato la cattiva compilazione letteraria, alla quale collaborava il re). Altre allusioni del genere per il La Marmora e per il Cialdini (anche se Cialdini non fu piemontese) e mai è riferito il nome di un generale piemontese che abbia in qualche modo brillato: altro accenno al Persano.
Non si comprende proprio cosa il Panzini abbia voluto scrivere con questa Vita di Cavour, perché non si tratta certo di una vita di Cavour né di una biografia dell’uomo Cavour, né di un profilo del politico Cavour. In verità, dal libro del Panzini, il Cavour, uomo e politico, esce piuttosto malconcio e ridotto a proporzioni da Gianduia: la sua figura non ha nessun rilievo concreto, perché a dare un rilievo non bastano certo le giaculatorie che il Panzini continuamente ripete: eroe, superbo, genio ecc. Questi giudizi, non essendo giustificati (perciò si tratta di giaculatorie), potrebbero addirittura parere canzonature, se non si comprendesse che la misura che il Panzini adopera per giudicare l’eroismo, la grandezza, il genio ecc. non è altro che la sua personale misura, la genialità, la grandezza, l’eroismo del sig. Panzini Alfredo. Allo stesso modo e per la stessa ragione, il Panzini abbonda nel trovar attivi il dito di dio, il fato, la provvidenza negli avvenimenti del Risorgimento; si tratta della concezione volgare dello «stellone» condita con parole da tragedia greca e da padre gesuita, ma non perciò meno triviale. In realtà l’insistenza balorda sull’«elemento extra umano» oltre che imbecillità storica, significa diminuire la funzione dello sforzo italiano, che pure ebbe non piccola parte negli avvenimenti. Cosa potrebbe significare che la rivoluzione italiana è stata un evento miracoloso? Che tra il fattore nazionale e quello internazionale dell’evento, è l’internazionale che aveva il peso maggiore e creava difficoltà che parevano insormontabili. È questo il caso?
Bisognerebbe dirlo e forse la grandezza di Cavour sarebbe messa ben più in rilievo e la sua funzione personale, il suo «eroismo» apparirebbe ben più da esaltare (a parte ogni altra considerazione). Ma il Panzini vuol dare colpi a molte botti con molti cerchi e non riesce a raccapezzare niente di sensato: né egli sa cosa sia una rivoluzione e quali siano i rivoluzionari: tutti furono grandi, rivoluzionari ecc. come al buio tutto i gatti sono bigi.
Nell’«Italia Letteraria» del 2 giugno 1929 è pubblicata un’intervista di Antonio Bruers col Panzini: Come e perché Alfredo Panzini ha scritto una «Vita di Cavour». Vi si dice che lo stesso Bruers ha indotto il Panzini a scrivere il libro «in modo che il pubblico potesse avere finalmente un “Cavour” italiano, dopo averne avuto uno tedesco, uno inglese, e uno francese». Nell’intervista il Panzini dice che la sua Vita «non è una monografia nel senso storico‑scientifico della parola; è un profilo destinato non ai dotti, agli “specialisti” ma al vasto pubblico» (cioè chincaglieria per negri). Il Panzini è persuaso che nel suo libro ci siano delle parti originali e precisamente il fatto di aver dato importanza all’attentato di Orsini per spiegare l’atteggiamento di Napoleone III; secondo il Panzini Napoleone III sarebbe stato inscritto da giovane alla Carboneria, «la quale vincolò con impegno d’onore (!) il futuro sovrano della Francia»; Orsini, mandatario della Carboneria (che non esisteva più da un bel pezzo) avrebbe ricordato a Napoleone il suo impegno e quindi ecc. (proprio un romanzo alla Ponson du Terrail; Orsini, se mai vi appartenne, doveva aver dimenticato, al tempo dell’attentato, da un bel pezzo, la Carboneria; le sue repressioni del 48 nelle Marche furono proprio dirette contro i vecchi carbonari, e ancora, l’Orsini, dopo aver superato, come gli altri rivoluzionari, la Carboneria nella «Giovane Italia» e nel mazzinianismo, era stato già in rotta con Mazzini). Le ragioni dell’atteggiamento personale di Napoleone verso Orsini (che in ogni modo fu ghigliottinato) si spiegano forse banalmente con la paura del complice sfuggito e che poteva ritentare la prova; anche la grande serietà dell’Orsini che non era un qualunque scalmanato, dovette imporsi e dimostrare che l’odio dei rivoluzionari italiani per Napoleone non era una bazzecola: occorreva far dimenticare la caduta della Repubblica Romana e cercare di distruggere l’opinione diffusa che Napoleone fosse il maggior nemico dell’unità d’Italia. Il Panzini poi dimentica (per «chiarezza») che c’era stata la guerra di Crimea e l’orientamento generale di Napoleone pro‑italiano (che però, essendo conservatore, non doveva essere gradito ai rivoluzionari); tanto che l’attentato sembrò spezzare la trama già ordita. Tutta l’ipotesi del Panzini si basa sull’aver visto il famoso pugnale che passava il cuore e sull’ipotesi che fosse un oggetto carbonaro: un romanzo alla Ponson e niente altro.
Q23 §33 Riccardo Bacchelli. Il diavolo al Pontelungo (ed. Ceschina, Milano). Questo romanzo del Bacchelli è stato tradotto in inglese da Orlo Williams e la «Fiera Letteraria» del 27 gennaio 1929 riporta l’introduzione del Williams alla sua traduzione. Il Williams nota che il Diavolo al Pontelungo è «uno dei pochi romanzi veri, nel senso che noi diciamo romanzo in Inghilterra», ma non pone in rilievo (sebbene parli dell’altro libro di Bacchelli Lo sa il tonno) che il Bacchelli è uno dei pochi scrittori italiani che si possono chiamare «moralisti» nel senso inglese e francese (ricordare che il Bacchelli è stato collaboratore della «Voce» e anzi per qualche tempo ne ha avuto la direzione in assenza di Prezzolini); lo chiama invece raisonneur, poeta dotto: raisonneur nel senso che troppo spesso interrompe l’azione del dramma con commenti intorno ai moventi delle azioni umane in generale. (Lo sa il tonno è il libro tipico di Bacchelli «morale» e non pare molto ben riuscito). In una lettera al Williams, riportata nell’introduzione, Bacchelli dà queste informazioni sul Diavolo: «Nelle linee generali (!) il materiale è storico strettamente tanto nella prima che nella seconda parte. Sono storici i protagonisti, come Bakunin, Cafiero, Costa. Nell’intendere l’epoca, le idee e i fatti, ho cercato d’essere storico in senso stretto: rivoluzionarismo cosmopolita, primordi della vita politica del Regno d’Italia, qualità del socialismo italiano agli inizi, psicologia politica del popolo italiano e suo ironico buon senso, suo istintivo e realistico machiavellismo (sarebbe piuttosto da dire guicciardinismo nel senso dell’uomo del Guicciardini di cui parla il De Sanctis) ecc. Le mie fonti sono l’esperienza della vita politica fatte a Bologna, che è la città politicamente più suscettibile e sottile d’Italia (mio padre era uomo politico, deputato liberale conservatore) (il giudizio che il Bacchelli dà di Bologna politica è essenzialmente giusto, ma non per il popolo, per le classi possidenti e intellettuali collegate contro la campagna irrequieta e violenta in modo elementare; a Bologna vivono in uno stato permanente di panico sociale, con la paura di una jacquerie e il timore aguzza l’orecchio politico), i ricordi di alcuni fra gli ultimi sopravvissuti dei tempi e dell’Internazionale anarchica (ho conosciuto uno che fu compagno e complice di Bakunin nei fatti di Bologna del 74) e, per i libri, sopra tutto il capitolo del professor Ettore Zoccoli nel suo libro sull’anarchia e i quaderni di Bakunin che lo storiografo austriaco dell’anarchia, Nettlau, ha ristampato nella sua rarissima biografia stampata in pochi esemplari. Il francese (era invece svizzero) James Guillaume tratta anch’egli di Bakunin e Cafiero nell’opera sull’Internazionale, che non conosco, ma dalla quale credo di discostarmi in vari punti importanti. Quest’opera fece parte (!) di una polemica posteriore sulla Baronata di Locarno, della quale non mi sono curato (! tuttavia questa polemica illuminò il carattere di Bakunin e quindi i suoi rapporti col Cafiero). Tratta di cose meschine e di quistioni di danaro (puah!). Credo che Herzen, nelle sue memorie, abbia scritto le parole più giuste e più umane intorno alla personalità variabile, inquieta e confusa di Bakunin. Marx, come non di rado, fu soltanto caustico e ingiurioso. In conclusione credo di poterle dire che il libro si fonda sopra una base di concetto sostanzialmente storico. Come e con quale sentimento artistico io abbia saputo svolgere questo materiale europeo (!) e rappresentativo, questo è argomento sul quale il giudicare non spetta a me». (Il diavolo al Pontelungo è da porre insieme a Pietro e Paolo del Sobrero per il chiaroscuro nel saggio sui «nipotini delpadre Bresciani»: del resto nel Bacchelli c’è molto Brescianesimo, non solo politico‑sociale, ma anche letterario: la «Ronda» fu una manifestazione digesuitismo artistico.
Q23 §34 Jahier, Raimondi e Proudhon. Articolo di Giuseppe Raimondi Rione Bolognina nella «Fiera Letteraria» del 17 giugno 1928; ha in epigrafe questo motto di Proudhon: «La pauvreté est bonne, et nous devons la considérer comme le principe de notre allégresse». L’articolo è una specie di manifesto «ideologico‑autobiografico» e culmina in queste frasi: «Come ogni operaio e ogni figlio di operaio, io ho sempre avuto chiaro il senso della divisione delle classi sociali. Io resterò, purtroppo (sic), fra quelli che lavorano. Dall’altra parte, ci sono quelli che io posso rispettare, per i quali posso anche provare della sincera gratitudine (!); ma qualcosa mi impedisce di piangere (!) con loro, e non mi riesce di abbracciarli con spontaneità (!). O mi mettono soggezione (!) o li disprezzo». (Un bel modo di presentare una superiore forma di dignità operaia!) «È nei sobborghi che si sono sempre fatte le rivoluzioni, e il popolo non è da nessuna parte così giovane, sradicato da ogni tradizione, disposto a seguire un improvviso moto di passione collettivo, come nei sobborghi, che non sono più città e non sono ancora campagna. … Di qui finirà per nascere una civiltà nuova, e una storia che avrà quel senso di rivolta e di riabilitazione secolare proprio dei popoli che solo la morale dell’età moderna ha fatto riconoscere degni. Se ne parlerà come oggi si parla del Risorgimento italiano e dell’Indipendenza americana. L’operaio è di gusti semplici: si istruisce con le dispense settimanali delle Scoperte della Scienza e della Storia delle Crociate: la sua mentalità resterà sempre quella un poco atea e garibaldina dei circoli suburbani e delle Università Popolari. … Lasciategli i suoi difetti, risparmiategli le vostre ironie. Il popolo non sa scherzare. La sua modestia è vera, come la sua fiducia nell’avvenire». (Molto oleografico, ma abbastanza alla moda del Proudhon deteriore, anche nel tono assiomatico e perentorio).
Nell’«Italia Letteraria» del 21 luglio 1929 lo stesso Raimondi parla della sua deferente amicizia per Piero Jahier, e delle loro conversazioni: «… mi parla di Proudhon, della sua grandezza e della sua modestia, dell’influenza che le sue idee hanno esercitato nel mondo moderno, dell’importanza che queste idee hanno assunto in un mondo retto dal lavoro socialmente organizzato, in un mondo dove la coscienza degli uomini si va sempre più evolvendo e perfezionando in nome del lavoro e dei suoi interessi. Proudhon ha fatto un mito, umano e vivente, di questi poveri (!) interessi. In me l’ammirazione per Proudhon è piuttosto sentimentale, d’istinto, come un affetto e un rispetto, che io ho ereditato, che mi sono stati trasmessi nascendo. In Jahier è tutta di intelletto, derivata dallo studio, perciò (!) profondissima».
Questo signor Giuseppe Raimondi era un discreto poseur con la sua «ammirazione ereditata»; aveva trovato uno dei cento modi di distinguersi nella gioventù letterata odierna; ma da qualche anno non se ne sente più parlare. (Bolognese: collabora con L. Longanesi nell’«Italiano», poi viene violentemente e sprezzantemente diffidato dal Longanesi, «rondista»).
Q23 §35 Scrittori «tecnicamente» cattolici. È notevole la scarsità degli scrittori cattolici in Italia, scarsità che ha una sua ragione d’essere, nel fatto che la religione è staccata dalla vita militante in tutte le sue manifestazioni. S’intende «scrittori» che abbiano una qualche dignità intellettuale e che producano opere d’arte, dramma, poesia, romanzo. Già accennato al Gallarati Scotti per un tratto caratteristico delle Storie dell’Amor Sacro e dell’Amor Profano, che ha una sua dignità artistica ma che puzza di modernismo. Paolo Arcari (più noto come scrittore di saggi letterari e politici, del resto già direttore della rivista liberale «L’azione liberale» di Milano, ma che ha scritto qualche romanzo). Luciano Gennari (che scrive in lingua francese). Non è possibile un confronto tra l’attività artistica dei cattolici francesi (e la statura letteraria) e quella degli italiani. Crispolti ha scritto un romanzo di propaganda Il Duello. In realtà, il cattolicismo italiano è sterile nel campo letterario come negli altri campi della cultura (cfr Missiroli, Date a Cesare…). Maria di Borio (ricordare l’episodio tipico della Di Borio durante la conferenza della indù Arcandamaia sul valore delle religioni ecc.). Gruppo fiorentino del «Frontespizio», guidato dal Papini, svolge una attività letterario‑cattolica estremista, ciò che è una riprova dell’indifferentismo dello strato intellettuale per la concezione religiosa.
Q23 §36 Criteri metodici. Sarebbe assurdo pretendere che ogni anno o anche ogni dieci anni, la letteratura di un paese produca un Promessi Sposi o un Sepolcri ecc. Appunto perciò l’attività critica normale non può non avere prevalentemente carattere «culturale» ed essere una critica di «tendenze» a meno di diventare un continuo massacro.
E in questo caso, come scegliere l’opera da massacrare, lo scrittore da dimostrare estraneo all’arte? Pare questo un problema trascurabile e invece, a rifletterci dal punto di vista dell’organizzazione moderna della vita culturale, è fondamentale. Una attività critica che fosse permanentemente negativa, fatta di stroncature, di dimostrazioni che si tratta di «non poesia» e non di «poesia», diventerebbe stucchevole e rivoltante: la «scelta» sembrerebbe una caccia all’uomo, oppure potrebbe essere ritenuta «casuale» e quindi irrilevante. Pare certo che l’attività critica debba sempre avere un aspetto positivo, nel senso che debba mettere in rilievo, nell’opera presa in esame, un valore positivo, che se non può essere artistico, può essere culturale e allora non tanto varrà il singolo libro – salvo casi eccezionali – quanto i gruppi di lavori messi in serie per tendenza culturale. Sulla scelta: il criterio più semplice, oltre l’intuizione del critico e l’esame sistematico di tutta la letteratura, lavoro colossale e quasi impossibile da farsi individualmente, pare quello della «fortuna libraria», intesa in due sensi: «fortuna di lettori» e «fortuna presso gli editori» che in certi paesi dove la vita intellettuale è controllata da organi governativi, ha pure il suo significato perché indica quale indirizzo lo Stato vorrebbe dare alla cultura nazionale. Partendo dai criteri della estetica crociana, si presentano gli stessi problemi: poiché «frammenti» di poesia possono trovarsi da per tutto, nell’«Amore Illustrato» come nell’opera di scienza strettamente specializzata, il critico dovrebbe conoscere «tutto» per essere in grado di rilevare la «perla» nel brago. In realtà ogni singolo critico sente di appartenere a una organizzazione di cultura che opera come insieme; ciò che sfugge a uno viene «scoperto» e segnalato da un altro ecc. Anche il dilagare dei «premi letterari» non è che una manifestazione, più o meno bene organizzata, con maggiori o minori elementi di frode, di questo servizio di «segnalazione» collettiva della critica letteraria militante.
È da notare che in certi periodi storici l’attività pratica può assorbire le maggiori intelligenze creative di una nazione: in un certo senso, in tali periodi, tutte le migliori forze umane vengono concentrate nel lavoro strutturale e non ancora si può parlare di superstrutture: secondo ciò che scrive il Cambon nella prefazione all’edizione francese dell’autobiografia di Henri Ford, in America si è costruita una teoria sociologica su questa base, per giustificare l’assenza, negli Stati Uniti, di una fioritura culturale umanistica e artistica. In ogni caso questa teoria, per avere almeno un’apparenza di giustificazione, deve essere in grado di mostrare una vasta attività creatrice nel campo pratico, sebbene rimanga senza risposta la quistione: se questa attività «poetico‑creativa» esiste ed è vitale, esaltando tutte le forze vitali, le energie, le volontà, gli entusiasmi dell’uomo, come non esalta l’energia letteraria e non crea un’epica? Se ciò non avviene, nasce il legittimo dubbio che si tratti di energie «burocratiche», di forze non espansive universalmente, ma repressive e brutali: si può pensare che i costruttori delle Piramidi, schiavi trattati con la frusta, concepissero liricamente il loro lavoro? Ciò che è da rilevare è che le forze che dirigono questa grandiosa attività pratica, non sono repressive solo nei confronti del lavoro strumentale, ciò che può capirsi, ma sono repressive universalmente, ciò che appunto è tipico e fa sì che una certa energia letteraria, come in America, si manifesti nei refrattari all’organizzazione dell’attività pratica che si vorrebbe gabellare come «epica» in se stessa. Tuttavia la situazione è peggiore dove alla nullità artistica non corrisponde neanche un’attività pratico-strutturale di una certa grandiosità e si giustifica la nullità artistica con un’attività pratica che si «verificherà» e a sua volta produrrà un’attività artistica.
In realtà ogni forza innovatrice è repressiva nei confronti dei propri avversari, ma in quanto scatena forze latenti, le potenzia, le esalta, è espansiva e l’espansività è di gran lunga il suo carattere distintivo. Le restaurazioni, con qualsiasi nome si presentino, e in special modo le restaurazioni che avvengono nell’epoca attuale, sono universalmente repressive: il «padre Bresciani», la letteratura brescianesca diventa predominante. La psicologia che ha preceduto una tale manifestazione intellettuale è quella creata dal panico, da una paura cosmica di forze demoniache che non si comprendono e non si possono quindi controllare altro che con una universale costruzione repressiva. Il ricordo di questo panico (della sua fase acuta) perdura a lungo e dirige la volontà e i sentimenti: la libertà e la spontaneità creatrice spariscono e rimane l’astio, lo spirito di vendetta, l’accecamento balordo ammantati dalla mellifluità gesuitica. Tutto diventa pratico (nel senso deteriore), tutto è propaganda, polemica, negazione implicita, in forma meschina, angusta, spesso ignobile e rivoltante come nell’Ebreo di Verona.
Quistione della gioventù letteraria di una generazione. Certo, nel giudicare uno scrittore, di cui si esamina il primo libro, occorrerà tener conto dell’«età», perché il giudizio sarà sempre anche di cultura: un frutto acerbo di un giovane può essere apprezzato come una promessa e ottenere un incoraggiamento. Ma i bozzacchioni non sono promesse, anche se paiono aver lo stesso gusto dei frutti acerbi.
Q23 §37 Papini. È da notare come gli scrittori della «Civiltà Cattolica» se lo tengono diletto, lo vezzeggiano, lo coccolano e lo difendono da ogni accusa di poca ortodossia. Frasi di Papini contenute nel libro su S. Agostino e che mostrano la tendenza al secentismo (i gesuiti furono spiccati rappresentanti del secentismo): «quando si dibatteva per uscire dalle cantine dell’orgoglio a respirare l’aria divina dell’assoluto», «salire dal letamaio alle stelle» ecc. Papini si è convertito non al cristianesimo, ma propriamente algesuitismo (si può dire, del resto, che ilgesuitismo, col suo culto del papa e l’organizzazione di un impero assoluto spirituale, è la fase più recente del cristianesimo cattolico).
Q23 §38 Mario Puccini. Cola o Ritratto dell’Italiano, Casa Editrice Vecchioni, Aquila, 1927. Cola è un contadino toscano, territoriale durante la guerra, nel quale il Puccini vorrebbe rappresentare il «vecchio italiano» ecc.: «… il carattere di Cola, … senza reazioni ma senza entusiasmi, capace di fare il proprio dovere e anche di compiere qualche atto di valore ma per obbedienza e per necessità e con un tenero rispetto per la propria pelle, persuaso sì e no della necessità della guerra ma senza nessun sospetto di valori eroici … il tipo di una coscienza, se non completamente sorda, certo passiva alle esigenze ideali, tra la bacchettona e pigra, resistente a guardare oltre gli “ordini del governo” e oltre le modeste funzioni della vita individuale, contento in una parola dell’esistenza di pianura senza ambizione delle alte cime». (Dalla recensione pubblicata nella Nuova Antologia del 16 marzo 1928, p. 270).
Q23 §39 Luigi Capuana. Estratto da un articolo di Luigi Tonelli, Il carattere e l’opera di Luigi Capuana («Nuova Antologia», 1° maggio 1928): «Re Bracalone (romanzo fiabesco: il secolo XX è creato, per forza d’incanto, nello spazio di brevi giorni, nei tempi di “c’era una volta”; ma dopo averne fatta l’amara esperienza, il re lo distrugge, preferendo ritornare ai tempi primitivi) c’interessa anche sotto il riguardo ideologico; ché, in un periodo d’infatuazione (!) internazionalista socialistoide, ebbe il coraggio (!) di bollare a fuoco (!) “le sciocche sentimentalità della pace universale, del disarmo e le non meno sciocche sentimentalità dell’uguaglianza economica e della comunità dei beni”, ed esprimere l’urgenza di “tagliar corto alle agitazioni che han già creato uno Stato dentro lo Stato, un governo irresponsabile”, ed affermare la necessità di una coscienza nazionale: “Ci fa difetto la dignità nazionale; bisogna creare il nobile orgoglio di essa, spingerlo fino all’eccesso. È l’unico caso in cui l’eccesso non guasta”». Il Tonelli è sciocco, ma il Capuana non scherza anche lui col suo frasario da giornaletto crispino di provincia: bisognerebbe poi vedere cosa valeva allora la sua ideologia del «C’era una volta», che esaltava un paternalismo anacronistico e tutt’altro che nazionale, nell’Italia di allora.
Del Capuana occorrerà ricordare il teatro dialettale e le opinioni sulla lingua nel teatro, a proposito della quistione della lingua nella letteratura italiana. Alcune commedie del Capuana (come Giacinta, Malia, Il cavalier Pedagna) furono scritte originariamente in italiano e poi voltate in dialetto: solo in dialetto ebbero successo. Il Tonelli, che non capisce nulla, scrive che il Capuana fu indotto alla forma dialettale nel teatro «non soltanto dalla convinzione che “bisogna passare pei teatri dialettali, se si vuole davvero arrivare al teatro nazionale italiano” …, ma anche e soprattutto dal carattere particolare delle sue creazioni drammatiche: le quali sono squisitamente (!) dialettali, e nel dialetto trovano la loro più naturale e schietta espressione». Ma cosa poi significa «creazioni squisitamente dialettali»? Il fatto è spiegato col fatto stesso, cioè non è spiegato (è da ricordare ancora che il Capuana scriveva in dialetto la sua corrispondenza con una sua «mantenuta», donna del popolo, cioè comprendeva che l’italiano non gli avrebbe permesso di essere capito con esattezza e «simpaticamente» dagli elementi del popolo, la cui cultura non era nazionale, ma regionale, o nazionale‑siciliana; come, in tali condizioni, si potesse passare dal teatro dialettale a quello nazionale è una affermazione per enigmi e dimostra solo scarsa comprensione dei problemi culturali nazionali).
È da vedere, nel teatro di Pirandello, perché certe commedie sono scritte in italiano e altre in dialetto: nel Pirandello l’esame è ancor più interessante, poiché Pirandello ha, in un altro momento, acquistato una fisionomia culturale cosmopolitica, cioè è diventato italiano e nazionale in quanto si è completamente sprovincializzato ed europeizzato. La lingua non ha ancora acquistato una «storicità» di massa, non è ancora diventata un fatto nazionale. Liolà di Pirandello, in italiano letterario vale ben poco, sebbene il Fu Mattia Pascal, da cui è tratta, possa ancora leggersi con piacere. Nel testo italiano l’autore non riesce a mettersi all’unisono col pubblico, non ha la prospettiva della storicità della lingua quando i personaggi vogliono essere concretamente italiani dinanzi a un pubblico italiano. In realtà in Italia esistono molte lingue «popolari» e sono i dialetti regionali che vengono solitamente parlati nella conversazione intima, in cui si esprimono i sentimenti e gli affetti più comuni e diffusi; la lingua letteraria è ancora, per molta parte, una lingua cosmopolita, una specie di «esperanto», cioè limitata all’espressione di sentimenti e nozioni parziali ecc.
Quando si dice che la lingua letteraria ha una grande ricchezza di mezzi espressivi, si afferma una cosa equivoca ed ambigua; si confonde la ricchezza espressiva «possibile» registrata nel vocabolario o contenuta inerte negli «autori», con la ricchezza individuale, che si può spendere individualmente; ma è quest’ultima la sola ricchezza reale e concreta ed è su di essa che si può misurare il grado di unità linguistica nazionale che è data dalla vivente parlata del popolo, dal grado di nazionalizzazione del patrimonio linguistico. Nel dialogo teatrale è evidente l’importanza di tale elemento; dal palcoscenico il dialogo deve suscitare immagini viventi, con tutta la loro concretezza storica di espressione; invece suggerisce, troppo spesso, immagini libresche, sentimenti mutilati dall’incomprensione della lingua e delle sue sfumature. Le parole della parlata famigliare si riproducono nell’ascoltatore come ricordo di parole lette nei libri e nei giornali o ricercate nel vocabolario, come sarebbe il sentire in teatro parlar francese da chi il francese ha imparato nei libri senza maestro: la parola è ossificata, senza articolazione di sfumature, senza la comprensione del suo significato esatto che è dato da tutto il periodo ecc. Si ha l’impressione di essere goffi, o che goffi siano gli altri. Si osservi nell’italiano parlato quanti errori di pronunzia fa l’uomo del popolo; profùgo, roséo ecc. ciò che significa che tali parole sono state lette e non sentite, non sentite ripetutamente, cioè collocate in prospettive diverse (periodi diversi), ognuna delle quali abbia fatto brillare un lato di quel poliedro che è ogni parola (errori di sintassi ancor più significativi).
Q23 §40 Bellonci e Crémieux. La «Fiera Letteraria» del 15 gennaio 1928 riassume un articolo, abbastanza scemo e spropositante, pubblicato da G. Bellonci nel «Giornale d’Italia». Il Crémieux nel suo Panorama scrive che in Italia manca una lingua moderna, ciò che è giusto in un senso molto preciso: 1) che non esiste una concentrazione della classe colta unitaria, i cui componenti scrivano e parlino «sempre» una lingua «viva» unitaria, cioè diffusa ugualmente in tutti gli strati sociali e gruppi regionali del paese; 2) che pertanto tra la classe colta e il popolo c’è un distacco marcato: la lingua del popolo è ancora il dialetto, col sussidio di un gergo italianizzante che in gran parte è il dialetto tradotto meccanicamente. Esiste inoltre un forte influsso dei vari dialetti nella lingua scritta, perché anche la così detta classe colta parla la lingua nazionale in certi momenti e i dialetti nella parlata famigliare, cioè in quella più viva e aderente alla realtà immediata; d’altra parte, però, la reazione ai dialetti, fa sì che, nello stesso tempo, la lingua nazionale rimanga un po’ fossilizzata e paludata e quando vuol essere famigliare si frange in tanti riflessi dialettali. Oltre il tono del discorso (il cursus e la musica del periodo) che caratterizza le regioni, sono influenzati il lessico, la morfologia e specialmente la sintassi. Il Manzoni sciacquò in Arno il suo lessico personale lombardizzante, meno la morfologia e quasi affatto la sintassi, che è più connaturata allo stile, alla forma personale artistica e all’essenza nazionale della lingua. Anche in Francia qualcosa di simile si verifica come contrasto tra Parigi e la Provenza, ma in misura molto minore, quasi trascurabile; in un confronto tra A. Daudet e Zola è stato trovato che Daudet non conosce quasi più il passato remoto etimologico, che è sostituito dall’imperfetto, ciò che in Zola si verifica solo casualmente.
Il Bellonci scrive contro l’affermazione del Crémieux: «Sino al cinquecento le forme linguistiche scendono dall’alto, dal seicento in poi salgono dal basso». Sproposito madornale, per superficialità e per assenza di critica e di capacità di distinguere. Poiché proprio fino al Cinquecento Firenze esercita un’egemonia culturale, connessa alla sua egemonia commerciale e finanziaria (papa Bonifazio VIII diceva che i fiorentini erano il quinto elemento del mondo) e c’è uno sviluppo linguistico unitario dal basso, dal popolo alle persone colte, sviluppo rinforzato dai grandi scrittori fiorentini e toscani. Dopo la decadenza di Firenze, l’italiano diventa sempre più la lingua di una casta chiusa, senza contatto vivo con una parlata storica. Non è questa forse la quistione posta dal Manzoni, di ritornare a un’egemonia fiorentina con mezzi statali, ribattuta dall’Ascoli, che, più storicista, non crede alle egemonie culturali per decreto, non sorrette cioè da una funzione nazionale più profonda e necessaria?
La domanda del Bellonci: «Negherebbe forse, il Crémieux, che esista (che sia esistita, avrà voluto dire) una lingua greca perché vi hanno da essa varietà doriche, joniche, eoliche?», è solo comica; mostra che egli non ha capito il Crémieux e non capisce nulla in queste questioni, ma ragiona per categorie libresche, come lingua, dialetto, «varietà», ecc.
Q23 §41 La Fiera del Libro. Poiché il popolo non va al libro (a un certo tipo di libro, quello dei letterati professionali) il libro andrà al popolo. L’iniziativa fu lanciata dalla «Fiera Letteraria» e dal suo direttore d’allora Umberto Fracchia, nel 1927 a Milano. L’iniziativa in sé non era cattiva e ha dato qualche piccolo risultato: ma la quistione non fu affrontata nel senso che il libro deve diventare intimamente nazionale‑popolare per andare al popolo e non solo «materialmente», con le bancarelle, gli strilloni ecc. In realtà, un’organizzazione per portare il libro al popolo esisteva ed esiste, ed è rappresentata dai «pontremolesi», ma il libro così diffuso è quello della più bassa letteratura popolare, dal Segretario degli amanti al Guerino ecc. Questa organizzazione potrebbe essere «imitata», ampliata, controllata e fornita di libri meno scemi e con maggiore varietà di scelta.
Q23 §42 Luca Beltrami (Polifilo). Per rintracciare gli scritti brescianeschi del Beltrami (I popolari di Casate Olona) è da vedere la Bibliografia degli scritti di Luca Beltrami, dal marzo 1881 al marzo 1930, curata da Fortunato Pintor, bibliotecario onorario del Senato, con prefazione di Guido Mazzoni. Da un cenno pubblicato nel «Marzocco» dell’11 maggio 1930 appare che gli scritti del Beltrami sull’ipotetico «Casate Olona» sono stati ben trentacinque. Il Beltrami ha postillato questa sua Bibliografia. A proposito di «Casate Olona» il «Marzocco» scrive: «… la bibliografia dei trentacinque scritti sull’ipotetico “Casate Olona” gli suggerisce l’idea di ricomporre in unità quelle sue dichiarazioni proposte e polemiche d’indole politico‑sociale che, male intonate a un regime democratico parlamentare, sotto un certo aspetto devono considerarsi un’anticipazione di cui altri – non il Beltrami – avrebbe potuto menar vanto di antiveggente precursore (!?)». Il Beltrami era un conservatore moderato e non è certo che il suo «precorrimento» sia accettato con entusiasmo. I suoi scritti, d’altronde, sono di una volgarità intellettuale sconcertante.
Q23 §43 Giovanni Cena. Sull’attività svolta dal Cena per le scuole dei contadini dell’Agro Romano sono da vedere le pubblicazioni di Alessandro Marcucci. (Il Cena intendeva proprio «andare al popolo»; è interessante vedere come praticamente cercò di attuare il suo proposito, perché ciò mostra cosa poteva intendere un intellettuale italiano, d’altronde pieno di buone intenzioni, per «amore per il popolo»).
Q23 §44 Gino Saviotti. Sul carattere antipopolare o almeno apopolare‑nazionale della letteratura italiana hanno scritto e continuano a scrivere molti letterati. Ma in queste scritture l’argomento non è posto nei suoi termini reali e le conclusioni concrete sono spesso stupefacenti. Per esempio di Gino Saviotti, che volentieri scrive contro la letteratura dei letterati, si trova citato nell’«Italia Letteraria» del 24 agosto 1930 questo brano riportato da un articolo pubblicato nell’«Ambrosiano» del 15 agosto: «Buon Parini, si capisce perché avete sollevato la poesia italiana, ai vostri tempi. Le avete dato la serietà che le mancava, avete trasfuso nelle sue aride vene il vostro buon sangue popolano. Vi sieno rese grazie anche in questo giorno dopo centotrentun’anni dalla vostra morte. Ci vorrebbe un altro uomo come voi, oggi, nella nostra così detta poesia!». Nel 1934 è stato dato al Saviotti un premio letterario (una parte del premio Viareggio) per un romanzo in cui si rappresenta lo sforzo di un popolano per diventare «artista» (cioè per diventare «artista professionale», non essere più «popolano», ma innalzarsi al rango degli intellettuali di professione): argomento essenzialmente «antipopolare» ed esaltazione della casta, come modello di vita «superiore»: ciò che di più vecchio e stantio può trovarsi nella tradizione italiana.
Q23 §45 La «scoperta» di Italo Svevo. Italo Svevo fu rivelato al pubblico dei letterati italiani da James Joyce, che lo aveva conosciuto personalmente a Trieste (tuttavia è da ricordare che Italo Svevo aveva scritto qualche volta nella «Critica Sociale» intorno al 1900).
Commemorando lo Svevo, la «Fiera Letteraria» sostenne che prima di questa rivelazione c’era stata la «scoperta» italiana: «In questi giorni parte della stampa italiana ha ripetuto l’errore della “scoperta francese” (cioè dovuta al Crémieux, al quale però dello Svevo aveva parlato il Joyce, quindi la “Fiera Letteraria”a gioca sull’equivoco); anche i maggiori giornali par che ignorino ciò che pure è stato detto e ripetuto a tempo debito. È dunque necessario scrivere ancora una volta che gli italiani colti furono per i primi informati dell’opera dello Svevo; e che per merito di Eugenio Montale, il quale ne scrisse sulle riviste l’“Esame” e il “Quindicinale”, lo scrittore triestino ebbe in Italia il primo e legittimo riconoscimento. Con ciò non si vuol togliere agli stranieri nulla di quanto spetta loro; soltanto, ci par giusto che nessuna ombra offuschi la sincerità e, diciamo pure, la fierezza (!!) del nostro omaggio all’amico scomparso». («Fiera Letteraria»a del 23 settembre 1928 – lo Svevo era morto il 13 settembre – in un editoriale introduttivo a un articolo del Montale Ultimo addio, e a uno di Giovanni Comisso, Colloquio).
Ma questa prosetta untuosa e gesuitesca è in contraddizione con ciò che afferma Carlo Linati, nella «Nuova Antologia» del 1° febbraio 1928 (Italo Svevo, romanziere): «Due anni fa, trovandomi a prender parte alla serata di un club intellettuale milanese, ricordo che ad un certo punto entrò un giovane scrittore tornato allora allora da Parigi, il quale dopo aver discorso a lungo con noi di un pranzo del Pen Club offerto a Pirandello dai letterati parigini, aggiunse che alla fine di esso il celebre romanziere irlandese James Joyce, chiacchierando con lui della letteratura italiana moderna, gli aveva detto: – Ma voialtri italiani avete un grande prosatore e forse neanche lo sapete – Quale? – Italo Svevo, triestino». Il Linati dice che nessuno conosceva quel nome, come non lo conosceva il giovane letterato che aveva parlato col Joyce. Il Montale riuscì finalmente a «scoprire» una copia di Senilità e ne scrisse sull’«Esame». Ecco come i letterati italiani hanno «scoperto» Svevo «fieramente». Si tratta di un puro caso? Non pare. Per la «Fiera Letteraria» sono da ricordare almeno altri due «casi», quello degli Indifferenti di Moravia e quello del Malagigi di Nino Savarese, di cui parlò solo dopo che fu indicato da un concorso a premio letterario. In realtà questa gente si infischia della letteratura e della poesia, della cultura e dell’arte: esercita la professione di sacrestano letterario e nulla più.
Q23 §46 Occorre ricordare onorevolmente, nel campo della letteratura per i ragazzi, «Il Giornalino della Domenica» diretto da Vamba, con tutte le sue iniziative e le sue organizzazioni. Per la collaborazione di padre Pistelli (esempio raro di un grande filologo che lavora genialmente per i ragazzi) cfr l’articolo di Lea Nissim Omero Redi e le «Pistole» nella «Nuova Antologia» del 1° febbraio 1928.
Q23 §47 Criteri. Essere un’epoca. Nella Nuova Antologia del 16 ottobre 1928 Arturo Calza scrive: «Bisogna cioè riconoscere che – dal 1914 in qua – la letteratura ha perduto non solo il pubblico che le forniva gli alimenti (!), ma anche quello che le forniva gli argomenti. Voglio dire che in questa (nostra) società europea, la quale traversa ora uno di quei momenti più acuti e più turbinosi di crisi morale e spirituale che preparano (!) le grandi rinnovazioni, il filosofo, e dunque anche, necessariamente, il poeta, il romanziere e il drammaturgo – vedono intorno a sé piuttosto una società “in divenire” che una società assestata e assodata in uno schema definitivo (!) di vita morale e intellettuale; piuttosto vaghe e sempre mutevoli parvenze di costumi e di vita che non vita e costumi saldamente stabiliti e organizzati; piuttosto semi e germogli, che non fiori sbocciati e frutti maturati. Ond’è che – come scriveva in questi giorni egregiamente il Direttore della “Tribuna” (Roberto Forges Davanzati), e hanno ripetuto poi e anzi “intensificato” altri giornali – “noi viviamo nella maggiore assurdità artistica fra tutti gli stili e tutti i tentativi, senza più capacità di essere un’epoca”». Quante parole inutili tra il Calza e il Forges Davanzati. Forse che solo oggi c’è stata una crisi storica? E non è anzi vero che proprio nei periodi di crisi storica, le passioni e gli interessi e i sentimenti si arroventano e si ha in letteratura il «romanticismo»? Gli argomenti dei due scrittori zoppicano e si rivoltano contro gli argomentatori: come mai il Forges Davanzati non si accorge che il non aver capacità di essere un’epoca non può limitarsi all’arte ma investe tutta la vita? L’assenza di un ordine artistico (nel senso in cui può intendersi l’espressione) è coordinata all’assenza di ordine morale e intellettuale, cioè all’assenza di sviluppo storico organico. La società gira su se stessa, come un cane che vuol prendersi la coda, ma questa parvenza di movimento non è svolgimento.
Q23 §48 Antonio Fradeletto. Già radicale massone, convertito poi al cattolicismo. Era un pubblicista retorico sentimentale, oratore delle grandi occasioni, rappresentava un tipo della vecchia cultura italiana che pare tenda a sparire in quella forma primitiva, perché il tipo si è universalizzato e stemperato. Scrittori di argomenti artistici, letterari e «patriottici». In ciò appunto consisteva il tipo: che il patriottismo non era un sentimento diffuso e radicato, lo stato d’animo di uno strato nazionale, un dato di fatto, ma una «specialità oratoria» di una serie di «personaggi» (cfr Cian, per esempio), una qualifica professionale per così dire. (Non confondere con i nazionalisti, sebbene Corradini sia appartenuto a questo tipo e si differenziasse in ciò dal Coppola e anche dal Federzoni. Neanche D’Annunzio è mai rientrato perfettamente in questa categoria. Ciò che è notevole è che sarebbe molto difficile spiegare a uno straniero, specialmente a un francese, in che consisteva questo tipo, che è legato allo sviluppo particolare della cultura e della formazione nazionale italiana. Nessun confronto possibile, per esempio col Barrès o con Peguy).
Q23 §49 Scrittori tecnicamente brescianeschi. Per questi scrittori è da confrontare Monsignor Giovanni Casati, Scrittori Cattolici Italiani viventi. Dizionario bio‑bibliografico ed indice analitico delle opere, con prefazione di F. Meda, pp. VIII‑112, in‑8°, nelle varie edizioni.
È da rilevare il fatto che da qualche anno gli scrittori cattolici in senso stretto cercano di organizzarsi a sé, di formare una corporazione solidale e che si controlla e si esalta attraverso tutta una serie di pubblicazioni e di iniziative. Ragione di questo atteggiamento militante e spesso aggressivo, che è connesso alla nuova situazione che legalmente e ufficialmente il cattolicismo è venuto conquistando nel paese.
Q23 §50 Panzini. In altra nota è stato già rilevato come F. Palazzi, nella sua recensione del libro del Panzini I giorni del sole e del grano osservi come l’atteggiamento del Panzini verso il contadino sia piuttosto quello del negriero che non quello del disinteressato e candido georgico; ma questa osservazione si può estendere ad altri, oltre che al Panzini, che è solo il tipo o la maschera di un’epoca. Ma altre osservazioni fa il Palazzi che sono strettamente legate al Panzini (e collegate a certe ossessioni del Panzini, alle sue pavide ossessioni, come quella, per esempio della «livida lama»). Scrive il Palazzi (ics del giugno 1929): «Quando (il Panzini) vi fa l’elogio, a mezza bocca, del frugale pasto consumato sulle zolle, a guardarlo bene vi accorgete che la sua bocca fa le smorfie di disgusto e nell’intimo pensa come mai si possa vivere di cipolle e di brodo nero spartano, quando Dio ha messo sotto la terra il tartufo e in fondo al mare le ostriche. …. “Una volta – egli confesserà – mi è venuto anche da piangere”. Ma quel pianto non sgorga dai suoi occhi, come da quelli di Leone Tolstoi, per le miserie che sono sotto i suoi occhi, per la bellezza intravista di certi umili atteggiamenti, per la simpatia viva verso gli umili e gli afflitti che pur non mancano tra i coltivatori rudi dei campi. Oh, no! egli piange perché a sentir ricordati certi dimenticati nomi di masserizie, si ricorda di quando sua madre li chiamava pure così, e si rivede bambino e ripensa alla brevità ineluttabile della vita, alla rapidità della morte che ci è sopra. “Signor arciprete, mi raccomando: poca terra sopra la bara”. Il Panzini insomma piange perché si fa pena. Piange di sé e della morte e non per gli altri. Egli passa accanto all’anima del contadino senza vederla. Vede le apparenze esteriori, ode quel che esce appena dalla sua bocca e si domanda se pel contadino la proprietà non sia per caso sinonimo di “rubare”».
Q23 §51 «Popolarità» del Tolstoi e del Manzoni. Nel «Marzocco» dell’11 novembre 1928 è pubblicato un articolo di Adolfo Faggi, Fede e dramma, nel quale sono contenuti alcuni elementi per istituire un confronto tra la concezione del mondo del Tolstoi e quella del Manzoni, sebbene il Faggi affermi arbitrariamente che i «Promessi Sposi corrispondono perfettamente al suo (del Tolstoi) concetto dell’arte religiosa», esposto nello studio critico sullo Shakespeare: «L’arte in generale e in particolare l’arte drammatica fu sempre religiosa, ebbe cioè sempre per iscopo di chiarire agli uomini i loro rapporti con Dio, secondo la comprensione che di questi rapporti s’erano fatta in ogni età gli uomini più eminenti e destinati perciò a guidare gli altri… Ci fu poi una deviazione nell’arte che l’asservì al passatempo e al divertimento; deviazione che ha avuto luogo anche nell’arte cristiana». Nota il Faggi che in Guerra e Pace i due personaggi che hanno la maggior importanza religiosa sono Platone Karatajev e Pietro Biezuchov: il primo è uomo del popolo, e il suo pensiero ingenuo ed istintivo ha molta efficacia sulla concezione della vita di P. Biezuchov.
Nel Tolstoi è caratteristico appunto che la saggezza ingenua ed istintiva del popolo, enunciata anche con una parola casuale, faccia la luce e determini una crisi nell’uomo colto. Ciò appunto è il tratto più rilevante della religione del Tolstoi che intende l’Evangelo «democraticamente», cioè secondo il suo spirito originario e originale. Il Manzoni invece ha subìto la Controriforma: il suo cristianesimo ondeggia tra un aristocraticismo giansenistico e un paternalismo popolaresco gesuitico. Il rilievo del Faggi che «nei Promessi Sposi sono gli spiriti superiori come il padre Cristoforo e il cardinale Borromeo che agiscono sugli inferiori e sanno sempre trovare per loro la parola che illumina e guida» non ha connessione sostanziale con la formulazione di ciò che è l’arte religiosa di Tolstoi, che si riferisce alla concezione generale e non ai particolari modi di estrinsecazione: le concezioni del mondo non possono non essere elaborate da spiriti eminenti, ma la «realtà» è espressa dagli umili, dai semplici di spirito.
Bisogna inoltre notare che nei Promessi Sposi non c’è popolano che non sia «preso in giro» e canzonato: da don Abbondio a fra Galdino, al sarto, a Gervasio, ad Agnese, a Perpetua, a Renzo, alla stessa Lucia: essi sono rappresentati come gente meschina, angusta, senza vita interiore. Vita interiore hanno solo i signori: fra Cristoforo, il Borromeo, l’Innominato, lo stesso don Rodrigo. Perpetua, secondo don Abbondio, aveva detto presso a poco ciò che disse poi il Borromeo, ma intanto si tratta di quistioni pratiche e poi è notevole come lo spunto sia oggetto di comicità. Così il fatto che il parere di Renzo sul valore del voto di verginità di Lucia coincide esteriormente col parere di padre Cristoforo. L’importanza che ha la frase di Lucia nel turbare la coscienza dell’Innominato e nel secondarne la crisi morale è di carattere non illuminante e folgorante come ha l’apporto del popolo, sorgente di vita morale e religiosa, nel Tolstoi, ma meccanico e di carattere «sillogistico». In realtà anche nel Manzoni si possono trovare voli tracce di Brescianesimo. (È da notare che prima del Parini, furono i gesuiti a «valorizzare» «paternalisticamente» il popolo: cfr La giovinezza del Parini, Verri e Beccaria di C. A. Vianello (Milano, 1933), dove si accenna al padre gesuita Pozzi «che tanto prima del Parini insorse a difendere ed esaltare – innanzi al consesso del migliore patriziato milanese – “il plebeo” o proletario, come ora si direbbe» (vedi «Civiltà Cattolica» del 4 agosto 1934, p. 272).
In un secondo articolo pubblicato nel «Marzocco» del 9 settembre 1928, il Faggi (Tolstoi e Shakespeare) esamina l’opuscolo di Tolstoi su Shakespeare, al quale aveva accennato nell’articolo precedente: Leo N. Tolstoi: Shakespeare, eine kritische Studie, Hannover, 1906. Il volumetto contiene anche un articolo di Ernest Crosby su L’atteggiamento dello Shakespeare davanti alle classi lavoratrici e una breve lettera di Bernardo Shaw sulla filosofia dello Shakespeare. Tolstoi vuole demolire lo Shakespeare partendo dal punto di vista della propria ideologia cristiana; la sua critica non è artistica, ma morale e religiosa. L’articolo del Crosby, da cui prese le mosse, mostra, contrariamente all’opinione di molti illustri inglesi, che non c’è in tutta l’opera dello Shakespeare quasi alcuna parola di simpatia per il popolo e le masse lavoratrici. Lo Shakespeare, conforme alle tendenze del suo tempo, parteggia manifestamente per le classi elevate della società: il suo dramma è essenzialmente aristocratico. Quasi tutte le volte che egli introduce sulla scena dei borghesi o dei popolani, li presenta in maniera sprezzante o repugnante, e li fa materia o argomento di riso (cfr ciò che già detto del Manzoni, la cui tendenza è analoga, sebbene le manifestazioni ne siano attenuate).
La lettera dello Shaw è rivolta contro Shakespeare «pensatore», non contro Shakespeare «artista», Secondo lo Shaw nella letteratura si deve dare il primo posto a quegli autori che hanno superato la morale del loro tempo e intraveduto le nuove esigenze dell’avvenire: Shakespeare non fu «moralmente» superiore al suo tempo ecc.
In queste occorre evitare ogni tendenziosità moralistica tipo Tolstoi e anche ogni tendenziosità del «senno di poi» tipo Shaw. Si tratta di una ricerca di storia della cultura, non di critica artistica in senso stretto: si vuole dimostrare che sono gli autori esaminati che introducono un contenuto morale estrinseco, cioè fanno della propaganda e non dell’arte, e che la concezione del mondo implicita nelle loro opere è angusta e meschina, non nazionale‑popolare ma di casta chiusa. La ricerca sulla bellezza di un’opera è subordinata alla ricerca del perché essa è «letta», è «popolare», è «ricercata» o, all’opposto, del perché non tocca il popolo e non l’interessa, mettendo in evidenza la assenza di unità nella vita culturale nazionale.
Q23 §52 Bruno Cicognani e l’autentica fondamentale umanità. Su Bruno Cicognani scrive Alfredo Gargiulo nell’«Italia Letteraria» del 24 agosto 1930 (cap. XIX di 1900-1930): «L’uomo e l’artista fanno nel Cicognani una cosa sola: nondimeno si sente il bisogno di dichiarar subito, quasi in separata sede (!), la simpatia che ispira l’uomo. L’umanissimo Cicognani! Qualche sconfinamento, lieve del resto, nell’umanitarismo di tipo romantico o slavo: che importa? Ognuno sarà disposto a perdonarglielo, in omaggio a quell’autentica (!) fondamentale umanità». Dal seguito non si capisce bene ciò che il Gargiulo intende dire: è forse «mostruoso» criticamente che l’uomo e l’artista si identifichino? O la attività artistica non è l’umanità dell’artista? E cosa significa quell’aggettivo «autentica» e l’altro «fondamentale»? Sono sinonimi dell’aggettivo «vero» che ormai è screditato per la sua vacuità. (Occorrerà, per questa rubrica, rileggere tutta l’esposizione del Gargiulo).
Umanità «autentica, fondamentale» può significare concretamente, nel campo artistico, una cosa sola: «storicità», cioè carattere «nazionale‑popolare» dello scrittore, sia pure nel senso largo di «socialità», anche in senso aristocratico, purché il gruppo sociale che si esprime sia vivo storicamente e il «collegamento» sociale non sia di carattere «pratico‑politico» immediato, cioè predicatorio‑moralistico, ma storico o etico‑politico.
Q23 § 53. Direttive e deviazioni. Tentativi francesi di letteratura popolare. È stata pubblicata un’antologia di scrittori operai americani (Poèmes d’ouvriers américains, traduits par N. Guterman et P. Morbange dalle edizioni «Les Revues», 1930, 9 franchi, Parigi) che ha avuto molto successo nella critica francese come si vede dagli estratti pubblicati nel prospetto editoriale.
Nel 1925 alle «Editions Aujourd’hui» è stata pubblicata una Anthologie des écrivains ouvriers raccolta da Gaston Depresle con prefazione di Barbusse (scritti, tra l’altro, di Marguerite Andoux, Pierre Hamp ecc.).
La Libreria Valois ha pubblicato nel 1930: Henri Poulaille, Nouvel âge littéraire nel cui prospetto editoriale sono elencati i nomi di C. L. Philippe, Carlo Péguy, G. Sorel, L. e M. Bonneff, Marcel Martinet, Carlo Vildrac ecc. (non appare se si tratta di un’antologia o di una raccolta di articoli critici del Poulaille). Da vedere i tentativi di Enrico Rocca nel «Lavoro Fascista» per sollecitare una collaborazione letteraria di operai. Critica di questi tentativi.
Q23 §54 Giulio Bechi. Morto il 28 agosto 1917 al fronte (cfr giornali e riviste del tempo: ne scrisse Guido Biagi nel «Marzocco»; cfr i Profili e caratteri di Ermenegildo Pistelli). Mario Puccioni (Militarismo e italianità negli scritti di Giulio Bechi, nel «Marzocco» del 13 luglio 1930), scrive: «La mentalità dei parlamentari sardi volle vedere in Caccia grossa solo un attacco spietato contro usi e persone e riuscì a fargli passare un guaio – così Giulio diceva con frase partenopea – di due mesi di arresto nella fortezza di Belvedere»; ciò che non è esatto perfettamente (pare che il Bechi sia stato sfidato a duello per aver «parlato male delle donne sarde» e quindi punito dall’autorità militare per essersi messo in condizioni di essere sfidato). Il Bechi andò in Sardegna col 67° fanteria. La quistione del contegno del Bechi nella repressione del così detto brigantaggio nuorese, con misure da stato d’assedio, illegali, e l’aver trattato la popolazione come negri, arrestando in massa vecchi e bambini, risulta dal tono generale del libro e dallo stesso titolo di esso ed è più complessa di quanto paia al Puccioni, il quale cerca di mettere in rilievo come il Bechi protestasse per l’abbandono in cui era lasciata la Sardegna e come esaltasse le virtù native dei sardi. Il libro mostra invece come il Bechi abbia colto l’occasione di fare della mediocre letteratura su avvenimenti gravi e tristi per la storia nazionale.
Q23 §55 Oscar Maria Graf. È stato tradotto in francese un romanzo di Oscar Maria Graf: Nous sommes prisonniers… (ed. Gallimard, 1930) che pare sia interessante e significativo come tentativo letterario di un operaio (panettiere?) tedesco.
Q23 §56 Lina Pietravalle. Dalla recensione scritta da Giulio Marzot del romanzo della Pietravalle Le Catene (Mondadori, 1930, pp. 320, L. 12): «A chi domanda con quale sentimento partecipa alla vita dei contadini, Felicia risponde: “Li amo come la terra, ma non mischierò la terra col mio pane”. C’è dunque la coscienza di un distacco: si ammette che anche (!) il contadino possa avere la sua dignità umana, ma lo si costringe entro i limiti della sua condizione sociale».
Il Marzot ha scritto un saggio su Giovanni Verga ed è un critico talvolta intelligente.
Sarebbe da studiare questo punto: se il naturalismo francese, nelle sue pretese di obbiettività scientifica e sperimentale, non contenesse già, in genere, la posizione ideologica che ebbe poi grande sviluppo nel naturalismo o realismo provinciale italiano e specialmente nel Verga: il popolo della campagna è visto con «distacco», come «natura» estrinseca sentimentalmente allo scrittore, come spettacolo ecc. È la posizione di Io e le belve di Hagenbeck. In Italia, la pretesa «naturalistica» dell’obbiettività sperimentale degli scrittori francesi che aveva un’origine polemica contro gli scrittori aristocratici, si innestò in una posizione ideologica preesistente, come appare dai Promessi Sposi, in cui esiste lo stesso «distacco» dagli elementi popolari, distacco appena velato da un benevolo sorriso ironico e caricaturale. In ciò Manzoni si distingue dal Grossi che nel Marco Visconti non canzona i popolani e persino dal D’Azeglio delle Memorie, almeno per ciò che riguarda le sulla popolazione dei castelli romani.
Q23 §57 La cultura nazionale italiana. Nella Lettera a Umberto Fracchia sulla critica («Pègaso», agosto 1930) Ugo Ojetti fa due osservazioni voli. 1) Ricorda che il Thibaudet divide la critica in tre classi: quella dei critici di professione, quella degli stessi autori e quella «des honnêtes gens», cioè del pubblico «illuminato», che alla fine è la vera Borsa dei valori letterari, visto che in Francia esiste un pubblico largo ed attento a seguire tutte le vicende della letteratura. In Italia mancherebbe la critica del pubblico (cioè mancherebbe o sarebbe troppo scarso un pubblico medio illuminato come esiste in Francia), «manca la persuasione o, se si vuole, l’illusione che questi (lo scrittore) compia opera d’importanza nazionale, anzi, i migliori, storica, perché, come ella (il Fracchia) dice “ogni anno e ogni giorno che passa ha ugualmente la sua letteratura, e così è sempre stato, e così sarà sempre, ed è assurdo aspettare o pronosticare o invocare per domani ciò che oggi è. Ogni secolo, ogni porzione di secolo, ha sempre esaltato le proprie opere; è anzi stato portato se mai ad esagerarne l’importanza, la grandezza, il valore e la durata”. Giusto, ma non in Italia ecc.». (L’Ojetti prende lo spunto dalla lettera aperta di Umberto Fracchia a S. E. Gioacchino Volpe, pubblicata nell’«Italia Letteraria» del 22 giugno 1930 e che si riferisce al discorso del Volpe tenuto nella seduta dell’Accademia in cui furono distribuiti dei premi. Il Volpe aveva detto, fra l’altro: «Non si vedono spuntare grandi opere pittoriche, grandi opere storiche, grandi romanzi.
Ma chi guarda attentamente, vede nella presente letteratura forze latenti, aneliti all’ascesa, alcune buone e promettenti realizzazioni»).
2) L’altra osservazione dell’Ojetti è questa: «La scarsa popolarità della nostra letteratura passata, cioè dei nostri classici. È vero: nella critica inglese e francese si leggono spesso paragoni tra gli autori viventi e i classici ecc. ecc.». Questa osservazione è fondamentale per un giudizio storico sulla presente cultura italiana: il passato non vive nel presente, non è elemento essenziale del presente, cioè nella storia della cultura nazionale non c’è continuità e unità. L’affermazione di una continuità ed unità è solo un’affermazione retorica o ha valore di mera propaganda suggestiva, è un atto pratico, che tende a creare artificialmente ciò che non esiste, non è una realtà in atto. (Una certa continuità e unità parve esistere dal Risorgimento fino al Carducci e al Pascoli, per i quali era possibile un richiamo fino alla letteratura latina; furono spezzate col D’Annunzio e successori). Il passato, compresa la letteratura, non è elemento di vita, ma solo di cultura libresca e scolastica; ciò che poi significa che il sentimento nazionale è recente, se addirittura non conviene dire che esso è solo ancora in via di formazione, riaffermando che in Italia la letteratura non è mai stata un fatto nazionale, ma di carattere «cosmopolitico».
Dalla lettera aperta di Umberto Fracchia a S. E. G. Volpe si possono estrarre altri brani tipici: «Solo un po’ più di coraggio, di abbandono (!), di fede (!) basterebbero per trasformare l’elogio a denti stretti che Ella ha fatto della presente letteratura in un elogio aperto ed esplicito; per dire che la presente letteratura italiana ha forze non solo latenti, ma anche scoperte, visibili (!) le quali non aspettano (!) che di essere vedute (!) e riconosciute da quanti le ignorano, ecc. ecc.». Il Volpe aveva un po’ «sul serio» parafrasato i versi giocosi del Giusti: «Eroi, eroi, che fate voi?
– Ponziamo il poi!», e il Fracchia si lamenta miserevolmente che non siano riconosciute ed apprezzate le ponzature come ponzature.
Il Fracchia parecchie volte ha minacciato gli editori che stampano troppe traduzioni di misure legislative‑corporative che proteggano gli scrittori italiani (è da ricordare l’ordinanza del sottosegretario agli Interni on. Bianchi, poi «interpretata» e di fatto revocata, e che era connessa a una campagna giornalistica del Fracchia). Il ragionamento del Fracchia già citato: ogni secolo, ogni frazione di secolo ha la sua letteratura, non solo, ma la esalta; tanto che le storie letterarie hanno dovuto mettere a posto molte opere esaltatissime e che oggi si riconosce non valgono nulla. All’ingrosso il fatto è giusto, ma se ne deve dedurre che l’attuale periodo letterario non sa interpretare il suo tempo, è staccato dalla vita nazionale effettiva, sicché neanche per «ragioni pratiche» vengono esaltate opere che poi magari potrebbero essere riconosciute artisticamente nulle perché la loro «praticità» sarà stata superata. Ma è vero che non ci siano libri molto letti? ci sono, ma sono stranieri e ce ne sarebbero di più se fossero tradotti, come i libri di Remarque, ecc. Realmente il tempo presente non ha una letteratura aderente ai suoi bisogni più profondi ed elementari, perché la letteratura esistente, salvo rare eccezioni, non è legata alla vita popolare‑nazionale, ma a gruppi ristretti che della vita nazionale sono le mosche cocchiere. Il Fracchia si lamenta della critica, che si pone solo dal punto di vista dei grandi capolavori, che si è rarefatta nella perfezione delle teorie estetiche ecc. Ma se i libri fossero esaminati da un punto di vista di storia della cultura, si lamenterebbe lo stesso e peggio, perché il contenuto ideologico e culturale dell’attuale letteratura è quasi zero, ed è, per di più, contraddittorio e discretamente gesuitico.
Non è neanche vero (come ha scritto l’Ojetti nella lettera al Fracchia) che in Italia non esista una «critica del pubblico»; esiste, ma a suo modo, perché il pubblico legge molto e quindi sceglie tra ciò che esiste a sua disposizione. Perché questo pubblico preferisce ancora Alessandro Dumas e Carolina Invernizio e si getta avidamente sui romanzi gialli? D’altronde questa critica del pubblico italiano ha una sua organizzazione, che è rappresentata dagli editori, dai direttori di quotidiani e periodici popolari; si manifesta nella scelta delle appendici; si manifesta nella traduzione di libri stranieri e non solo attuali, ma vecchi, molto vecchi; si manifesta nei repertori delle compagnie teatrali ecc. Né si tratta di esotismo al cento per cento, perché in musica lo stesso pubblico vuole Verdi, Puccini, Mascagni, che non hanno i corrispondenti nella letteratura, evidentemente. Non solo; ma all’estero Verdi, Puccini, Mascagni sono preferiti spesso dai pubblici stranieri ai loro stessi musicisti nazionali e attuali. Questo fatto è la riprova più perentoria che in Italia c’è distacco tra pubblico e scrittori e il pubblico cerca la «sua» letteratura all’estero, perché la sente più «sua» di quella così detta nazionale. In questo fatto è posto un problema di vita nazionale essenziale. Se è vero che ogni secolo o frazione di secolo ha la sua letteratura, non è sempre vero che questa letteratura sia prodotta nella stessa comunità nazionale. Ogni popolo ha la sua letteratura, ma essa può venirgli da un altro popolo, cioè il popolo in parola può essere subordinato all’egemonia intellettuale e morale di altri popoli. È questo spesso il paradosso più stridente per molte tendenze monopolistiche di carattere nazionalistico e repressivo: che mentre si costruiscono piani grandiosi di egemonia, non ci si accorge di essere oggetto di egemonie straniere; così come, mentre si fanno piani imperialistici, in realtà si è oggetto di altri imperialismi ecc. D’altronde non si sa se il centro politico dirigente non capisca benissimo la situazione di fatto e non cerchi di superarla: è certo però che i letterati, in questo caso, non aiutano il centro dirigente politico in questi sforzi e i loro cervelli vuoti si accaniscono nell’esaltazione nazionalistica per non sentire il peso dell’egemonia da cui si dipende e si è oppressi.
Q23 §58 Il sentimento «attivo» nazionale degli scrittori. Estratto dalla Lettera a Piero Parini sugli scrittori sedentari di Ugo Ojetti (nel «Pègaso» del settembre 1930): «Come mai noi italiani che abbiamo portato su tutta la terra il nostro lavoro e non soltanto il lavoro manuale, e che da Melbourne a Rio, da S. Francisco a Marsiglia, da Lima a Tunisi abbiamo dense colonie nostre, siamo i soli a non avere romanzi in cui i nostri costumi e la nostra coscienza siano rivelati in contrasto con la coscienza e i costumi di quelli stranieri fra i quali siamo capitati a vivere, a lottare, a soffrire, e talvolta anche a vincere? D’Italiani, in basso e in alto, manovali o banchieri, minatori o medici, camerieri o ingegneri, muratori o mercanti, se ne trovano in ogni angolo del mondo. La letteratissima letteratura nostra li ignora, anzi li ha sempre ignorati. Se non v’è romanzo o dramma senza un progrediente contrasto d’anime, quale contrasto più profondo e concreto di questo tra due razze, e la più antica delle due, la più ricca cioè d’usi e riti immemorabili, spatriata e ridotta a vivere senza altro soccorso che quello della propria energia e resistenza?».
Molte osservazioni o aggiunte da fare. In Italia è sempre esistita una notevole massa di pubblicazioni sull’emigrazione, come fenomeno economico‑sociale. Non corrisponde una letteratura artistica: ma ogni emigrante racchiude in sé un dramma, già prima di partire dall’Italia. Che i letterati non si occupino dell’emigrato all’estero dovrebbe far meno meraviglia del fatto che non si occupano di lui prima che emigri, delle condizioni che lo costringono a emigrare ecc.; che non si occupino cioè delle lacrime e del sangue che in Italia, prima che all’estero, ha voluto dire l’emigrazione in massa. D’altronde occorre dire che se è scarsa (e per lo più retorica) la letteratura sugli italiani all’estero, è scarsa anche la letteratura sui paesi stranieri. Perché fosse possibile, come scrive l’Ojetti, rappresentare il contrasto tra italiani immigrati e le popolazioni dei paesi d’immigrazione, occorrerebbe conoscere e questi paesi e… gli italiani.
Q23 §59 Leonida Répaci. Una sua lettera alla direzione dell’«Italia Letteraria» (7 luglio 1934) per protestare molto comicamente contro una stroncatura di Roberto Fracassi del romanzo Potenza dei fratelli Rupe, contiene, riferite a se stesso, queste parole: «… un uomo, un uomo vero, di quelli che la vita se la guadagnano giorno per giorno con fatica e qualche volta con disperazione».
QUADERNO 24
GIORNALISMO
Q24 §1 Il tipo di giornalismo che si considera in queste è
quello che si potrebbe chiamare «integrale» (nel senso che
acquisterà significato sempre più chiaro nel corso delle
stesse), cioè quello che non solo intende soddisfare tutti i
bisogni (di una certa categoria) del suo pubblico, ma intende di
creare e sviluppare questi bisogni e quindi di suscitare, in un
certo senso, il suo pubblico e di estenderne progressivamente
l’area. Se si esaminano tutte le forme di giornalismo e di
attività pubblicistica‑editoriale in genere esistenti, si vede
che ognuna di esse presuppone altre forze da integrare o alle
quali coordinarsi «meccanicamente». Per svolgere criticamente
l’argomento e studiarne tutti i lati, pare più opportuno (ai
fini metodologici e didattici) presupporre un’altra situazione:
che esista, come punto di partenza, un aggruppamento culturale
(in senso lato) più o meno omogeneo, di un certo tipo, di un
certo livello e specialmente con un certo orientamento generale
e che su tale aggruppamento si voglia far leva per costruire un
edificio culturale completo, autarchico, cominciando addirittura
dalla... lingua, cioè dal mezzo di espressione e di contatto
reciproco.
Tutto l’edifizio dovrebbe essere costruito secondo principii «razionali», cioè funzionali, in quanto si hanno determinate premesse e si vogliono raggiungere determinate conseguenze. Certo, durante l’elaborazione del «piano» le premesse necessariamente mutano, perché se è vero che un certo fine presuppone certe premesse è anche vero che, durante l’elaborazione reale dell’attività data, le premesse sono necessariamente mutate e trasformate e la coscienza del fine, allargandosi e concretandosi, reagisce sulle premesse «conformandole» sempre più. L’esistenza oggettiva delle premesse permette di pensare a certi fini, cioè le premesse date sono tali solo in rapporto a certi fini pensabili come concreti. Ma se i fini cominciano progressivamente a realizzarsi, per il fatto di tale realizzazione, dell’effettualità raggiunta, mutano necessariamente le premesse iniziali, che intanto non sono più… iniziali e quindi mutano anche i fini pensabili e così via. A questo nesso si pensa ben raramente, quantunque sia di evidenza immediata. La sua manifestazione la vediamo nelle imprese «secondo un piano» che non sono puri «meccanismi», appunto perché si basano secondo questo modo di pensare in cui la parte della libertà e dello spirito d’iniziativa (spirito di «combinazioni») è molto più grande di quanto non vogliano ammettere, per il ruolo di maschere da commedia dell’arte che è loro proprio, i rappresentanti ufficiali della «libertà» e dell’«iniziativa» astrattamente concepite (o troppo «concretamente» concepite). Questo nesso è dunque vero, tuttavia è anche vero che le «premesse» iniziali si ripresentano continuamente sia pure in altre condizioni. Che una «leva scolastica» impari l’alfabeto non significa che l’analfabetismo scompaia di colpo e per sempre; ogni anno ci sarà una nuova «leva» a cui insegnare l’alfabeto. Tuttavia è evidente che quanto più l’analfabetismo diventa raro negli adulti, tanto meno difficoltà si presenteranno per popolare le scuole elementari fino al 100%: ci saranno sempre «analfabeti» ma essi tenderanno a scomparire fino al limite normale dei fanciulli di 5‑6 anni.
Q24 §2 Ecco come negli «Annali dell’Italia Cattolica» per il 1926 si descrivono i diversi tipi di giornale, con riferimento alla stampa cattolica: «In senso largo il giornale “cattolico” (o piuttosto “scritto da cattolici”) è quello che non contiene nulla contro la dottrina e morale cattolica, e ne segue e difende le norme. Dentro tali linee il giornale può perseguire intenti politici, economico‑sociali, o scientifici. Invece il giornale “cattolico” in senso stretto è quello che, d’intesa con l’Autorità Ecclesiastica, ha come scopo diretto un efficace apostolato sociale cristiano, a servizio della Chiesa e in aiuto dell’Azione cattolica. Esso importa, almeno implicitamente, la responsabilità dell’Autorità Ecclesiastica, e però ne deve seguire le norme e direttive».
Si distingue, insomma, il giornale così detto d’informazione o «senza partito» esplicito, dal giornale d’opinione, dall’organo ufficiale di un determinato partito; il giornale per le masse popolari o giornale «popolare» da quello dedicato a un pubblico necessariamente ristretto.
Nella storia della tecnica giornalistica, per alcuni aspetti, può essere ritenuto «esemplare» il «Piccolo» di Trieste, come appare almeno dal libro dedicato alla storia di questo giornale da Silvio Benco (per rapporto alla legislazione austriaca sulla stampa, alla posizione dell’irredentismo italiano nell’Istria, al legalitarismo formale delle autorità imperiali e regie, alle lotte interne tra le diverse frazioni dell’irredentismo, al rapporto tra la massa popolare nazionale e la direzione politica del nazionalismo italiano, ecc.).
Per altri aspetti è stato molto interessante il «Corriere della Sera» nel periodo giolittiano o liberale in genere, se si tiene conto della situazione giornalistica e politico‑culturale italiana, talmente diversa da quella francese e in generale da quella degli altri paesi europei. La divisione netta, esistente in Francia, tra giornali popolari e giornali d’opinione, non può esistere in Italia, dove manca un centro così popoloso e culturalmente predominante come Parigi (e dove esiste minore «indispensabilità» del giornale politico anche nelle classi superiori e così dette colte). È da notare inoltre come il «Corriere», pur essendo il giornale più diffuso del paese, non sia mai stato ministeriale esplicitamente che per brevi periodi di tempo e anche a modo suo: per essere «statale» doveva anzi essere quasi sempre antiministeriale, esprimendo così una delle più voli contraddizioni della vita nazionale.
Sarebbe utile ricercare nella storia del giornalismo italiano le ragioni tecniche e politico‑culturali della fortuna che ebbe per un certo tempo il vecchio «Secolo» di Milano. Pare che nella storia del giornalismo italiano si possano distinguere due periodi: quello «primitivo» dell’indistinto generico politico culturale che rese possibile la grande diffusione del «Secolo» su un programma di un vago «laicismo» (contro l’influsso clericale) e di un vago «democraticismo» (contro l’influsso preponderante nella vita statale delle forze di destra): il «Secolo» inoltre fu il primo giornale italiano «moderno» con servizi dall’estero, con abbondanza d’informazioni e di cronaca europea, ecc.; un periodo successivo in cui, attraverso il trasformismo, le forze di destra si «nazionalizzano» in senso popolare e il «Corriere» sostituisce il «Secolo» nella grande diffusione: il vago laicismo democratico del «Secolo» diventa nel «Corriere» unitarismo nazionale più concreto, il laicismo è meno plebeo e sbracato e il nazionalismo meno popolaresco e democratizzante. È da notare come nessuno dei partiti distintisi dall’informe popolarismo «secolino» abbia tentato di ricreare l’unità democratica su un piano politico‑culturale più elevato e concreto di quello precedente e primitivo, ma questo compito sia stato abbandonato quasi senza lotta ai conservatori del «Corriere». Eppure questo dovrebbe essere il compito, dopo ogni processo di chiarificazione e distinzione: ricreare l’unità, rottasi nel movimento progressivo, su un piano superiore, da parte della élite che dall’indistinto generico è riuscita a conquistare una più concreta personalità, esercitando una funzione direttiva sul vecchio complesso da cui si è distinta e staccata. Lo stesso processo si è ripetuto nel mondo cattolico dopo la formazione del Partito Popolare, «distinzione» democratica che i destri sono riusciti a subordinare ai propri programmi. Nell’un caso e nell’altro i piccoli borghesi, pur essendo la maggioranza tra gli intellettuali dirigenti, sono stati soverchiati dagli elementi della classe fondamentale: nel campo laico gli industriali del «Corriere», nel campo cattolico la borghesia agraria unita ai grandi proprietari soverchiano i professionisti della politica del «Secolo» e del Partito Popolare, che pure rappresentano le grandi masse dei due campi, i semiproletari e piccoli borghesi della città e della campagna.
Q24 §3 Riviste tipiche. All’ingrosso si possono stabilire tre tipi fondamentali di riviste, caratterizzate dal modo con cui sono compilate, dal tipo di lettori cui intendono rivolgersi, dai fini educativi che vogliono raggiungere. Il primo tipo può essere offerto dalla combinazione degli elementi direttivi che si riscontrano in modo specializzato nella «Critica» di B. Croce, nella «Politica» di F. Coppola e nella «Nuova Rivista Storica» di C. Barbagallo. Il secondo tipo «critico‑storico‑bibliografico» dalla combinazione degli elementi che caratterizzavano i fascicoli meglio riusciti del «Leonardo» di L. Russo, l’«Unità» di Rerum Scriptor e la «Voce» di Prezzolini. Il terzo tipo dalla combinazione di alcuni elementi del secondo tipo e il tipo di settimanale inglese come il «Manchester Guardian Weekly», o il «Times Weekly».
Ognuno di questi tipi dovrebbe essere caratterizzato da un indirizzo intellettuale molto unitario e non antologico, cioè dovrebbe avere una redazione omogenea e disciplinata; quindi pochi collaboratori «principali» dovrebbero scrivere il corpo essenziale di ogni fascicolo. L’indirizzo redazionale dovrebbe essere fortemente organizzato in modo da produrre un lavoro omogeneo intellettualmente, pur nella necessaria varietà dello stile e delle personalità letterarie: la redazione dovrebbe avere uno statuto scritto che, per ciò che può servire, impedisca le scorribande, i conflitti, le contraddizioni (per esempio, il contenuto di ogni fascicolo dovrebbe essere approvato dalla maggioranza redazionale prima della pubblicazione).
Un organismo unitario di cultura che offrisse ai diversi strati del pubblico i tre tipi suaccennati di riviste (e d’altronde tra i tre tipi dovrebbe circolare uno spirito comune) coadiuvate da collezioni librarie corrispondenti, darebbe soddisfazione alle esigenze di una certa massa di pubblico che è più attiva intellettualmente, ma solo allo stato potenziale, che più importa elaborare, far pensare concretamente, trasformare, omogeneizzare, secondo un processo di sviluppo organico che conduca dal semplice senso comune al pensiero coerente e sistematico.
Tipo critico‑storico‑bibliografico: esame analitico di opere, fatto dal punto di vista dei lettori della rivista che non possono, generalmente, leggere le opere stesse. Uno studioso che esamina un fenomeno storico determinato, per costruire un saggio sintetico, deve compiere tutta una serie di ricerche e operazioni intellettuali preliminari, che solo in piccola parte risultano utilizzate. Questo lavorio può essere invece utilizzabile per questo tipo medio di rivista, dedicato a un lettore che ha bisogno, per svilupparsi intellettualmente, di aver dinanzi, oltre al saggio sintetico, tutta l’attività analitica nel suo complesso che ha condotto a quel tale risultato. Il lettore comune non ha e non può avere un abito «scientifico», che solo si acquista col lavoro specializzato: occorre perciò aiutarlo a procurarsene almeno il «senso» con una attività critica opportuna. Non basta dargli dei concetti già elaborati e fissati nell’espressione «definitiva»; la loro concretezza, che è nel processo che ha condotto a quella affermazione, gli sfugge; occorre perciò offrirgli tutta la serie dei ragionamenti e dei nessi intermedi, ben individualizzati e non solo per accenni. Per es.: un movimento storico complesso si scompone nel tempo e nello spazio e inoltre può scomporsi in piani diversi: così l’Azione Cattolica, pur avendo sempre avuto una direttiva unica e centralizzata, mostra grandi differenze (e anche contrasti) di atteggiamenti regionali nei diversi tempi e a seconda dei problemi speciali (per es. la quistione agraria, l’indirizzo sindacale, ecc.).
Nelle riviste di questo tipo sono indispensabili o utili alcune rubriche: 1) un dizionario enciclopedico politico-scientifico‑filosofico, in questo senso: in ogni fascicolo sono da pubblicarsi una (o più) piccola monografia di carattere enciclopedico su concetti politici, filosofici, scientifici che ricorrono spesso nei giornali e nelle riviste e che il lettore medio difficilmente comprende o addirittura travisa. In realtà ogni corrente culturale crea un suo linguaggio, cioè partecipa allo sviluppo generale di una determinata lingua nazionale, introducendo termini nuovi, arricchendo di contenuto nuovo termini già in uso, creando metafore, servendosi di nomi storici per facilitare la comprensione e il giudizio su determinate situazioni attuali ecc. ecc. Le trattazioni dovrebbero essere «pratiche», cioè riallacciarsi a esigenze realmente sentite, ed essere, per la forma dell’esposizione, adeguate alla media dei lettori. I compilatori dovrebbero essere possibilmente informati degli errori più diffusi e risalire alle fonti stesse degli errori, cioè alle pubblicazioni di paccotiglia scientifica, tipo «Biblioteca popolare Sonzogno» o dizionari enciclopedici (Melzi, Premoli, Bonacci, ecc.) o enciclopedie popolari più diffuse (quella Sonzogno, ecc.). Queste trattazioni non dovrebbero presentarsi in forma organica (per es., in un ordine alfabetico o di raggruppamenti per materia), né secondo un’economia prefissata di spazio, come se già fosse in vista un’opera complessiva, ma invece dovrebbero essere messe in rapporto immediato con gli argomenti svolti dalla stessa rivista o da quelle collegate di tipo superiore o più elementare: l’ampiezza della trattazione dovrebbe essere fissata volta a volta non dall’importanza intrinseca dell’argomento ma dall’interesse immediato giornalistico (tutto ciò sia detto in generale e col solito grano di sale): insomma la rubrica non deve presentarsi come un libro pubblicato a puntate, ma come, ogni volta, trattazione di argomenti interessanti per se stessi, da cui potrà scaturire un libro, ma non necessariamente.
2) Legata alla precedente è la rubrica delle biografie, da intendersi in due sensi: sia in quanto tutta la vita di un uomo può interessare la cultura generale di un certo strato sociale, sia in quanto un nome storico può entrare in un dizionario enciclopedico per un determinato concetto o evento suggestivo.
Così, per esempio, può darsi che si debba parlare di lord Carson, per accennare al fatto che la crisi del regime parlamentare esisteva già prima della guerra mondiale e proprio in Inghilterra, nel paese, cioè, dove questo regime pareva più efficiente e sostanziale; – ciò non vorrà dire che si debba fare tutta la biografia di lord Carson. A una persona di media cultura interessano due soli dati biografici: a) lord Carson nel 1914, alla vigilia della guerra, arruolò nell’Ulster un corpo armato numerosissimo per opporsi con l’insurrezione a che fosse applicata la legge dell’Home Rule irlandese, approvata dal Parlamento che, secondo «il modo di dire» inglese, «può far tutto eccetto che un uomo diventi donna»; b) lord Carson non solo non fu punito per «alto tradimento», ma divenne ministro poco dopo, allo scoppio della guerra. (Può essere utile che le biografie complete siano presentate in rubrica separata).
3) Altra rubrica può essere quella delle autobiografie politico‑intellettuali. Se ben costruite, con sincerità e semplicità, esse possono essere del massimo interesse giornalistico e di grande efficacia formativa. Come uno sia riuscito a districarsi da un certo ambiente provinciale o corporativo, attraverso quali impulsi esterni e quali lotte interiori, per raggiungere una personalità superiore storicamente, può suggerire, in forma vivente, un indirizzo intellettuale e morale, oltre che essere un documento dello sviluppo culturale in certe epoche.
4) Una rubrica fondamentale può essere costituita dall’esame critico‑storico‑bibliografico delle situazioni regionali (intendendo per regione un organismo geoeconomico differenziato). Molti vorrebbero conoscere e studiare le situazioni locali, che interessano sempre molto, ma non sanno come fare, da dove incominciare: non conoscono il materiale bibliografico, non sanno fare ricerche nelle biblioteche ecc. Si tratterebbe dunque di dare l’ordito generale di un problema concreto (o di un tema scientifico), indicando i libri che l’hanno trattato, gli articoli delle riviste specializzate, oltre che il materiale ancora grezzo (statistiche, ecc.), in forma di rassegne bibliografiche, con speciale diffusione per le pubblicazioni poco comuni o in lingue straniere. Questo lavoro, oltre che per le regioni, può essere fatto, da diversi punti di vista, per problemi generali, di cultura ecc.
5) Uno spoglio sistematico di giornali e riviste per la parte che interessa le rubriche fondamentali: sola citazione degli autori, dei titoli, con brevi cenni sulle tendenze: questa rubrica bibliografica dovrebbe essere compilata per ogni fascicolo, e per alcuni argomenti dovrebbe essere anche retrospettiva.
6) Recensioni di libri. Due tipi di recensione. Un tipo critico‑informativo: si suppone che il lettore medio non possa leggere il libro dato, ma che sia utile per lui conoscerne il contenuto e le conclusioni. Un tipo teorico‑critico: si suppone che il lettore debba leggere il libro dato e quindi esso non viene semplicemente riassunto, ma si svolgono criticamente le obbiezioni che si possono muovere, si pone l’accento sulle parti più interessanti, si svolge qualche parte che vi è sacrificata ecc. Questo secondo tipo di recensione è più adatto per le riviste di grado superiore.
7) Uno spoglio critico bibliografico, ordinato per argomenti o gruppi di quistioni, della letteratura riguardante gli autori e le quistioni fondamentali per la concezione del mondo che è alla base delle riviste pubblicate: per gli autori italiani e per le traduzioni in italiano degli autori stranieri. Questo spoglio dovrebbe essere molto minuzioso e circostanziato, poiché occorre tener presente che attraverso questo lavoro e questa elaborazione critica sistematica si può solo raggiungere la fonte autentica di tutta una serie di concetti errati che circolano senza controllo e censura. Occorre tener presente che in ogni regione italiana, data la ricchissima varietà di tradizioni locali, esistono gruppi e gruppetti caratterizzati da motivi ideologici e psicologici particolari: «ogni paese ha o ha avuto il suo santo locale, quindi il suo culto e la sua cappella».
La elaborazione nazionale unitaria di una coscienza collettiva omogenea domanda condizioni e iniziative molteplici. La diffusione da un centro omogeneo di un modo di pensare e di operare omogeneo è la condizione principale, ma non deve e non può essere la sola. Un errore molto diffuso consiste nel pensare che ogni strato sociale elabori la sua coscienza e la sua cultura allo stesso modo, con gli stessi metodi, cioè i metodi degli intellettuali di professione. L’intellettuale è un «professionista» (skilled), che conosce il funzionamento di proprie «macchine» specializzate; ha un suo «tirocinio» e un suo «sistema Taylor». È puerile e illusorio attribuire a tutti gli uomini questa capacità acquisita e non innata, così come sarebbe puerile credere che ogni manovale può fare il macchinista ferroviario. È puerile pensare che un «concetto chiaro», opportunamente diffuso, si inserisca nelle diverse coscienze con gli stessi effetti «organizzatori» di chiarezza diffusa: è questo un errore «illuministico». La capacità dell’intellettuale di professione di combinare abilmente l’induzione e la deduzione, di generalizzare senza cadere nel vuoto formalismo, di trasportare da una sfera a un’altra di giudizio certi criteri di discriminazione, adattandoli alle nuove condizioni, ecc., è una «specialità», una «qualifica», non è un dato del volgare senso comune. Ecco dunque che non basta la premessa della «diffusione organica da un centro omogeneo di un modo di pensare e operare omogeneo». Lo stesso raggio luminoso passando per prismi diversi dà rifrazioni di luce diversa: se si vuole la stessa rifrazione occorre tutta una serie di rettificazioni dei singoli prismi.
La «ripetizione» paziente e sistematica è un principio metodico fondamentale: ma la ripetizione non meccanica, «ossessionante», materiale; ma l’adattamento di ogni concetto alle diverse peculiarità e tradizioni culturali, il presentarlo e ripresentarlo in tutti i suoi aspetti positivi e nelle sue negazioni tradizionali, organando sempre ogni aspetto parziale nella totalità. Trovare la reale identità sotto l’apparente differenziazione e contraddizione, e trovare la sostanziale diversità sotto l’apparente identità è la più delicata, incompresa eppure essenziale dote del critico delle idee e dello storico dello sviluppo storico. Il lavoro educativo-formativo che un centro omogeneo di cultura svolge, l’elaborazione di una coscienza critica che esso promuove e favorisce su una determinata base storica che contenga le premesse concrete per tale elaborazione, non può limitarsi alla semplice enunciazione teorica di principii «chiari» di metodo: questa sarebbe pura azione da «filosofi» del Settecento. Il lavoro necessario è complesso e deve essere articolato e graduato: ci deve essere la deduzione e l’induzione combinate, la logica formale e la dialettica, l’identificazione e la distinzione, la dimostrazione positiva e la distruzione del vecchio. Ma non in astratto, ma in concreto, sulla base del reale e dell’esperienza effettiva. Ma come sapere quali siano gli errori più diffusi e radicati? Evidentemente è impossibile una «statistica» dei modi di pensare e delle singole opinioni individuali, con tutte le combinazioni che ne risultano per gruppi e gruppetti, che dia un quadro organico e sistematico della situazione culturale effettiva e dei modi in cui si presenta realmente il «senso comune»; non rimane altro che la revisione sistematica della letteratura più diffusa e più accetta al popolo, combinata con lo studio e la critica delle correnti ideologiche del passato, ognuna delle quali «può» aver lasciato un sedimento, variamente combinandosi con quelle precedenti e susseguenti.
In questo stesso ordine di osservazioni si inserisce un criterio più generale: i mutamenti nei modi di pensare, nelle credenze, nelle opinioni, non avvengono per «esplosioni» rapide, simultanee e generalizzate, avvengono invece quasi sempre per «combinazioni successive», secondo «formule» disparatissime e incontrollabili «d’autorità». L’illusione «esplosiva» nasce da assenza di spirito critico. Come non si è passati, nei metodi di trazione, dalla diligenza a motore animale ai moderni espressi elettrici, ma si è passati attraverso una serie di combinazioni intermedie, che in parte sussistono ancora (come la trazione animale su rotaie, ecc. ecc.) e come avviene che il materiale ferroviario invecchiato negli Stati Uniti sia utilizzato ancora per molti anni in Cina e vi rappresenti un progresso tecnico, così nella sfera della cultura i diversi strati ideologici si combinano variamente e ciò che è diventato «ferravecchio» in città è ancora «utensile» in provincia. Nella sfera della cultura, anzi, le «esplosioni» sono ancora meno frequenti e meno intense che nella sfera della tecnica, in cui una innovazione si diffonde, almeno nel piano più elevato, con relativa rapidità e simultaneità. Si confonde l’«esplosione» di passioni politiche accumulatesi in un periodo di trasformazioni tecniche, alle quali non corrispondono forme nuove di una adeguata organizzazione giuridica, ma immediatamente un certo grado di coercizioni dirette e indirette, con le trasformazioni culturali, che sono lente e graduali, perché se la passione è impulsiva, la cultura è prodotto di una elaborazione complessa. (L’accenno al fatto che talvolta ciò che è diventato «ferravecchio» in città è ancora «utensile» in provincia può essere utilmente svolto).
Q24 §4 Una rivista tipica è stata l’«Osservatore» del Gozzi, cioè il tipo di rivista moraleggiante del Settecento (che raggiunse la perfezione in Inghilterra, dove era sorta, con lo «Spectator» dell’Addison) che ebbe un certo significato storico‑culturale per diffondere la nuova concezione della vita, servendo di anello di passaggio, per il lettore medio, tra la religione e la civiltà moderna. Oggi il tipo, degenerato, si conserva specialmente nel campo cattolico, mentre nel campo della civiltà moderna, si è trasformato, incorporandosi nelle riviste umoristiche, che, a loro modo, vorrebbero essere una critica «costruttiva» del costume. Le pubblicazioni tipo «Fantasio», «Charivari», ecc., che non hanno corrispondenti in Italia (qualcosa del genere erano il primitivo «Asino» di Podrecca e il «Seme», scritto per i contadini). Per alcuni aspetti sono una derivazione della rivista moraleggiante settecentesca alcune rubriche della cronaca cittadina e della cronaca giudiziaria dei quotidiani e i così detti «piccoli elzeviri» o corsivi.
La «Frusta letteraria» del Baretti è una varietà del tipo: rivista di bibliografia universale ed enciclopedica, critica del contenuto con tendenze moralizzatrici (critica dei costumi, dei modi di vedere, dei punti di vista, prendendo lo spunto non dalla vita e dalla cronaca, ma dai libri). «Lacerba» di Papini, per la parte non artistica, rientrò in questo tipo in modo originale e avvincente per alcune qualità, ma la tendenza «satanistica» (Gesù peccatore, Viva il maiale, Contro la famiglia, ecc., di Papini; il Giornale di bordo di Soffici; gli articoli di Italo Tavolato: Elogio della prostituzione, ecc.) era sforzata e l’originalità troppo spesso era artificio.
Il tipo generale si può dire appartenga alla sfera del «senso comune» o «buon senso», perché il suo fine è di modificare l’opinione media di una certa società, criticando, suggerendo, sbeffeggiando, correggendo, svecchiando, e, in definitiva, introducendo «nuovi luoghi comuni». Se ben scritte, con brio, con un certo senso di distacco (in modo da non assumere toni da predicatore), ma tuttavia con interesse cordiale per l’opinione media, le riviste di questo tipo possono avere grande diffusione ed esercitare un influsso profondo. Non devono avere nessuna «mutria», né scientifica né moralisteggiante, non devono essere «filistee» e accademiche, né apparire fanatiche o soverchiamente partigiane: debbono porsi nel campo stesso del «senso comune», distaccandosene quel tanto che permette il sorriso canzonatorio, ma non di disprezzo o di altezzosa superiorità.
«La Pietra» e la «Compagnia della Pietra». Motto dantesco dalle rime della Pietra: «Così nel mio parlar voglio esser aspro».
Ogni strato sociale ha il suo «senso comune» e il suo «buon senso», che sono in fondo la concezione della vita e dell’uomo più diffusa. Ogni corrente filosofica lascia una sedimentazione di «senso comune»: è questo il documento della sua effettualità storica. Il senso comune non è qualcosa di irrigidito e di immobile, ma si trasforma continuamente arricchendosi di nozioni scientifiche e di opinioni filosofiche entrate nel costume. Il «senso comune» è il folclore della filosofia e sta sempre di mezzo tra il folclore vero e proprio (cioè come è comunemente inteso) e la filosofia, la scienza, l’economia degli scienziati. Il senso comune crea il futuro folclore, cioè una fase relativamente irrigidita delle conoscenze popolari di un certo tempo e luogo.
Q24 §5 Annuari e almanacchi. Il tipo di rivista «Politica» ‑ «Critica» esige immediatamente un corpo di redattori specializzati, in grado di fornire, con una certa periodicità, un materiale scientificamente elaborato e selezionato; l’esistenza di questo corpo di redattori, che abbiano raggiunto tra loro un certo grado di omogeneità culturale, è cosa tutt’altro che facile, e rappresenta un punto d’arrivo nello svolgimento di un movimento culturale. Questo tipo di rivista può essere sostituito (o anticipato) con la pubblicazione di un «Annuario». Questi «Annuari» non dovrebbero avere niente di simile ad un comune «Almanacco» popolare (la cui compilazione è legata qualitativamente al quotidiano, cioè è predisposta tenendo di vista il lettore medio del quotidiano); non deve neanche essere una antologia occasionale di scritti troppo lunghi per essere accolti in altro tipo di rivista; dovrebbe invece essere preparato organicamente, secondo un piano generale, in modo da essere come il prospetto di un determinato programma di rivista. Potrebbe essere dedicato a un solo argomento oppure essere diviso in sezioni e trattare una serie organica di quistioni fondamentali (la costituzione dello Stato, la politica internazionale, la quistione agraria, ecc.). Ogni Annuario dovrebbe stare a sé (non dovrebbe avere scritti in continuazione) ed essere fornito di bibliografie, di indici analitici, ecc.
Studiare i diversi tipi di «Almanacchi» popolari (che sono, se ben fatti, delle piccole Enciclopedie dell’attualità).
Q24 §6 Per una esposizione generale dei tipi principali di riviste è da ricordare l’attività giornalistica di Carlo Cattaneo. L’«Archivio Triennale» e il «Politecnico» sono da studiare con molta attenzione (accanto al «Politecnico» la rivista «Scientia» fondata dal Rignano).
Q24 §7 Saggi originali e traduzioni. La quistione si pone specialmente per le riviste di tipo medio ed elementare, che dovrebbero anch’esse essere composte prevalentemente di scritti originali. Occorre reagire contro l’abitudine tradizionale di riempire le riviste con traduzioni, anche se di scritti dovuti a persone «autorevoli». Tuttavia la collaborazione di scrittori stranieri non può essere abolita: essa ha la sua importanza culturale, di reazione contro il provincialismo e la meschinità. Diverse soluzioni: 1) ottenere una collaborazione originale; 2) riassumere i principali scritti della stampa internazionale, compilando una rubrica come quella dei Marginalia del «Marzocco»; 3) compilare dei supplementi periodici di sole traduzioni, con titolo parzialmente indipendente, con numerazione di pagine propria, che contenga una scelta organica, critico‑informativa, delle pubblicazioni teoriche straniere. (È da vedere il tipo «Minerva» popolare, e il tipo «Rassegna della Stampa Estera» pubblicata dal Ministero degli Esteri).
Q24 §8 Rubriche scientifiche. Il tipo italiano del giornale quotidiano è determinato dall’insieme delle condizioni organizzative della vita culturale nel paese: mancanza di una vasta letteratura di divulgazione, sia attraverso il libro che la rivista. Il lettore del giornale vuole perciò trovare nel suo foglio un riflesso di tutti gli aspetti della complessa vita sociale di una nazione moderna. È da rilevare il fatto che il giornale italiano, relativamente meglio fatto e più serio che in altri paesi, abbia nel paese trascurato l’informazione scientifica, mentre esisteva un corpo notevole di giornalisti specializzati per la letteratura economica, letteraria ed artistica. Anche nelle riviste più importanti (come la «Nuova Antologia» e la «Rivista d’Italia») la parte dedicata alle scienze era quasi nulla (oggi le condizioni sono mutate da questo punto di vista e il «Corriere della Sera» ha una serie di collaboratori, specializzati nelle quistioni scientifiche, molto notevole). Sono sempre esistite riviste scientifiche di specialisti, ma mancavano le riviste di divulgazione (è da vedere l’«Arduo» che usciva a Bologna diretto da S. Timpanaro; molto diffusa la «Scienza per Tutti» della Casa Sonzogno, ma per un giudizio di essa basta ricordare che fu diretta per molti anni da… Massimo Rocca).
L’informazione scientifica dovrebbe essere integrante di qualsiasi giornale italiano, sia come notiziario scientifico-tecnologico, sia come esposizione critica delle ipotesi e opinioni scientifiche più importanti (la parte igienico‑sanitaria dovrebbe costituire una rubrica a sé). Un giornale popolare, più degli altri, dovrebbe avere questa sezione scientifica, per controllare e dirigere la cultura dei suoi lettori, che spesso è «stregonesca» o fantastica e per «sprovincializzare» le nozioni correnti.
Difficoltà di avere specialisti che sappiano scrivere popolarmente: si potrebbe fare lo spoglio sistematico delle riviste generali e speciali di cultura professionale, degli atti delle Accademie, delle pubblicazioni straniere e compilare estratti e riassunti in appendici speciali, scegliendo accuratamente e con intelligenza delle esigenze culturali del popolo, gli argomenti e il materiale.
Q24 §9 Scuole di giornalismo. Nella Nuova Antologia del 1° luglio 1928 è pubblicato, con questo titolo, un articolo di Ermanno Amicucci, che forse in seguito è stato pubblicato in volume con altri. L’articolo è interessante per le informazioni e gli spunti che offre. È da rilevare tuttavia che in Italia la quistione è molto più complessa da risolvere di quanto non paia leggendo questo articolo ed è da credere che i risultati delle iniziative scolastiche non possano essere molto grandi (almeno per ciò che riguarda il giornalismo tecnicamente inteso; le scuole di giornalismo saranno scuole di propaganda politica generale). Il principio, però, che il giornalismo debba essere insegnato e che non sia razionale lasciare che il giornalista si formi da sé, casualmente, attraverso la «praticaccia», è vitale e si andrà sempre più imponendo, a mano a mano che il giornalismo, anche in Italia, diventerà un’industria più complessa e un organismo civile più responsabile. La quistione, in Italia, trova i suoi limiti nel fatto che non esistono grandi concentrazioni giornalistiche, per il decentramento della vita culturale nazionale, che i giornali sono molto pochi e la massa dei lettori è scarsa. Il personale giornalistico è molto limitato e quindi si alimenta attraverso le sue stesse gradazioni d’importanza: i giornali meno importanti (e i settimanali) servono da scuola per i giornali più importanti e reciprocamente. Un redattore di secondo ordine del «Corriere» diventa direttore o redattore capo di un giornale di provincia e un redattore rivelatosi di primo ordine in un giornale di provincia o in un settimanale, viene assorbito da un grande giornale ecc. Non esistono in Italia centri come Parigi, Londra, Berlino, ecc., che contano migliaia di giornalisti, costituenti una vera categoria professionale diffusa, economicamente importante; inoltre le retribuzioni in Italia, come media, sono molto basse. In alcuni paesi, come quelli tedeschi, il numero dei giornali che si pubblicano in tutto il paese è imponente, e alla concentrazione di Berlino corrisponde una vasta stratificazione in provincia.
Quistione dei corrispondenti locali, che raramente (solo per le grandi città e in generale per quelle dove si pubblicano settimanali importanti) possono essere giornalisti di professione.
Per certi tipi di giornale il problema della scuola professionale deve essere risolto nell’ambito della stessa redazione, trasformando o integrando le riunioni periodiche redazionali in scuole organiche di giornalismo, ad assistere alle cui lezioni dovrebbero essere invitati anche elementi estranei alla redazione in senso stretto: giovani e studenti, fino ad assumere il carattere di vere scuole politico‑giornalistiche, con lezioni di argomenti generali (di storia, di economia, di diritto costituzionale, ecc.) affidate anche a estranei competenti e che sappiano investirsi dei bisogni del giornale.
Si dovrebbe partire dal principio che ogni redattore o reporter dovrebbe essere messo in grado di compilare e dirigere tutte le parti del giornale, così come, subito, ogni redattore dovrebbe acquistare le qualità di reporter, cioè dare tutta la sua attività al giornale, ecc.
A proposito del numero dei giornalisti italiani, l’«Italia Letteraria» del 24 agosto 1930 riferisce i dati di un censimento eseguito dalla Segreteria del Sindacato Nazionale dei giornalisti: al 30 giugno erano inscritti 1960 giornalisti dei quali 800 affiliati al Partito Fascista, così ripartiti: Sindacato di Bari, 30 e 26, Bologna 108 e 40, Firenze 108 e 43, Genova 113 e 39, Milano 348 e 143, Napoli 106 e 45, Palermo 50 e 17, Roma 716 e 259, Torino 144 e 59, Trieste 90 e 62, Venezia 147 e 59.
QUADERNO 25
I MARGINI DELLA STORIA. STORIA DEI GRUPPI SOCIALI SUBALTERNI
Q25 §1 Davide Lazzaretti. In un articolo pubblicato dalla «Fiera
Letteraria» del 26 agosto 1928, Domenico Bulferetti ricorda
alcuni elementi della vita e della formazione culturale di
Davide Lazzaretti. Bibliografia: Andrea Verga, Davide Lazzaretti
e la pazzia sensoria (Milano, Rechiedei, 1880); Cesare Lombroso,
Pazzi e anormali (questo era il costume culturale del tempo:
invece di studiare le origini di un avvenimento collettivo, e le
ragioni del suo diffondersi, del suo essere collettivo, si
isolava il protagonista e ci si limitava a farne la biografia
patologica, troppo spesso prendendo le mosse da motivi non
accertati o interpretabili in modo diverso: per una élite
sociale, gli elementi dei gruppi subalterni hanno sempre
alcunché di barbarico e di patologico). Una Storia di David
Lazzaretti, Profeta di Arcidosso fu pubblicata a Siena nel 1905
da uno dei più distinti discepoli del Lazzaretti, l’ex‑frate
filippino Filippo Imperiuzzi: altre scritture apologetiche
esistono, ma questa è la più notevole, secondo il Bulferetti. Ma
l’opera «fondamentale» sul Lazzaretti è quella di Giacomo
Barzellotti, che nella 1a e2a edizione (presso Zanichelli) era
intitolata Davide Lazzaretti e che fu ampliata e in parte
modificata nelle successive edizioni (Treves) col titolo Monte
Amiata e il suo Profeta. Il Bulferetti crede che il Barzellotti
abbia sostenuto che le cause del movimento lazzarettista sono
«tutte particolari e dovute solo allo stato d’animo e di coltura
di quella gente là» solo «un po’ per naturale amore ai bei
luoghi nativi (!) e un po’ per suggestione delle teorie di
Ippolito Taine». È più ovvio pensare, invece, che il libro del
Barzellotti, che ha servito a formare l’opinione pubblica
italiana sul Lazzaretti, sia niente altro che una manifestazione
di patriottismo letterario (– per amor di patria! – come si
dice) che portava a cercar di nascondere le cause di malessere
generale che esistevano in Italia dopo il 70, dando, dei singoli
episodi di esplosione di tale malessere, spiegazioni
restrittive, individuali, folcloristiche, patologiche ecc. La
stessa cosa è avvenuta più in grande per il «brigantaggio»
meridionale e delle isole.
Gli uomini politici non si sono occupati del fatto che l’uccisione del Lazzaretti è stata di una crudeltà feroce e freddamente premeditata (in realtà il Lazzaretti fu fucilato e non ucciso in conflitto: sarebbe interessante conoscere le istruzioni riservate mandate dal governo alle autorità): neanche i repubblicani se ne sono occupati (ricercare e verificare) nonostante che il Lazzaretti sia morto inneggiando alla repubblica (il carattere tendenzialmente repubblicano del movimento, che era tale da poter diffondersi tra i contadini, deve aver specialmente contribuito a determinare la volontà del governo di sterminarne il protagonista), forse per la ragione che nel movimento la tendenzialità repubblicana era bizzarramente mescolata all’elemento religioso e profetico. Ma appunto questo miscuglio rappresenta la caratteristica principale dell’avvenimento perché dimostra la sua popolarità e spontaneità. È da ritenere inoltre che il movimento lazzarettista sia stato legato al non‑expedit del Vaticano, e abbia mostrato al governo quale tendenza sovversiva‑popolare‑elementare poteva nascere tra i contadini in seguito all’astensionismo politico clericale e al fatto che le masse rurali, in assenza di partiti regolari, si cercavano dirigenti locali che emergevano dalla massa stessa, mescolando la religione e il fanatismo all’insieme di rivendicazioni che in forma elementare fermentavano nelle campagne. Altro elemento politico da tener presente è questo: al governo erano andate da due anni le sinistre, il cui avvento aveva suscitato nel popolo un ribollimento di speranze e di aspettazioni che dovevano essere deluse. Il fatto che al governo fossero le sinistre può spiegare anche la tiepidezza nel sostenere una lotta per l’uccisione delittuosa di un uomo che poteva essere presentato come un codino, papalino, clericale ecc.
Nota il Bulferetti che il Barzellotti non fece ricerche sulla formazione della cultura del Lazzaretti, alla quale pure si riferisce. Altrimenti avrebbe visto che anche a Monte Amiata arrivavano allora in gran copia (!? da dove lo sa il Bulferetti? D’altronde per chi conosce la vita dei contadini, specialmente di una volta, la «gran copia» non è necessaria, per spiegare l’estensione e la profondità di un movimento) foglietti, opuscoli e libri popolari stampati a Milano. Il Lazzaretti ne era lettore insaziabile e per il suo mestiere di barrocciaio aveva agio di procurarsene. Davide era nato in Arcidosso il 6 novembre 1834 e aveva esercitato il mestiere paterno fino al 1868, quando, da bestemmiatore si convertì e si ritirò a far penitenza in una grotta della Sabina dove «vide» l’ombra di un guerriero che gli «rivelò» di essere il capostipite della sua famiglia, Manfredo Pallavicino, figlio illegittimo di un re di Francia ecc. Uno studioso danese, il dottor Emilio Rasmussen, trovò che Manfredo Pallavicino è il protagonista di un romanzo storico di Giuseppe Rovani, intitolato appunto Manfredo Pallavicino. L’intreccio e le avventure del romanzo sono passati tali e quali nella «rivelazione» della grotta e da questa rivelazione si inizia la propaganda religiosa del Lazzaretti. Il Barzellotti aveva creduto invece che il Lazzaretti fosse stato influenzato dalle leggende del Trecento (le avventure del re Giannino, senese) e la scoperta del Rasmussen lo indusse solo a introdurre nell’ultima edizione del suo libro un vago accenno alle letture del Lazzaretti, senza però accennare al Rasmussen e lasciando intatta la parte del libro dedicata a re Giannino. Tuttavia il Barzellotti studia il successivo svolgimento dello spirito del Lazzaretti, i suoi viaggi in Francia, e l’influsso che ebbe su di lui il prete milanese Onorio Taramelli, «uomo di fine ingegno e larga coltura», che per aver scritto contro la monarchia era stato arrestato a Milano e poi era fuggito in Francia. Dal Taramelli Davide ebbe l’impulso repubblicano. La bandiera di Davide era rossa con la scritta: «La repubblica e il regno di Dio». Nella processione del 18 agosto 1878 in cui Davide fu ucciso, egli domandò ai suoi fedeli se volevano la repubblica. Al «sì» fragoroso egli rispose: «la repubblica incomincia da oggi in poi nel mondo; ma non sarà quella del ’48: sarà il regno di Dio, la legge del Diritto succeduta a quella di Grazia». Nella risposta di David ci sono alcuni elementi interessanti, che devono essere collegati alle sue reminiscenze delle parole del Taramelli: il voler distinguersi dal ’48 che in Toscana non aveva lasciato buon ricordo tra i contadini, la distinzione tra Diritto e Grazia.
Il dramma del Lazzaretti deve essere riannodato alle «imprese» delle così dette bande di Benevento, che sono quasi simultanee: i preti e i contadini coinvolti nel processo di Malatesta pensavano in modo molto analogo a quello dei Lazzarettisti, come risulta dai resoconti giudiziari (cfr per es. il libro di Nitti sul Socialismo Cattolico dove giustamente si accenna alle bande di Benevento: vedere se accenni al Lazzaretti). In ogni modo, il dramma del Lazzaretti è stato finora veduto solo dal punto di vista dell’impressionismo letterario, mentre meriterebbe un’analisi politico‑storica.
Giuseppe Fatini, nell’«Illustrazione Toscana» (cfr il «Marzocco» del 31 gennaio 1932) richiama l’attenzione sulle attuali sopravvivenze del lazzarettismo. Si credeva che dopo l’esecuzione di Davide da parte dei carabinieri, ogni traccia di lazzarettismo si fosse per sempre dispersa anche nelle pendici dell’Amiata grossetana. Invece i lazzarettisti o cristiani giurisdavidici, come amano chiamarsi, continuano a vivere: raccolti per lo più nel villaggio arcidossino di Zancona, con qualche proselite sparso nelle borgate adiacenti, trassero dalla guerra mondiale nuovo alimento per stringersi sempre più fra loro nella memoria del Lazzaretti, che, secondo i seguaci, aveva tutto previsto, dalla guerra mondiale a Caporetto, dalla vittoria del popolo latino alla nascita della Società delle Nazioni. Di quando in quando, quei fedeli si fanno vivi fuor del loro piccolo cerchio con opuscoli di propaganda, indirizzandoli ai «fratelli del popolo latino», e in essi raccolgono qualcuno dei tanti scritti, anche poetici, lasciati inediti dal Maestro e che i seguaci custodiscono gelosamente.
Ma che cosa vogliono i cristiani giurisdavidici? A chi non è ancora tocco dalla grazia di poter penetrare nel segreto del linguaggio dei Santi non è facile comprendere la sostanza della loro dottrina. La quale è un miscuglio di dottrine religiose d’altri tempi con una buona dose di massime socialistoidi e con accenni generici alla redenzione morale dell’uomo, redenzione che non potrà attuarsi se non col pieno rinnovamento dello spirito e della gerarchia della Chiesa Cattolica. L’articolo XXIV che chiude il «Simbolo dello Spirito Santo», costituente come il «Credo» dei lazzarettisti, dichiara che «il nostro istitutore David Lazzaretti, l’unto del Signore, giudicato e condannato dalla Curia Romana, è realmente il Cristo Duce e Giudice nella vera e viva figura della seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo sul mondo, come figlio dell’uomo venuto a portare compimento alla Redenzione copiosa su tutto il genere umano in virtù della terza legge divina del Diritto e Riforma generale dello Spirito Santo, la quale deve riunire tutti gli uomini alla fede di Cristo in seno alla Cattolica Chiesa in un sol punto e in una sola legge in conferma delle divine promesse». Parve per un momento, nel dopoguerra, che i lazzarettisti si incanalassero «per una via pericolosa», ma seppero ritrarsene a tempo e dettero piena adesione ai vincitori. Non certo per le sue divergenze con la Chiesa cattolica – «la setta dell’Idolatria papale» – ma per la tenacia con cui essi difendono il Maestro e la Riforma, il Fatini ritiene degno di attenzione e di studio il fenomeno religioso amiatino.
Q25 §2 Criteri metodologici. La storia dei gruppi sociali subalterni è necessariamente disgregata ed episodica. È indubbio che nell’attività storica di questi gruppi c’è la tendenza all’unificazione sia pure su piani provvisori, ma questa tendenza è continuamente spezzata dall’iniziativa dei gruppi dominanti, e pertanto può essere dimostrata solo a ciclo storico compiuto, se esso si conchiude con un successo. I gruppi subalterni subiscono sempre l’iniziativa dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano e insorgono: solo la vittoria «permanente» spezza, e non immediatamente, la subordinazione. In realtà, anche quando paiono trionfanti, i gruppi subalterni sono solo in istato di difesa allarmata (questa verità si può dimostrare con la storia della Rivoluzione francese fino al 1830 almeno). Ogni traccia di iniziativa autonoma da parte dei gruppi subalterni dovrebbe perciò essere di valore inestimabile per lo storico integrale; da ciò risulta che una tale storia non può essere trattata che per monografie e che ogni monografia domanda un cumulo molto grande di materiali spesso difficili da raccogliere.
Q25 §3 Adriano Tilgher, Homo faber. Storia del concetto del lavoro nella civiltà occidentale, Roma, Libreria di Scienze e Lettere, 1929. L. 15.
Q25 §4 Alcune generali sullo sviluppo storico dei gruppi sociali subalterni nel Medio Evo e a Roma. Nel saggio di Ettore Ciccotti Elementi di «verità» e di «certezza» nella tradizione storica romana (contenuto nel volume Confronti storici) ci sono alcuni accenni allo sviluppo storico delle classi popolari nei Comuni italiani, specialmente degni di attenzione e di trattazione separata. Le guerre reciproche fra i Comuni e quindi la necessità di reclutare una più vigorosa e abbondante forza militare col lasciare armare il maggior numero, davano la coscienza della loro forza ai popolani e nello stesso tempo ne rinsaldavano le file (cioè funzionarono da eccitanti alla formazione compatta e solidale di gruppo e di partito). I combattenti rimanevano uniti anche in pace, sia per il servizio da prestare, sia, in prosieguo, con crescente solidarietà, per fini di utilità particolare. Si hanno gli statuti delle «Società d’armi», che si costituirono a Bologna, come sembra, verso il 1230 ed emerge il carattere della loro unione e il loro modo di costituzione. Verso la metà del secolo XIII le società erano già ventiquattro, distribuite a seconda della contrada ove abitavano (i componenti). Oltre al loro ufficio politico di difesa esterna del Comune, avevano il fine di assicurare a ciascun popolano la tutela necessaria contro le aggressioni dei nobili e dei potenti. I capitoli dei loro statuti – per esempio della Società detta dei Leoni – hanno in rubrica titoli come: «De adiutorio dando hominibus dicte societatis…»; «Quod molestati iniuste debeant adiuvari ab hominibus dicte societatis». E alle sanzioni civili e sociali si aggiungevano, oltre al giuramento, una sanzione religiosa, con la comune assistenza alla messa e alla celebrazione di uffici divini, mentre altri obblighi comuni, come quelli, comuni alle confraternite pie, di soccorrere i soci poveri, seppellire i defunti ecc., rendevano sempre più persistente e stretta l’unione. Per le funzioni stesse delle società si formarono poi cariche e consigli ‑ a Bologna, per es., quattro o otto «ministeriales» foggiati sugli ordini della Società delle Arti o su quelli più antichi del Comune – che col tempo ebbero valore oltre i termini delle società e trovarono luogo nella costituzione del Comune.
Originariamente, in queste società entrano milites al pari di pedites, nobili e popolani, se anche in minor numero. Ma, a grado a grado, i milites, i nobili tendono ad appartarsene, come a Siena, o, secondo i casi, ne possono essere espulsi, come nel 1270, a Bologna. E a misura che il movimento di emancipazione prende piede, oltrepassando anche i limiti e la forma di queste società, l’elemento popolare chiede e ottiene la partecipazione alle maggiori cariche pubbliche. Il popolo si costituisce sempre più in vero partito politico e per dare maggiore efficienza e centralizzazione alla sua azione si dà un capo, «il Capitano del popolo», ufficio che pare Siena abbia preso da Pisa e che nel nome come nella funzione, rivela insieme origini e funzioni militari e politiche. Il popolo che già, volta a volta, ma sporadicamente, si era armato, si era riunito, si era costituito e aveva preso deliberazioni distinte, si costituisce come un ente a parte, che si dà anche proprie leggi. Campana propria per le sue convocazioni «cum campana Comunis non bene audiatur». Entra in contrasto col Podestà a cui contesta il diritto di pubblicar bandi e col quale il Capitano del popolo stipula delle «paci». Quando il popolo non riesce ad ottenere dalle autorità comunali le riforme volute, fa la sua secessione, con l’appoggio di uomini eminenti del Comune e, costituitosi in assemblea indipendente, incomincia a creare magistrature proprie ad immagine di quelle generali del Comune, ad attribuire una giurisdizione al Capitano del popolo, e a deliberare di sua autorità, dando inizio (dal 1255) a tutta un’opera legislativa. (Questi dati sono del Comune di Siena). Il popolo riesce, prima praticamente, e poi anche formalmente, a fare accettare negli Statuti generali del Comune disposizioni che prima non legavano se non gli ascritti al «Popolo» e di uso interno. Il popolo giunge quindi a dominate il Comune, soverchiando la precedente classe dominante, come a Siena dopo il 1270, a Bologna con gli Ordinamenti «Sacrati» e «Sacratissimi», a Firenze con gli «Ordinamenti di giustizia». (Provenzan Salvani a Siena è un nobile che si pone a capo del popolo).
La maggior parte dei problemi di storia romana che il Ciccotti prospetta nello studio già citato (a parte l’accertamento di episodi «personali» come quello di Tanaquilla ecc.) si riferiscono ad eventi ed istituzioni dei gruppi sociali subalterni (tribuno della plebe ecc.). Perciò il metodo dell’«analogia» affermato e teorizzato dal Ciccotti può dare qualche risultato «indiziario», perché, i gruppi subalterni, mancando di autonomia politica, le loro iniziative «difensive» sono costrette da leggi proprie di necessità, più semplici, più limitate e politicamente più compressive che non siano le leggi di necessità storica che dirigono e condizionano le iniziative della classe dominante. Spesso i gruppi subalterni sono originariamente di altra razza (altra cultura e altra religione) di quelli dominanti e spesso sono un miscuglio di razze diverse, come nel caso degli schiavi. La quistione dell’importanza delle donne nella storia romana è simile a quella dei gruppi subalterni, ma fino a un certo punto; il «maschilismo» può solo in un certo senso essere paragonato a un dominio di classe, esso ha quindi più importanza per la storia dei costumi che per la storia politica e sociale.
Di un altro criterio di ricerca occorre tener conto per rendere evidenti i pericoli insiti nel metodo dell’analogia storica come criterio d’interpretazione: nello Stato antico e in quello medioevale, l’accentramento sia politico‑territoriale, sia sociale (e l’uno non è poi che funzione dell’altro) era minimo. Lo Stato era, in un certo senso, un blocco meccanico di gruppi sociali e spesso di razze diverse: entro la cerchia della compressione politico‑militare, che si esercitava in forma acuta solo in certi momenti, i gruppi subalterni avevano una vita propria, a sé, istituzioni proprie ecc. e talvolta queste istituzioni avevano funzioni statali, che facevano dello Stato una federazione di gruppi sociali con funzioni diverse non subordinate, ciò che nei periodi di crisi dava un’evidenza estrema al fenomeno del «doppio governo». L’unico gruppo escluso da ogni vita propria collettiva organizzata era quello degli schiavi (e dei proletari non schiavi) nel mondo classico, e quello dei proletari e dei servi della gleba e dei coloni nel mondo medioevale. Tuttavia se per molti aspetti schiavi antichi e proletari medioevali si trovavano nelle stesse condizioni, la loro situazione non era identica: il tentativo dei Ciompi non produsse certo l’impressione che avrebbe prodotto un tentativo simile degli schiavi antichi (Spartaco che domanda di essere assunto al governo in collaborazione con la plebe ecc.). Mentre nel Medio Evo era possibile una alleanza tra proletari e popolo e ancor di più, l’appoggio dei proletari alla dittatura di un principe, niente di simile nel mondo classico per gli schiavi. Lo Stato moderno sostituisce al blocco meccanico dei gruppi sociali una loro subordinazione all’egemonia attiva del gruppo dirigente e dominante, quindi abolisce alcune autonomie, che però rinascono in altra forma, come partiti, sindacati, associazioni di cultura. Le dittature contemporanee aboliscono legalmente anche queste nuove forme di autonomia e si sforzano di incorporarle nell’attività statale: l’accentramento legale di tutta la vita nazionale nelle mani del gruppo dominante diventa «totalitario».
Q25 §5 Criteri metodici. L’unità storica delle classi dirigenti avviene nello Stato e la storia di esse è essenzialmente la storia degli Stati e dei gruppi di Stati. Ma non bisogna credere che tale unità sia puramente giuridica e politica, sebbene anche questa forma di unità abbia la sua importanza e non solamente formale: l’unità storica fondamentale, per la sua concretezza, è il risultato dei rapporti organici tra Stato o società politica e «società civile». Le classi subalterne, per definizione, non sono unificate e non possono unificarsi finché non possono diventare «Stato»: la loro storia, pertanto, è intrecciata a quella della società civile, è una funzione «disgregata» e discontinua della storia della società civile e, per questo tramite, della storia degli Stati o gruppi di Stati. Bisogna pertanto studiare: 1) il formarsi obbiettivo dei gruppi sociali subalterni, per lo sviluppo e i rivolgimenti che si verificano nel mondo della produzione economica, la loro diffusione quantitativa e la loro origine da gruppi sociali preesistenti, di cui conservano per un certo tempo la mentalità, l’ideologia e i fini; 2) il loro aderire attivamente o passivamente alle formazioni politiche dominanti, i tentativi di influire sui programmi di queste formazioni per imporre rivendicazioni proprie e le conseguenze che tali tentativi hanno nel determinare processi di decomposizione e di rinnovamento o di neoformazione; 3) la nascita di partiti nuovi dei gruppi dominanti per mantenere il consenso e il controllo dei gruppi subalterni; 4) le formazioni proprie dei gruppi subalterni per rivendicazioni di carattere ristretto e parziale; 5) le nuove formazioni che affermano l’autonomia dei gruppi subalterni ma nei vecchi quadri; 6) le formazioni che affermano l’autonomia integrale ecc.
La lista di queste fasi può essere ancora precisata con fasi intermedie o con combinazioni di più fasi. Lo storico deve notare e giustificare la linea di sviluppo verso l’autonomia integrale, dalle fasi più primitive, deve notare ogni manifestazione del sorelliano «spirito di scissione». Perciò, anche la storia dei partiti dei gruppi subalterni è molto complessa, in quanto deve includere tutte le ripercussioni delle attività di partito, per tutta l’area dei gruppi subalterni nel loro complesso, e sugli atteggiamenti dei gruppi dominanti e deve includere le ripercussioni delle attività ben più efficaci, perché sorrette dallo Stato, dei gruppi dominanti su quelli subalterni e sui loro partiti. Tra i gruppi subalterni uno eserciterà o tenderà ad esercitare una certa egemonia attraverso un partito e ciò occorre fissare studiando gli sviluppi anche di tutti gli altri partiti in quanto includono elementi del gruppo egemone o degli altri gruppi subalterni che subiscono tale egemonia. Molti canoni di ricerca storica si possono costruire dall’esame delle forze innovatrici italiane che guidarono il Risorgimento nazionale: queste forze hanno preso il potere, si sono unificate nello Stato moderno italiano, lottando contro determinate altre forze e aiutate da determinati ausiliari o alleati; per diventare Stato dovevano subordinarsi o eliminare le une e avere il consenso attivo o passivo delle altre. Lo studio dello sviluppo di queste forze innovatrici da gruppi subalterni a gruppi dirigenti e dominanti deve pertanto ricercare e identificare le fasi attraverso cui esse hanno acquistato l’autonomia nei confronti dei nemici da abbattere e l’adesione dei gruppi che le hanno aiutate attivamente o passivamente, in quanto tutto questo processo era necessario storicamente perché si unificassero in Stato. Il grado di coscienza storico‑politica cui erano giunte progressivamente queste forze innovatrici nelle varie fasi si misura appunto con questi due metri e non solo con quello del suo distacco dalle forze precedentemente dominanti. Di solito si ricorre solo a questo criterio e si ha così una storia unilaterale o talvolta non ci si capisce nulla, come nel caso della storia della penisola dall’era dei Comuni in poi. La borghesia italiana non seppe unificare intorno a sé il popolo e questa fu la causa delle sue sconfitte e delle interruzioni del suo sviluppo. Anche nel Risorgimento tale egoismo ristretto impedì una rivoluzione rapida e vigorosa come quella francese. Ecco una delle quistioni più importanti e delle cause di difficoltà più gravi nel fare la storia dei gruppi sociali subalterni e quindi della storia senz’altro (passata) degli Stati.
Q25 §6 Gli schiavi a Roma. 1) Un’osservazione casuale di Cesare (Bello Gallico, I, 40, 5) informa del fatto che il nucleo degli schiavi che si rivoltarono con Spartaco era costituito dai prigionieri di guerra Cimbri: questi rivoltosi furono annientati. (Cfr Tenney Frank, Storia economica di Roma, trad. italiana, Ed. Vallecchi, p. 153). In questo stesso capitolo del libro del Frank sono da vedere le osservazioni e le congetture sulla diversa sorte delle varie nazionalità di schiavi e sulla loro sopravvivenza probabile in quanto non furono distrutti: o si assimilarono alla popolazione indigena o addirittura la sostituirono.
2) A Roma gli schiavi non potevano essere riconosciuti esteriormente come tali. Quando un senatore propose una volta che agli schiavi fosse dato un abito che li distinguesse, il Senato fu contrario al provvedimento, per timore che gli schiavi divenissero pericolosi qualora potessero rendersi conto del loro grande numero (cfr Seneca, De clem., I, 24 e Tacito, Annali, 4, 27). In questo episodio sono contenute le ragioni politico‑psicologiche che determinano una serie di manifestazioni pubbliche: le processioni religiose, i cortei, le assemblee popolari, le parate di vario genere e anche in parte le elezioni (la partecipazione alle elezioni di alcuni gruppi) e i plebisciti.
Q25 §7 Fonti indirette. Le «Utopie» e i così detti «romanzi filosofici». Sono stati studiati per la storia dello sviluppo della critica politica, ma un aspetto dei più interessanti da vedere è il loro riflettere inconsapevolmente le aspirazioni più elementari e profonde dei gruppi sociali subalterni, anche dei più bassi, sia pure attraverso il cervello di intellettuali dominati da altre preoccupazioni. Questo genere di pubblicazioni è sterminato, se si tiene conto anche dei libri che hanno nessuna importanza letteraria e artistica, cioè se si parte dal punto di vista che si tratta di un fenomeno sociale. Si pone perciò il primo problema: la pubblicazione in massa (relativa) di tale letteratura, coincide con determinati periodi storici, con i sintomi di profondi rivolgimenti politico‑sociali? Si può dire che essa è come un insieme di «cahiers de doléance» indeterminati e generici, e di un tipo particolare? Intanto è anche da osservare che una parte di questa letteratura esprime gli interessi dei gruppi dominanti o spodestati ed ha carattere retrivo e forcaiolo. Sarebbe interessante compilare un elenco di questi libri, «utopie» propriamente dette, romanzi così detti filosofici, libri che attribuiscono a paesi lontani e poco conosciuti ma esistenti, determinate usanze e istituzioni che si vogliono contrapporre a quelle del proprio paese. L’Utopia di T. Moro, la Nuova Atlantide di Bacone, l’Isola dei Piaceri e la Salento di Fénelon (ma anche il Telemaco), i Viaggi di Gulliver dello Swift, ecc. Di carattere retrivo in Italia sono da ricordare brani incompiuti di Federico De Roberto e di Vittorio Imbriani (Naufragazia, frammento di romanzo inedito, con un’avvertenza di Gino Dotia, nella Nuova Antologia del 1° agosto 1934).
2) In un articolo di Giuseppe Gabrieli su Federico Cesi linceo, nella Nuova Antologia del 1° agosto 1930, si afferma un nesso storico‑ideologico tra la Controriforma (che secondo il Gabrieli contrappose all’individualismo, acuito dall’Umanesimo e sbrigliato dal Protestantesimo, lo spirito romano (!) di collegialità, di disciplina, di corporazione, di gerarchia per la ricostruzione (!) della società), le Accademie (come quella dei Lincei, tentata dal Cesi, cioè il lavoro collegiale degli scienziati, di tipo ben diverso da quello dei centri universitari, rimasti medioevali nei metodi e nelle forme), e le idee e le audacie delle grandi teorie, delle riforme palingenetiche e delle ricostruzioni utopistiche dell’umana convivenza (la Città del Sole, la Nuova Atlantide, ecc.).
In questo nesso c’è troppo di stiracchiato, di unilaterale, di meccanico e di superficiale. Si può sostenere, a maggior ragione, che le Utopie più famose sono nate nei paesi protestantici e che anche nei paesi della Controriforma le Utopie sono piuttosto una manifestazione, la sola possibile e in certe forme, dello spirito «moderno» essenzialmente contrario alla Controriforma (tutta l’opera di Campanella è un documento di questo lavoro «subdolo» di scalzare dall’interno la Controriforma, la quale, del resto, come tutte le restaurazioni, non fu un blocco omogeneo, ma una combinazione sostanziale, se non formale, tra il vecchio e il nuovo). Le Utopie sono dovute a singoli intellettuali, che formalmente si riattaccano al razionalismo socratico della Repubblica di Platone e che sostanzialmente riflettono, molto deformate, le condizioni di instabilità e di ribellione latente delle grandi masse popolari dell’epoca; sono, in fondo, manifesti politici di intellettuali, che vogliono raggiungere l’ottimo Stato. Bisogna tener conto inoltre delle scoperte scientifiche del tempo e del razionalismo scientifista che ebbe le sue prime manifestazioni proprio nel periodo della Controriforma. Anche il Principe del Machiavelli fu a suo modo un’Utopia (cfr in proposito alcune in altro quaderno). Si può dire che proprio l’Umanesimo, cioè un certo individualismo, fu il terreno propizio al nascere delle Utopie e delle costruzioni politico‑filosofiche: la Chiesa, con la Controriforma, si staccò definitivamente dalle masse degli «umili» per servire i «potenti»; singoli intellettuali tentarono di trovare, attraverso le Utopie, una soluzione di una serie dei problemi vitali degli umili, cioè cercarono un nesso tra intellettuali e popolo: essi sono da ritenere pertanto i primi precursori storici dei Giacobini e della Rivoluzione francese, cioè dell’evento che pose fine alla Controriforma e diffuse l’eresia liberale, ben più efficace contro la Chiesa di quella protestantica.
3) Articolo di Ezio Chiòrboli nella Nuova Antologia del 1° maggio 1928 su Anton Francesco Doni: profilo interessante su questo pubblicista, popolarissimo al suo tempo, nel Cinquecento, spiritoso, caustico, di spiriti moderni. Il Doni si occupò di infiniti problemi di ogni genere, precorrendo molte innovazioni scientifiche. Di tendenze che oggi si direbbero materialistiche (volgari); accenna all’importanza dell’angolo facciale e ai segni specifici della delinquenza due secoli prima del Camper (Pietro, olandese, 1722‑1789) e due secoli e mezzo prima del Lavater (Gian Gaspare, svizzero, nato a Zurigo, 1741‑1801) e del Gall (Francesco Giuseppe, tedesco, 1758‑1828) parlò delle funzioni dell’intelletto e delle parti del cervello ad esse deputate. Scrisse una Utopia nel Mondo pazzo o savio – «immaginosa ricostruzione sociale che si pinge di molte delle iridescenze e delle ansie onde s’è arroventato il socialismo odierno» – che forse tolse dall’Utopia del Moro. Conobbe il libro del Moro e lo pubblicò egli stesso nella volgarizzazione del Lando. «Pure l’immaginazione non è più la medesima, come la medesima non è di Platone nella Repubblica né d’altri quali si fossero, oscuri o ignoti; ché egli se la compì, se la rimutò, se la rifoggiò a sua posta, sì che n’ha già avvivata un’altra, sua, proprio sua, della quale tanto è preso che e nei Marmi e via via in più opere e opuscoli esce or in questo e or in quel particolare, in questo o quel sentimento». Per la bibliografia del Doni cfr l’edizione dei Marmi curata dal Chiòrboli negli «Scrittori d’Italia» del Laterza e l’antologia del Doni pubblicata nelle «Più belle pagine» del Treves.
4) La Tempesta di Shakespeare (l’opposizione di Calibano e Prospero ecc.; carattere utopistico dei discorsi di Gonzalo). Cfr Achille Loria, Pensieri e soggetti economici in Shakespeare nella Nuova Antologia del 1° agosto 1928 che può essere utilizzato come prima scelta dei brani shakespeariani di carattere politico‑sociale e come documento indiretto del modo di pensare dei popolani del tempo. A proposito della Tempesta sono da vedere il Calibano e l’Eau de Jouvence del Renan.
Q25 §8 Scientismo e postumi del basso romanticismo. È da vedere
la tendenza della sociologia di sinistra in Italia a occuparsi
intensamente del problema della criminalità. È essa legata al
fatto che alla tendenza di sinistra avevano aderito Lombroso e
molti dei più «brillanti» seguaci che parevano allora la suprema
espressione della scienza e che influivano con tutte le loro
deformazioni professionali e i loro specifici problemi? O si
tratta di un postumo del basso romanticismo del 48 (Sue e le sue
elucubrazioni di diritto penale romanzato)? O è legato a ciò che
in Italia «impressionava»L’integrazione è basata sul testo A.
certi gruppi intellettuali la grande quantità di reati di sangue
ed essi pensavano di non poter procedere oltre senza aver
spiegato «scientificamente» (cioè naturalisticamente) questo
fenomeno di «barbarie»?
QUADERNO 26
ARGOMENTI DI CULTURA II
Q26 §1 Indicazioni bibliografiche. 1) Il Catalogo dei cataloghi
del libro italiano, pubblicato dalla Società generale delle
Messaggerie italiane di Bologna nel 1926 (sono stati pubblicati
successivamente dei supplementi) è una pubblicazione da tener
presente per le ricerche bibliografiche. Questo repertorio
contiene i dati di 65 000 volumi (meno l’indicazione
dell’editore) classificati in 18 classi, due indici alfabetici,
uno degli autori, curatori e traduttori e uno degli argomenti
con relativi richiami alla classe e al numero d’ordine.
2) Altra pubblicazione bibliografica da tener presente è il Catalogo metodico degli scritti contenuti nelle Pubblicazioni periodiche italiane e straniere edita dalla Biblioteca della Camera dei Deputati.
Q26 §2 L’«equazione personale». I calcoli dei movimenti stellari sono turbati da quella che gli scienziati chiamano l’«equazione personale», per cui sono necessari controlli e rettifiche. Vedere esattamente come si identifica questa causa di errore, con quali criteri e come viene apportata la rettifica. In ogni modo, la nozione di «equazione personale» può essere impiegata utilmente anche in altri campi oltre che nell’astronomia.
Q26 §3 Il naso di Cleopatra. Cercare il senso esatto che Pascal dava a questa sua espressione divenuta tanto famosa (è contenuta nelle Pensées) e il suo legame con le opinioni generali dello scrittore. (Frivolità della storia degli uomini; pessimismo giansenistico).
Q26 §4 Del ragionare per medie statistiche. Del ragionare e specialmente del «pensare» per medie statistiche. In questo caso è utile ricordare la barzelletta secondo la quale se Tizio fa due pasti al giorno e Caio nessuno, «statisticamente» Tizio e Caio fanno «in media» un pasto al giorno ciascuno. La deformazione di pensiero originata dalla statistica è molto più diffusa di quanto non si creda. Generalizzazione astratta, senza una continua ripresa di contatto con la realtà concreta. Ricordare come un partito austriaco, che aveva due suoi soci in un sindacato, scrisse che la sua influenza nel sindacato era cresciuta del 50% perché un terzo socio si aggiunse ai primi due.
Q26 §5 «Contraddizioni» dello storicismo ed espressioni letterarie di esse (ironia, sarcasmo). Vedere le pubblicazioni di Adriano Tilgher contro lo storicismo. Da un articolo di Bonaventura Tecchi (Il Demiurgo di Burzio, «Italia Letteraria», 20 ottobre 1929) sono estratti alcuni spunti di F. Burzio che sembrano mostrare nel Burzio una certa profondità (se si astrae dal linguaggio sforzato e dalle costruzioni a tendenza paradossale‑letteraria) nello studio delle contraddizioni «psicologiche» che nascono sul terreno dello storicismo idealistico, ma anche in quello dello storicismo integrale.
È da meditare l’affermazione: «essere sopra alle passioni e ai sentimenti pur provandoli»‘, che potrebbe essere ricca di conseguenze. Infatti il nodo delle quistioni che sorgono a proposito dello storicismo, e che il Tilgher non riesce di districare, è proprio nella constatazione che «si può essere critici e uomini d’azione nello stesso tempo, in modo non solo che l’uno aspetto non indebolisca l’altro, ma anzi lo convalidi». Il Tilgher molto superficialmente e meccanicamente scinde i due termini della personalità umana (dato che non esiste e non è mai esistito un uomo tutto critico e uno tutto passionale), mentre invece si deve cercare di determinare come in diversi periodi storici i due termini si combinano sia nei singoli, sia per strati sociali (aspetto della quistione della funzione sociale degli intellettuali) facendo prevalere (apparentemente) un aspetto o l’altro (si parla di epoche di critica, di epoche di azione, ecc.). Ma non pare che neanche il Croce abbia analizzato a fondo il problema negli scritti dove vuol determinare il concetto «politica = passione»: se l’atto concreto politico, come dice il Croce, si attua nella persona del capo politico, è da osservare che la caratteristica del capo come tale non è certo la passionalità, ma il calcolo freddo, preciso, obbiettivamente quasi impersonale, delle forze in lotta e dei loro rapporti (tanto più ciò vale se si tratta di politica nella sua forma più decisiva e determinante, la guerra o qualsiasi altra forma di lotta armata). Il capo suscita e dirige le passioni, ma egli stesso ne è «immune» o le domina per meglio scatenarle, raffrenarle al momento dato, disciplinarle, ecc.; deve più conoscerle, come elemento obbiettivo di fatto, come forza, che «sentirle» immediatamente, deve conoscerle e comprenderle, sia pure con «grande simpatia» (e allora la passione assume una forma superiore, che occorre analizzare, sulla traccia dello spunto del Burzio; tutta la quistione è da vedere sui «testi» autentici).
Dallo scritto del Tecchi pare che il Burzio accenni spesso all’elemento «ironia» come caratteristica (o una delle caratteristiche) della posizione riferita e condensata nella affermazione «essere sopra alle passioni e ai sentimenti pur provandoli». Pare evidente che l’atteggiamento «ironico» non possa essere quello del capo politico o militare nei confronti delle passioni e sentimenti dei seguaci e diretti. «Ironia» può essere giusto per l’atteggiamento di intellettuali singoli, individuali, cioè senza responsabilità immediata sia pure nella costruzione di un mondo culturale o per indicare il distacco dell’artista dal contenuto sentimentale della sua creazione (che può «sentire» ma non «condividere», o può condividere ma in forma intellettualmente più raffinata); ma nel caso dell’azione storica, l’elemento «ironia» sarebbe solo letterario o intellettualistico e indicherebbe una forma di distacco piuttosto connessa allo scetticismo più o meno dilettantesco dovuto a disillusione, a stanchezza, a «superominismo». Invece nel caso dell’azione storico‑politica l’elemento stilistico adeguato, l’atteggiamento caratteristico del distacco‑comprensione, è il «sarcasmo» e ancora in una forma determinata, il «sarcasmo appassionato». Nei fondatori della filosofia della prassi si trova l’espressione più alta, eticamente ed esteticamente, del sarcasmo appassionato. Altre forme. Di fronte alle credenze e illusioni popolari (credenza nella giustizia, nell’eguaglianza, nella fraternità, cioè negli elementi ideologici diffusi dalle tendenze democratiche eredi della Rivoluzione francese), c’è un sarcasmo appassionatamente «positivo», creatore, progressivo: si capisce che non si vuol dileggiare il sentimento più intimo di quelle illusioni e credenze, ma la loro forma immediata, connesso a un determinato mondo «perituro», il puzzo di cadavere che trapela attraverso il belletto umanitario dei professionisti degli «immortali principii». Perché esiste anche un sarcasmo di «destra», che raramente è appassionato, ma è sempre «negativo», scettico e distruttivo non solo della «forma» contingente, ma del contenuto «umano» di quei sentimenti e credenze. (E a proposito dell’attributo «umano» si può vedere in alcuni libri, ma specialmente nella Sacra Famiglia, quale significato occorre dargli). Si cerca di dare al nucleo vivo delle aspirazioni contenute in quelle credenze una nuova forma (quindi di innovare, determinare meglio quelle aspirazioni), non di distruggerle. Il sarcasmo di destra cerca invece di distruggere proprio il contenuto delle aspirazioni (non, beninteso, nelle masse popolari, che allora si distruggerebbe anche il cristianesimo popolare, ma negli intellettuali), e perciò l’attacco alla «forma» non è che un espediente «didattico».
Come sempre avviene, le prime e originali manifestazioni del sarcasmo hanno avuto imitatori e pappagalli; lo stile è diventato una «stilistica», è divenuto una specie di meccanismo, una cifra, un gergo, che potrebbero dar luogo ad osservazioni piccanti (per es., quando la parola «civiltà» è sempre accompagnata dall’aggettivo «sedicente», è lecito pensare che si creda nell’esistenza di una «civiltà» esemplare, astratta, o almeno ci si comporta come se ciò si credesse, cioè dalla mentalità critica e storicistica si passa alla mentalità utopistica). Nella forma originaria il sarcasmo è da considerare come una espressione che mette in rilievo le contraddizioni di un periodo di transizione; si cerca di mantenere il contatto con le espressioni subalterne umane delle vecchie concezioni e nello stesso tempo si accentua il distacco da quelle dominanti e dirigenti, in attesa che le nuove concezioni, con la saldezza acquistata attraverso lo sviluppo storico, dominino fino ad acquistare la forza delle «credenze popolari». Queste nuove concezioni sono già acquisite saldamente in chi adopera il sarcasmo, ma devono essere espresse e divulgate in atteggiamento «polemico», altrimenti sarebbero una «utopia» perché apparirebbero «arbitrio» individuale o di conventicola: d’altronde, per la sua natura stessa, lo «storicismo» non può concepire se stesso come esprimibile in forma apodittica o predicatoria, e deve creare un gusto stilistico nuovo, persino un linguaggio nuovo come mezzi di lotta intellettuale. Il «sarcasmo» (come, nel piano letterario ristretto dell’educazione di piccoli gruppi, l’«ironia») appare pertanto come la componente letteraria di una serie di esigenze teoriche e pratiche che superficialmente possono apparire come insanabilmente contraddittorie; il suo elemento essenziale è la «passionalità» che diventa criterio della potenza stilistica individuale (della sincerità, della profonda convinzione in opposto al pappagallismo e al meccanicismo).
Da questo punto di vista occorre esaminare le ultime notazioni del Croce nella prefazione del 1917 al volume sul Materialismo storico , dove si parla della «maga Alcina», e alcune osservazioni sullo stile del Loria. Così è da vedere il saggio di Mehring sull’«allegoria» nel testo tedesco, ecc.
Q26 §6 Lo Stato «veilleur de nuit». Nella polemica (del resto superficiale) sulle funzioni dello Stato (e si intende dello Stato come organizzazione politico‑giuridica in senso stretto) l’espressione di «Stato ‑ veilleur de nuit» corrisponde all’italiano di «Stato carabiniere» e vorrebbe significare uno Stato le cui funzioni sono limitate alla tutela dell’ordine pubblico e del rispetto delle leggi. Non si insiste sul fatto che, in questa forma di regime (che poi non è mai esistito altro che, come ipotesi‑limite, sulla carta) la direzione dello sviluppo storico appartiene alle forze private, alla società civile, che è anch’essa «Stato», anzi è lo Stato stesso. Pare che l’espressione «veilleur de nuit», che dovrebbe avere un valore più sarcastico di «Stato carabiniere» o di «Stato poliziotto», sia di Lassalle. Il suo opposto dovrebbe essere lo «Stato etico» o lo «Stato intervenzionista» in generale, ma ci sono differenze tra una e l’altra espressione: il concetto di Stato etico è di origine filosofica e intellettuale (propria degli intellettuali: Hegel) e in verità potrebbe essere congiunta con quello di «Stato ‑ veilleur de nuit», poiché si riferisce piuttosto all’attività, autonoma, educativa e morale dello Stato laico in contrapposto al cosmopolitismo e all’ingerenza e organizzazione religioso‑ecclesiastica come residuo medioevale; il concetto di Stato intervenzionista è di origine economica ed è connesso, da una parte, alle correnti protezionistiche o di nazionalismo economico e, dall’altra, al tentativo di far assumere a un personale statale determinato, di origine terriera e feudale, la «protezione» delle classi lavoratrici contro gli eccessi del capitalismo (politica di Bismarck e Disraeli). Queste diverse tendenze possono combinarsi in vario modo e di fatto si sono combinate. Naturalmente i liberali «economisti» sono per lo «Stato ‑ veilleur de nuit» e vorrebbero che l’iniziativa storica fosse lasciata alla società civile e alle diverse forze che vi pullulano con lo «Stato» guardiano della «lealtà del gioco» e delle leggi di esso: gli intellettuali fanno distinzioni molto importanti quando sono liberali e anche quando sono intervenzionisti (possono essere liberali nel campo economico e intervenzionisti in quello culturale, ecc.).
I cattolici vorrebbero lo Stato intervenzionista in loro completo favore; in mancanza di ciò, o dove sono minoranza, domandano lo Stato «indifferente», perché non sostenga i loro avversari.
Q26 §7 Postulato. Nelle scienze matematiche, specialmente, s’intende per postulato una proposizione che, non avendo la evidenza immediata e la indimostrabilità degli assiomi, né potendo, d’altra parte, essere sufficientemente dimostrata come un teorema, è tuttavia provvista, in base ai dati dell’esperienza, di una tale verosimiglianza che può essere acconsentita o concessa anche dall’avversario e posta quindi a base di talune dimostrazioni. Il postulato quindi è, in questo senso, una proposizione richiesta ai fini della dimostrazione e costruzione scientifica.
Nell’uso comune, invece, postulato significa un modo di essere e di operare che si desidera realizzare (o conservare, se già realizzato; o anzi, che si vuole e, in certi casi si deve, attuare o conservare) o si afferma essere il risultato di una indagine scientifica (storia, economia, fisiologia ecc.). Perciò si fa spesso confusione (o si interferisce) tra il significato di «rivendicazione», di «desiderata», di «esigenza» e quello di «postulato» e di «principio»; i postulati di un partito politico o di uno Stato sarebbero i suoi «principii» pratici, da cui conseguono immediatamente le rivendicazioni di carattere più concreto e particolare (esempio: l’indipendenza del Belgio è un postulato della politica inglese, ecc.).
Q26 §8 Classe media. Il significato dell’espressione «classe media» muta da un paese all’altro (come muta quello di «popolo» o di «volgo» in rapporto alla boria di certi strati sociali) e perciò dà luogo spesso a equivoci molto curiosi (ricordare come il sindaco Frola di Torino firmasse un manifesto in inglese col titolo «Lord Mayor»). Il termine è venuto dalla letteratura politica inglese ed esprime la particolare forma dello sviluppo sociale inglese. Pare che in Inghilterra la borghesia non sia mai stata concepita come una parte integrante del popolo, ma sempre come una entità staccata da questo: è avvenuto anzi, nella storia inglese, che non la borghesia abbia guidato il popolo e si sia fatta aiutare da esso per abbattere i privilegi feudali, ma la nobiltà (o una frazione di essa) abbia formato il blocco nazionale‑popolare contro la Corona prima e poi contro la borghesia industriale. Tradizione inglese di un torismo popolare (Disraeli, ecc.). Dopo le grandi riforme liberali che conformarono lo Stato agli interessi e ai bisogni della classe media, i due partiti fondamentali della vita politica inglese si distinsero su quistioni interne riguardanti la stessa classe, la nobiltà acquistò sempre più un carattere particolare di «aristocrazia borghese» legata a certe funzioni della società civile e di quella politica (Stato) riguardanti la tradizione, l’educazione del ceto dirigente, la conservazione di una data mentalità che garantisce da bruschi rivolgimenti, ecc., la consolidazione della struttura imperiale, ecc.
In Francia il termine «classe media» dà luogo ad equivoci, nonostante che l’aristocrazia, di fatto, abbia conservato molta importanza come casta chiusa: il termine viene adoperato sia nel senso inglese, sia nel senso italiano di piccola e media borghesia. In Italia dove l’aristocrazia feudale è stata distrutta dai Comuni (fisicamente distrutta nelle guerre civili, eccetto che nell’Italia meridionale e in Sicilia), poiché manca la classe «alta» tradizionale, il termine di «media» si è abbassato di un gradino. Classe media significa «negativamente» non‑popolo, cioè «non operai e contadini»; significa positivamente i ceti intellettuali, i professionisti, gli impiegati.
È da notare come il termine «signore» sia diffuso in Italia da molto tempo per indicare anche i non‑nobili; il «don» meridionale, «galantuomini», «civili», «borghesi», ecc.; in Sardegna «signore» non è mai il rurale, anche quello ricco ecc.
Q26 §9 Ufficiale. Il termine «ufficiale», specialmente nelle traduzioni da lingue straniere (in primo luogo dall’inglese) dà luogo ad equivoci, a incomprensioni e... stupore. In italiano, il significato di «ufficiale» è sempre più venuto restringendosi e ormai indica solo gli ufficiali dell’esercito: nel significato più largo è rimasto il termine solo in alcune espressioni diventate idiomatiche e di origine burocratica: «pubblico ufficiale», «ufficiale dello stato civile», ecc. In inglese «official» indica ogni specie di funzionario (per ufficiale dell’esercito si usa «officer», che però indica anch’esso il funzionario in generale) non solo dello Stato ma anche privato (funzionario sindacale). (Sarà utile però fare un’indagine più precisa, di carattere storico, giuridico, politico).
Q26 §10 Ascari, krumiri, moretti, ecc. Venivano chiamati «ascari» i deputati delle maggioranze parlamentari senza programma e senza indirizzo, quindi sempre pronti a defezionare e a lasciare in asso i governi che si basavano su di esse; l’espressione era legata alle prime esperienze fatte in Africa con le truppe indigene mercenarie.
La parola «crumiri» è legata all’occupazione della Tunisia da parte della Francia col pretesto iniziale di respingere ipotetiche tribù di Krumiri che dalla Tunisia si sarebbero spinte in Algeria per razziare. Ma come il termine è entrato a far parte del vocabolario speciale del sindacalismo operaio?
Il termine «moretto» deve essere una derivazione di «ascaro», ma era impiegato più che a mettere in rilievo l’insicurezza della fedeltà e la facilità a disertare, a mettere in rilievo l’attitudine al servilismo e la predisposizione a eseguire i più bassi servizi, con grande disinvoltura. (Può anche essere derivato dall’abitudine di avere come servitori dei negri).
Q26 §11 Rinascimento, Risorgimento, Riscossa, ecc. Nel linguaggio storico‑politico italiano è da notare tutta una serie di espressioni, legate strettamente al modo tradizionale di concepire la storia della nazione e della cultura italiana, che è difficile e talvolta impossibile di tradurre nelle lingue straniere. Così abbiamo il gruppo «Rinascimento», «Rinascita» («Rinascenza», francesismo), termini che sono ormai entrati nel circolo della cultura europea e mondiale, perché se il fenomeno indicato ebbe il massimo splendore in Italia, non fu però ristretto all’Italia.
Nasce nell’Ottocento il termine «Risorgimento» in senso più strettamente nazionale e politico, accompagnato dalle altre espressioni di «Riscossa nazionale» e «riscatto nazionale»: tutti esprimono il concetto del ritorno a uno stato di cose già esistito nel passato o di «ripresa» offensiva («riscossa») delle energie nazionali disperse intorno a un nucleo militante e concentrato, o di emancipazione da uno stato di servitù per ritornare alla primitiva autonomia («riscatto»). Sono difficili da tradurre appunto perché strettamente legate alla tradizione letteraria‑nazionale di una continuità essenziale della storia svoltasi nella penisola italiana, da Roma all’unità dello Stato moderno, per cui si concepisce la nazione italiana «nata» o «sorta» con Roma, si pensa che la cultura greco‑romana sia «rinata», la nazione sia «risorta», ecc. La parola «riscossa» è del linguaggio militare francese, ma poi è stata legata alla nozione di un organismo vivo che cade in letargia e si riscuote, sebbene non si possa negare che le è rimasto un po’ del primitivo senso militare.
A questa serie puramente italiana si possono collegare altre espressioni corrispondenti: per esempio il termine, di origine francese e indicante un fatto prevalentemente francese, «Restaurazione».
La coppia «formare e riformare», perché, secondo il significato assunto storicamente dalla parola, una cosa «formata» si può continuamente «riformare», senza che tra la formazione e la riforma sia implicito il concetto di una parentesi catastrofica o letargica, ciò che invece è implicito per «rinascimento» e «restaurazione». Si vede da ciò che i cattolici sostengono che la Chiesa Romana è stata più volte riformata dall’interno, mentre nel concetto protestante di «Riforma» è implicita l’idea di rinascita e restaurazione del cristianesimo primitivo, soffocato dal romanesimo. Nella cultura laica si parla perciò di Riforma e Controriforma, mentre i cattolici (e specialmente i gesuiti che sono più accurati e conseguenti anche nella terminologia) non vogliono ammettere che il Concilio di Trento abbia solamente reagito al luteranesimo e a tutto il complesso delle tendenze protestantiche, ma sostengono che si sia trattato di una «Riforma cattolica» autonoma, positiva, che si sarebbe verificata in ogni caso. La ricerca della storia di questi termini ha un significato culturale non trascurabile.
QUADERNO 27
OSSERVAZIONI SUL «FOLCLORE»
Q27 §1 Giovanni Crocioni (nel volume Problemi fondamentali del
Folclore, Bologna, Zanichelli, 1928) critica come confusa e
imprecisa la ripartizione del materiale folcloristico proposta
dal Pitrè nel 1897 nella Premessa alla Bibliografia delle
tradizioni popolari e propone una sua ripartizione in quattro
sezioni: arte, letteratura, scienza, morale del popolo. Ma anche
questa ripartizione è criticata come imprecisa, mal definita e
troppo lata. Raffaele Ciampini, nella «Fiera Letteraria» del 30
dicembre 1928, domanda: «È essa scientifica? Come per es. farvi
rientrare le superstizioni? E che vuole dire una morale del
popolo? Come studiarla scientificamente? E perché, allora, non
parlare anche di una religione del popolo?» Si può dire che
finora il folclore sia stato studiato prevalentemente come
elemento «pittoresco» (in realtà finora è stato solo raccolto
materiale da erudizione e la scienza del folclore è consistita
prevalentemente negli studi di metodo per la raccolta, la
selezione e la classificazione di tale materiale, cioè nello
studio delle cautele pratiche e dei principii empirici necessari
per svolgere proficuamente un aspetto particolare
dell’erudizione, né con ciò si misconosce l’importanza e il
significato storico di alcuni grandi studiosi del folclore).
Occorrerebbe studiarlo invece come «concezione del mondo e della
vita», implicita in grande misura, di determinati strati
(determinati nel tempo e nello spazio) della società, in
contrapposizione (anch’essa per lo più implicita, meccanica,
oggettiva) con le concezioni del mondo «ufficiali» (o in senso
più largo delle parti colte della società storicamente
determinate) che si sono successe nello sviluppo storico.
(Quindi lo stretto rapporto tra folclore e «senso comune» che è
il folclore filosofico).
Concezione del mondo non solo non elaborata e sistematica, perché il popolo (cioè l’insieme delle classi subalterne e strumentali di ogni forma di società finora esistita) per definizione non può avere concezioni elaborate, sistematiche e politicamente organizzate e centralizzate nel loro sia pur contradditorio sviluppo, ma anzi molteplice – non solo nel senso di diverso, e giustapposto, ma anche nel senso di stratificato dal più grossolano al meno grossolano – se addirittura non deve parlarsi di un agglomerato indigesto di frammenti di tutte le concezioni del mondo e della vita che si sono succedute nella storia, della maggior parte delle quali, anzi, solo nel folclore si trovano i superstiti documenti mutili e contaminati.
Anche il pensiero e la scienza moderna danno continuamente nuovi elementi al «folclore moderno», in quanto certe nozioni scientifiche e certe opinioni, avulse dal loro complesso e più o meno sfigurate, cadono continuamente nel dominio popolare e sono «inserite» nel mosaico della tradizione (la Scoperta dell’America di C. Pascarella mostra come le nozioni, diffuse dai manuali scolastici e dalle «Università popolari», su Cristoforo Colombo e su tutta una serie di opinioni scientifiche, possano essere bizzarramente assimilate). Il folclore può essere capito solo come un riflesso delle condizioni di vita culturale del popolo, sebbene certe concezioni proprie del folclore si prolunghino anche dopo che le condizioni siano (o sembrino) modificate o diano luogo a combinazioni bizzarre.
Certo esiste una «religione di popolo», specialmente nei paesi cattolici e ortodossi, molto diversa da quella degli intellettuali (che siano religiosi) e specialmente da quella organicamente sistemata dalla gerarchia ecclesiastica – sebbene si possa sostenere che tutte le religioni, anche le più dirozzate e raffinate, siano «folclore» in rapporto al pensiero moderno, con la capitale differenza che le religioni e quella cattolica in primo luogo, sono appunto «elaborate e sistemate» dagli intellettuali (c. s.) e dalla gerarchia ecclesiastica e pertanto presentano speciali problemi (è da vedere se una tale elaborazione e sistemazione non sia necessaria per mantenere il folclore disseminato e molteplice: le condizioni della Chiesa prima e dopo la Riforma e il Concilio di Trento e il diverso sviluppo storico‑culturale dei paesi riformati e di quelli ortodossi dopo la Riforma e Trento sono elementi molto significativi). Così è vero che esiste una «morale del popolo», intesa come un insieme determinato (nel tempo e nello spazio) di massime per la condotta pratica e di costumi che ne derivano o le hanno prodotte, morale che è strettamente legata, come la superstizione, alle credenze reali religiose: esistono degli imperativi che sono molto più forti, tenaci ed effettuali che non quelli della «morale» ufficiale. Anche in questa sfera occorre distinguere diversi strati: quelli fossilizzati che rispecchiano condizioni di vita passata e quindi conservativi e reazionari, e quelli che sono una serie di innovazioni, spesso creative e progressive, determinate spontaneamente da forme e condizioni di vita in processo di sviluppo e che sono in contraddizione, o solamente diverse, dalla morale degli strati dirigenti.
Il Ciampini trova molto giusta la necessità sostenuta dal Crocioni che il folclore sia insegnato nelle scuole dove si preparano i futuri insegnanti, ma poi nega che possa porsi la quistione della utilità del folclore (c’è indubbiamente confusione tra «scienza del folclore», «conoscenza del folclore» e «folclore» cioè «esistenza del folclore»; pare che il Ciampini qui voglia proprio dire «esistenza del folclore» così che l’insegnante non dovrebbe combattere la concezione tolemaica, che è propria del folclore). Per il Ciampini il folclore (?) è fine a se stesso o ha la sola utilità di offrire a un popolo gli elementi per una più profonda conoscenza di se stesso (qui folclore dovrebbe significare «conoscenza e scienza del folclore»). Studiare le superstizioni per sradicarle sarebbe per il Ciampini, come se il folclore uccidesse se stesso, mentre la scienza non è che conoscenza disinteressata, fine a se stessa! Ma allora perché insegnare il folclore nelle scuole che preparano gli insegnanti? Per accrescere la cultura disinteressata dei maestri? Per mostrar loro ciò che non devono distruggere?
Come appare, le idee del Ciampini sono molto confuse e anzi intimamente incoerenti, poiché, in altra sede, il Ciampini stesso riconoscerà che lo Stato non è agnostico ma ha una sua concezione della vita e ha il dovere di diffonderla, educando le masse nazionali. Ma questa attività formativa dello Stato, che si esprime, oltre che nell’attività politica generale, specialmente nella scuola, non si svolge sul niente e dal niente: in realtà essa è in concorrenza e in contradditorio con altre concezioni esplicite ed implicite e tra queste non delle minori e meno tenaci è il folclore, che pertanto deve essere «superato». Conoscere il «folclore» significa pertanto per l’insegnante conoscere quali altre concezioni del mondo e della vita lavorano di fatto alla formazione intellettuale e morale delle generazioni più giovani per estirparle e sostituirle con concezioni ritenute superiori. Dalle scuole elementari alle… Cattedre d’agricoltura, in realtà, il folclore era già sistematicamente battuto in breccia: l’insegnamento del folclore agli insegnanti dovrebbe rafforzare ancor più questo lavoro sistematico. È certo che per raggiungere il fine occorrerebbe mutare lo spirito delle ricerche folcloristiche oltre che approfondirle ed estenderle. Il folclore non deve essere concepito come una bizzarria, una stranezza o un elemento pittoresco, ma come una cosa che è molto seria e da prendere sul serio. Solo così l’insegnamento sarà più efficiente e determinerà realmente la nascita di una nuova cultura nelle grandi masse popolari, cioè sparirà il distacco tra cultura moderna e cultura popolare o folclore. Un’attività di questo genere, fatta in profondità, corrisponderebbe nel piano intellettuale a ciò che è stata la Riforma nei paesi protestanti.
Q27 §2 «Diritto naturale» e folclore. Viene esercitata ancora oggi una certa critica, per lo più di carattere giornalistico e superficiale, non molto brillante contro il così detto diritto naturale (cfr qualche elucubrazione di Maurizio
Maraviglia e i sarcasmi e le beffe più o meno convenzionali e stantie dei giornali e delle riviste). Qual è il significato reale di queste esercitazioni?
Per comprendere ciò occorre, mi pare, distinguere alcune delle espressioni che tradizionalmente ha assunto il «diritto naturale»:
1) La espressione cattolica, contro la quale gli attuali polemisti non hanno il coraggio di prendere una netta posizione, sebbene il concetto di «diritto naturale» sia essenziale ed integrante della dottrina sociale e politica cattolica. Sarebbe interessante ricordare lo stretto rapporto che esiste tra la religione cattolica, così come è stata intesa sempre dalle grandi masse e gli «immortali principii dell’89». I cattolici stessi della gerarchia ammettono questo rapporto quando affermano che la rivoluzione francese è stata una «eresia» o che da essa si è iniziata una nuova eresia, riconoscono cioè che allora è avvenuta una scissione nella stessa fondamentale mentalità e concezione del mondo e della vita: d’altronde solo così si può spiegare la storia religiosa della Rivoluzione francese, ché sarebbe altrimenti inesplicabile l’adesione in massa alle nuove idee e alla politica rivoluzionaria dei giacobini contro il clero, di una popolazione che era certo ancora profondamente religiosa e cattolica. Per ciò si può dire che concettualmente non i principii della Rivoluzione francese superano la religione, poiché appartengono alla sua stessa sfera mentale, ma i principii che sono superiori storicamente (in quanto esprimono esigenze nuove e superiori) a quelli della Rivoluzione francese, cioè quelli che si fondano sulla realtà effettuale della forza e della lotta.
2) La espressione di diversi gruppi intellettuali, di diverse tendenze politico‑giuridiche, che è quella sulla quale si è svolta finora la polemica scientifica sul «diritto naturale». A questo proposito la quistione è stata risolta fondamentalmente dal Croce, col riconoscimento che si è trattato di correnti politiche e pubblicistiche, che avevano il loro significato e la loro importanza in quanto esprimevano esigenze reali nella forma dogmatica e sistematica della così detta scienza del diritto (cfr la trattazione del Croce). Contro questa tendenza si svolge la polemica «apparente» degli attuali esercitatori di scienza del diritto, che in realtà, non distinguendo tra il contenuto reale del «diritto naturale» (rivendicazioni concrete di carattere politico‑economico‑sociale), la forma della teorizzazione e le giustificazioni mentali che del contenuto reale dà il diritto naturale, sono essi più acritici e antistorici dei teorici del diritto naturale, cioè sono dei muli bendati del più gretto conservatorismo (che si riferisce anche alle cose passate e «storicamente» superate e spazzate via).
3) La polemica in realtà mira ad infrenare l’influsso che specialmente sui giovani intellettuali potrebbero avere (e hanno realmente) le correnti popolari del «diritto naturale», cioè quell’insieme di opinioni e di credenze sui «proprii» diritti che circolano ininterrottamente nelle masse popolari, che si rinnovano di continuo sotto la spinta delle condizioni reali di vita e dello spontaneo confronto tra il modo di essere dei diversi ceti. La religione ha molto influsso su queste correnti, la religione in tutti i sensi, da quella come è realmente sentita e attuata a quella quale è organizzata e sistematizzata dalla gerarchia, che non può rinunziare al concetto di diritto popolare. Ma su queste correnti influiscono, per meati intellettuali incontrollabili e capillari, anche una serie di concetti diffusi dalle correnti laiche del diritto naturale e ancora diventano «diritto naturale», per contaminazioni le più svariate e bizzarre, anche certi programmi e proposizioni affermati dallo «storicismo». Esiste dunque una massa di opinioni «giuridiche» popolari, che assumono la forma del «diritto naturale» e sono il «folclore» giuridico. Che tale corrente abbia importanza non piccola è stato dimostrato dalla organizzazione delle «Corti d’Assisi» e di tutta una serie di magistrature arbitrali o di conciliazione, in tutti i campi dei rapporti individuali e di gruppo, che appunto dovrebbero giudicare tenendo conto del «diritto» come è inteso dal popolo, controllato dal diritto positivo o ufficiale. Né è da pensare che l’importanza di questa quistione sia sparita con l’abolizione delle giurie popolari, perché nessun magistrato può in una qualsiasi misura prescindere dall’opinione: è anzi probabile che la quistione si ripresenti in altra forma e in misura ben più estesa che nel passato, ciò che non mancherà di sollevare pericoli e nuove serie di problemi da risolvere.
QUADERNO 28
LORIANISMO
Di alcuni aspetti deteriori e bizzarri della mentalità di un gruppo di intellettuali italiani e quindi della cultura nazionale (disorganicità, assenza di spirito critico sistematico, trascuratezza nello svolgimento dell’attività scientifica, assenza di centralizzazione culturale, mollezza e indulgenza etica nel campo dell’attività scientifico‑culturale ecc., non adeguatamente combattute e rigidamente colpite: quindi irresponsabilità verso la formazione della cultura nazionale) che possono essere descritti sotto il titolo comprensivo di «lorianismo».
Q28 §1 Registro dei principali «documenti», in cui si trovano le
principali «bizzarrie» di Achille Loria. (Ricordati a memoria:
esiste ora la Bibliografia di Achille Loria, compilata da Luigi
Einaudi, supplemento al n. 5, settembre‑ottobre 1932, della
Riforma Sociale; la lista non è completa, evidentemente, e forse
mancano «bizzarrie» ben più significative di quelle ricordate.
La fatica dell’Einaudi è anch’essa significativa, poiché
avvalora la «dignità» scientifica del Loria, e mette
necessariamente, dinanzi al lettore ‑ giovane contemporaneo,
tutti gli scritti del Loria su uno stesso «piano», colpendo la
fantasia con la massa del «lavoro» fatto dal Loria: 884 numeri
in questi tempi di civiltà quantitativa. L’Einaudi merita per
questa sua «fatica» di essere iscritto ad honorem nella lista
dei Loriani; d’altronde è da notare che l’Einaudi, come
organizzatore di movimenti culturali, è responsabile delle
«bizzarrie» del Loria e su questo punto particolare sarebbe da
scrivere una nota).
1) Le influenze sociali dell’aviazione (Verità e fantasia) in «Rassegna Contemporanea» (diretta dal Colonna di Cesarò e da V. Picardi), Roma, III fasc., 1° gennaio 1910, pp. 20‑28, ripubblicato nel II vol. di Verso la giustizia sociale (Idee, battaglie ed apostoli) che ha come titolo proprio Nell’alba di un secolo (1904‑1915), Milano, Società Editrice Libraria, 1915, in 8º, pp. 522. (Non mi pare che nella pubblicazione nella «Rassegna Contemporanea» esistesse il sottotitolo Verità e fantasia: occorrerebbe vedere se la ristampa in volume presenta dei cambiamenti nel testo). Questo articolo è tutto un capolavoro di «bizzarrie»: vi si trova la teoria dell’emancipazione operaia dalla coercizione del salario di fabbrica non più ottenuta per mezzo della «terra libera» ma per mezzo degli aeroplani che opportunamente unti di vischio, permetteranno l’evasione dalla presente società con il nutrimento assicurato dagli uccelli impaniati; una teoria della caduta del credito fiduciario, dello sfrenarsi delle birbonate sessuali (adulteri impuniti, seduzioni ecc.); sull’ammazzamento sistematico dei portinai per le cadute di cannocchiali; un compendio della teoria, altrove svolta, sul grado di moralità secondo l’altezza dal livello del mare, con la proposta pratica di rigenerare i delinquenti portandoli nelle alte sfere dell’aria su immensi aeroplani, correzione di una precedente proposta di edificare le carceri in alta montagna ecc. ecc. (Questo articolo, data l’amenità del contenuto, si presta a diventare «libro di testo negativo» per una scuola di logica formale e di buon senso scientifico).
2) Una conferenza tenuta a Torino durante la guerra e pubblicata subito dopo nella Nuova Antologia (nella Bibliografia di Einaudi, al n. 222 è citata una conferenza – La pietà della scienza – conferenza tenuta il 13 dicembre 1915 a beneficio degli ospedali territoriali di Torino della Croce rossa e pubblicata in «Conferenze e Prolusioni», IX, n. 1, e che potrebbe essere quella in quistione). Il Loria parlò del «dolore universale», in modo molto «bizzarro», come appare da ciò, che unico documento concreto da lui esibito per dimostrare una legge universale del dolore fu la lista di ciò che costa la «claque» agli attori di teatro, secondo una statistica fissata dal Reina (quindi mostruoso dolore degli attori). È vero che, secondo il suo metodo solito, il Loria fece intravedere la parte positiva del problema, affermando seriamente che la natura provvidenziale crea una difesa e un antidoto contro l’avvelenamento universale del dolore come si vede dal fatto che i poverelli costretti a pernottare all’aria aperta e sul nudo sasso hanno la pelle più spessa degli uomini che dormono sulle soffici piume.
3) Articolo Perché i veneti non addoppiano ed i valtellinesi triplano; l’Einaudi lo cita al n. 697 e dopo il titolo aggiunge «in Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis», annotando: «È l’estratto in un foglietto di 1 col., ma nella Miscellanea c. s. edita in Trieste, maggio 1909, 2 voll., pag. 1050, con ritr. non si rileva questo articolo». L’articolo era stato inviato dal Loria al Comitato triestino per le onoranze ad Attilio Hortis nel cinquantenario della sua attività letteraria; il Comitato non poteva inserire l’articolo nella Miscellanea per la sua ridicola insulsaggine, ma non volle neppure mancare di riguardi al Loria che a Trieste era un esponente «illustre» della scienza italiana. Così fu comunicato al Loria che il suo «contributo» non poteva essere pubblicato nella Miscellanea già stampata in tipografia e che l’avrebbe pubblicato il (settimanale) letterario «Il Palvese». L’estratto catalogato dall’Einaudi è del «Palvese», dove occorrerebbe rintracciarlo per curiosità. L’articolo espone un aspetto (quello linguistico) della dottrina loriana sull’influenza dell’«altimetria» sullo sviluppo della civiltà (ciò che dimostra, tra l’altro, che in Loria non manca lo spirito di sistema e una certa coerenza e quindi che le sue «bizzarrie» non sono casuali e dovute ad impulsi di dilettantismo improvvisatore, ma corrispondono a un sustrato «culturale» che affiora continuamente): i montanari moralmente più puri, fisicamente più robusti «triplicano» le consonanti; la gente di pianura, invece (e guai se si tratta di popolazioni che stanno al livello del mare, come i veneziani), oltre che moralmente depravata, è anche fisicamente degenerata e non riesce neppure ad «addoppiare». Il Loria ricorre alla «testimonianza della propria coscienza» e afferma che da malato egli non riesce a domandare alla cameriera che una scempia «taza» di brodo.
4) La prefazione alla 1a edizione di una delle prime opere «scientifiche» del Loria, in cui il Loria parla della sua prolusione all’Università di Siena, e della impressione suscitata nel pubblico accademico dall’esposizione delle sue «originali» dottrine materialistiche: vi si trova accennata la sua teoria della connessione tra «misticismo» e «sifilide» (per «misticismo» il Loria intende tutti gli atteggiamenti che non siano «positivistici» o materialistici in senso volgare). Su tale argomento, nella Bibliografia è citato un articolo: Sensualità e misticismo in «Rivista Popolare», XV, 15 novembre 1909, 577‑578.
5) Documenti ulteriori a suffragio dell’economismo storico nella Riforma Sociale del settembre‑ottobre 1929. Questi cinque «documenti» sono i più vistosi che si ricordino in questo momento: ma è da ricordare che nel caso del Loria non si tratta di qualche caso di «dormicchiamento» intellettuale, sia pure con ricadute negli stessi delirii: si tratta di un filone «profondo», di una continuità abbastanza sistematica che accompagna tutta la sua carriera letteraria. Né si può negare che il Loria sia uomo di ingegno e che abbia del giudizio. In tutta una serie di articoli le «bizzarrie e stranezze» appaiono qua e là, estemporaneamente, ma ci sono quelle di un certo tipo, legate cioè a determinati «nessi di pensiero». Per esempio, si vede la teoria «altimetrica» apparire nella quistione «penitenziaria» e in quella «linguistica». Così in un articoletto pubblicato nella «Prora» che usciva a Torino durante la guerra (diretto da un certo Cipri‑Romanò, giornalettucolo un po’ losco, certamente di bassissima speculazione ai margini della guerra e dell’antidisfattismo) si dividevano i protagonisti della guerra mondiale in mistici (Guglielmo e Francesco Giuseppe o Carlo) e positivisti (Clémenceau e Lloyd George) e si parlava della fine dello zarismo come di un destino antimistico (nello stesso numero della «Prora» apparve Il vipistrello disfattista di Esuperanzo Ballerini).
Ricca di elementi comici è la poesia Al mio bastone. Nel XXXV anno di possesso in Nuova Antologia del 16 novembre 1909.
La «leziosità letteraria» notata dal Croce è un elemento secondario dello squilibrio loriano, ma ha una certa importanza: 1) perché si manifesta continuamente; 2) perché l’immagine e l’enfasi letteraria trascinano meccanicamente il Loria al grottesco come nei secentisti e sono origine immediata di alcune «bizzarrie». Altro elemento del genere è la pretesa infantile e scriteriata all’«originalità» intellettuale ad ogni costo. Non manca nel Loria, oltre al «grande opportunismo», anche una notevole dose di «piccolo opportunismo» della più bassa estrazione: si ricordano in proposito due articoli, quasi simili e pubblicati a breve distanza di tempo nella «Gazzetta del Popolo» (ultrareazionaria) e nel «Tempo» di Pippo Naldi (nittiano allora) nei quali un’immagine del Macaulay era svolta nell’uno in un senso e nell’altro nel senso opposto (si trattava della Russia e forse gli articoli sono del 1918: sulla Russia il Loria scrisse nel «Tempo» del 10 marzo 1918 e nella «Gazzetta» del 1° giugno successivo).
A proposito delle osservazioni del Croce sulla dottrina loriana dei «servi a spasso» e della sua importanza nella sociologia loriana è da ricordare un capocronaca della «Gazzetta del Popolo» del ’18 o anni successivi (prima del ’21), in cui il Loria parla degli intellettuali come di quelli che tengono dritta la «scala d’oro» sulla quale sale il popolo, con avvertimenti al popolo di tenersi buoni questi intellettuali ecc. ecc.
Loria non è un caso teratologico individuale: è invece l’esemplare più compiuto e finito di una serie di rappresentanti di un certo strato intellettuale di un determinato periodo storico; in generale di quello strato di intellettuali positivisti che si occuparono della quistione operaia e che erano più o meno convinti di approfondire e rivedere e superare la filosofia della prassi. Ma è da notare che ogni periodo ha il suo lorianismo più o meno compiuto e perfetto e ogni paese ha il suo: l’hitlerismo ha mostrato che in Germania covava, sotto l’apparente dominio di un gruppo intellettuale serio, un lorianismo mostruoso che ha rotto la crosta ufficiale e si è diffuso come concezione e metodo scientifico di una nuova «ufficialità». Che Loria potesse esistere, scrivere, elucubrare, stampare a sue spese libri e libroni, niente di strano: esistono sempre gli scopritori del moto perpetuo e i parroci che stampano continuazioni della Gerusalemme Liberata. Ma che egli sia diventato un pilastro della cultura, un «maestro», e che abbia trovato «spontaneamente» un grandissimo pubblico, ecco ciò che fa riflettere sulla debolezza, anche in tempi normali, degli argini critici che pur esistevano: è da pensare come, in tempi anormali, di passioni scatenate, sia facile a dei Loria, appoggiati da forze interessate, di traboccare da ogni argine e di impaludare per decenni un ambiente di civiltà intellettuale ancora debole e gracile.
Solo oggi (1935), dopo le manifestazioni di brutalità e d’ignominia inaudita della «cultura» tedesca dominata dall’hitlerismo, qualche intellettuale si è accorto di quanto fosse fragile la civiltà moderna – in tutte le sue espressioni contradditorie, ma necessarie nella loro contraddizione – che aveva preso le mosse dal primo rinascimento (dopo il Mille) e si era imposta come dominante attraverso la Rivoluzione francese e il movimento d’idee conosciuto come «filosofia classica tedesca» e come «economia classica inglese». Perciò la critica appassionata di intellettuali come Giorgio Sorel, come Spengler ecc., che riempiono la vita culturale di gas asfissianti e sterilizzanti.
Q28 §2 Col Loria occorre esaminare Enrico Ferri e Lumbroso. Arturo Labriola. Lo stesso Turati potrebbe dare una certa messe di osservazioni e aneddoti. Luzzati, in altro campo, è da vedere. Guglielmo Ferrero. Corrado Barbagallo (nel Barbagallo le manifestazioni «loriane» sono forse più occasionali ed episodiche: pure il suo scritto sul capitalismo antico pubblicato nella «Nuova Rivista Storica» del 1929 è estremamente sintomatico; con la postilla un po’ comica che segue all’articolo del prof. G. Sanna). Molti documenti del «lorianesimo» in senso largo si possono trovare nella «Critica», nella «Voce» e nell’«Unità» fiorentina.
Q28 §3 L’ossicino di Cuvier. Esposizione del principio di Cuvier. Ma non tutti sono Cuvier e specialmente la «sociologia» non può essere paragonata alle scienze naturali. Le generalizzazioni arbitrarie e «bizzarre» vi sono estremamente più possibili (e più dannose per la vita pratica).
Q28 §4 Paolo Orano. Due «stranezze» di P. Orano (a memoria): il «saggio» Ad metalla, nel volume Altorilievi (ed. Puccini, Milano), in cui propone agli operai minatori (dopo una catastrofe mineraria) di abbandonare definitivamente lo sfruttamento delle miniere, di tutte le miniere: lo propone da «sindacalista», da rappresentante di una nuova morale dei produttori moderni ecc., cioè propone, come niente, di interrompere e distruggere tutta l’industria metallurgica e meccanica; il volumetto sulla Sardegna (che pare sia il primo scritto pubblicato dall’Orano, dove si parla di un comico «liquido ambiente» ecc. Nei «medaglioni» (I Moderni) e nelle altre pubblicazioni dell’Orano c’è molto da spulciare, fino alla sua più recente produzione (ricordare il discorso di risposta alla Corona dopo il Concordato, dove c’è una teoria dell’«arbitrario», connesso col bergsonismo, veramente spassosa).
Q28 §5 Nelle lettere di G. Sorel a B. Croce si può spigolare più di un elemento di lorianesimo nella produzione letteraria dei sindacalisti italiani. Il Sorel afferma, per esempio, che nella tesi di laurea di Arturo Labriola si scrive come se il Labriola credesse che il Capitale di Marx è stato elaborato sull’esperienza economica francese e non su quella inglese.
Q28 §6 Alberto Lumbroso. A. Lumbroso è da collocare nella serie loriana, ma in altro campo e da altro punto di vista.
Si potrebbe fare un’introduzione generale alla rassegna, per dimostrare come Loria non sia una eccezione, nel suo campo, ma si tratti di un fenomeno generale di deterioramento culturale, che forse ha avuto la tumefazione più vistosa nel campo «sociologico». Così sono da ricordare Tommaso Sillani e la sua «casa dei parti», la «gomma di Vallombrosa» di Filippo Carli, del quale è notevole anche un grande articolo della «Perseveranza» (del 1918-1919) sul prossimo trionfo della navigazione a vela su quella a vapore; la letteratura economica dei protezionisti vecchia covata è piena di tali preziosità, che hanno avuto molti continuatori anche in tempi più vicini, come si può vedere negli scritti del Belluzzo sulle possibili ricchezze nascoste nelle montagne italiane e sullo scatenamento di scempiaggini che ha provocato la prima campagna per il ruralismo e l’artigianato.
Questi elementi generici e vagabondi del «lorianismo» potrebbero servire per rendere piacevole l’argomento. Si potrebbe ricordare come caso limite e assurdo perché già appartenente alla tecnica clinica‑patologica, la candidatura del Lenzi al IV collegio di Torino nel 1914, con l’«aereo cigno», il «filopresentaneismo» e la proposta di radere le montagne italiane, ingombranti, per trasportarne il materiale in Libia e fertilizzare così il deserto (mi pare però che anche il Kropotkin, nella Lotta per il pane, proponga di macinare i sassi per rendere più ampia l’area coltivabile).
Il caso del Lumbroso è molto interessante, perché suo padre (Giacomo) era un erudito di gran marca; ma la metodologia dell’erudizione (e la serietà scientifica), a quanto pare non si trasmette per generazione e neppure per il contatto intellettuale il più assiduo. C’è da domandarsi, nel caso Lumbroso, come i suoi due ponderosi volumi sulle Origini diplomatiche e politiche della guerra abbiano potuto essere accolti nella Collezione Gatti: la responsabilità del sistema è qui evidente. Così per Loria e la Riforma Sociale, per L. Luzzatti e il «Corriere della Sera» (a proposito del Luzzatti è da ricordare il caso del «fioretto» di S. Francesco, pubblicato come inedito dal «Corriere» – del 1913, mi pare, o prima – con un commento economico spassosissimo proprio del Luzzatti che aveva poco prima pubblicato un’edizione dei Fioretti nella Collezione Notari; il così detto inedito era una variante inviata al Luzzatti dal Sabatier). Del Luzzatti frasi famose, come «lo sa il tonno» in un articolo del «Corriere», che è stata l’origine casuale del libro del Bacchelli.
Q28 §7 Lorianismo nella scienza geografica. Ricordare il libro del prof. Alberto Magnaghi (fuori commercio) sui geografi spropositanti. Mi pare che il libro sia un modello del genere.
Q28 §8 Ricordare il volume sulla Cultura italiana di Papini e Prezzolini (ed. Lumachi e F. Gonnelli).
Q28 §9 Turati. Il discorso parlamentare sulle «salariate dell’amore». Discorso disonorevole e abbietto. I tratti di «cattivo gusto» del Turati sono numerosi nelle sue «poesie».
Q28 §10 Credaro‑Luzzatti. Ricordare l’episodio parlamentare Credaro‑Luzzatti. Era stata proposta una cattedra speciale all’Università di Roma di «filosofia della storia» per Guglielmo Ferrero (nell’11 o nel 12). Il ministro Credaro, fra l’altro, giustificò la «filosofia della storia» (contro B. Croce che aveva parlato in Senato contro la cattedra) con l’importanza che i filosofi hanno avuto nello svolgimento della storia, citando come esempio… Cicerone. Il Luzzatti assentì gravemente: «È vero! È vero!».
Q28 §11 Graziadei e il paese di Cuccagna. Cfr nel libretto di Graziadei Sindacati e Salari la alquanto comica risposta alla nota del Croce sul graziadeiano paese di Cuccagna, dopo quasi trent’anni. La risposta, comica, ma non sprovvista di una buona dose digesuitismo politico (crocianesimo tardivo di un certo gruppetto di personaggi laschiani: il Lasca diceva che l’uomo è un pezzo di sterco su due fuscelli), è stata indubbiamente determinata dal saggio pubblicato nel 1926 dall’«Unter dem Banner» su Prezzo e sovraprezzo che si iniziava appunto con la citazione della nota crociana. (Sarebbe interessante ricercare nella produzione letteraria del Graziadei i possibili accenni al Croce: non ha mai risposto, neppure indirettamente? Eppure la pizzicata era stata forte! In ogni modo, l’ossequio all’autorità scientifica del Croce espresso con tanta unzione dopo trent’anni, è veramente comico). Il motivo del paese di Cuccagna rilevato dal Croce in Graziadei, è di un certo interesse generale, perché serve a rintracciare una corrente sotterranea di romanticismo e di fantasticherie popolari alimentata dal «culto della scienza», dalla «religione dei progresso» e dall’ottimismo del secolo XIX, che è stato anch’esso una forma di oppio. In questo senso è da vedere se non sia stata legittima e di larga portata la reazione del Marx, che colla legge tendenziale della caduta del saggio del profitto e col così detto catastrofismo gettava molta acqua nel fuoco; è da vedere anche in che misura l’«oppiomania» abbia impedito una analisi più accurata delle proposizioni del Marx.
Queste osservazioni riconducono alla quistione della «utilità» o meno di una esposizione del lorianismo. A parte il fatto di un giudizio «spassionato» dell’opera complessiva del Loria e dell’apparente «ingiustizia» di mettere in rilievo solo le manifestazioni strampalate del suo ingegno, rimane, per giustificare queste notazioni, una serie di ragioni. Gli «autodidatti» specialmente sono inclini, per l’assenza di una disciplina critica e scientifica, a fantasticare di paesi di Cuccagna e di facili soluzioni di ogni problema. Come reagire? La soluzione migliore sarebbe la scuola, ma è soluzione di lunga attesa, specialmente per le grandi agglomerazioni di uomini che si lasciano portare all’oppiomania. Occorre perciò colpire intanto la «fantasia» con dei tipi «grandiosi» di ilotismo intellettuale, creare l’avversione «istintiva» per il disordine intellettuale, accompagnandolo col senso del ridicolo; ciò, come si è visto sperimentalmente in altri campi, si può ottenere, anche con una certa facilità, perché il buon senso, svegliato da un opportuno colpo di spillo, quasi fulmineamente annienta gli effetti dell’oppio intellettuale. Questa avversione è ancora poco, ma è già la premessa necessaria per instaurare un ordine intellettuale indispensabile: perciò il mezzo pedagogico indicato ha la sua importanza.
Ricordare alcuni episodi tipici: l’Interplanetaria del 1916‑17 di Rab.; l’episodio del «moto perpetuo» nel 1925, mi pare; figure come Pozzoni di Como e altri, che risolvevano tutto partendo dall’affitto della casa ecc. (Del resto, un episodio clamoroso è stato quello della «Baronata» che ha offerto uno spunto al Diavolo al Pontelungo del Bacchelli). La mancanza di sobrietà e di ordine intellettuale si accompagna molto spesso al disordine morale. La quistione sessuale porta, con le sue fantasticherie, molto disordine: poca partecipazione delle donne alla vita collettiva, attrazione di farfalloni postribolari verso iniziative serie ecc. (ricordare l’episodio narrato da Cecilia De Tourmay che è verosimile, anche se inventato); in molte città, specialmente meridionali, alle riunioni femminili, faticosamente organizzate, si precipitavano subito i liberoamoristi coi loro opuscoli neomaltusiani ecc. e tutto era da rifare. Tutti i più ridicoli fantasticatori che nei loro nascondigli di geni incompresi fanno scoperte strabilianti e definitive, si precipitano su ogni movimento nuovo persuasi di poter spacciare le loro fanfaluche. D’altronde ogni collasso porta con sé disordine intellettuale e morale. Bisogna creare uomini sobri, pazienti, che non disperino dinanzi ai peggiori orrori e non si esaltino a ogni sciocchezza. Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà.
Q28 §12 Guglielmo Ferrero. Ricordare gli spropositi contenuti nelle prime edizioni di alcuni suoi libri di storia: per esempio una misura itineraria persiana creduta una regina, di cui si scrive la biografia romanzata ecc. (Come sarebbe se tra mille anni, in un’epoca di puritanesimo, si scoprisse un’insegna da villaggio con su «Regia Gabella» e l’immagine di ragazza con la pipa in bocca diventasse una «Regina Gabella» ricettacolo di tutti i vizî). Del resto il Ferrero non ha cambiato: nella sua Fine delle avventure che è del 1930, mi pare, si crede possibile tornare alla «guerra dei merletti» e si esalta l’arte militare dei cicisbei.
Q28 §13 Luigi Valli. Luigi Valli e la sua interpretazione «cospiratoria» e massonica del dolce stil nuovo (con i precedenti di D. G. Rossetti e del Pascoli) è da porre in una determinata serie del Lorianismo. Invece Giulio Salvadori che nei Promessi Sposi scopre il dramma di Enrichetta Blondel (Lucia) oppressa dal Condorcet, Donna Giulia e il Manzoni stesso (Don Rodrigo, l’Innominato ecc.) è forse piuttosto da considerare come un «seguace» inconscio delle teorie di Freud, fenomeno curioso a sua volta per tanti aspetti. (Di Giulio Salvadori e della sua interpretazione cfr un articolo in «Arte e vita» del giugno 1920 e il libro postumo Enrichetta Manzoni‑Blondel e il Natale del 33, Treves, 1929).
Q28 §14 Loria e l’altimetria. A proposito delle teorie «altimetriche» del Loria si potrebbe ricordare, per ridere, che, secondo Aristotele, «le acropoli sono opportune pei governi oligarchici e tirannici, le pianure per i governi democratici».
Q28 §15 Corso Bovio. Corso Bovio deve essere collocato nel quadro del Lorianismo, ma occorre nello stesso tempo, ricordare di mantenere le distanze per la prospettiva. Nel quadro Loria è un «elefante», cos’è Corso Bovio? Certi fiamminghi mettono sempre un cagnolino nei loro quadri, ma forse il cagnolino è già un animale troppo grosso e stimabile: una blatta è forse più adeguata a rappresentare Corso Bovio.
Q28 §16 Domenico Giuliotti. Alla «dottrina» loriana del nesso necessario tra misticismo e sifilide fa riscontro (fino a un certo punto) Domenico Giuliotti che, nella prefazione a Profili di Santi edito dalla Casa Ed. Rinascimento del Libro, scrive: «Eppure, o edifichiamo unicamente in Cristo o, in altri modi, edifichiamo nella morte. Nietzsche, per esempio, l’ultimo anticristiano di grido, è bene non dimenticare che finì luetico e pazzo». A quanto pare, secondo il Giuliotti, Nietzsche è solo uno di una serie, si tratta di una legge, cioè, ed «è bene non dimenticare» il nesso. Giuliotti dice: state attenti, ragazzi, a non essere anticristiani, perché altrimenti morrete luetici e pazzi; e ancora: «state ragazze attente agli anticristiani: essi sono luetici e pazzi». (La prefazione del Giuliotti è riportata dall’«Italia Letteraria» del 15 dicembre 1929: pare che il libro sia una raccolta di vite di santi tradotte dal Giuliotti).
Q28 §17 G. A. Fanelli. Un volume che può essere considerato come l’espressione‑limite teratologica della reazione degli intellettuali di provincia alle tendenze «americaniste» di razionalizzazione dell’economia, è quello di G. A. Fanelli (il cui settimanale rappresenta l’estrema destra retriva nell’attuale situazione italiana): L’Artigianato. Sintesi di un’economia corporativa, Ed. Spes, Roma, 1929, in 8°, pp. XIX‑505, L. 30.00, di cui la «Civiltà Cattolica» del 17 agosto 1929 pubblica una recensione nella rubrica Problemi sociali (del p. Brucculeri). È da notare che il padre gesuita difende la civiltà moderna (almeno in alcune sue manifestazioni) contro il Fanelli. Brani caratteristici del Fanelli citati dalla «Civiltà Cattolica»: «Il sistema (dell’industrialismo meccanico) presenta l’inconveniente di riassorbire per indiretta via, neutralizzandola, la massima parte dei materiali vantaggi che esso può offrire. Dei cavalli‑vapore installati, i tre quarti sono adibiti nei trasporti celeri, resi indispensabili dalla necessità di ovviare ai facili deperimenti che cagionano i forti concentramenti di merci. Della quarta parte, adibita alla concentrazione delle merci, circa la metà è impiegata nella produzione delle macchine, sì che, a somme fatte, di tutto l’enorme sviluppo meccanico che opprime il mondo col peso del suo acciaio, non altro che un ottavo dei cavalli installati viene impiegato nella produzione dei manufatti e delle sostanze alimentari» (p. 205, del libro).
«L’Italiano, temperamento asistematico, geniale, creatore, avverso alle razionalizzazioni, non può adattarsi a quella metodicità della fabbrica, in cui solo è riposto il rendimento del lavoro in serie. Che anzi, l’orario di lavoro diviene per lui puramente nominale per lo scarso rendimento ch’egli dà in un lavoro sistematico. Spirito eminentemente musicale, l’Italiano può accompagnarsi col solfeggio nel lavoro libero, attingendo da tale ricreazione nuove forze ed ispirazioni. Mente aperta, carattere vivace, cuore generoso, portato nella bottega… l’Italiano può esplicare le proprie virtù creative a cui, del resto, si appoggia tutta l’economia della bottega. Sobrio come nessun altro popolo, l’Italiano sa attingere, nella indipendenza della vita di bottega, qualunque sacrifizio o privazione per far fronte alle necessità dell’arte, mentre mortificato nel suo spirito creatore dal lavoro squalificato della fabbrica, egli sperpera la paga nell’acquisto di un oblio e di una gioia che gli abbrevian l’esistenza» (p. 171 del libro).
Nel piano intellettuale e culturale il libro del Fanelli corrisponde all’attività letteraria di certi poeti di provincia che ancora continuano a scrivere continuazioni, in ottava rima, della Gerusalemme Liberata e Vittoriosa (Conquistata), a parte certa mutria altezzosa e buffa. È da notare che le «idee» esposte dal Fanelli hanno avuto, in certi anni, una grande diffusione, ciò che era in curioso contrasto col programma «demografico» da una parte, e col concetto di «nazione militare» dall’altra, poiché non si può pensare a cannoni e corazzate costruite da artigiani o alla motorizzazione coi carri a buoi, né al programma di un’Italia «artigiana» e militarmente impotente in mezzo a Stati altamente industrializzati con le relative conseguenze militari: tutto ciò dimostra che i gruppi intellettuali che esprimevano queste lorianate in realtà s’infischiavano, non solo della logica, ma della vita nazionale, della politica e di tutto quanto. Non è molto difficile rispondere al Fanelli: il Brucculeri stesso nota giustamente che ormai l’artigianato è legato alla grande industria e ne dipende: esso ne riceve materie prime semilavorate e utensili perfezionati.
Che l’operaio italiano (come media) dia una produzione relativamente scarsa può essere vero: ma ciò dipende da ciò che in Italia l’industrialismo, abusando della massa crescente di disoccupati (che l’emigrazione solo in parte riusciva ad assorbire) è stato sempre un industrialismo di rapina, che ha speculato sui bassi salari e ha trascurato lo sviluppo tecnico; la proverbiale «sobrietà» degli italiani è solo una metafora per significare che non esiste un tenore di vita adeguato al consumo di energia domandato dal lavoro di fabbrica (quindi anche bassi rendimenti).
L’«Italiano» tipo, presentato dal Fanelli è coreografico e falso per ogni rispetto: nell’ordine intellettuale sono gli italiani che hanno creato l’«erudizione» e il paziente lavoro d’archivio: il Muratori, il Tiraboschi, il Baronio ecc. erano italiani e non tedeschi; la «fabbrica» come grande manifattura ebbe certo in Italia le sue prime manifestazioni organiche e razionali. Del resto, tutto questo parlare di artigianato e di artigiani è fondato su un equivoco grossolano: perché nell’artigianato esiste un lavoro in serie e standardizzato dello stesso tipo «intellettuale» di quello della grande industria razionalizzata: l’artigiano produce mobili, aratri, roncole, coltelli, case di contadini, stoffe ecc. sempre di uno stesso tipo, che è conforme al gusto secolare di un villaggio, di un mandamento, di un distretto, di una provincia, al massimo di una regione. La grande industria cerca di standardizzare il gusto di un continente o del mondo intero per una stagione o per qualche anno; l’artigianato subisce una standardizzazione già esistente e mummificata di una valle o di un angolo del mondo. Un artigianato a «creazione individuale» arbitraria incessante è così ristretto che comprende solo gli artisti nel senso stretto della parola (e ancora: solo i «grandi» artisti che diventano «prototipi» dei loro scolari).
Il libro del Fanelli eccelle per il lorianismo: ma può essere esaminato in altre rubriche: «Americanismo» e «Passato e Presente».
Q28 §18 L’altimetria, i buoni costumi e l’intelligenza. Nell’«utopia» di Ludovico Zuccolo: Il Belluzzi o la Città felice ristampato da Amy Bernardy nelle «Curiosità letterarie» dell’ed. Zanichelli (che non è precisamente un’utopia, perché si parla della repubblica di S. Marino) si accenna alla teoria loriana dei rapporti tra l’altimetria e i costumi umani. L. Zuccolo sostiene che «gli uomini di animo rimesso o di cervello ottuso si uniscono più facilmente a consultare degli affari comuni»: questa sarebbe la ragione della saldezza degli ordinamenti di Venezia, degli Svizzeri e di Ragusa, mentre gli uomini di natura vivace ed acuta, come i fiorentini, sono portati alla sopraffazione o «a occuparsi dei privati interessi senza punto occuparsi dei pubblici». Come allora spiegarsi che i Sanmarinesi, di natura vivace ed acuta, abbiano tuttavia conservato per tanti secoli un governo popolare? Perché a S. Marino la sottigliezza d’aria che rende ben composti e vigorosi i corpi, produce anche gli «spiriti puri e sinceri». È vero che lo Zuccolo parla anche delle ragioni economiche, cioè la mediocrità delle ricchezze individuali, per cui il più ricco ha «poco davantaggio» e al più povero non manca nulla. Questa eguaglianza è assicurata da buone leggi: proibizione dell’usura, inalienabilità della terra ecc.
Lo Zuccolo ha scritto un’«Utopia» vera e propria, La Repubblica di Evandria, posta in una penisola agli antipodi dell’Italia, che, secondo il Gargàno (Un utopista di senso pratico in «Marzocco» del 2 febbraio 1930) avrebbe un legame con l’Utopia di T. Moro e avrebbe quindi originato il Belluzzi.
QUADERNO 29
PER UNA INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA GRAMMATICA
Q29 §1 Saggio del Croce: Questa tavola rotonda è quadrata. Il
saggio è sbagliato anche dal punto di vista crociano (della
filosofia crociana). Lo stesso impiego che il Croce fa della
proposizione mostra che essa è «espressiva» e quindi
giustificata: si può dir lo stesso di ogni «proposizione», anche
non «tecnicamente» grammaticale, che può essere espressiva e
giustificata in quanto ha una funzione, sia pure negativa (per
mostrare l’«errore» di grammatica si può impiegare una
sgrammaticatura). Il problema va quindi posto in altro modo, nei
termini di «disciplina alla storicità del linguaggio» nel caso
delle «sgrammaticature» (che sono assenza di «disciplina
mentale», neolalismo, particolarismo provinciale gergo, ecc.) o
in altri termini (nel caso dato del saggio crociano l’errore è
stabilito da ciò, che una tale proposizione può apparire nella
rappresentazione di un «pazzo», di un anormale, ecc. ed
acquistare valore espressivo assoluto; come rappresentare uno
che non sia «logico» se non facendogli dire «cose illogiche»?
ecc.). In realtà tutto ciò che non è «grammaticalmente esatto»
può anche essere giustificato dal punto di vista estetico,
logico, ecc., se lo si vede non nella particolare logica, ecc.,
dell’espressione immediatamente meccanica, ma come elemento di
una rappresentazione più vasta e comprensiva.
La quistione che il Croce vuol porre: «Cosa è la grammatica?» non può avere soluzione nel suo saggio. La grammatica è «storia» o «documento storico»: essa è la «fotografia» di una fase determinata di un linguaggio nazionale (collettivo) formatosi storicamente e in continuo sviluppo, o i tratti fondamentali di una fotografia. La quistione pratica può essere: a che fine tale fotografia? Per fare la storia di un aspetto della civiltà o per modificare un aspetto della civiltà?
La pretesa del Croce porterebbe a negare ogni valore a un quadro rappresentante tra l’altro una… sirena, per esempio, cioè si dovrebbe concludere che ogni proposizione deve corrispondere al vero o al verosimile, ecc.
(La proposizione può essere non logica in sé, contradditoria, ma nello stesso tempo «coerente» in un quadro più vasto).
Q29 §2 Quante forme di grammatica possono esistere? Parecchie, certamente. C’è quella «immanente» nel linguaggio stesso, per cui uno parla «secondo grammatica» senza saperlo, come il personaggio di Molière faceva della prosa senza saperlo. Né sembri inutile questo richiamo, perché il Panzini (Guida alla Grammatica italiana, 18° migliaio) non pare distinguere tra questa «grammatica» e quella «normativa», scritta, di cui intende parlare e che per lui pare essere la sola grammatica possibile esistente. La prefazione alla prima edizione è piena di amenità, che d’altronde hanno il loro significato in uno scrittore (e ritenuto specialista) di cose grammaticali, come l’affermazione che «noi possiamo scrivere e parlare anche senza grammatica». In realtà oltre alla «grammatica immanente» in ogni linguaggio, esiste anche, di fatto, cioè anche se non scritta, una (o più) grammatica «normativa», ed è costituita dal controllo reciproco, dall’insegnamento reciproco, dalla «censura» reciproca, che si manifestano con le domande, «Cosa hai inteso, o vuoi dire?», «Spiegati meglio», ecc., con la caricatura e la presa in giro, ecc.; tutto questo complesso di azioni e reazioni confluiscono a determinare un conformismo grammaticale, cioè a stabilire «norme» o giudizi di correttezza o di scorrettezza, ecc. Ma questo manifestarsi «spontaneo» di un conformismo grammaticale, è necessariamente sconnesso, discontinuo, limitato a strati sociali locali o a centri locali, ecc. (Un contadino che si inurba, per la pressione dell’ambiente cittadino, finisce col conformarsi alla parlata della città; nella campagna si cerca di imitare la parlata della città; le classi subalterne cercano di parlare come le classi dominanti e gli intellettuali, ecc.).
Si potrebbe schizzare un quadro della «grammatica normativa» che opera spontaneamente in ogni società data, in quanto questa tende a unificarsi sia come territorio, sia come cultura, cioè in quanto vi esiste un ceto dirigente la cui funzione sia riconosciuta e seguita.
Il numero delle «grammatiche spontanee o immanenti» è incalcolabile e teoricamente si può dire che ognuno ha una sua grammatica. Tuttavia, accanto a questa «disgregazione» di fatto sono da rilevare i movimenti unificatori, di maggiore o minore ampiezza sia come area territoriale, sia come «volume linguistico». Le «grammatiche normative» scritte tendono ad abbracciare tutto un territorio nazionale e tutto il «volume linguistico» per creare un conformismo linguistico nazionale unitario, che d’altronde pone in un piano più alto l’«individualismo» espressivo, perché crea uno scheletro più robusto e omogeneo all’organismo linguistico nazionale di cui ogni individuo è il riflesso e l’interprete. (Sistema Taylor e autodidattismo).
Grammatiche storiche oltre che normative. – Ma è evidente che uno scrittore di grammatica normativa non può ignorare la storia della lingua di cui vuole proporre una «fase esemplare» come la «sola» degna di diventare, «organicamente» e «totalitariamente», la lingua «comune» di una nazione, in lotta e concorrenza con altre «fasi» e tipi o schemi che esistono già (collegati a sviluppi tradizionali o a tentativi inorganici e incoerenti delle forze che, come si è visto, operano continuamente sulle «grammatiche» spontanee e immanenti nel linguaggio). La grammatica storica non può non essere «comparativa»: espressione che, analizzata a fondo, indica la intima coscienza che il fatto linguistico, come ogni altro fatto storico, non può avere confini nazionali strettamente definiti, ma che la storia è sempre «storia mondiale» e che le storie particolari vivono solo nel quadro della storia mondiale. La grammatica normativa ha altri fini, anche se non si può immaginare la lingua nazionale fuori del quadro delle altre lingue, che influiscono per vie innumerevoli e spesso difficili da controllare su di essa (chi può controllare l’apporto di innovazioni linguistiche dovute agli emigrati rimpatriati, ai viaggiatori, ai lettori di giornali e lingue estere, ai traduttori, ecc.?)
La grammatica normativa scritta è quindi sempre una «scelta», un indirizzo culturale, è cioè sempre un atto di politica culturale‑nazionale. Potrà discutersi sul modo migliore di presentare la «scelta» e l’«indirizzo» per farli accettare volentieri, cioè potrà discutersi dei mezzi più opportuni per ottenere il fine; non può esserci dubbio che ci sia un fine da raggiungere che ha bisogno di mezzi idonei e conformi, cioè che si tratti di un atto politico.
Quistioni: di che natura è questo atto politico, e se debba sollevare opposizioni di «principio», una collaborazione di fatto, opposizioni nei particolari, ecc. Se si parte dal presupposto di centralizzare ciò che esiste già allo stato diffuso, disseminato, ma inorganico e incoerente, pare evidente che non è razionale una opposizione di principio, ma anzi una collaborazione di fatto e un accoglimento volenteroso di tutto ciò che possa servire a creare una lingua comune nazionale, la cui non esistenza determina attriti specialmente nelle masse popolari, in cui sono più tenaci di quanto non si creda i particolarismi locali e i fenomeni di psicologia ristretta e provinciale; si tratta insomma di un incremento della lotta contro l’analfabetismo ecc. L’opposizione di «fatto» esiste già nella resistenza delle masse a spogliarsi di abitudini e psicologie particolaristiche. Resistenza stupida determinata dai fautori fanatici delle lingue internazionali. È chiaro che in questo ordine di problemi non può essere discussa la quistione della lotta nazionale di una cultura egemone contro altre nazionalità o residui di nazionalità.
Il Panzini non si pone neanche lontanamente questo problema e perciò le sue pubblicazioni grammaticali sono incerte, contraddittorie, oscillanti. Non si pone per esempio il problema di quale oggi sia, dal basso, il centro di irradiazione delle innovazioni linguistiche; che pure non ha poca importanza pratica. Firenze, Roma, Milano. Ma d’altronde non si pone neanche il problema se esista (e quale sia) un centro di irradiazione spontanea dall’alto, cioè in forma relativamente organica, continua, efficiente, e se essa possa essere regolata e intensificata.
Q29 §3 Focolai di irradiazione di innovazioni linguistiche nella tradizione e di un conformismo nazionale linguistico nelle grandi masse nazionali. 1) La scuola; 2) i giornali; 3) gli scrittori d’arte e quelli popolari; 4) il teatro e il cinematografo sonoro; 5) la radio; 6) le riunioni pubbliche di ogni genere, comprese quelle religiose; 7) i rapporti di «conversazione» tra i vari strati della popolazione più colti e meno colti – (una quistione alla quale forse non si dà tutta l’importanza che si merita è costituita da quella parte di «parole» versificate che viene imparata a memoria sotto forma di canzonette, pezzi d’opera, ecc. È da notare come il popolo non si curi di imparare bene a memoria queste parole, che spesso sono strampalate, antiquate, barocche, ma le riduca a specie di filastrocche utili solo per ricordare il motivo musicale); 8) i dialetti locali, intesi in diversi sensi (dai dialetti più localizzati a quelli che abbracciano complessi regionali più o meno vasti: così il napoletano per l’Italia meridionale, il palermitano o il catanese per la Sicilia, ecc.).
Poiché il processo di formazione, di diffusione e di sviluppo di una lingua nazionale unitaria avviene attraverso tutto un complesso di processi molecolari, è utile avere consapevolezza di tutto il processo nel suo complesso, per essere in grado di intervenire attivamente in esso col massimo di risultato. Questo intervento non bisogna considerarlo come «decisivo» e immaginare che i fini proposti saranno tutti raggiunti nei loro particolari, che cioè si otterrà una determinata lingua unitaria: si otterrà una lingua unitaria, se essa è una necessità, e l’intervento organizzato accelererà i tempi del processo già esistente; quale sia per essere questa lingua non si può prevedere e stabilire: in ogni caso, se l’intervento è «razionale», essa sarà organicamente legata alla tradizione, ciò che non è di poca importanza nell’economia della cultura.
Manzoniani e «classicisti». Avevano un tipo di lingua da far prevalere. Non è giusto dire che queste discussioni siano state inutili e non abbiano lasciato tracce nella cultura moderna, anche se non molto grandi. In realtà in questo ultimo secolo la cultura unitaria si è estesa e quindi anche una lingua unitaria comune. Ma tutta la formazione storica della nazione italiana era a ritmo troppo lento. Ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la quistione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare‑nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale. Oggi si sono verificati diversi fenomeni che indicano una rinascita di tali quistioni: pubblicazioni del Panzini, Trabalza‑Allodoli, Monelli, rubriche nei giornali, intervento delle direzioni sindacali, ecc.
Q29 §4 Diversi tipi di grammatica normativa. Per le scuole. Per le così dette persone colte. In realtà la differenza è dovuta al diverso grado di sviluppo intellettuale del lettore o studioso, e quindi alla tecnica diversa che occorre impiegare per fare apprendere o intensificare la conoscenza organica della lingua nazionale ai ragazzi, verso i quali non si può prescindere didatticamente da una certa rigidità autoritaria perentoria («bisogna dire così») e gli «altri» che invece bisogna «persuadere» per far loro accettare liberamente una determinata soluzione come la migliore (dimostrata la migliore per il raggiungimento del fine proposto e condiviso, quando è condiviso). Non bisogna inoltre dimenticare che nello studio tradizionale della grammatica normativa sono stati innestati altri elementi del programma didattico d’insegnamento generale, come quello di certi elementi della logica formale: si potrà discutere se questo innesto è opportuno o no, se lo studio della logica formale è giustificato o no (pare giustificato e pare anche giustificato che sia accompagnato a quello della grammatica, più che dell’aritmetica, ecc., per la somiglianza di natura e perché insieme alla grammatica la logica formale è relativamente vivificata e facilitata), ma non bisogna prescindere dalla quistione.
Q29 §5 Grammatica storica e grammatica normativa. Posto che la grammatica normativa è un atto politico, e che solo partendo da questo punto di vista si può giustificare «scientificamente» la sua esistenza, e l’enorme lavoro di pazienza che il suo apprendimento richiede (quanto lavoro occorre fare per ottenere che da centinaia di migliaia di reclute della più disparata origine e preparazione mentale risulti un esercito omogeneo e capace di muoversi e operare disciplinatamente e simultaneamente: quante «lezioni pratiche e teoriche» di regolamenti, ecc.) è da porre il suo rapporto con la grammatica storica. Il non aver definito questo rapporto spiega molte incongruenze delle grammatiche normative, fino a quella del Trabalza‑Allodoli. Si tratta di due cose distinte e in parte diverse, come la storia e la politica, ma che non possono essere pensate indipendentemente: come la politica dalla storia. D’altronde, poiché lo studio delle lingue come fenomeno culturale è nato da bisogni politici (più o meno consapevoli e consapevolmente espressi) le necessità della grammatica normativa hanno influito sulla grammatica storica e sulle «concezioni legislative» di essa (o almeno questo elemento tradizionale ha rafforzato nel secolo scorso l’applicazione del metodo naturalistico‑positivistico allo studio della storia delle lingue concepito come «scienza del linguaggio»). Dalla grammatica del Trabalza e anche dalla recensione stroncatoria dello Schiaffini (Nuova Antologia, 16 settembre 1934) appare come anche dai così detti «idealisti» non sia compreso il rinnovamento che nella scienza del linguaggio hanno portato le dottrine del Bartoli. La tendenza dell’«idealismo» ha trovato la sua espressione più compiuta nel Bertoni: si tratta di un ritorno a vecchie concezioni rettoriche, sulle parole «belle» e «brutte» in sé e per sé, concezioni riverniciate con un nuovo linguaggio pseudo‑scientifico. In realtà si cerca di trovare una giustificazione estrinseca della grammatica normativa, dopo averne altrettanto estrinsecamente «mostrato» la «inutilità» teoretica e anche pratica.
Il saggio del Trabalza sulla Storia della grammatica potrà fornire indicazioni utili sulle interferenze tra grammatica storica (o meglio storia del linguaggio) e grammatica normativa, sulla storia del problema, ecc.
Q29 §6 Grammatica e tecnica. Per la grammatica può porsi la quistione come per la «tecnica» in generale? La grammatica è solo la tecnica della lingua? In ogni caso, è giustificata la tesi degli idealisti, specialmente gentiliani, dell’inutilità della grammatica e della sua esclusione dall’insegnamento scolastico? Se si parla (ci si esprime con le parole) in un modo determinato storicamente per nazioni o per aree linguistiche, si può prescindere dall’insegnare questo «modo storicamente determinato»? Ammesso che la grammatica normativa tradizionale fosse insufficiente, è questa una buona ragione per non insegnare nessuna «grammatica», cioè per non preoccuparsi in nessun modo di accelerare l’apprendimento del modo determinato di parlare di una certa area linguistica, ma di lasciare che la «lingua si impari nel vivente linguaggio» o altra espressione del genere impiegata dal Gentile o dai gentiliani? Si tratta, in fondo, di una forma di «liberalismo» delle più bislacche e strampalate. Differenze tra il Croce e il Gentile. Al solito il Gentile si fonda sul Croce, esagerandone all’assurdo alcune posizioni teoretiche. Il Croce sostiene che la grammatica non rientra in nessuna delle attività spirituali teoretiche da lui elaborate, ma finisce col trovare nella «pratica» una giustificazione di molte attività negate in sede teoretica: il Gentile esclude anche dalla pratica, in un primo tempo, ciò che nega teoreticamente, salvo poi a trovare una giustificazione teoretica delle manifestazioni pratiche più superate e tecnicamente ingiustificate.
Si deve apprendere «sistematicamente» la tecnica? È successo che alla tecnica di Ford si contrapponga quella dell’artigiano di villaggio. In quanti modi si apprende la «tecnica industriale»: artigiano, durante lo stesso lavoro di fabbrica, osservando come lavorano gli altri (e quindi con maggior perdita di tempo e di fatica e solo parzialmente); con le scuole professionali (in cui si impara sistematicamente tutto il mestiere, anche se alcune nozioni apprese dovranno servire poche volte in tutta la vita e anche mai); con le combinazioni di vari modi, col sistema Taylor-Ford che crea un nuovo tipo di qualifica e di mestiere ristretto a determinate fabbriche, e anche macchine o momenti del processo produttivo.
La grammatica normativa, che solo per astrazione può essere ritenuta scissa dal linguaggio vivente, tende a fare apprendere tutto l’organismo, della lingua determinata, e a creare un atteggiamento spirituale che renda capaci di orientarsi sempre nell’ambiente linguistico (vedi nota sullo studio del latino nelle scuole classiche). Se la grammatica è esclusa dalla scuola e non viene «scritta», non perciò può essere esclusa dalla «vita» reale, come è stato già detto in altra nota: si esclude solo l’intervento organizzato unitariamente nell’apprendimento della lingua e, in realtà, si esclude dall’apprendimento della lingua colta la massa popolare nazionale, poiché il ceto dirigente più alto, che tradizionalmente parla in «lingua», trasmette di generazione in generazione, attraverso un processo lento che incomincia coi primi balbettamenti del bambino sotto la guida dei genitori, e continua nella conversazione (coi suoi «si dice così», «deve dirsi così», ecc.) per tutta la vita: in realtà la grammatica si studia «sempre», ecc. (con l’imitazione dei modelli ammirati, ecc.). Nella posizione del Gentile c’è molta più politica di quanto si creda e molto reazionarismo inconscio, come del resto è stato notato altre volte e in altre occasioni: c’è tutto il reazionarismo della vecchia concezione liberale, c’è un «lasciar fare, lasciar passare» che non è giustificato, come era nel Rousseau (e il Gentile è più rousseauiano di quanto creda) dall’opposizione alla paralisi della scuola gesuitica, ma è diventato un’ideologia astratta, «astorica».
Q29 §7 La così detta «quistione della lingua». Pare chiaro che il De Vulgari Eloquio di Dante sia da considerare come essenzialmente un atto di politica culturale-nazionale (nel senso che nazionale aveva in quel tempo e in Dante), come un aspetto della lotta politica è stata sempre quella che viene chiamata «la quistione della lingua» che da questo punto di vista diventa interessante da studiare. Essa è stata una reazione degli intellettuali allo sfacelo dell’unità politica che esisté in Italia sotto il nome di «equilibrio degli Stati italiani», allo sfacelo e alla disintegrazione delle classi economiche e politiche che si erano venute formando dopo il Mille coi Comuni e rappresenta il tentativo, che in parte notevole può dirsi riuscito, di conservare e anzi di rafforzare un ceto intellettuale unitario, la cui esistenza doveva avere non piccolo significato nel Settecento e Ottocento (nel Risorgimento). Il libretto di Dante ha anch’esso non piccolo significato per il tempo in cui fu scritto; non solo di fatto, ma elevando il fatto a teoria, gli intellettuali italiani del periodo più rigoglioso dei Comuni, «rompono» col latino e giustificano il volgare, esaltandolo contro il «mandarinismo» latineggiante, nello stesso tempo in cui il volgare ha così grandi manifestazioni artistiche. Che il tentativo di Dante abbia avuto enorme importanza innovatrice, si vede più tardi col ritorno del latino a lingua delle persone colte (e qui può innestarsi la quistione del doppio aspetto dell’Umanesimo e del Rinascimento, che furono essenzialmente reazionari dal punto di vista nazionale‑popolare e progressivi come espressione dello sviluppo culturale dei gruppi intellettuali italiani e europei).
Q29 §8 Del Bartoli, Quistioni linguistiche e diritti nazionali, discorso tenuto all’inaugurazione dell’anno accademico torinese 1934, pubblicato nel 1935 (vedi nota in «Cultura» dell’aprile 1935). Pare dalla nota che il discorso sia molto discutibile per alcune parti generali: per esempio l’affermazione che «l’Italia dialettale è una e indivisibile».
Notizie sull’Atlante linguistico pubblicate in due numeri di un Bollettino.
Q29 §9 Il titolo dello studio potrebbe essere: «Lingua nazionale e grammatica».